 | | Eroe che doma un leone. Gilgameš? (✍ VIII sec. a.C.) | Bassorilievo in pietra alabastrina da Dūr-Šarrukīn (tall Hursābād, ‘Irāq)
Altezza m. 4,45. Musée du Louvre, Paris. |
TRACCE DI UN COSMO REMOTO Dal Medio Oriente all'antico Mediterraneo affiora insistente il mito di un eroe che, a dispetto dei disegni divini, cerca di ritornare in quel giardino meraviglioso da dove l'uomo era stato scacciato alle origini del tempo. Una disperata ricerca che lo condurrà in un viaggio zodiacale verso la misteriosa «confluenza dei fiumi»: in quelle isole
oltremondane dove ancora regna l'età aurea, dove sgorga la fonte dell'immortalità e fiorisce l'albero della vita. Nel tracciare questo percorso, che vede in Gilgameš il suo più
noto archetipo, seguiremo per un certo tratto alcune strade ben calcate dai mitologi. Alcuni temi conducono, com'è noto, alle leggende alessandrine e al mondo
islāmico; altri temi spiccano ben chiari nel mito greco, incastonati nel ciclo di Hērakls. Ma lo scenario rivela un disegno assai complesso e coerente, in cui tutti gli elementi si stagliano su una precisa ideologia, cosmologica e insieme metafisica. Partendo da frammenti apparentemente slegati, cercheremo di portare alla luce lo schema di un mito antichissimo, i cui elementi sono sparpagliati dalla Mesopotamia alla Grecia, dall'Arabia all'Īrān, dalla Cina all'Irlanda. Ed è un mito altamente suggestivo, in cui si riconoscono forti connotazioni astronomiche, e
ben più validi studiosi, prima di noi, hanno tentato molte ingegnose interpretazioni.
Simboli ricorrenti tornano continuamente ad affacciarsi negli esiti pervenuti fino a noi; tori, leoni, aquile e serpenti indicano la presenza di qualche antico schema cosmologico, ma sfuggono a ogni tentativo di fissarli in un kósmos univoco. Le letture possibili sono
molte, ma c'è anche il rischio di farsi prendere dalla vertigine della comparazione e di eccedere i limiti del buon senso. In questo studio procederemo con cautela, cercando di spingerci fin dove possibile. Suggeriremo alcune ipotesi di lavoro ma
inevitabilmente, a un certo punto, dovremo fermarci, tirare un respiro e contemplare il disegno ormai irrimediabilmente sfocato e confuso di qualche antichissimo universo. |
 | | Il giardino delle delizie (✍ 1503-1504) | Hieronymus Bosch (1450-1516). Particolare.
2.2 m x 3.9 m. Museo Nacional Del Prado, Madrid. |
A ORIENTE, IN ʿĒḎẸN Wayyiṭṭaʿ Yǝhwāh lōhîm gan-bǝʿĒḏẹn miqqẹḏẹm... | E Yǝhwāh lōhîm piantò un giardino in ʿĒḏẹn, a oriente... | Bǝrēʾšîṯ [2: ] |
Varchiamo, con l'ottavo versetto del secondo capitolo del Genesi, la soglia di uno dei temi più antichi e suggestivi della mitologia universale: quello del paradiso terrestre. Per sottolineare subito che quest'espressione, «paradiso terrestre», non rende affatto il senso della parola ʿĒḏẹn,
bensì la distorce, restituendone un'immagine estranea al testo
biblico. Il termine ʿēḏẹn (עֵדֶן) in ebraico significava «piacere» o «delizia»,
sostantivo che in altri luoghi della Bibbia viene tradotto come
hēdonḗ o voluptas. Pare che questa parola, ʿēḏẹn, si sia originata dall'accadico edinu, «steppa». Difficile dire quando e come sia avvenuto lo slittamento di significato. L'idea generativa del giardino di ʿĒḏẹn
sembra essere quella di una verde oasi nell'arido deserto orientale.
La traduzione di gan, «giardino», quale parádeisos si trova nella Bibbia greca dei Settanta
(Kaì ephýteusen kýrios ho theòs parádeison en Edem katà anatolà...), dove viene adattata una parola di origine persiana, pairadaǝza, il cui significato originale era quello di un parco reale adibito al divertimento e alla caccia. Questa parola, passando in occidente, darà pārdǝs in ebraico e parádeisos in greco. L'aggettivo «terrestre» verrà invece apposto a distinguere, nelle tarde teologie, il giardino paradisiaco, sito in un luogo segreto della terra, dal «vero» paradiso, il regno spirituale che è nei cieli, destinato ad accogliere le anime dei giusti dopo la
loro morte. Alla sua prima apparizione nel Bǝrēʾšîṯ, la parola ʿēḏẹn ha un valore prettamente topografico, in quanto il testo distingue chiaramente tra il giardino, gan, e la regione in cui è collocato, ʿēḏẹn. Come nota
l'ebraista Giulio Busi, «la precisione di questo inizio è solo apparente, giacché i particolari che si susseguono nel racconto rendono la geografia simbolica di ʿĒḏẹn uno dei tempi più sfuggenti dell'intera scrittura», e fa notare come la parola ʿēḏẹn venga introdotta
in tutta naturalezza, senza alcuna anticipazione, come se i lettori sapessero perfettamente di cosa si stesse parlando (Busi 1999). Il ché non ci autorizza a trarre la conclusione che si possa localizzare la terra di ʿĒḏẹn su un atlante geografico: la nozione stessa di uno spazio felice, dove l'umanità, all'inizio del tempo, aveva condotto un'esistenza libera dal dolore e dalla morte, non è che un felice tópos mitico e letterario. Non appartiene alla storia, ma al passato assoluto del mito. A rendere più ambigua la narrazione biblica, le nozioni del giardino e della regione che lo accoglie si confondono nella parte centrale dell'episodio, dove il gan-bǝʿĒḏẹn (il «giardino in ʿĒḏẹn»), ormai divenuto a tutti gli effetti il gan ʿĒḏẹn (il «giardino di ʿĒḏẹn») (Bǝrēʾšîṯ [2: ), funge da incantevole scenario alla fase più intensa della vicenda.
Se poi intendiamo ʿēḏẹn, non come nome
proprio, ma come sostantivo, nel suo significato di «piacere», ecco
che la formula gan ʿēḏẹn ci conduce diritti
all'hortus voluptatis dei testi medievali, dove il concetto di spazio recintato
si accorda all'abbandono edonistico dei sensi: è il «giardino delle
delizie» magnificato da Hieronymus Bosch in uno dei suoi capolavori pittorici. Subito dopo averci informati che il giardino è stato piantato nella terra di ʿĒḏẹn, il Bǝrēʾšîṯ aggiunge il dettaglio essenziale del punto cardinale: «a oriente». Ma c'è anche qui un'ambiguità. La nozione di est direzionale si trova ancora una volta nella traduzione greca dei Settanta, che rende con katà anatolas, «in oriente», l'originale espressione ebraica miqqẹḏẹm, la quale ha però anche un significato temporale: «anticamente». L'esegesi midrāšica interpreta questa parola proprio in senso cronologico, finendo con lo stabilire la preesistenza del gan ʿĒḏẹn rispetto a ogni altra creazione. Ma completiamo la nostra citazione: | Wayyiṭṭaʿ Yǝhwāh lōhîm gan-bǝʿĒḏẹn miqqẹḏẹm wayyaśẹm šām ẹṯ-hāʾāḏām ăšẹr yāṣār. | E Yǝhwāh lōhîm piantò un giardino in ʿĒḏẹn, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva creato. | Bǝrēʾšîṯ [2: ] |
Questa seconda parte del verso finalizza la prima, chiudendola idealmente. La principale se non l'unica ragione per cui Yǝhwāh lōhîm aveva piantato questo giardino, nella terra di ʿĒḏẹn (in principio o a oriente), era perché l'uomo potesse vivere e dimorarvi per sempre. Il gan ʿĒḏẹn si configura quale simbolo della perfezione del creato, perfezione a cui l'uomo è chiamato a partecipare. | Wayyiqqaḥ Yǝhwāh lōhîm eṯ-hāʾāḏām; wayyanniḥēhû ḇǝan-ʿĒḏẹn lǝʿāḇǝḏāh walǝšāmǝrāh. | E Yǝhwāh lōhîm prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di ʿĒḏẹn affinché lo coltivasse e lo custodisse. | Bǝrēʾšîṯ [2: ] |
E possiamo anche prestare una fugace attenzione all'errore di sintassi presente in questa frase: i due femminili lǝʿāḇǝḏāh walǝšāmǝrāh, «la coltivasse e la custodisse», sfuggiti all'attenzione dei redattori, non possono riferirsi al maschile gan, «giardino». Oggetto del lavoro e della tutela dell'uomo doveva essere piuttosto il femminile ăḏāmāh, «terra». Il testo della Bǝrēʾšîṯ mostra ripetute tracce di interventi letterari, segni di una nuova teologia che ha ridisegnato il preesistente substrato mitico. Ciò che ci interessa, tuttavia, è l'idea sottesa a questo passaggio, ed è un'idea sfolgorante, forse del tutto nuova nel panorama medio-orientale: l'uomo è stato destinato all'incorruttibilità e alla perfezione. Il gan ʿĒḏẹn è il luogo privilegiato dove l'umano partecipa del divino. Ma come ben sappiamo, noi che abbiamo seguito le disavventure di Ḥawwāh e gli inganni di Pandṓra
Ⓐ▼, questa comunione si è spezzata e la vita dell'uomo è oggi segnata dal dolore e della morte. Il mondo, lungi dall'essere un giardino, è un deserto di pietre e di spine. Nella perfezione primordiale è già insita la caduta ed essa si affaccia nel mito biblico col contrasto di due simboli arborei. | Wa-yyaṣmaḥ Yǝhwāh lōhîm min-hāʾăḏāmāh, kāl-ʿēṣ nẹḥmāḏ lǝmarʾeh wǝṭôḇ lǝmaʾăḵāl wǝʿēṣ haḥayyîm bǝṯôḵ haggān wǝʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ. | E Yǝhwāh lōhîm fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli all'aspetto e buoni da mangiare e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. | Bǝrēʾšîṯ [2: ] |
Vi sono dunque, nel giardino meraviglioso, due alberi fatali. Lo ʿēṣ haḥayyîm, l'«albero della vita», e lo ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male». Questo è l'unico verso in cui i due alberi vengano citati insieme, giacché, nel seguito dell'episodio, sarà il solo albero della conoscenza ad occupare tutta la scena, mentre l'albero della vita sarà nominato di nuovo soltanto nella chiusa.
Non vi è simmetria tra i due alberi: nell'economia del testo hanno
un'importanza diversa e nemmeno presentano una specularità di valenze. Inoltre, gli esegeti si sono a lungo domandati quale fosse l'effettivo significato della «conoscenza» [daʿaṯ] rappresentata dal secondo albero. In alcuni passi, la Bibbia tratta della conoscenza del bene e del male come nozione generica che differenzia l'età matura dall'infanzia («I vostri figli che non distinguono oggi il bene dal male» (Dǝḇārîm [1: ])) o come difficile acquisizione della tarda vecchiaia («Ne ho compiuti ottanta oggi: so forse ancora distinguere tra il bene e il male?» (Šǝmûʾēl Bēyṯ [19: ])). Alcuni autori, forse un po' superficialmente, hanno suggerito che la coppia coordinata «bene» [ṭôḇ] e «male» [rāʿ], associata al concetto di «conoscenza» [daʿaṯ], non fosse che un'aggiunta retorica per definire l'idea di una sapienza generale. Comunque sia, lo ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male», fa la sua comparsa avvolto da una luce minacciosa. | Wayṣaw Yǝhwāh lōhîm ʿal-hāʾāḏām lēʾmōr; mikkōl ʿēṣ-haggān āḵōl tōʾḵēl. | Poi Yǝhwāh lōhîm diede all'uomo quest'ordine: “Tu puoi mangiare di ogni albero del giardino. | | Ûmēʿēṣ, haddaʿaṯ ṭôḇ wā-rāʿ, lōʾ ṯōʾḵal mimmennû; kî, bǝyôm ăḵālǝḵā mimmennû môṯ tāmūṯ. | Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché il giorno in cui ne mangiassi, di certo moriresti”. | Bǝrēʾšîṯ [2: -] |
I simboli sono in grado di sorreggere un gran numero di interpretazioni e non si sbaglia asserendo che il giardino di ʿĒḏẹn è il luogo che precede il tempo e la storia. L'uomo ha pieno accesso all'albero della vita ma, per qualche ragione, quello della conoscenza del bene e del male gli è precluso. “Perché il giorno in cui ne mangiassi, di certo moriresti”. Con questo ammonimento l'asimmetria tra i due alberi viene di fatto annullata. La «vita» offerta dal primo albero non viene opposta dialetticamente alla «conoscenza» che caratterizza il secondo albero, bensì, tramite la conoscenza stessa, alla morte che è figlia del tempo. Il coraggioso lettore che ci ha seguito fin qui sa bene di cosa stiamo parlando. Nei testi rabbinici di epoca tardo-antica, preoccupati di districarsi tra questi due alberi tanto sbilanciati e asimmetrici, si affacciò l'idea di un diretto antagonismo tra l'«albero della vita» e l'«albero della conoscenza», nella quale il secondo assumeva i tratti di un vero e proprio «albero della morte». Quest'idea viene esplicitata nel Tannāʾ dǝḇēy liyyāhû rabbah (l'«Insegnamento della scuola di liyyāhû»,
✍ IX sec.), dove la locuzione ʿēṣ mawet, «albero della morte», veniva messa
esplicitamente in relazione con «la pianta che il Santo, sia egli benedetto, aveva proibito al primo uomo, ma di cui questi si nutrì, procurando la morte a sé e alla sua discendenza futura, sino alla fine di tutte le generazioni» (Tannāʾ dǝḇēy liyyāhû rabbah [V]). Ogni ordine porta in sé l'impronta della propria trasgressione. Il seguito del racconto è stato da noi abbondantemente citato quando abbiamo parlato della creazione della donna. Ma non sarà male riportarlo ancora una volta: | Wǝ hannāḥāš hāyāh ʿārûm mikkōl ḥayyaṯ haśśaḏẹh, ăšẹr ʿāśāh Yǝhwāh lōhîm wayyōʾmẹr ẹl-hāʾiššāh a kî-ʾāmar lōhîm, lōʾ ṯōʾḵǝlû mikkōl ʿēṣ haggān. | Ora il serpente era astuto più di tutte le fiere della steppa che Yǝhwāh lōhîm aveva fatto, e disse alla donna: “È dunque vero che lōhîm vi ha detto: “Non dovete mangiare di tutti gli alberi del giardino?” | | Wattōʾmẹr hāʾišsāh, ẹl hannāḥāš: mippǝrî ʿēṣ-haggān nōʾḵēl. | Rispose la donna al serpente: “Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare. | | Wûmippǝrî hāʿēṣ ăšẹr bǝṯôkǝ-haggān āmar lōhîm lōʾ ṯōʾḵǝlû mimmẹnnû wǝlōʾ ṯiggǝʿû bô: pẹn-tǝmuṯun. | “Ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, lōhîm ha detto: ‘Non lo dovete mangiare e non lo dovete toccare, per paura che ne moriate’.” | | Wayyōʾmẹr hannāḥāš, ẹl-hāʾiššāh: lōʾ-moṯ, tǝmuṯûn. | Ma il serpente disse alla donna: “No, voi non morirete. | | Kî yōḏēʿ lōhîm, kî bǝyôm ăḵālkẹm mimmẹnnû wǝniqǝḥû ʿênêḵẹm; wihyîṯẹm, kēʾlōhîm yōḏǝʿê, ṭoḇ wārāʿ. | “Anzi, lōhîm sa che il giorno in cui voi ne mangerete, si apriranno allora i vostri occhi e diventerete come lōhîm: conoscitori del bene e del male”. | | Wattērẹʾ hāʾišsāh kî ṭoḇ hāʿēṣ lǝmaʾăḵāl wǝḵî ṯaʾăwāh-hûʾ lāʿênayim, wǝnẹḥmāḏ hāʿēṣ lǝhaśkîl wattiqqaḥ mippiryô, wattōʾḵal wattittēn gam-lǝʾîšāh ʿimmāh, wayyōʾḵal. | Allora la donna vide che l'albero era buono a mangiarsi, e che esso era seducente per gli occhi e che era, quell'albero, desiderabile per avere la conoscenza; perciò prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. | | Wattippāqaḥnāh, ʿênê sǝnêhẹm wayyēḏǝʿû kî ʿêrummim hēm... | Allora si aprirono gli occhi di ambedue e conobbero che essi erano nudi... | Bǝrēʾšîṯ [3: -] |
 | | Tentazione di Āḏām e Ḥawwāh (✍ 1424-1425) | Masolino da Panicale (1383-1447)
Cappella Brancacci, chiesa di Santa Maria del Carmine, Firenze. |
Dobbiamo ora staccarci dall'uomo e dalla donna per esaminare il terzo protagonista di questo dramma primordiale e chiederci perché proprio il nāḥāš, il serpente, interpreti, tra tutti gli animali, il ruolo del responsabile della perdita dell'immortalità. Il racconto biblico, che balza nelle pagine del Bǝrēʾšîṯ già costruito con perfetta coscienza dei simboli mitici, ha evidentemente ereditato la figura del serpente da un'epoca ancora più remota. I redattori che fissarono il testo nella forma attuale, attorno al V secolo a.C., non vollero rinunciare a questo mitema antichissimo e di cui ancora percepivano
un barlume del senso originale. I secoli successivi vollero identificare il nāḥāš con Sama˒ēl che, prima di diventare il demonio, era l'angelo della morte e della distruzione.
È una logica evoluzione nell'interpretazione della figura del
serpente. Ma più risaliamo il tempo più diviene evidente che il nāḥāš non era né un angelo né un dèmone, ma una sorta di guardiano dell'albero della vita. E quale altro animale poteva essere più indicato del nāḥāš? Il serpente è la sola creatura che abbia facoltà di uscire dalla propria pelle e tornare giovane. Il Bǝrēʾšîṯ concentra tutta la sua attenzione sullo ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male», lasciando lo ʿēṣ haḥayyîm, l'«albero della vita», in secondo piano. Quest'inelegante compresenza di due alberi al centro del gan ʿĒḏẹn, peraltro pure asimmetrici nel loro gioco di attributi e di valenze, ha sempre turbato non poco gli esegeti, tanto che la successiva speculazione rabbinica si preoccuperà non poco di interpretarli nell'ordine di una simbologia più equilibrata.
①▼ È tuttavia
possibile che anche i due alberi siano il risultato di un maldestro lavoro di elaborazione del testo da parte dei suoi redattori. Quasi tutta l'esegesi moderna si trova d'accordo sull'ipotesi che, nella fonte di Bǝrēʾšîṯ [2-3], vi fosse stato un solo albero. Ma quale dei due? L'opinione maggioritaria è quella avanzata dal teologo Karl Budde (1850-1935), secondo il quale l'unico albero presente nella fonte era il ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male», mentre il ʿēṣ haḥayyîm, l'«albero della vita», sarebbe stato aggiunto in un intervento redazionale. Conclusione giustificata dal fatto che il racconto del Bǝrēʾšîṯ parla quasi unicamente dell'albero della conoscenza, mentre l'albero della vita è citato solo all'inizio e alla fine della vicenda (Bǝrēʾšîṯ [2: | 3: ]). Quest'ultimo sarebbe dunque un semplice elemento decorativo, un leit-motiv della letteratura medio-orientale finito per incastrarsi chissà come nel testo biblico (Budde 1883). Con maggior sottigliezza, Claus Westermann (1909-2000) ha fatto però notare che in origine l'unico albero non dovesse avere alcuna specificazione: il suo nome e ruolo sarebbero stati ricavati solo in fase di redazione, a partire da una frase pronunciata dal serpente: “diventerete come lōhîm, conoscitori del bene e del male” [wihyîṯẹm, kēʾlōhîm yōḏǝʿê, ṭoḇ wārāʿ] (Westermann 1966). L'errore, come suggerisce Aldo Magris, è leggere il Bǝrēʾšîṯ presumendo che l'ideologia del testo coincida in tutto o in parte con quella già presente nelle sue fonti: come se i suoi redattori si fossero limitati ad aggiustare dei dettagli secondari lasciando inalterato il senso profondo della narrazione (Magris 2003). L'intentio auctorum assegna il ruolo decisivo al ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male», e incentra la trasgressione di Āḏām su un atto di orgoglio intellettuale. Ma era questa l'ideologia della fonte originale? Il fatto che svariate leggende su alberi, piante e frutti in grado di elargire la vita e l'immortalità siano ben noti alla mitologia universale, e alcuni di essi siano attestati nelle tradizioni medio-orientali, indica che il motivo del ʿēṣ haḥayyîm sia più antico di quello del ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, il quale, al contrario, sembra essere un'innovazione introdotta dai redattori del Bǝrēʾšîṯ. Ci conforta sapere che l'albero della vita è attestato in diversi passi scritturali (es. Yǝḥẹzqēʾel [42: ]), mentre non si parla mai dell'albero della conoscenza in contesti estranei al Bǝrēʾšîṯ. È anche paradossale che la stessa tradizione giudaica identifichi Ḥọḵmāh, la «sapienza», con l'albero della vita e non con quello della conoscenza (Mišlê [3: ]). Dunque, se la nostra idea è corretta, e se l'antemito del gan ʿĒḏẹn contemplava, quale unico albero, l'albero della vita, possiamo allora chiederci quale forma
aveva avuto il racconto prima che gli ignoti redattori del Bǝrēʾšîṯ
lo adattassero alla nuova teologia. E qual era stato il ruolo
originale del nāḥāš? È impossibile stabilirlo con certezza, ma niente ci impedisce di imbastire alcune ipotesi. L'unica possibile traccia potrebbe provenirci dal mito di Adapa... Conosciamo questo importante mito mesopotamico da una serie di tavolette
redatte sia in accadico che in sumerico. Il dio-cielo An/Anu offre al pescatore Adapa il pane e l'acqua della vita, ma il consiglio fraudolento di Enki/Ea – il dio della sapienza, creatore dell'uomo – farà sì che Adapa rinunci al grande dono e non venga ammesso al consesso degli immortali:
| | Gli si placò il cuore, ed [Anu] disse:
“Perché Ea a un'umanità imperfetta
i misteri del cielo e della terra ha rivelato?
Un cuore gagliardo ha posto in
lui;
egli ha dunque fatto ciò!
Noi cosa potremo fare per lui?
Cibo di vita prendete per lui, che ne mangi!”
Cibo di vita presero per lui, ma egli non ne mangiò;
acqua di vita presero per lui, ma egli non ne bevve. [...]
Anu lo guardò e gli sorrise:
“Orsù, Adapa! Perché non hai mangiato e non hai bevuto?
Proprio non vuoi vivere! Non possono gli esseri umani essere immortali?”
Ea, il mio signore, ha detto: “Non mangiare, non bere!”.
“Prendetelo, [riconducetelo] alla sua terra!” [...]
Anu dell'operato di Ea rise altamente:
“Chi altri tra tutti gli dèi del cielo e della terra, avrebbe potuto agire così?
Chi avrebbe osato considerare il proprio comando superiore a quello di Anu?” | Adapa [B - | ... | D -] |
L'intera struttura rivela un nuovo esito dello schema che già avevamo analizzato nel capitolo precedente: altro non è che una ulteriore versione del motivo dell'inganno che priva l'uomo dell'immortalità. Ma, nell'ipotesi vi fosse stato un mito analogo a questo alla base del racconto del Bǝrēʾšîṯ, possiamo chiederci: chi tra i due personaggi, Yǝhwāh lōhîm e il nāḥāš, intendeva offrire all'uomo l'immortalità? E chi dei due lo ha ingannato? La risposta non è affatto scontata. Anzi, le numerose ambiguità di cui è infarcito il testo biblico – dovute agli interventi con cui il redattore ha cercato di adattare un mito precedente alla nuova ideologia – contribuiscono ad alimentare i nostri sospetti. Leggendo attentamente le parole di Yǝhwāh e del nāḥāš, non c'è dubbio, infatti, che sia quest'ultimo a dire la verità. Yǝhwāh aveva ammonito Āḏām e la donna (che poi verrà chiamata Ḥawwāh) di non mangiare il frutto del ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, avvertendoli che, se avessero trasgredito, sarebbero morti. Ma il nāḥāš smentisce la dichiarazione divina: “No. Voi non morirete”, e aggiunge: “Anzi, lōhîm sa che il giorno in cui voi ne mangerete, si apriranno allora i vostri occhi e diventerete come lōhîm: conoscitori del bene e del male” (Bǝrēʾšîṯ [3: -]). Ed è esattamente quel che accade. Il serpente non ha affatto mentito.
E lo stesso Yǝhwāh lōhîm
lo ammette senza reticenze: | Wayyō˒mẹr Yǝhwāh lōhîm, hēn hā˒āḏām hāyāh kǝ˒aḥaḏ mimmẹnnû, lāḏa˓aṯ ṭôḇ wārā˓; wǝ˓attāh pẹn-yišlaḥ yāḏô, wǝlāqaḥ gam mē˓ēṣ haḥayyîm, wǝ˒āḵal wāḥay lǝ˓ōlām. | Yǝhwāh lōhîm disse: “Ecco l'uomo è diventato come uno di noi nella conoscenza del bene e del male. Ora dunque, che egli non stenda la mano e non colga anche dell'albero della vita e ne mangi e viva in eterno...” | | Bǝrēʾšîṯ [3: ] |
Da questa frase traspare che: (a) Yǝhwāh lōhîm aveva tenuto nascosta ad Āḏām la virtù del ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ e gli aveva vietato di mangiare i frutti dell'albero allo scopo di negargli la capacità di distinguere il bene dal male (e stante tali premesse, diventa arduo comprendere come l'uomo e la donna possano avere responsabilità di una colpa commessa prima di aver acquisito la «conoscenza del bene e del male»); (b) Yǝhwāh non aveva tuttavia mentito su un dettaglio: Āḏām e Ḥawwāh, avendo mangiato il fatidico frutto, dovranno morire. Ma non a causa di qualche proprietà mortale del frutto stesso: come il nāḥāš aveva
assicurato, Āḏām e Ḥawwāh lo hanno mangiato e non sono morti. Ma è lo stesso Yǝhwāh, ora, a non poter permettere l'esistenza di un'umanità immortale e per di più dotata della capacità di formulare giudizi etici. O l'una o l'altra cosa: non entrambe. Dunque Yǝhwāh non aveva semplicemente messo in guardia Āḏām e Ḥawwāh, li aveva praticamente ricattati. Questo pasticcio, incomprensibile alla luce di una disamina razionale, ha tuttavia le radici ben piantate nelle concezioni mitologiche mesopotamiche e medio-orientali, concezioni da cui il popolo di Israele, appena affrancatosi dalla cattività babilonese, cerca di sbarazzarsi per sviluppare una teologia originale. Era necessario che gli antichi miti cananei, che nel V secolo a.C. dovevano essere ancora ben radicati nella memoria popolare, venissero riletti secondo nuove chiavi di lettura. Il redattore dovette intervenire sulle fonti in modo piuttosto cauto, in modo che gli antichi miti di substrato
rimanessero riconoscibili, sebbene alterandoli ideologicamente. Non sappiamo se la nostra ipotesi sia corretta, e se la fonte di Bǝrēʾšîṯ [2-3] contemplasse – come diverse altre tradizioni medio-orientali – il mito di un dio geloso che ha ingannato gli uomini privandoli dell'immortalità: quel che è certo è che il redattore cercò, con alterazioni minime, di costruire un testo «canonico» dove l'uomo
fosse responsabile della propria caduta, grazie all'ingenuità della donna e alla malizia del nāḥāš, e di presentare una nuova teologia nazionale dove Yǝhwāh apparisse giusto e infallibile.
②▼ Le simbologie sono, più che complesse, inestricabilmente stratificate. Quale metafora teologica, il giardino di ʿĒḏẹn è luogo di perfezione e di immortalità, simbolo della primordiale immutabilità che precede la nascita del tempo, e dunque, territorio interiore dove l'uomo è una sola cosa con il suo principio creatore. La rottura psicologica tra umano e divino, che il mito interpreta come accadimento fatale avvenuto alle origini della storia, viene fatta risalire al nostro comune progenitore Āḏām, il cui peccato è stato ereditato dall'intero genere umano. Attraverso la conoscenza del bene e del male l'uomo è uscito dall'eternità ed è entrato nel tempo, e il tempo è mutamento e dolore e morte. La maledizione che Yǝhwāh getta sull'uomo è insita nella stessa natura del mondo temporale: | ...ʾărûrāh hāʾăḏāmāh, baʿăḇûrẹḵā bǝʿiṣṣāḇôn tōʾḵǝlẹnnāh kōl yǝmê ḥayyêkā. | “...maledetto sia il suolo per causa tua. Con fatica ne trarrai il nutrimento tutti i giorni della tua vita. | | Wǝqôṣ wǝḏardar taṣmîaḥ lāḵ; wǝʾāḵaltā ẹṯʿēśẹḇ haśśāḏẹ. | “Ti germoglierà spine e cardi e tu mangerai le graminacee della campagna. | | Bǝzēʿaṯ appêḵā tōʾḵal lẹḥẹm, ʿaḏ šûḇǝḵā ẹl-hāʾăḏāmāh kî mimmẹnnāh luqqāḥtā: kî-ʿāār ʾattāh, wǝʾẹl-ʿāār tāšûḇ. | “Con il sudore del tuo volto mangerai pane, finché tornerai nel suolo, perché da esso sei stato tratto: infatti sei polvere e in polvere devi ritornare”. | | Bǝrēʾšîṯ [3: -] |
Si direbbe – una volta che la storia e la tradizione hanno reso «canonica» la visione post-esilica dei redattori del Bǝrēʾšîṯ – che il tempo stesso sia una conseguenza della capacità di discernere il bene dal male. L'esistenza nel mondo temporale sembra quasi concepita come una conseguenza all'avvenuta presa di coscienza dell'uomo. L'uomo è il solo essere del regno animale consapevole della propria morte, e il mito stesso, impalcatura psicologica del nostro cosmo interiore, è nato come risposta a questa consapevolezza. È dalla conoscenza del bene e del male che deriva la coscienza del tempo, del peccato e della morte. Alla fine di questo dramma primordiale, Yǝhwāh si premunisce affinché l'albero della vita rimanga per sempre precluso al genere umano. A oriente di ʿĒḏẹn (ma perché a
oriente?) vengono posti dei custodi, i
kǝrûḇîm, illuminati dal bagliore altrettanto enigmatico della
«spada guizzante», affinché nessuno possa mai più raggiungere l'«albero della vita». | Wayārẹš ẹṯ-hā˒āḏām; wayyaškēn miqqẹḏẹm lǝan-˓ēḏẹn ẹṯ-hakkǝruḇîm, wǝ˒ēṯ lahaṭ haḥẹrẹḇ hammiṯhappẹḵẹṯ, lišmōr ẹṯ-dẹrẹḵ ˓ēṣ haḥayyîm. | [Yǝhwāh] cacciò dunque l'uomo e pose a oriente del giardino di ʿĒḏẹn i
kǝrûḇîm e la fiamma della spada guizzante per custodire l'accesso all'albero della vita. | | Bǝrēʾšîṯ [3: ] |
Ecco. L'uomo è stato cacciato da ʿĒḏẹn. La rottura è avvenuta. L'umanità è ormai irrimediabilmente tagliata fuori dal giardino di immortalità. Ora abita nel mondo temporale e strappa il nutrimento alle asperità del suolo, guidata dal suo giudizio e dal suo libero arbitrio. Ma il tempo ha le sue regole, le sue necessità, le sue formule specifiche, e la morte è una delle sue leggi più severe. |
①▲ Paradossale il caso di rabbî Áron Chorin (1766-1844), pioniere dell'emancipazione giudaica, che in un suo pamphlet del 1798 – incentrato sul problema se lo storione fosse un alimento kāšēr –, trasse spunto dal Bǝrēʾšîṯ Rabbāh e conferì all'albero della vita delle dimensioni a dir poco immense, tali che un uomo avrebbe impiegato cinquecento anni per coprire una distanza pari al diametro del suo tronco, mentre non meno sterminato era il territorio ombreggiato dalla sua chioma, e aggiunse che l'albero della conoscenza del bene e del male lo circondava a guisa di una siepe, sicché solo colui che riusciva ad aprirsi un varco attraverso le fronde dell'albero della conoscenza avrebbe potuto raggiungere l'albero della vita (Imrê nô˓am). In questo modo, ponendo i due alberi l'uno al centro dell'altro, il solerte rabbino risolveva il problema posto dal fatto che fossero entrambi situati al «centro» (bǝṯôk) del giardino. |
| | |
②▲ I tentativi di riparare alle goffaggini del testo biblico avanzati nel corso dei secoli dagli esegeti delle Scritture, sia ebrei che cristiani, potrebbero riempire un'intera biblioteca.
I tentativi di trovare una giustificazione alle contraddizioni del comportamento di Dio sono legioni. Si narrava ad esempio che il frutto del ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ avrebbe effettivamente fatto morire Āḏām e Ḥawwāh prima della fine del giorno, ma Yǝhwāh stabilì che il giorno in questione fosse un «giorno divino» della durata di mille anni, ed è sicuramente questa la ragione per cui nessuno dei patriarchi antidiluviani raggiunse mai il millennio d'età (969 anni sono il record biblico di longevità, toccata a Mǝṯûšelaḥ). Si raccontava anche che lōhîm impedì all'uomo di mangiare allo ʿēṣ haḥayyîm perché, in tal caso, divenendo allo stesso tempo peccatore e immortale, sarebbe stato indistinguibile dai dèmoni. |
|
| | INDIETRO TRA I SUMERI: LA TERRA FELICE DI DILMUN La concezione di un'antica terra prospera e felice, di cui il biblico ʿĒḏẹn è il modello da cui abbiamo intrapreso il nostro cammino, trova riscontro nei poemi sumerici. Il nome di questa regione favolosa è Dilmun, e pare che all'origine dei tempi vi avesse dimorato il dio della saggezza, Enki/Ea. Esso compare, all'inizio del Secondo millennio
avanti Cristo, in un testo oggi conosciuto come Enki e Ninḫursa (ma il cui titolo originale era forse Iri kugkuggam, «Pura è la città»). Qui si descrive Dilmun, il luogo dove, all'origine del tempo, Enki risiedeva insieme alla consorte Ninsikila:
iri kug-kug-ga-àm e-ne ba-àm-me-en-zé-en kur dilmun kug-ga-àm
ki-en-gi kug-ga e-ne ba-àm-me-en-zé-en kur dilmun kug-ga-àm
kur dilmun kug-ga-àm kur dilmun sikil-àm
kur dilmun sikil-àm kur dilmun dadag-ga-àm
dili-ni-ne dilmun-a ù-bí-in-nú
ki den-ki dam-a-ni-da ba-an-da-nú-a-ba
ki-bi sikil-àm ki-bi dadag-ga-àm
dili-ni-ne dilmun-a ù-bí-in-nú
ki en-ki nin-sikil-la ba-an-da-nú-a-ba
ki-bi sikil-àm ki-bi dadag-ga-àm
dilmun-a uga gù gù nu-mu-ni-bé
dar-e gù dar-re nu-mu-ni-ib-bé
ur-gu-la sa iš nu-ub-ra-ra
ur-bar-ra-ke₄ sila₄ nu-ub-kar-re
ur-gi₇ máš gam-gam nu-ub-zu
šáḫ še gu₇-gu₇-e nu-ub-zu
nu-mu-un-sú munu₄ ùr-ra bárag-ga-ba
mušen-e an-na munu₄-bi na-an-gu₇-e
tu-e sa nu-mu-un-da-ru-e
igi-gig-e igi-gig-me-en nu-mu-ni-bé
sa-gig-e sa-gig-me-en nu-mu-ni-bé
um-ma-bi um-ma-me-en nu-mu-ni-bé
ab-ba-bi ab-ba-me-en nu-mu-ni-bé
ki-sikil a nu-tu₅-a-ni iri-a nu-mu-ni-ib-sig₁₀-ge
lú íd-da bal-e i₆-dè nu-mu-ni-bé
niir-e zag-ga-na nu-um-niin
nar-e e-lu-lam nu-mu-ni-bé
zag iri-ka i-lu nu-mu-ni-bé... | Pura è la città [...]: ma Dilmun è puro anch'esso!
Puro è il Kiengi [...]: ma Dilmun è puro anch'esso!
Dilmun è puro! Dilmun è santo!
Dilmun è santo! Dilmun è luminoso!
È quando egli vi si fu stabilito con la sua unica
[?]
quando Enki vi si fu stabilito con la sua sposa,
che questo paese divenne puro e luminoso!
Quando si fu stabilito a Dilmun con la sua unica [?]
questo paese, quando Enki vi si fu stabilito con Ninsikila,
questo paese divenne puro e luminoso!
A Dilmun, prima, non gracchiava il corvo,
il francolino non gridava “dar! dar!”,
il leone non uccideva,
il lupo non sbranava gli agnelli,
il cane selvaggio non razziava i capretti,
il cinghiale non divorava i raccolti,
gli uccelli non beccavano il malto
che le vedove spargevano sul tetto.
Non esisteva la colomba dalla testa china.
L'ammalato agli occhi non diceva: “Sono ammalato agli occhi!”,
colui che aveva mal di capo non diceva: “Ho mal di capo!”,
la vecchia non diceva: “Sono vecchia!”,
il vecchio non diceva: “Sono vecchio!”,
la fanciulla non si bagnava nell'acqua chiara,
il traghettatore non diceva: “Forza, issa!”,
l'araldo non andava in giro,
l'aedo non cantava: “Elulam!”
All'entrata della città non si udivano pianti... | Iri kugkuggam [-] |
Che il paese di Dilmun sia una prefigurazione del biblico ʿĒḏẹn lo si evince dal fatto che sono assenti malattie e vecchiaia, gli animali selvatici non predano i domestici, e tutto quanto si troverebbe sospeso in uno stato «paradisiaco», come ha sottolineato Samuel N. Kramer (Kramer 1945). Ma il testo lascia in sospeso un mucchio di interrogativi: perché insistere sulla non-presenza del male se poi non si dice come esso si sia introdotto nel paese? Come valutare quegli elementi che nulla hanno a che vedere con il male o l'infelicità, come il canto degli uccelli, il bagno della fanciulla o il canto dell'aedo? Sembra piuttosto, avverte Jean Bottéro, che questo brano sia una descrizione dello stato di originario non-essere (Bottéro ~ Kramer 1989). Sulla localizzazione del paese di Dilmun vi sono molte più notizie di quante non ve ne siano riguardo al biblico ʿĒḏẹn. Nel racconto sumerico del diluvio si dice che Ziudsura (sumerogrammi zi.ud.sù.rá, ma
ziu₄sud₄rà nella lista regale), lugal di Šuruppak, dopo aver condotto la sua arca attraverso le acque diluviali, sia stato poi ricompensato dagli dèi e condotto nel paese di Dilmun per condurvi una vita beata e immortale:
zi-ud-sù-rá lugal-àm
igi an en-líl-lá-šè kìri ki su-ub ba-gùb
an en-líl zi-ud-sù-rá mí-e-⌜èš⌝? [... dug₄ ...]
tìl diir-gin₇ mu-un-na-šúm-mu
zi da-rí diir-gin₇ mu-un-<na>-ab-èd-dè
ud-ba zi-ud-sù-rá lugal-àm
mu ní-gilim-ma numun nam-lú-ùlu ùri-ak
kur-bal kur dilmun-na ki utu éd-šè mu-un-tìl-eš... | Frattanto Ziudsura il lugal,
essendosi prostrato davanti ad An ed Enlíl,
questi si affezionarono a lui.
Inoltre gli concessero una vita simile a quella degli dèi:-
Un soffio di vita immortale, come quello degli dèi.
Ecco come Ziudsura, il lugal,
che aveva salvato gli animali e il genere umano,
fu insediato in una regione al di là del mare, a Dilmun, dove si leva Utu... | «Poema di Ziudsura» [V: -] |
Utu era il dio-sole sumerico: dunque il paese di Dilmun, «dove si leva Utu», il luogo dove Ziudsura era stato condotto dagli dèi per godere della vita eterna, si trovava anch'esso a oriente. È significativo che nel testo sumerico la notazione direzionale non sia soltanto geografica ma venga associata al dio-sole: ma è anche ovvio che l'«oriente» e l'«occidente» siano legati, per definizione, al sorgere e al tramontare del sole. Però il toponimo Dilmun, al contrario di ʿĒḏẹn, non compare soltanto nei testi mitologici, ma anche nei documenti storici e commerciali. In una tavoletta antico-babilonese si legge che re Šarru-kīnu di Akkad (Sargon I
il grande, ♔ ±2334-±2279 a.C.) faceva attraccare ai suoi porti navi provenienti da Magan, Meluḫḫa e Tilmun (AFO [20 37: -]). Altre due tavolette, una neo-assira e una tardo-babilonese, preservano parte di un testo, informalmente intitolato «La geografia di Sargon», dove si elencano tutte le terre anticamente governate dal mitico fondatore della dinastia di Akkad. Il testo, in cui l'esagerazione epica prevale sull'informazione storica, ci informa che Šarru-kīnu regnava su un lungo elenco di territori, tra cui compaiono:
a-na-kù kap-ta-ra
KUR.KUR(=mātātu) BAL.RI(=eberti) [tâm]ti AN.TA(=elīti)
tilmun má-gan-na
KUR.KUR (=mātātu) BAL.RI(=eberti) [tâm]ti KI.TA(=šaplīti)
ù KUR.KUR (=mātātu) ultu ṣīt UTU.⌜È⌝.[A](=ša[mši]) adi ereb... | ...Anaku e Kaptara,
le terre oltre il mare superiore,
Tilmun e Maganna,
le terre oltre il mare inferiore,
e le terre dall'alba al tramonto, la totalità di tutte le terre... | VAT 8006 [-] |
 | | Localizzazione ipotetica di località citate nei testi commerciali antico-babilonesi. |
L'affermazione di re Šarru-kīnu, di aver assoggettato l'intera estensione della terra «dall'alba al tramonto», non va certo presa sul serio. Tuttavia il primo re di Akkad controllava certamente un'ampia mezzaluna di territorio dal «mare superiore» [tâmtu elītu] al «mare inferiore» [tâmtu šaplītu], cioè dal Mediterraneo al
golfo Persico. I toponimi Anaku e Kaptara, Tilmun e Maganna, si riferiscono a regioni situate sicuramente oltre la sfera politica del regno di Akkad. Anaku non è stata identificata con certezza: si tratta forse di qualche località dell'Anatolia. Kaptara è però Creta. Maganna si trova quasi certamente sulla costa del ʿUmān, sebbene alcuni
studiosi abbiano proposto l'Īrān. Per Meluḫḫa sono state avanzate varie proposte ma la maggior parte degli archeologi ritiene la si possa identificare con il porto di Khaṃbāta, nella valle dell'Indo, o ancora più a est, con quello di Lothala, nel Gujārat. In quanto a Tilmun, un'iscrizione assira, questa volta risalente a Šarru-kīnu II di Aššur (♔ 722-705 a.C.), ci dà una precisa localizzazione geografica:
ú-pi-ri šàr tilmun ša malak 30 bēri i-na qabal tam-tim šá ṣi-it
šamši ki-ma nu-ú-ni nar-ba-ṣu šit-ku-nu-ma | Upiri, re di Tilmun, il cui territorio si trova a 30 bērû di distanza
nel mare del sole nascente. | Iscrizione di Šarru-kīnu II a Ḫursābād [65:-66:] |
La maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere che Dilmun vada da identificarsi con il territorio sulla costa orientale della penisola araba e/o con le odierne isole del Baḥrayn, nel
golfo Persico. Queste ultime distano circa 450 km dall'attuale accesso al mare ʿirāqeno, mentre la distanza fornita nell'iscrizione è un po' inferiore: un bēru (sumerico DA-NA) misurava infatti 10˙800 metri. Inoltre, poiché al-Baḥrayn si trova a sud, e non ad est, della terra di Sumer, altri studiosi hanno guardato piuttosto verso l'India. Secondo Kramer la terra felice di Dilmun andrebbe identificata con la regione di Haṛappā, nella valle dell'Indo.  | | Sigilli di Dilmun (2000-1800 a.C.) | Sigilli circolari, in steatite dal sito di Sār, al-Baḥrayn.
[Museo] Matḥaf al-Baḥrayn al-waṭanī. Al-Manāma, al-Baḥrayn. |
Il ritrovamento di sigilli provenienti da Haṛappā in siti mesopotamici e arabi, unito a quello dei bellissimi sigilli circolari tipici del Baḥrayn, ma rinvenuti tanto a Lothala, nel Gujārat, quanto sull'isola di Faylakā, dinanzi al Kuwayt, testimoniano l'esistenza, nella prima metà del Terzo millennio avanti Cristo, di rotte commerciali che collegavano il
golfo Persico alla costa indo-pakistāna. In epoca presargonica, al-Baḥrayn era un vivace porto di transito e di smistamento di merci che fungeva da raccordo tra la valle dell'Indo e la Mesopotamia. I Sumeri importavano rame da Tilmun, diorite da Maganna, pietre semipreziose (cornaline e lapislazzuli) dall'Elam o dall'Īrān, avorio e ebano da Meluḫḫa. In quanto alle esportazioni, consistevano probabilmente in ceramiche, granaglie, filati di lana, datteri, forse olio. I Sumeri non possedevano una vocazione marinara: i loro miti parlano sovente di avventurose spedizioni verso le montagne, mai di viaggi per mare. Le loro imbarcazioni fluviali potevano discendere i fiumi lungo la corrente e, al limite, svolgere qualche servizio di piccolo cabotaggio presso la foce dell'Eufrate, ma è improbabile che potessero affrontare il mare aperto e arrivare fino al Baḥrayn. Erano le navi straniere a risalire l'Eufrate e i canali navigabili per commerciare con le città sumere. Alcune di queste, come Ur, possedevano dei porti ben attrezzati ed erano centri di traffici piuttosto importanti. Questo potrebbe spiegare perché i Sumeri non avessero un'idea precisa di dove si trovassero località come Tilmun e Meluḫḫa. Il culmine di quest'epoca di floridi commerci può essere collocata, più o meno, al tempo di Gudea, ensi di Lagaš (♔ 2144-2124), il quale faceva arrivare legname da Tilmun e da Meluḫḫa, diorite da Maganna, oro grezzo e corniola da Meluḫḫa,
e via dicendo. Ma dopo la III dinastia di Ur, al chiudersi del Terzo millennio avanti Cristo, una serie di eventi influenzò negativamente gli scambi commerciali della Mesopotamia con gli altri paesi. All'affermarsi della potenza antico-babilonese, che sposterà l'asse politico-economico verso nord, corrisponde il progressivo arretramento delle foci del Tigri e dell'Eufrate che, a causa dei depositi alluvionali, renderà sempre più difficile il traffico fluviale. Parallelamente il crollo della civiltà della valle dell'Indo, in parte dovuto alle invasioni ariane, dal XVIII secolo a.C., e l'occupazione del Baḥrayn da parte dei Cassiti, mezzo millennio più tardi, chiuderanno definitivamente questo felice periodo. Bisognerà attendere l'epoca ellenistica per vedere rifiorire il commercio sul
golfo Persico. Questa, in sintesi, la situazione storica, così com'è stata definita dagli archeologi, e rimandiamo il lettore interessato alla materia a opere ben più approfondite. Noi torniamo piuttosto alle nostre tavolette impresse a pittogrammi e cuneiformi, le più dirette testimoni del pensiero e dei sogni dell'antico popolo di Sumer, nonché delle trionfali dichiarazioni dei loro diretti successori, i re antico-babilonesi. I documenti sembrano muoversi su due distinti livelli: concezioni mitiche e percezioni geografiche vengono a confondersi tra loro. Dilmun è un ben preciso territorio da cui arrivano navi e merci, identificabile con il Baḥrayn, ma è contemporaneamente il favoloso giardino di immortalità posto in un oriente cosmologico, in un luogo sacro al sole nascente, e dove gli dèi hanno condotto il mitico
Ziudsura dopo averlo reso immortale. Come si spiega questa dicotomia? Gli studiosi hanno avanzato in proposito opinioni piuttosto divergenti. Il fatto che i Sumeri non avessero un'idea precisa della localizzazione di certe regioni lontane, di cui avevano notizia dai mercanti stranieri, non spiega perché avessero posto il loro ʿēḏẹn proprio a Dilmun, nel Baḥrayn. L'identificazione del territorio geografico con il tópos mitico deve avere ragioni diverse. Una possibilità da prendere in seria considerazione è che abbiano assorbito il mito di Dilmun da una cultura di substrato. Sebbene sulle origini dei Sumeri vi siano poche certezze, gli archeologi tendono a pensare che essi siano arrivati dal territorio dei monti Zāgros, come ci mostrano i reperti archeologici, e che si siano poi integrati con le culture presenti nel sud della Mesopotamia, in particolare quella di Uruk e quella di al-ʿUbayd. Sembra che la navigazione fosse ben conosciuta nel periodo ʿUbayd 3 (4500-4000 a.C.),
a cui risalgono manufatti diffusi sulle coste arabe, oltre a relitti di imbarcazioni rinvenute in Kuwayt (Carter 2006).
La cultura ʿubaydiana potrebbe essere stata il tramite attraverso il quale i Sumeri – popolo dalle tradizioni montane – si siano messi a favoleggiare di terre incantate poste sui lontani mari orientali. Ma anche se dessimo valore a certe ipotesi, permane intatta la difficoltà di integrare il Dilmun dei testi mitologici e il Tilmun dei documenti commerciali. Spiegare il mito tramite la «deformazione» di antiche memorie storiche, sia pure assorbite da una cultura di substrato, non rende un buon favore alla nostra analisi dei processi di mitopoiesi. La riscoperta di Dilmun, nei primi decenni del XX secolo, ebbe l'effetto di dare un novello impulso alle ricerche di una localizzazione geografica del gan ʿĒḏẹn, dopo che gli orientalisti avevano ormai esaurito tutte le valli, i siti, le oasi, da Palmýra alla Mesopotamia, dove fosse possibile individuare il mitico giardino. A partire dal lavoro di William Foxwell Albright, che trovava l'origine del mitema edenico in Dilmun (Albright 1922),
qualsiasi lavoro di localizzazione di ʿĒḏẹn ha dovuto necessariamente contemplare il
golfo Persico, la costa araba e il Baḥrayn,
se non addirittura la valle dell'Indo. In alcuni dei lavori più
recenti, gli specialisti hanno tenuto conto che nel 6000 a.C. il
livello del golfo Persico era notevolmente più basso di quello
attuale e quindi hanno avanzato l'ipotesi che il gan ʿĒḏẹn potesse trovarsi vicino all'attuale costa ʿirāqena, in un'area oggi sommersa dal mare (Hamblin 1987). La letteratura, in proposito, è immensa, ed è arduo poter aggiungere qualcosa di nuovo. E qui bisogna sbarazzarci di un pregiudizio, o forse soltanto di un metodo fuorviante. Molti studiosi ritengono che basti localizzare un sito mitologico sull'atlante per darne una spiegazione definitiva. Ma a ben guardare, l'inconciliabilità tra la geografia reale e mitologica è un elemento costante in tutte le tradizioni del mondo. Si pensi al paese degli Hyperbóreoi, ad
Ynys Afaỻon, al Hawaiki polinesiano. Nonostante le pie illusioni dei cartografi, la maggior parte di questi luoghi non
sono il ricordo deformato di una geografia reale, ma si sono
sviluppati da elaborazioni narrative di antiche concezioni
cosmologiche. La localizzazione di questi mitòtopi con un luogo reale è sempre un processo a posteriori. E qualora un luogo mitico sia il ricordo deformato di qualche patria lontana, il luogo in questione è ormai talmente simbolizzato da rendere non solo arduo il riconoscimento, ma ridicolo il problema della sua corrispondenza con il luogo di ispirazione. Queste note basteranno per dichiarare i nostri intenti e, insieme, di sbarazzarci di tanti ottimistici tentativi di localizzare il giardino di ʿĒḏẹn sugli atlanti geografici. Nel nostro viaggio troveremo un gran numero di monti, fiumi e mari che appartengono contemporaneamente al piano geografico e quello mitologico. Ma ciò di cui parleremo, ciò che metteremo in correlazione, sono semplicemente le necessità del mito, il convergere di antichissime cosmologie di cui il mitema del giardino di immortalità è un elemento imprescindibile e necessario. | L'EPOPEA DIMENTICATA: IL RITORNO DEL RE DI URUK Per secoli, la Bibbia aveva costituito l'unica inappellabile testimonianza della cultura, della religione e della mitologia dell'antico Oriente. Le cose cambiarono, e piuttosto bruscamente, il 3 dicembre 1872 quando, nel corso di un'affollata conferenza, nella prestigiosa sede della Biblical Archaeological Society a Londra, l'orientalista dilettante George Smith (1840–1876) rivelò al mondo che un antico racconto del diluvio universale era tornato alla luce tra le perdute rovine della Mesopotamia. O per essere più precisi, tra le migliaia di frammenti di tavolette «caldee» (come allora si diceva) che da almeno vent'anni giacevano nel più totale disordine nei magazzini del British Museum. Queti frammenti erano il risultato di svariate campagne di scavo che si erano accanite attorno ai tilāl di Qūyunǧiq e Nabī Yūnus, nel luogo dove più di due millenni prima sorgeva l'orgogliosa Ninive (accadico Ninwe, ebraico Nînwēh, greco Nineuḗ), antica capitale d'Assiria. Il territorio – siamo nel ʿIrāq settentrionale, non lontano dall'odierna al-Mawṣil – apparteneva all'impero ottomano e gli archeologi, perlopiù inglesi e francesi, agivano in aperta competizione tra loro, destreggiandosi con tutte le armi fornite dalla diplomazia e della burocrazia nel tentativo di occupare i siti migliori e, allo stesso tempo, cercando di ostacolare il lavoro dei rivali.  | | Gli scavi di sir Austin Henry Layard a Ninive | | Frontespizio di A popular account of discoveries at Nineveh (Layard 1851). |
Primo a scavare sul luogo era stato, nel 1846, l'italo-francese Paul-Émile Botta (1802-1870), il quale, non trovando nulla di significativo, aveva spostato le ricerche a tall Ḫursābād, a una ventina di chilometri da tall Qūyunǧiq, dove aveva rinvenuto i magnifici resti di Dūr Šarru-kīnu,
la fortezza di re Šarru-kīnu II. Le sensazionali scoperte di Botta avevano convinto gli inglesi a intervenire: l'allora console di Baġdād, sir Henry Rawlinson (1810-1895), lui stesso valente orientalista, riuscì a farsi finanziare una serie di campagne di scavo, che affidò a sir Austin Henry Layard (1817-1894), faccendiere, diplomatico, giornalista e orientalista, il quale ripagò in breve gli investimenti, riportando alla luce gli splendidi palazzi assiri a tall Nimrūd e i resti di Kalḫu. Tra il 1849 e il 1951, Layard tornò tuttavia a scavare sul tall Qūyunǧiq e rinvenne, sul lato nord della collina, settantun ambienti che mostravano chiare tracce di devastazioni e incendi. Aveva scoperto il palazzo del re assiro Sîn-aḫḫī-erība (Sennacherib, ♔ 705-681 a.C.), saccheggiato dai Medi e dai Babilonesi nel 612. Tra molti preziosi reperti – ortostati di marmo, portali, tori alati... –, Layard trovò una gran quantità di tavolette incise a cuneiformi. Ma a questo punto i francesi fecero valere i loro diritti di precedenza – Botta era stato in situ cinque anni prima – e bloccarono il lavoro degli inglesi. Tra le polemiche, Rawlinson s'incontrò con il console francese di al-Mawṣil, Victor Place, lui stesso archeologo dilettante, e i due stabilirono di dividersi i luoghi di scavo. Tornato Layard a Londra, il suo posto fu preso nel 1852 dall'«assiro» (arabo-cristiano) Hurmuzd Rassām (1826-1910), una singolare figura di archeologo-avventuriero dalla dubbia deontologia professionale. Contrariato dal fatto che ai francesi fosse toccato il lato settentrionale del tall Qūyunǧiq, da lui considerato assai promettente, Rassām approfittò dell'assenza dei francesi, i quali pare si fossero temporaneamente spostati a tall Ḫursābād, per scavare di nascosto nel loro campo durante la notte, e portò alla luce una gran quantità di preziosi reperti e tavolette. Aveva scoperto il palazzo di Aššur-bāni-apli (Assurbanipal, ♔ 668-631 a.C.). Questa invasione di campo suscitò indignazione tra i francesi: Place diede subito ordine di riaprire i cantieri a tall Qūyunǧiq e, soprattutto, di non lasciar trapelare nulla su quanto avessero trovato. Ben presto la loro pazienza e tenacia venne ripagata. Tuttavia il capo-operaio degli archeologi francesi, un arabo di origine albanese, era stato corrotto da Rassām affinché lo informasse di quanto i rivali andavano scoprendo. Rassām seppe così che Place era penetrato in una serie di stanze colme di inestimabili reperti, di cui la quinta appariva piena di tavolette bruciate e spezzate. Poiché la scoperta era stata fatta di giovedì, e il giorno dopo gli operai musulmani osservavano il riposo settimanale, Rassām riunì nottetempo una cinquantina di operai e, alla luce delle candele, fece scavare un tunnel dal suo settore a quello francese e fece man bassa di tutto. Possiamo immaginarci la costernazione di Place allorché, il sabato mattina, trovò vuote tutte le stanze, compresa la preziosa biblioteca! Rassām negò di essere l'artefice del saccheggio. Due mesi dopo le preziose tavolette di Aššur-bāni-apli si trovavano in un magazzino del British Museum. (Pettinato 1992 | D'Agostino 1997) Ci vollero anni perché gli studiosi riuscissero a catalogare tutti i frammenti, giunti a destinazione in stato di totale disordine. Ed è qui che, alla disonestà e ai sbrigativi saccheggi di Rassām fa da contraltare il lavoro metodico e paziente di George Smith. Questo giovanotto, un orientalista dilettante ma entusiasta, era stato assunto nel British Museum proprio perché desse una mano a catalogare delle migliaia di frammenti giunti dalla Mesopotamia. Per capire l'enormità del lavoro, basti pensare che a oggi la banca dati del British Museum contempla oltre trentamila frammenti provenienti dalla Biblioteca di Ninive e ancora non è stato compilato un catalogo completo e definitivo del materiale. Nel sistemare i reperti di tall Qūyunǧiq, lo sguardo di Smith era caduto su un testo dove si parlava di una nave arenata contro una montagna e dell'invio di una colomba che, non riuscendo a trovare un posto dove fermarsi,
era tornata indietro. Subito Smith aveva cercato altri frammenti appartenenti alla stessa serie e, quando ebbe messo insieme un documento leggibile, si accorse di avere tra le mani un lungo e complesso poema di epoca assira (VII sec. a.C.) incentrato su un sovrano della città sumerica di Uruk (la biblica Ẹrẹḵ), il cui nome, inizialmente letto come IZ.DU.BAR, sarebbe stato in seguito restituito nella forma di Gilgameš.  | | Tavola XI della «serie di Gilgameš» | | British Museum, Londra (Regno Unito) |
La serie completa constava di dodici tavolette, ma era l'undicesima destinata a sollevare un certo clamore presso filologi e biblisti. Il mito del diluvio, che tornava alla luce dopo venticinque secoli, era il primo – eccezion fatta per la leggenda ellenica di Deukalíōn – che provenisse da un contesto extra-biblico. La conferenza con cui George Smith annunciò la sua scoperta, il 3 dicembre 1872, fu anche l'inizio di un'annosa querelle nota con la formula Babel und Bibel: la documentazione assiro-babilonese riportava nomi di re, città, popolazioni e divinità noti fino ad allora soltanto attraverso il testo biblico e, soprattutto, riportava miti analoghi, ma decisamente più antichi, di quelli presenti nel Bǝrēʾšîṯ, e piuttosto differenti. Se da un lato tutto questo materiale permetteva di contestualizzare la scrittura ebraica nell'ambito del più vasto retroterra culturale e letterario dell'antico Oriente, dall'altro,
le toglieva quel primato di unicità che aveva conservato per secoli e ne ridimensionava drasticamente l'autorità. Negli anni successivi venne alla luce molto altro materiale su Gilgameš, da siti sparsi dalla Mesopotamia all'Anatolia. E ci si rese ben presto conto che Gilgameš era stato una sorta di eroe «nazionale» di tutto l'antico Oriente. Dopo un oblio millenario, la più antica epopea dell'umanità tornava a far parte della letteratura universale. Lo Ša naqba īmuru, «Colui che vide nel profondo», è il titolo dell'epopea classica neo-assira in dodici tavole, anche nota ai bibliotecari assiri come iškar GIŠ-gim-maš, la «serie di Gilgameš». Attualmente si conoscono 184 frammenti di questa versione (dove con «frammento» si intende un reperto a cui è stato assegnato un numero di inventario in un museo). Accostando i frammenti contigui, il totale si riduce a 116. Questi 116, a loro volta, sono testimoni di almeno settantatré diversi manoscritti, la maggior parte dei quali è individuata solo da due/tre pezzi: pochi manoscritti constano di quattro o più frammenti. Almeno trentaquattro manoscritti sono neo-assiri (VII sec. a.C.) e i migliori testimoni sono quelli rinvenuti a tall Qūyunǧiq: non c'è tavola della «serie di Gilgameš» che non fosse conservata nella biblioteca di Aššur-bāni-apli in almeno un esemplare e alcune erano presenti in copie multiple. Sono arrivati a noi sedici distinti colophon. Gli altri manoscritti neo-assiri vengono da Aššur, da Kalḫu/Nimrūd e Ḫuzirina/Sultantepe Höyüğü, in Anatolia. Una trentina di manoscritti sono invece tardo-babilonesi (VI-V sec. a.C.), di cui sette provenienti da Uruk/Warkāʾ e due da Babilonia. I rimanenti frammenti tardo-babilonesi, custoditi nel British Museum, sono il risultato degli scavi affrettati e disordinati di Hurmuzd Rassām: Sippar è la loro dichiarata provenienza, ma si ritiene che alcuni provengano da Babilonia e da Barsip. (George 2003) Alla redazione «classica» si affiancano poi altri manoscritti neo-assiri che testimoniano delle interessanti varianti. Due di essi sono talmente vicini allo Ša naqba īmuru da essere usati come fonti per integrare le lacunae dell'epopea classica, ma altri ancora attestano delle fasi alternative del testo. Un manoscritto da Kalḫu/Nimrūd riporta l'incontro di Gilgameš con Šiduri e Ūtanapištî, ma con un un testo differente inserito al posto della storia del diluvio. Infine, due piccoli frammenti rinvenuti a tall Qūyunǧiq non sono integrabili nello Ša naqba īmuru, segno che nella biblioteca di Ninive era conservata più di una versione dell'epopea. Già George Smith si era domandato se non esistessero documenti più antichi che fossero serviti da base per la stesura della redazione ninivita dell'epopea di Gilgameš.
E infatti furono scoperti poemi medio-babilonesi (±1500-1000 a.C.) e antico-babilonesi (±1950-1500 a.C.) che confermarono quanto lo studioso aveva intuito: lo Ša naqba īmuru era la forma definitiva di un vasto ciclo epico che la Mesopotamia andava elaborando da cinquecento o addirittura mille anni. Conosciamo oggi una dozzina tra tavolette e frammenti antico-babilonesi incentrati su Gilgameš, risalenti alla prima metà del Secondo millennio avanti Cristo. Sebbene di diverso contenuto e qualità, riportano degli episodi riconducibili all'epopea classica. Il colophon della cosiddetta tavoletta di Pennsylvania ci informa che il titolo e incipit di questa antica versione dell'epopea era Šūtur eli šarrī, «Egli sovrasta ogni re!» (verso che corrisponde a Ša naqba īmuru [I: ]). Gli studiosi ritengono che si trattasse di un'opera unitaria, suddivisa in varie tavole: quale fosse la sua ampiezza non è noto, ma era probabilmente più breve dell'epopea ninivita. Questo un elenco dei testimoni: - AB P e Y. I testi antico-babilonesi più importanti sono la tavoletta di Pennsylvania e quella di Yale, acquistate dalle rispettive università a New York, da un medesimo venditore, nel 1914. Sembra provenissero da Uruk/Warkā˒ ed è possibile che siano state redatte da una stessa mano. Le sezioni dell'epopea di Gilgameš riportate dalle due tavolette corrispondono rispettivamente a Ša naqba īmuru [I-II] e [II-III].
- AB Ph. Il frammento UM 29-13-570, cosiddetto di Philadelphia, proveniente da Nippur, è un breve testimone (venti righe in tutto) della stessa redazione delle tavolette di Pennsylvania e di Yale.
- AB Ch.
La tavoletta A22007, detta di Chicago, in quanto custodita nel locale Oriental Institute Museum, ma anche di Bauer, dal nome del suo primo editore, o di Nērebtum o di Iščālī, è stata
appunto rinvenuta nel sito di Nērebtum, odierna Iščālī/Šaǧālī, nel 1935. Sebbene sia andato perduto da un quarto a un terzo del testo, e quanto rimane non sia ben conservato, essa riporta un'interessante variante della vicenda della lotta di Gilgameš con Ḫumbaba (cfr. Ša naqba īmuru [V]).
- AB B-L. Letterariamente molto bella è la tavoletta di Berlino/Londra (VA+BM), proveniente, si ritiene, da Sippar.
Venne spezzata da un commerciante arabo di Baġdād nel 1902, che riuscì
così a venderla due volte. Comprati separatamente, i due frammenti sono conservati rispettivamente al Pergamonmuseum e al British Museum. La tavoletta narra, con interessanti
varianti, dell'incontro di Gilgameš con Šiduri e Sursunabu (cfr. Ša naqba īmuru [X]). La precisione della redazione fa pensare a un esemplare destinato a una biblioteca.
- AB Sch₁ e Sch₂. Le due tavolette «norvegesi», di provenienza sconosciuta e oggi conservate nella Schøyen Collection, a Oslo, sono assai diverse tra loro come qualità redazionale. Di quella redatta con maggiore cura è sopravvissuto solo un breve frammento, mentre l'altra, piuttosto disordinata, ci è pervenuta praticamente integra. La prima porta alcuni versi sovrapponibili alla tavoletta di Yale; la seconda riprende, con interessanti varianti, alcuni dettagli della spedizione di Gilgameš nel Qišti Erēn (cfr. Ša naqba īmuru [IV]).
- AB N, Ḥ₁₋₂, Baġ. Alcuni frammenti di tavolette conservati nel Matḥaf al-ʿIrāqi, a Baġdād: la tavoletta di Nippur (AB N), rinvenuta nel 1951-1952, le due frammentarie tavolette di Šaduppūm (AB Ḥ₁₋₂), rinvenute nel tall Ḥarmal nel 1947, e i cosiddetti frammenti di Baġdād (AB Baġ), raggruppati sotto la comune collazione IM 21180, di provenienza ignota. Tutti questi frammenti hanno per argomento la spedizione di Gilgameš nel Qišti Erēn (cfr. Ša naqba īmuru [IV-V]).
Altri diciotto tra tavolette e frammenti, risalenti alla seconda metà del Secondo millennio avanti Cristo, rivelano invece la diffusione del ciclo di Gilgameš in epoca medio-babilonese, fornendoci uno sguardo sui lunghi secoli che separano lo Šūtur eli šarrī dallo Ša naqba īmuru. Questi manoscritti, di diversa epoca e provenienza, testimoniano un periodo in cui la trasmissione dall'epopea era caratterizzata da considerevoli divergenze rispetto alle redazioni antico-babilonesi. La scarsa consistenza di documentazione non ci consente di trarre conclusioni definitive circa il suo rapporto con l'epopea ninivita: nonostante i paralleli riscontrati, tuttavia, i frammenti rivelano una tradizione ancora non canonica. Alcuni vengono da siti lontani dalla Mesopotamia e testimoniano versioni straniere dell'epopea accadica. - MB U. La tavoletta di Ur, dal supposto luogo di provenienza, descrive i sogni di Enkidu e parte della sua agonia. Il testo si distacca in molti punti da quello dello Ša naqba īmuru.
È più antico di circa mezzo millennio della versione ninivita,
- MB Böğ₁₋₃. Diversi frammenti del poema di Gilgameš vengono da Ḫattuša/Böğazköy, capitale del regno degli Ḫittiti, in Anatolia. Otto di questi brevi frammenti (MB Böğ₁), rinvenuti in quella che sembra la biblioteca di un tempio e datati al 1400 a.C., sembrano provenire da una serie di tavolette correlate e trattano della civilizzazione di Enkidu e del viaggio al Qišti Erēn. Un ampio frammento (MB Böğ₂), rinvenuto all'inizio del XX secolo, tratta dei sogni di Gilgameš e dell'ira di Ištâr . Un terzo ritrovamento è quasi illegibile (MB Böğ₃).
- MB E₁₋₂. Due frammenti trovati nel 1974 a tall Maskana, l'antica città di Emar, in Siria. Il secondo di essi, piuttosto ampio, riporta la scena in cui Gilgameš rinfaccia a Ištâr la triste sorte dei suoi amanti e la richiesta della dea ad Anu di scatenare il toro Gudanna.
- MB M. Un frammento scoperto nel 1954 a Meîddô, in Palestina,
che riporta una scena dell'agonia di Enkidu.
- MB N₁₋₄. Alcune tavolette provenienti da Nippur,
i quali utilizzano estratti di poemi gilgamešaici come esercizi scolastici. I testi, ridotti a pochissime righe, sono spesso inintellegibili. Uno rappresenta la creazione di Enkidu.
I babilonesi attribuivano la paternità del poema a un certo Sîn-lēqi-unninni (il nome significa «O Sîn, accetta la mia preghiera»). In un «catalogo librario» di epoca neo-assira si legge: «Serie di Gilgameš: dalla bocca di Sîn-lēqi-unninni» [ÉŠ.GÀR(=iškar) GIŠ-gim-maš: šá pi-i 30(=sîn)-le-qi-un-nin-ni].
Poiché questo nome compare nelle liste reali come apkallu dello stesso Gilgameš, si è pensato che Sîn-lēqi-unninni potrebbe essere stato una leggendaria figura di cantore, un po' come Hṓmēros, a cui veniva tradizionalmente attribuita la prima redazione del poema. C'è però anche la possibilità che Sîn-lēqi-unninni sia un personaggio
perfettamente reale e sia intervenuto sul testo dello Šūtur eli šarrī in una fase precedente alle redazioni medio-babilonesi, sebbene sia impossibile precisare quando e come. La redazione della tavoletta di Ur (MB U), secondo la prudente ipotesi avanzata da alcuni studiosi, sembra sia quella che meglio potrebbe rappresentare l'ipotetico testo attribuito a Sîn-lēqi-unninni. Ma
costui potrebbe anche essere stato l'autore della redazione definitiva dello Ša naqba īmuru all'inizio del Primo millennio, da cui poi sarebbe derivata la versione ninivita. Sebbene George Smith non potesse saperlo, la scoperta delle tavolette antico- e medio-babilonesi era solo il primo passo nella scoperta delle origini del mito di Gilgameš. All'epoca, i Sumeri non erano ancora noti come entità etnica e politica e ci volle del tempo, e un bel po' di polemiche, prima che gli orientalisti accettassero l'esistenza di un popolo, insediato nella Mezzaluna Fertile prima dell'arrivo dei Semiti, di cui non era rimasta memoria nemmeno nella Bibbia. Man mano che venivano alla luce tavolette sempre più antiche, gli eleganti cuneiformi si devolvevano in rozzi pittogrammi, e man mano che la remota lingua sumerica veniva identificata, analizzata e decifrata, cominciarono ad affiorare racconti su un certo Bilgames, lugal di Uruk. Nell'identificazione e decifrazione di questi testi ha avuto un ruolo da protagonista il sumerologo Samuel Noah Kramer (1897-1990), il quale ha dedicato tutta la vita a cercare frammenti di tavolette sumere nei musei di tutto il mondo, per poi ricomporli pazientemente nelle corrette sequenze. È soprattutto grazie a Kramer se conosciamo oggi sei testi sumerici su Bilgames, alcuni dei quali del tutto sconosciuti all'epica classica:
-
Lukigia Agga (LÚ.KI.GI₄.A AG.GÀ, «I messaggeri di Agga»), conosciuto informalmente come
Bilgames e Agga: poema completamente sconosciuto dall'epopea classica.
-
Ud rea ud sudra rea (UD RE.A UD SÙD.RÁ RE.A, «In quei giorni, in quei giorni remoti»), conosciuto informalmente come Bilgames, Enkidu e gli inferi; poema appartenente al ciclo di
Inanna, di cui una parte è citata a mo' di appendice nella
XII tavoletta dell'epopea classica.
-
En-e kur lu tillaše (EN.E KUR LÚ TI.LA.ŠÈ, «Il signore nella terra del vivente»), conosciuto informalmente come
Bilgames e Huwawa A, a cui si riferisce un episodio dell'epopea classica.
-
Ia lulu uluḫḫa sudsud (I.A LU₄.LU₄ Ù.LUḪ.ḪA SUD.SUD, «Vieni ora, portatore dello scettro»), altra versione del poema precedente; conosciuto con il titolo informale di
Bilgames e Huwawa B.
-
Šul meka šul meka (ŠUL MÈ.KA ŠUL MÈ.[KA], «Eroe in battaglia»), conosciuto informalmente come
Bilgames e il toro del cielo, episodio presente nell'epopea classica.
- Ursa [amgale] banu (UR.SA [AM.GAL.E] BA.NÚ, «Giace l'eroe [il grande toro]»), conosciuto dagli specialisti come
La morte di Bilgames, di cui non c'è alcun riferimento nell'epopea classica.
Bisogna infine citare, per completare il quadro, il rinvenimento di tavolette in lingue diverse dall'accadico, a ricordarci come il ciclo di Gilgameš fosse popolare e ben conosciuto anche fuori dalla Mesopotamia. Conosciamo frammenti ḫittiti (Ḫ) di diversa datazione, derivati probabilmente dalle redazioni antico-babilonesi. Vi sono poi frammenti di poemi ḫurriti riallacciabili a vari episodi dello Ša naqba îmuru, alcuni dei quali sembrano avere Ḫumbaba, e non Gilgameš, come eroe protagonista. Esiste un frammento di una versione elamita (El) che riguarda l'episodio dell'incontro tra Gilgameš e Šiduri, svolto in maniera molto diversa da come compare nell'epopea classica. (Pettinato 1992 | George 2003) Ma ora che abbiamo fatto il punto della situazione – e il lettore ci scuserà se ci siamo fatti prendere la mano dal nostro gusto per le divagazioni, ma si ammetterà che l'argomento è davvero affascinante – dedichiamoci al nostro protagonista. Gilgameš, lugal di Uruk. | GILGAMEŠ, COLUI CHE VIDE LE
PROFONDITÀ  | | Gilgameš, il re | | Tudor Humphries, illustrazione (Shepherd 1994) |
A chi affidarci per la nostra ricerca del giardino della vita? A chi, se non a colui che vide le
profondità, che calpestò i sentieri del mondo e ci riportò un mito dei tempi del diluvio? All'antichissimo re di Uruk, che non fu soltanto il primo eroe epico della storia dell'umanità, ma anche il primo eroe tragico, il cui sconcerto di fronte al mistero della morte, giunto a noi da tempi tanto remoti, ancora ci appartiene. Il suo nome, riportato provvisoriamente come IZ.DU.BAR da George Smith, è stato a lungo una vexata quaestio presso gli orientalisti. Nei documenti accadici compariva come GIŠ-gím-maš (spesso abbreviato
sulle tavolette in un semplice GIŠ) e venne
dapprima proposta la lettura Gišṭubar. La lettura con cui oggi il personaggio è universalmente conosciuto venne stabilita dall'assiriologo
Theophilus Goldridge Pinches solo nel 1890, allorché fu reso disponibile un commentario tardo-babilonese che riportava l'equazione GIŠ-gím-maš = gil-ga-⌜meš⌝. Ci si accorse, peraltro, che di questo nome si conosceva già la versione in greco Gílgamos, personaggio sul quale
l'ellenista Claudius Aelianus (±175-±235) narrava una leggenda che non ha alcun riferimento diretto con il materiale accadico (Perì zṓıōn idiótētos [12, ]). Era stato dunque Gilgameš il nome con cui il nostro eroe era conosciuto intorno al VII-V
secolo a.C. Ma nelle epoche precedenti? Nelle tavolette sumeriche il nome dell'eroe compare in un gran numero di lezioni diverse.
Nella più antica attestazione, in una lista divina di Šuruppak (tall Fārā) della metà del Terzo millennio avanti Cristo, il nome compare nella lezione GIŠ:BIL:PAP.ga.mes. La maggior parte delle lezioni
sumeriche sono costruite su una radice della forma Pabilga, assai comune negli antroponimi,
da cui si deduce una lettura Pagilbames. Un'altra lezione, diffusa a partire dal XXIV secolo a.C., si avvicina a quella accadica: è GIŠ.BÍL.gi₁₁.mes (o GIŠ.BÍL.gím.mes). Poiché a volte GIŠ.BÍL è una combinazione tra un logogramma e un complemento fonetico, cioè GIŠ, è probabile che vada pronunciato /bil/ o /pil/. Da quest'epoca, inoltre, pabilga- sembra contrarsi in bilga-, da cui la lettura proposta
dai sumerologi: Bilgames. (George 2003) E ora che sappiamo come si chiama il nostro eroe, entriamo nel vivo delle sue vicende. L'epopea classica, la stessa di cui George Smith aveva presentato le prime traduzioni alla sua conferenza, nel 1872, ci servirà da mappa per seguire il viaggio di Gilgameš alla ricerca della pianta della vita. Ci limiteremo tuttavia a dare una scorsa veloce ma appassionata all'intero poema, riservandoci di approfondire poi quei dettagli che ci torneranno preziosi per il nostro studio. Il titolo dell'epopea classica, Ša naqba îmuru, «colui che vide le profondità», deriva, com'era uso, dal suggestivo incipit [šá naq-ba i-mu-ru i]š-di ma-a-ti
[×××-ti i-du]-⌜ú ka⌝-la-mu ḫa-as-s[u]
[GIŠ-gím-maš šá n]aq-⌜ba⌝-i-mu-ru iš-di ma-⌜a⌝-[ti]
[×××-t]i i-du-ú ka-la-mu ḫa-a[s-su]
[××]×-ma mit-ḫa-riš pa-×[×]
[nap-ḫ]ar né-me-qí ša ka-la-a-mi⌜i⌝-[ḫu-uz]
[ni]-ṣir-ta i-mur-ma ka-tim-ti ip-⌜tu⌝
[u]b-la ṭè-e-ma šá la-am a-bu-b[i]
[u]r-ḫa ru-uq-ta il-li-kam-ma a-ni-iḫ u šup-šu-uḫ
[šá-k]in i-na ⁴NA.RÚ.A(=narê) ka-lu ma-na-aḫ-ti | [Colui che vide le profondità, il] fondamento del paese,
[di colui che sapeva] ogni cosa, rendendosi esperto di tutto;
[Gilgameš che] vide le profondità, il fondamento del paese,
[di colui che] sapeva [ogni cosa], rendendosi esperto di tutto.
[...] egualmente [...]
egli [imparò] la sapienza in tutte le cose;
vide i segreti e scoprì le cose nascoste
e riportò un messaggio dai tempi prima del diluvio.
Egli percorse vie lontane, finché, stanco e abbattuto, [si fermò]
e fece incidere tutte le sue fatiche su una stele di pietra. | Ša naqba īmuru [I: -] |
Gilgameš, figlio di Lugalbanda, è il quinto re di Uruk dei tempi postdiluviani. Ma questo lo apprendiamo dalle liste reali. La tavola I del poema ninivita lo introduce con la formula: ša naqba īmuru, «colui che vide le profondità». Dunque un uomo esperito e sapiente, gran viaggiatore e inesausto scopritore dei misteri del mondo. Nessuno, più di lui, ha il diritto di dire: “Io sono il lugal!”. Possente eroe destinato alla gloria, Gilgameš è per due terzi dio e per un terzo uomo. All'inizio del poema, Gilgameš è un giovane e vigoroso sovrano, dotato di un'energia incontenibile, tanto che gli abitanti di Uruk devono subire le sue continue intemperanze. Gilgameš
suona il tamburo giorno e notte, chiamando continuamente la
cittadinanza a raccolta per il lavoro e per la guerra, e
costringendo tutti a dure e prolungate corvée. Il suo impeto sessuale è tale che non lascia in pace nessuna fanciulla della città. Gli urukiti, angustiati da questo lugal troppo esigente, innalzano al cielo un lamento. (Ša naqba īmuru [I: -]) Gli dèi decidono di intervenire. Aruru crea dall'argilla un uomo, simile a Gilgameš come un suo riflesso, in modo che si opponga a lui (Ša naqba īmuru [I: -] | MB [N₂: - -]). La dea modella un grumo di creta e nella steppa dà vita al silvestre Enkidu:
ina (=ṣeri) en-ki-dù ib-ta-ni qu-ra-du
i-lit-ti qul-ti ki-ṣir nin-urta
[š]u-ʾ-ur šar-ta ka-lu zu-um-ri-šú
up-pu-uš pe-re-tu (=kīma) sin-niš-ti
⌜i⌝-ti-iq pe-er-ti-šu uḫ-tan-na-ba ki-ma nissaba | Essa creò un uomo primordiale, Enkidu, il guerriero,
seme del silenzio, potenza di Ninurta.
Tutto il suo corpo era coperto di peli,
la chioma intrecciata come quella di una donna,
i riccioli crescevano lussureggianti come grano. | Ša naqba īmuru [I: -] |
Enkidu, questo enfant sauvage, mai passato attraverso il filtro della cultura e del vivere civile, conduce un'esistenza errabonda tra gli animali, correndo con le gazzelle per le steppe e le montagne, brucando l'erba insieme al bestiame e abbeverandosi alle pozze. Più simile a una bestia che a un uomo, Enkidu aiuta gli animali a sfuggire ai cacciatori, a cui distrugge le trappole e riempie le buche. Un cacciatore lo scorge nel folto e, colto da indicibile terrore, comunica a Gilgameš
dello strano uomo selvaggio che si aggira nella campagna. Il re
ordina al cacciatore di scegliere una prostituta sacra e di condurla
dall'uomo selvaggio, in modo che attraverso la conoscenza della
donna egli abbandoni il proprio stato ferino e venga iniziato alla
civiltà umana. Il brano, dolcemente esplicito, che descrive l'atto
amoroso tra Šamḫat e il selvaggio Enkidu segna il trapasso tra l'esistenza istintiva delle bestie e la coscienza propria degli uomini. (Ša naqba īmuru [I: -]). Dopo aver giaciuto con
la donna, Enkidu, la cui virilità
era evidentemente dovuta alla sua natura selvaggia, si accorge di aver perduto le
sue doti ferine e che ora gli animali rifiutano la sua compagnia.
ur-tam-mi šam-ḫat di-da-šá
úr-šá ip-te-e-ma ku-zu-ub-šá il-qé
ul iš-ḫu-ut il-ti-qé na-pis-su
lu-bu-ši-šá ú-ma-ṣi-ma UGU(=eli)-šá iṣ-lal
i-pu-us-su-ma lul-la-a ši-pir sin-niš-te
da-du-šú iḫ-bu-bu (=eli) EDIN(=ṣeri)-šá
6 ur-ri ù 7 GI₆(=mušāti) en-ki-dù te-bi-ma šam-ḫat ir-ḫi
ul-tu iš-bu-ú la-la-šá
pa-ni-šú iš-ta-kan ina (=ṣer) bu-li-šú
i-mu-ra-šu-ma en-ki-dù i-rap-pu-da MAŠ.DÀ(=ṣabātu)
bu-ul EDIN(=ṣeri) it-te-si ina ZU(=zumri)-šú
⌜ul-taḫ-ḫi⌝ en-ki-dù ul-lu-la pa-gar-šu
it-ta-ziz-⌜za⌝ bir-ka-a-šú šá il-li-ka bu-ul-šú
um-ta-aṭ-ṭu en-k[i-dù u]l ki-i šá pa-ni la-sa-an-šú
ù šu-ú i-ši ṭ[é-ma r]a-pa-áš ḫa-si-sa | Šamḫat lasciò cadere i suoi abiti
denudò la sua vulva e lo catturò col suo fascino.
Non lo respinse, lo abbracciò stretto,
aprì le sue vesti ed egli giacque su di lei.
Ella donò a lui, l'uomo, l'arte della donna,
egli la carezzò con amore e la abbracciò.
Per sei giorni e sette notti Enkidu, eretto, possedette Šamḫat.
Dopo essersi saziato delle sue delizie
volse lo sguardo verso le bestie:
le gazzelle guardarono Enkidu e fuggirono,
gli animali della steppa si tennero lontani da lui.
Enkidu era diverso, ora che il suo corpo era stato purificato:
le sue gambe, che tenevano il passo delle bestie, erano rigide;
Enkidu non aveva più forza, non poteva più correre come prima;
egli però aveva la ragione; il suo sapere era divenuto vasto. | Ša naqba īmuru [I: -] |
Šamḫat consiglia a Enkidu di abbandonare la sua esistenza selvaggia e di seguirla. Nel frattempo, Gilgameš ha alcuni sogni che sua madre Ninsun, sacerdotessa del dio-sole Šamaš, interpreta annunciandogli il prossimo arrivo di un uomo destinato a diventare suo intimo amico e compagno (Ša naqba īmuru [I: -]). Qui si conclude la prima tavola. La recensione della tavola II è assai mal conservata e mutila in più sezioni, al punto che oltre tre quarti del testo sono di fatto perduti. Parte del racconto può venire integrato, con qualche cautela, dalla redazione antico-babilonese, lo Šūtur eli šarrī. La tavoletta di Pennsylvania (AB P) racconta il tirocinio di Enkidu presso alcuni pastori, i quali gli insegnano a mangiare il pane e bere il vino. In seguito Šamḫat convince il suo selvaggio amico a scendere nel consorzio umano e lo conduce nella città di Uruk. Qui giunto, Enkidu incontra Gilgameš presso le mura della città. Se si è ben interpretato il testo, Gilgameš si sta recando a una festa di nozze per quello che sembra essere un diritto di ius primae noctis. Enkidu gli sbarra la strada e i due uomini si battono tra loro. L'esito del combattimento sembra arridere ad Enkidu, che con la sua forza costringe Gilgameš a piegare un ginocchio. Enkidu riconosce tuttavia l'eccellenza di Gilgameš e i due stringono una profonda amicizia (AB Šūtur eli šarrī [P: -]). Qui s'interrompe la tavoletta di Pennsylvania. Ritornando alla parte finale della seconda tavola ninivita, integrata con la tavoletta di Yale (AB Y), Gilgameš presenta Enkidu
a Ninsun, con l'apparente proposito che la madre adotti il giovane selvaggio. Entrambi i testi si fanno lacunosi e, quando tornano a essere intellegibili, Enkidu sta piangendo sconsolato, forse per un rifiuto da parte di Ninsun. Per consolare l'amico, Gilgameš gli propone di partire insieme a lui per una pericolosa avventura. (Ša naqba īmuru [II: -] | AB Šūtur eli šarrī [Y: -]) L'esatta formulazione della proposta di Gilgameš è andata perduta tanto nella redazione ninivita tanto nella tavoletta di Yale, ma la risposta atterrita di Enkidu è fin troppo palese. Gilgameš vuole andare a prendere il legname in un luogo, il cui nome, nei testi accadici, è riportato in sumerogrammi: . La lettura accadica di questo toponimo è Qišti Erēn, la «foresta dei cedri», e colui che la custodisce ha un nome minaccioso: Ḫumbaba. E lui Enkidu, l'uomo selvaggio, che conosce già la foresta e il suo terrificante guardiano, cerca di dissuadere Gilgameš dal tentare un'impresa
tanto temeraria. (Ša naqba īmuru [II: -] | AB Šūtur eli šarrī [Y: -]). Anche i giovani e gli anziani di Uruk intervengono con parere negativo, e spiegano al re quanto sia pericoloso il viaggio, soprattutto a causa di Ḫumbaba:
áš-šu šul-lu-mu EREN(=erēni)
ana pul-ḫa-a-ti ša ÙG(=nišī) ⌜i⌝-šim-šu en-líl
[...] ḫum-ba-ba rig-ma-šu a-bu-bu
pi-i-šu ⌜GÌRA(=girru)⌝-um-ma na-pis-su mu-tú | “Per proteggere la foresta,
per incutere timore agli uomini, lo ha destinato Enlil.
[...] Ḫumbaba, il cui grido è il diluvio,
il cui soffio è fuoco, il cui respiro è morte...” | Ša naqba īmuru [II: a-a | -] |
Questo episodio è probabilmente uno dei più antichi del ciclo di Gilgameš. È infatti trattato da due racconti sumerici, di diversa ampiezza, intitolati rispettivamente
En-e kur lu tillaše, «Il signore nella terra del vivente», e Ia lulu uluḫḫa sudsud, «Vieni ora, portatore dello scettro», conosciuti con i titoli informali di Bilgames e Ḫuwawa A e Bilgames e Ḫuwawa B. La descrizione che Enkidu fa di Ḫuwawa nella versione sumerica, di duemila anni più antica di quella assira, è altrettanto inquietante:
lugal-u₁₀ za-e lú-ba igi nu-mu-ni-in-du₈-a šag₄
nu-mu-ni-dab₅-bé-en
e₂₆-e lu₂-ba igi mu-ni-du₈-a šag₄ mu-ni-dab₅-bé-en
ur-sa ka-ga₁₄-ni ka ušumgal-la-kam
igi-ni igi piri-á-kam
IŠ.GABA-a-ni a-i₆ du₇-du₇-dam
sa-ki-ni iš-gi bí-gu₇-a lú
lugal-u₁₀ za-e kur-šè
u₅-a e₂₆-e iriki-šè ga-u₅
ma-zu-úr ì-tìl-zu ga-na-ab-dug₄ zú-zú ḫé-li₉-li₉
eer-ra ba-úš-zu ga-na-ab-dug₄ [ér-zu][ér gig]. | “O mio lugal, poiché tu non hai visto quell'uomo,
non hai paura di lui;
ma io, che ho visto quell'uomo, sono pieno di terrore.
I denti dell'uomo sono denti di drago;
gli occhi dell'uomo sono occhi di leone;
il torace dell'uomo è un diluvio travolgente.
Alla sua fronte che divora il canneto, nessuno sfugge.
O mio lugal, naviga pure verso la montagna [kur],
io navigherò verso la città.
A tua madre io racconterò che tu vivi, così essa gioirà.
Poi io le racconterò che tu sei morto,
così ella piangerà [per te][amaramente].” |
En-e kur lu tillaše [-] |
I millenni non possono mutare i meccanismi dell'epica. Nonostante i pareri contrari, Gilgameš non si lascia distogliere dal progetto. Egli è deciso a compiere un'impresa tanto ardita che nessuna l'ha mai neppure concepita prima d'allora. Vuole lasciare il proprio nome alle generazioni future affinché sappiano chi erano Gilgameš ed Enkidu. Le parole del lugal riescono a vincere le resistenze dell'amico. L'umanità ha i giorni contati per volere degli dèi e tutto ciò che l'uomo compie nella vita è insignificante come una brezza: di fronte alla morte, dichiara a Enkidu, meglio una fama che duri in eterno (AB Šūtur eli šarrī [Y: -]) Nella tavola III della redazione ninivita, Gilgameš ottiene l'appoggio degli anziani e la benedizione del dio-sole Šamaš, quindi si congeda dalla madre Ninsun. Con i preparativi per la spedizione si chiudono sia la tavola III che la tavoletta di Yale. (Ša naqba īmuru [III] | AB Šūtur eli šarrī [Y: -]). L'intera tavola IV è occupata dal viaggio di Gilgameš e Enkidu verso il Qišti Erēn, la «foresta dei cedri», che la redazione ninivita colloca nel Labananu, il Libano [III: ]. I due eroi sono armati con scuri, asce bipenni e pesanti spade: ma compiono
il percorso in tre giorni. Ciò nonostante, il viaggio è scandito da cinque soste, in ciascuna delle quali Gilgameš ed Enkidu, dopo essersi rifocillati, si coricano per dormire. Ogni volta Gilgameš viene destato di soprassalto da un sogno angoscioso che Enkidu interpreta però in maniera favorevole (Ša naqba īmuru [IV: -]). Il quinto sogno è perduto nell'epopea classica ma viene restituito nella versione antico-babilonese tramandata dalla tavoletta di Šaduppûm/Ḥarmal (AB [Ḥ₁]). Il racconto dei sogni occupa quasi tutta la tavola IV. Quando i due eroi giungono in vista della «foresta dei cedri», Gilgameš ne è improvvisamente atterrito. La vista di quegli alberi altissimi, di quel groviglio buio e inestricabile, gli comunica un improvviso presagio di sconfitta e di morte. È il dio Šamaš, suo protettore, a rincuorarlo dal cielo: “Affrettati, prima che Ḫumbaba si rifugi nel bosco!”. I due scattano verso il limitare della foresta. Ma la loro corsa mette in allarme il guardiano: Ḫumbaba fugge a sua volta, emettendo un grido terrificante. È Enkidu
a esserne atterrito. Gilgameš lo sferza con durezza: “Dimentica la morte, persegui la vita!” (Ša naqba īmuru [IV: -]). Con le parole di Gilgameš si conclude la quarta tavola. L'avventura nel Qišti Erēn e la lotta contro Ḫumbaba è uno dei momenti clou dell'epopea. Occupa tutta la tavola V della redazione ninivita, ma è anche presente in diversi frammenti antico-babilonesi: il mito è trattato infatti nella tavoletta di Chicago (AB [Ch]), nella seconda tavoletta di Schøyen (AB [Sch₂]) e in quella di Nippur (AB [N]). Anche i testi sumerici ci forniscono preziose notizie sulla natura della «foresta dei cedri» e del suo guardiano, Ḫuwawa, ma non affrettiamoci a voler scoprire tutto subito, e procediamo con cautela, come Gilgameš ed Enkidu una volta entrati nel Qišti Erēn. E mentre i cedri svettano tutto intorno, eccoci alla tavola V. Penetrati nella foresta, Gilgameš ed Enkidu vengono presi da un senso di inquietudine: dinanzi a loro si erge la montagna che è santuario degli dèi e trono delle dee (Ša naqba īmuru [V: -]). Tra lo smarrimento degli eroi, una lacuna interrompe di colpo la quinta tavola e, per poter conoscere il seguito, bisogna affidarci a una tavoletta tardo-babilonese da Uruk/Warkāʾ. Ḫumbaba rivolge furibonde invettive ai due eroi. Il suo tono è violento ma anche ironico: minaccia di
spiccare la testa al lugal e lasciare il cadavere del suo amico ai serpenti e agli avvoltoi. Il terrore mozza il respiro a Gilgameš e tocca a Enkidu riscuoterlo ancora una volta. Gilgameš reagisce, si muove contro Ḫumbaba. La lotta tra i due avversari è apocalittica: le nuvole diventano nere, la morte cade come nebbia, la montagna si spacca in due, separando il Libano da Sirara. Ma quando la battaglia è al suo apice, il dio-sole Šamaš scaglia i suoi venti contro il terrificante guardiano. Ḫumbaba è accecato, abbattuto. Crolla al suolo e supplica di essere risparmiato. Enkidu mette in guardia Gilgameš dal muoversi a compassione. Presentendo la sua fine, Ḫumbaba maledice i due eroi: che essi non giungano a vedere la vecchiaia. Sono le sue ultime parole. Enkidu lo uccide. (Ša naqba īmuru [V (ms. dd): -] | AB [Ch]). Superata la lacuna, la tavola V si conclude con Gilgameš che torna ad Uruk portando i tronchi abbattuti nel Qišti Erēn e recando alta la testa mozzata di Ḫumbaba. (Ša naqba īmuru [V (ms. dd): -]) La tavola VI si è mantenuta quasi integralmente e le poche interruzioni della versione ninivita possono essere colmate da un ulteriore manoscritto proveniente da Aššur. Lavatosi dalla sporcizia del viaggio, indossati vesti e ornamenti regali, Gilgameš fa la sua apparizione in tutta la sua magnificenza. Ištâr, la dea poliade di Uruk, signora dell'amore e della guerra, che insieme al padre Anu abita nell'Eanna, il tempio al centro della città, volge lo sguardo sulla bellezza di Gilgameš (Ša naqba īmuru [VI: ]). Colta da improvvisa passione per il lugal, Ištâr fa la sua comparsa sulla cima della ziqqurat e, incapace di frenare i propri appetiti, si dichiara apertamente, proponendo a Gilgameš di diventare suo sposo, promettendogli in cambio gloria, magnificenza e ricchezza. Ma il lugal le risponde sferzante, ricordandole la triste sorte toccata a tutti i suoi amanti, sopraffatti dalla voluttà della dea e poi abbandonati al loro destino (Ša naqba īmuru [VI: -] | MB [Emar₂]). Curiosamente i testi sumerici davano una versione assai diversa di questa vicenda. Qui è
Bilgames a rivolgersi a Inanna, offrendole ricchi doni. Le lacunae del testo non permettono di capire esattamente quale fosse la richiesta del lugal. È possibile che
Bilgames avesse preteso più poteri e competenze di quante gli spettassero? Sembra di sì, a giudicare dal secco rifiuto della dea:
am-u₁₀ lú-u₁₀ ME.EN.NE.EN šu nu-ri-bar-re
en gilgaméš am-u₁₀ lá-u₁₀ NE
šu nu-ri-bar-re
é-an-na-ka di kud-dè šu nu-ri-bar-re
i₆-par₄ kug-á ka-aš bar-re šu nu-ri-bar-re
é-an-na an-né ki á di kud-dè šu nu-ri-bar-re
gilgaméš za-e ù-NE ḫé-me-en za-e gud ḫé-e | “Il mio bestiame, di qualunque specie esso sia, non ti concedo;
en Bilgames, il mio bestiame, di qualunque specie esso sia,
non ti concedo;
di giudicare nell'Eanna non ti concedo;
di dare ordini nel mio santo ipar non ti concedo;
di giudicare nell'Eanna che An ama non ti concedo;
o
Bilgames che tu sia... che tu sia...” | Šul meka šul meka [B, -] |
Questo rifiuto pare abbia scatenato una reazione da parte di
Bilgames/Gilgameš, la cui arroganza ci appare qui assai più coerente con l'hýbris del personaggio, sempre propenso a superare i limiti imposti dall'ordine delle cose, che non il suo sprezzante rifiuto alle profferte d'amore della dea. Ma quali siano le ragioni dell'offesa mossa a Inanna/Ištâr, in entrambe le versione la reazione della dea è la medesima: si reca da An/Anu per chiedergli di liberare il Gudanna (sum. GUD.AN.NA o GU₄.AN.NA), il «toro del cielo», per distruggere i due eroi. An/Anu tentenna: scatenare il Gudanna vuole dire condannare la terra di Uruk a sette anni di siccità e carestia. Ma Inanna/Ištâr insiste: se non sarà accontentata, ella lancerà un grido tale da avviluppare il cielo e la terra (versione sumerica), oppure (versione neoassira) abbatterà le porte degli inferi e capovolgerà l'ordine naturale della vita e della morte. (Šul meka šul meka
[B, -] | Ša naqba īmuru [VI: -])
[a-bi G]U₄.AN.NA bi-nam-ma
GIŠ-⌜gím-maš⌝ lu-nir-r[u i]na šub-ti-šú
šum-m[a] a-la-al[a t]a-da-n[a]
a-maḫ-[ḫaṣ da]n-ni-〈na〉 a-⌜di⌝ KI.TUŠ(=šubti)-šú
a-šak-[ka]n ⌜sa⌝-p[a-nam] ⌜a⌝-na šap-la-t[i]
ú-šel-lam-ma ÚŠ(=mītūti) ik-ka-lu ba[l-ṭ]u-ú-ti
UGU(=eli) bal-ṭu-ti ú-šam-[a-d]u ÚŠ(=mītūti) | “Padre mio, dammi per favore, il Gudanna ;
voglio uccidere
Gilgameš nella sua casa.
Se tu non mi darai il Gudanna,
allora io abbatterò le porte degli inferi,
volgerò [...] dalle regioni inferiori al suolo,
farò resuscitare i morti in modo che divorino i vivi;
allora i morti saranno più numerosi dei vivi!” | Ša naqba īmuru [VI: -] |
Il Gudanna, il toro del cielo, attraversa l'Eufrate e irrompe furibondo nella città di Uruk. Sotto i suoi zoccoli si squarcia la terra e centinaia di persone precipitano nelle crepe. Gilgameš ed Enkidu muovono contro il toro. Dopo uno strenuo combattimento, Enkidu afferra l'animale per le corna e la coda, e Gilgameš lo uccide conficcandogli la spada nella nuca. Il pericolo è scongiurato.
Poi, mentre gli eroi festeggiano, Ištâr compare sulle mura di Uruk, piangendo l'uccisione del Gudanna. Ma il tracotante Enkidu le tira contro la coscia mozzata del toro. (Ša naqba īmuru [VI: -] | Šul meka šul meka [-]). Quella notte, dopo aver festeggiato, gli eroi dormono. Ma d'un tratto Enkidu si desta e, subito, si rivolge a Gilgameš: “Amico mio, perché i grandi dèi sono in assemblea?”. Con questa domanda, si conclude la tavola VI e inizia la VII. (Ša naqba īmuru [VI: ] = [VII: ]) Il sogno di Enkidu, conservato nella versione ḫittita dell'epopea, ci mostra gli dèi riuniti a consulto per decidere come punire i due sacrileghi eroi, colpevoli di aver ucciso Ḫumbaba e il Gudanna,
oltre che di aver gravemente offeso la dea
Ištâr (Ḫ [III: -]). La decisione è che Enkidu dovrà morire. L'eroe viene colpito da una malattia contro cui i più valenti medici ed esorcisti di Uruk sono impotenti. La settima tavola dell'epopea ninivita, la più drammatica di tutte, narra dei vaneggiamenti di Enkidu, della preoccupazione di Gilgameš, dell'acuirsi della malattia, e si sofferma con lucida pietà sul lento venir meno di Enkidu. Dopo dodici giorni di agonia, Enkidu muore, lasciando Gilgameš prostrato da un dolore incredulo e sgomento. (Ša naqba īmuru [VII: -] | MB [Ur | M | Böğ₁]) Pur arrivando a noi da un'epoca tanto remota, il grido di dolore di Gilgameš è straziante oggi come lo era al tempo degli assiri:
[ši-ma-in-n]i GURUŠ(=eṭlūtu) ši-ma-[in-ni ia-a-ši]
ši-ma-in-ni ši-bu-ut URU(=āli) rap-ši UNUG(=uruk)
š[i-ma-i]n-⌜ni ia-a-ši⌝
a-na-ku a-na en-⌜ki⌝-d[ù ib-ri]-ia a-bak-ki
GIM(=kīma) lal-la-ri-ti [ú-n]am-ba ṣar-piš
ḫa-aṣ-ṣi-in a-ḫi-i[a tuk-l]a-tu i-di-ia
nam-ṣar šip-pi-ia [a-ri-t]u šá pa-ni-ia
lu-bar i-sin-na-ti-ia n[i-bi-iḫ] la-le-e-a
[š]á-a-ru lem-nu it-ba-am-ma i-[te-ek-ma]n-ni ia-a-ši
[ib-ri ku-d]a-ni ⌜ṭa-rid ak-kan-nu šá KURi(=šadî)⌝
nim-ru šá EDIN
e[n-ki-dù i]b-ri ku-dan-ni [K]IMIN
šá nin-n[ém]-du-ma ni-lu-ú [KURi(=šadâ)]
ni-iṣ-b[a-t]u-ma a-la-a [ni-na-ru]
[nu-šal-pi-t]u ḫum-ba-ba šá ina TIR(=qišti) [EREN(=erēni) áš-bu]
e-nin-na mi-nu-ú šit-tu šá iṣ-ba-tu-[ka ka-a-ši]
ta-ʾ-ad-ram-ma ul ta-še[m-man-ni ia-a-ši] | “Ascoltatemi, o giovani, ascoltatemi!
Ascoltatemi, o anziani di Uruk,
ascoltatemi!
Io piangerò per Enkidu, l'amico mio,
emetterò amari lamenti come una prefica.
L'ascia del mio fianco, in cui confidava il mio braccio,
la spada della mia cintura, lo scudo del mio petto,
i miei ornamenti festivi, la mia cintura regale,
un vento malvagio è venuto a me e li ha portati via.
Amico mio, mulo imbizzarrito, asino delle montagne,
leopardo della steppa,
Enkidu, amico mio, mulo imbizzarrito, asino delle montagne,
leopardo della steppa,
noi, dopo esserci incontrati, abbiamo scalato assieme il kur,
abbiamo catturato Gudanna e lo abbiamo ucciso,
abbiamo abbattuto Ḫumbaba, l'eroe del Qišti [Erēn],
e ora qual è il sonno che si è impadronito di te?
Sei diventato immoto, e non mi ascolti!” | Ša naqba īmuru [VIII: -] |
La scena del compianto di Enkidu
è talmente bella che meriterebbe di essere riportata integralmente.
Essa occupa tutta l'ottava tavola. (Ša naqba īmuru [VII: -]). È solo quando sono ormai conclusi i funerali, all'inizio della tavola IX, che ci accorgiamo che nel cuore del re di Uruk è avvenuto il lampo del riconoscimento. La fine di Enkidu lo ha messo di fronte alla consapevolezza che la morte è il comune destino di tutti gli uomini. Gilgameš è ormai conscio della futilità della vita, sa che gli artigli della morte possono ghermirlo in qualsiasi istante
e comprende d'un tratto i suoi limiti in quanto essere umano. Egli è dio per due terzi, ma non è sufficiente. Fissando il corpo dell'amico chiede a sé stesso: “Non sarò forse, quando io morirò, come Enkidu?” E la risposta a questa domanda non può che riempirlo di paura e di amarezza. La gloria, il rango, il trono. Tutto passa in secondo piano di fronte alla brutale e sconvolgente certezza del destino che lo attende. Persino l'essersi conquistato una fama immortale, a cui tanto aveva ambito al tempo della spedizione nel Qišti Erēn, è ora diventata ben poca cosa. Gilgameš, il lugal, sa che non potrà più godere delle effimere gioie della vita se non troverà un rimedio alla profonda ingiustizia della morte. “Io trascurerò il mio aspetto dopo la tua morte”, promette Gilgameš al corpo immoto
e rigido di Enkidu, “e con indosso una pelle di leone vagherò nella steppa” (Ša naqba īmuru [VIII: -]). E, abbandonata la sua città, il dolce ovile di Uruk, s'incammina nel deserto. È un viaggio disperato, ma non disorganizzato. Gilgameš ha una meta precisa. Vuole trovare il solo uomo a cui gli dèi abbiano concesso la vita, il solo che possa rivelargli il modo per sconfiggere la morte. Il suo nome, nell'epopea ninivita, è Ūtnapištî: è l'uomo che, a bordo della sua arca, aveva affrontato le acque straripanti del diluvio, salvando il seme e la discendenza del genere umano. Noi lo abbiamo incontrato nell'epica sumerica, sotto il nome di
Ziudsura; gli dèi lo avevano reso immortale e condotto «in una regione al di là del mare, a Dilmun, dove si leva Utu» [kur-bal kur dilmun-na ki utu éd-šè mu-un-tìl-eš] («Poema di Ziudsura» [V: ]). Ed è appunto in questo paradiso d'immortalità che Gilgameš sta cercando di arrivare. Il poema rivela d'un tratto inaspettate stratificazioni meta-letterarie: Ūtnapištî è infatti, per lo stesso Gilgameš, un nome ai limiti della memoria umana, un vero e proprio mito nel mito, tanto da essere chiamato rēqu, il «remoto». E il luogo dove egli risiede, lontano nello spazio, è indicato dall'epopea ninivita con una formula assai suggestiva: ana pî-nārāti, «alla confluenza dei fiumi».
GIŠ-gím-maš a-na en-ki-dù ib-ri-šu
ṣar-piš i-bak-ki-ma i-rap-pu-ud EDIN(=ṣēra)
a-na-ku a-mat-ma ul ki-i en-ki-dù ma-a
ni-is-sa-a-tum i-te-ru-ub ina kar-ši-ia
mu-ta ap-làḫ-ma a-rap-pu-ud EDIN(=ṣēra)
a-na le-et UD-ZI(=napišti) DUMU(=mār) ubara-tu-tu
ur-ḫa ṣab-ta-ku-ma ḫa-an-ṭiš al-lak | Gilgameš per Enkidu, il suo amico,
piange amaramente, vagando per la steppa:
“Io morirò e non sarò allora come Enkidu?
Amarezza si impadronì del mio animo,
la paura della morte mi sopraffece e ora io vado per la steppa;
verso Ūtnapištî, il figlio di Ubāra-tutu,
sono sulla strada e viaggio rapidamente...” | Ša naqba īmuru [IX: -] |
Il cammino di Gilgameš è affidato quasi unicamente all'epopea ninivita,
a parte alcuni episodi attestati nel testo ḫittita. Mentre dorme, il lugal viene attaccato da un branco di leoni. Difficile dire se si tratta di un sogno: le lacunae del testo impediscono una piena comprensione dell'episodio. Gilgameš li affronta alla luce della luna e li disperde. È una scena onirica, suggestiva, che certo doveva avere in origine un'importanza molto maggiore nell'economia del mito originale, almeno a giudicare dalle molte immagini a noi pervenute che raffigurano l'eroe alle prese con le belve.
a-na né-re-bé-e-ti šá KURi(=šadî) ⌜ak⌝-ta-šad mu-ši-tam
UR.MAḪ(=nēšī) a-mur-ma ap-ta-làḫ a-na-ku
áš-ši re-ši-⌜ia⌝ a-na 30(=sîn) a-kar-rab
a-na ⌜⌝[× (×) na]-⌜mir⌝ -ti DIIR(=ilī) DUku(=illikū) su-pu-u-a
⌜⌝[30(=sîn) u ×]× šul-li-ma-in-ni ia-a-ti
[GIŠ-gím-maš i]t be-⌜ig⌝-gél-tu-ma šu-ut-tum
[× × × ×] ⌜mut⌝-[tíš] ⌜⌝30(=sîn) iḫ-te-du ba-la-ṭu
⌜iš-ši⌝ ḫa-a[ṣ-ṣi-in-na] a-na i-di-šu
iš-lu-up [nam-ṣar] šib-bi-šu
ki-ma šil-t[a-ḫi a-na b]i-ri-šú-nu im-qut
im-ḫa-aṣ la-[ab-biḫ i]-duk ú-par-ri-ir | “Di notte ho raggiunto passi montani:
ho visto leoni e ho avuto paura.
Ho alzato allora la testa, rivolgendo la mia preghiera a Sîn.
[...] Al più luminoso (?) degli dèi è rivolta la mia preghiera:
O [Sîn e...] fammi uscire sano e salvo!”
Di notte [Gilgameš] dormì (?) ma fu svegliato da un sogno.
[I leoni (?)] gioivano della vita alla luce della luna.
Allora egli prese l'asta nella sua mano,
estrasse [la spada] dalla guaina,
si buttò su di essi come una freccia,
li colpì, li uccise e li disperse. | Ša naqba īmuru [IX: -] |
Dopo un lungo viaggio, Gilgameš giunge infine allo šadû Māšu,
la grande montagna le cui basi poggiano sull'abisso e le cui cime si
ergono verso il cielo. Ogni mattino la illumina nel suo sorgere il dio-sole Šamaš. Il monte è fornito di una porta [bābu], a cui stanno di guardia due aqrab-amēlû, o «uomini-scorpione». Conosciamo già questi sgradevoli esseri, chiamati in sumerico girtab-lullu (GIR-TAB-LÚ₁₈-U-LU): li abbiamo intravisti tra le schiere di Tiāmat nell'Enūma Elîš. Quando Gilgameš li incontra, essi irradiano un fulgore divino [melāmmu] e nel loro sguardo c'è la morte. Di guardia alle porte del Māšu essi contemplano il sole nel suo sorgere e nel suo tramontare.
Ma non traspare malvagità da loro. I due aqrab-amēlû, un maschio e una femmina, scorgono Gilgameš giungere dal deserto, lacero e affamato, e constatano con stupore che il corpo dell'uomo è carne degli dèi, ma un terzo è umano. Non appena Gilgameš vede i due esseri, ne è terrificato. Si copre gli occhi e chiede loro di permettergli di proseguire alla ricerca di Ūtnapištî. (Ša naqba īmuru [IX: -]) La risposta dell'aqrab-amēlu è resa problematica dalle
lacunae nella tavoletta:
ul ib-ši GIŠ-gím-maš G[IM(=kīma)...]
ša ša-di-i ma-am-ma du-×[...]
a-na 12 DANNA(=bēr) lib-ba-š[u...]
ša-pat ek-le-tùm-ma ul i[b-ba-áš-ši nu-ru]
a-na a-ṣe-e ⌜UTUši(=šamši) i⌝-[...]
a-na e-reb U[TUši(=šamši)...] | “O Gilgameš, non c'è stato [...] che [...].
nessuno della montagna [...]
per dodici bēru le sue viscere.
densa è l'oscurità, non vi è [luce]
verso il sorgere del sole [...]
rivolto al s[ole...]” | Ša naqba īmuru [IX: -] |
Una lunga lacuna ci impedisce di cogliere altri dettagli di questa straordinaria «uscita dal mondo» compiuta da Gilgameš attraverso la «porta» dello šadû Māšu. Il seguito della tavola narra il cammino dell'eroe lungo il ḫarran šamši, il «sentiero del sole».
Nessuna luce trova il nostro eroe nelle «viscere» [libbû] del Māšu: il nostro eroe avanza in una tenebra assoluta, con incrollabile determinazione, per dodici bērû. Quest'unità di misura, come già abbiamo detto, corrispondeva più o meno a dieci chilometri; ma un bēru era anche una misura del tempo, per l'esattezza una delle dodici «ore» in cui i babilonesi dividevano la durata del giorno. Ma i dodici bērû che troviamo qui vanno intesi in senso spaziale o temporale? Gli studiosi li interpretano di solito in questa seconda accezione. Dodici bērû fanno quindi ventiquattro delle nostre ore. Un giorno intero avanzando a tentoni attraverso la totale oscurità. Gilgameš non vede nulla davanti a sé, nulla dietro di sé. Poi, al nono bēru egli avverte il primo refolo
del vento del nord sul viso, e solo all'undicesimo bēru comincia a intravedere in lontananza il primo bagliore del giorno. (Ša naqba īmuru [IX: -]) Quando infine egli emerge dalle viscere della montagna, quale stupenda visione dinanzi ai suoi occhi!
×[... n]a-mir-tú šak-na-at
a-×[× ×]× ×-ḫi iṣ-ṣi ⌜šá DIIR(=ilī)⌝ ina a-ma-ri i-ši-ir
⁴GUG(=sāmtu) na-šá-at i-ni-ib-šá
is-ḫu-un-na-tum ul-lu-la-at a-na da-ga-la ḫi-pat
⁴ZA.GÌN(=uqnû) na-ši ḫa-as-ḫal-ta
in-ba na-ši-ma a-na a-ma-ri ṣa-a-a-aḫ
[...]
GIM(=kīma) DÌḪ(=balti) u K[IŠI(=ašāgi) ib-šu-ú ⁴]
AN.ZA.GUL.ME
ḫa-ru-bu ⌜il⌝-p[u-ut ⁴A]D(=aba)-aš-⌜mu⌝
⁴ŠUBA(=šubû) ⁴K[A.GI.NA(=adānu) × (×)]×-an-⌜rat⌝ | [Dopo il dodicesimo bēru, ecco] risplende la luce!
Sbalordito avanza nel vedere gli alberi degli dèi:
la corniola porta i suoi frutti,
la vite vi è appesa con i grappoli, bella da ammirare.
Il lapislazzuli porta foglie,
e anch'esso porta frutti piacevoli da guardare.
[...]
Come fosse arbusti e cespugli, fiorisce
l'AN.ZA.GUL.ME.
Il carrubbo egli prende in mano, ed ecco è calcedonio,
grappoli di gemme, ematite... | Ša naqba īmuru [IX: - ... -] |
La scena è sospesa in un'atmosfera incantata, fiabesca, e lo sbalordimento di Gilgameš è perfettamente percepibile. Persino la traduzione si fa incerta, quasi in punta di penna, perché gli studiosi non sono sicuri di aver identificato le varietà di gemme e pietre preziose di cui sono fatti i frutti che pendono dagli alberi. Siamo certi però di essere sulla pista giusta: un eco del giardino di ʿĒḏẹn si riverbera sicuramente in questo frutteto meraviglioso, posto all'uscita dello šadû Māšu, in cui crescono gli «alberi degli dèi» [iṣû ilī] [IX: ]. Nell'epopea classica, Gilgameš si limita a superare questo frutteto e e qui si conclude la nona tavola. Ma qualcosa di più sorprendente viene invece narrato nella cosiddetta tavoletta di Berlino/Londra. In questa versione antico-babilonese, il frutteto non compare; al suo posto,
il dio Šamaš parla con il lugal di Uruk che, lacero e affaticato, avanza verso il mare. Vi sono delle lacunae, ma si capisce che Gilgameš sta raccontando a Šamaš la sua storia e le ragioni che l'hanno spinto nel suo viaggio ai confini del mondo,
e la risposta di Šamaš è diretta e tagliente:
GIŠ e-eš ta-da al
ba-la-ṭám ša ta-sa-aḫ-ḫu-ru la tu-ut-ta | “Gilgameš, dove stai andando?
la vita che cerchi, non la troverai.” | AB [B/L: i, '-'] |
All'inizio della tavola X, Gilgameš già udiva le onde battere la spiaggia. Poco dopo egli arriva a una locanda che si erge proprio sulla riva del mare. La taverniera, Šiduri,
non appena vede arrivare quest'uomo emaciato, vestito di pelli, s'impaurisce e chiude la porta. Gilgameš la blocca col piede e le racconta la sua storia. Le narra della fine di Enkidu,
del suo terrore di essere ghermito dalla morte e di come sia giunto
in quel luogo remoto alla ricerca della vita (Ša naqba īmuru [X: -]). Nella versione classica, Šiduri non dà risposta ed è ancora una volta la versione antico-babilonese,
attestata nella tavoletta di Berlino/Londra, a riportarci le parole toccanti della donna, qui chiamata semplicemente sābītu, la «taverniera»:
GIŠ e-eš ta-da al
ba-la-ṭám ša ta-sa-aḫ-ḫu-ru la tu-ut-ta
i-nu-ma DIIR(=ilū) ib-nu a-wi-lu-tam
mu-tam iš-ku-nu a-na a-wi-lu-tim
ba-la-ṭám in-a qá-ti-šu-nu iṣ-ṣa-ab-tu
at-ta GIŠ lu ma-li ka-ra-aš-ka
ur-ri ù mu-šī ḫi-ta-ad-dú at-ta
u₄-mi-ša-am šu-ku-un ḫi-du-tam
ur-ri ù mu-šī su-ur ù me-li-il
lu ub-bu-bu ṣú-KU(=ba)-tu-ka
qá-qá-ad-ka lu me-si me-e lu ra-am-ka-ta
ṣú-ub-bi ṣe-eḫ-ra-am ṣa-bi-tu qá-ti-ka
mar-ḫī-tum li-iḫ-ta-⌈⌜ad-da-am⌝⌉ in-a su-ni-⌈ka⌉
an-na-ma ši-i[m-ti a-wi-lu-tim] | “Gilgameš, dove stai andando?
La vita che cerchi, non la troverai.
Quando gli dèi crearono l'umanità,
essi assegnarono la morte per l'umanità,
tennero la vita nelle loro mani.
Così, Gilgameš, riempi il tuo stomaco,
giorno e notte datti alla gioia,
fa' festa ogni giorno.
Giorno e notte canta e danza,
che i tuoi vestiti siano puliti,
che la tua testa sia lavata: làvati con acqua,
gioisci del bimbo che tiene la tua mano,
possa tua moglie godere al tuo petto.
Questo è des[tino di ogni uomo (?)].” | AB [B/L: iii, -] |
Non è stata mai spiegata completamente, la splendida figura di Šiduri, l'ostessa che siede sulla riva
del mare ai confini del mondo. Ma non dobbiamo prendere alla leggera le sue parole. L'immagine dell'enofora era ancora usata secoli dopo dai ṣūfī
islāmici come metafora della rivelazione mistica. Il suo messaggio, nel quale udiamo riecheggiare Qōhẹlẹṯ [9: -], è un invito all'accettazione dell'umanità, nei suoi dolori come nelle sue gioie. Non si può fare a meno di pensare che nel fatalista mondo mesopotamico non esistesse
alcun modo per superare lo iato tra l'umanità, creata per servire gli dèi, e gli dèi, gelosi della loro beatitudine e immortalità. Ma Gilgameš non è affatto persuaso dalle parole della sābītu. È abbattuto dal dolore della morte di Enkidu, terrorizzato all'idea che anch'egli è destinato a diventare argilla. Nell'epopea ninivita
non v'è traccia della morale esistenzialista di Šiduri. Il dialogo tra i due si incentra sugli aspetti narrativi della vicenda, sulle sovrumane difficoltà del viaggio che Gilgameš ha intrapreso. Egli domanda alla taverniera quale sia la via per arrivare a Ūtnapištî, e la risposta di Šiduri è:
ul ib-ši GIŠ-gím-maš né-bé-ru ma-ti-ma
u ma-am-ma šá ul-tu u₄-um ṣa-at {KUR} la ib-bi-ru tam-ta
e-bir tam-ti UTU(=šamaš) qu-ra-du-um-mu
ba-lu UTU(=šamaš) e-bir tam-tim man-⌜nu⌝⌉
pa-áš-qat né-ber-tum šup-šu-qat ú-ru-uḫ-šá
ù bi-ra-a A(=mê) mu-ti
šá pa-na-as-sa par-ku
a-ḫum-ma GIŠ-gím-maš te-te-bir tam-ta
a-na A(=mê) mu-ú-ti ki-i tak-tal-du te-ep-pu-uš mi-na | “O Gilgameš, non c'è mai stato un traghetto
e nessuno dai tempi antichi ha mai attraversato il mare [tâmtu];
l'unico che attraversa il mare è l'eroe Šamaš:
al di fuori di Šamaš chi può mai attraversare il mare?
La traversata è difficile, la via piena di insidie;
e in mezzo vi sono le acque della morte [mê mūti]
che impediscono il passaggio.
Come puoi tu, quindi, Gilgameš, attraversare il mare?
E una volta che hai raggiunto le acque della morte, cosa farai?” | Ša naqba īmuru [X: -] |
Lo Ša naqba īmuru non fornisce spiegazioni su questo «mare» [tâmtu]. Si tratta probabilmente del Marratu, il fiume «amaro» che circonda il mondo, secondo il termine attestato nella
Imago mundi Babylonica. Ma questo «mare», spiega Šiduri, nessuno può attraversarlo, perché in esso scorrono le mê mūti, le «acque della morte». Šiduri è chiara: solo il dio-sole Šamaš può navigare
su di esso. In realtà, aggiunge Šiduri, c'è anche un'altra persona che può attraversare le mê mūti. È Uršanabi, il
nocchiero di Ūtnapištî. Solo lui potrà condurre il lugal di Uruk da Ūtnapištî. Gilgameš si mette dunque alla ricerca di Uršanabi (Sursunabu nella versione antico-babilonese). Ma a questo punto succede qualcosa di non molto chiaro, che le pessime condizioni delle tavolette non aiutano a stabilire. Non appena Gilgameš arriva al campo di Uršanabi, eccolo furibondo a distruggere delle enigmatiche «cose di pietra». Uršanabi arriva di corsa, attirato dal rumore, cerca di bloccare Gilgameš e i due si azzuffano. (Ša naqba īmuru [-] | AB [B/L: iv, -]). Uršanabi/Sursunabu blocca Gilgameš al suolo e gli chiede chi sia. Il lugal di Uruk narra ancora una volta tutta la sua vicenda e spiega le ragioni che lo spingono a voler arrivare da Ūtnapištî.
GIŠ šu-mi a-na-ku
ša al-li-kam iš-tu uruk⁽⁼!⁾ é-an-ni
ša ás ḫu-ra-am ša-di-i
ur-ḫa-am re-qé-e-tam wa-ṣa-ú UTUši(=šamši)
i-na-an-na su-ur-su-na-bu a-ta-mar pa-ni-ka
ku-ul-li-ma-an-ni ú-ta-na-iš-tim re-qá-am | “Gilgameš è il mio nome,
sono colui che è venuto dall'Eanna di Uruk,
colui che ha vagato per le montagne
compiendo un lungo viaggio verso il sorgere del sole.
Ora che ho visto la tua faccia, Sursunabu,
mostrami Ūtanaʾištîm il distante [rēqu].” | AB [B/L: iv, -] |
Risponde il battelliere:
šut-ut ab-nim-ma GIŠ mu-še-bi-ru-ú-ia
aš-šum la a-⌜la⌝-op-pa-tu me-e mu-tim
i-na uz-zi-ka tu-úḫ-te-ep-pí-šu-nu-ti. | “Le cose di pietra, o Gilgameš, erano le mie guide,
in modo che io non toccassi le acque della morte.
Tu, nella tua furia, le hai frantumate...” | AB [B/L: iv, -] |
A questo punto il lettore non si stupisca se anche lo studioso tradisce la sua perplessità. Cosa sono esattamente queste «cose di pietra» [sût abnê]? Come possono proteggere il battello di Uršanabi attraverso le «acque della morte» [mê mūti]? E perché Gilgameš le ha distrutte? Gli specialisti sono sempre rimasti imbarazzati di fronte a questi problematici oggetti, di cui non è stata ancora proposta un'interpretazione convincente. Si dice che senza di essi non si può navigare sulle mê mūti, anche se poi il viaggio è fattibilissimo.
Alcuni hanno parlato di ancore, altri di pietre di zavorra, altri ancora di immagini magiche. La versione ḫittita dell'epopea parla di «idoli di pietra», ma anche questo non ci aiuta molto. Non sappiamo e non sapremo mai, forse,
cosa fossero le sût abnê. Per attraversare le acque della morte, avendo distrutto le «cose di pietra», Gilgameš deve procurare trecento pali, lunghi cinque cubiti ciascuno. L'eroe si mette subito al lavoro. Taglia gli alberi, li scorteccia, leviga il legno, finché non ha procurato la quantità richiesta di pali (Ša naqba īmuru [-] | AB [B/L: iv, ]). Con questi preparativi s'interrompe la versione antico-babilonese. D'ora in poi il nostro unico testimone sarà l'epopea ninivita. Uršanabi vara la sua barca e i due eroi iniziano la navigazione. Il percorso di un mese e mezzo viene compiuto in soli tre giorni: poi
l'imbarcazione arriva alle mê mūti. Allora Uršanabi avverte Gilgameš:
um-MEŠ TE GIŠ-gím-maš [l]i-⌜qé⌝-[1-en pa-ri-su]
A(=mê) mu-ti qat-ka a-a il-ta-pit tu-⌜šam⌝-[× (×) ×]
2-a šal-šá u re-ba-a GIŠ-gím-maš li-qé pa-r[i-su]
¿a-an-šá 6-šá u 7-a GIŠ-gím-maš li-qé pa-ri-[su]
8-a 9-a u 10-a GIŠ-gím-maš li-qé pa-ri-s[u]
11-a 12-a GIŠ-gím-maš li-qé pa-ri-s[u]
ina 2.GÌ! GIŠ-gím-maš ug-dam-me-ra pa-r[i-si]
u šu-ú ip-ṭur MURUB₄(=qabal)-šú [× (×)]
GIŠ-gím-maš iḫ-ta-ma-aṣ TÚ[G(=ṣubāt)-su]
ina kap-pi-šú ka-ra-a ú-šaq-[qí] | “Sta' indietro Gilgameš! Prendi [un primo palo],
che le mê mūti non sfiorino la tua mano [...];
un secondo, un terzo e un quarto palo prendi o Gilgameš;
un quinto, un sesto e un settimo palo prendi o Gilgameš;
un ottavo, un nono e un decimo palo prendi o Gilgameš;
un undicesimo, un dodicesimo palo prendi o Gilgameš”.
Preso il centoventesimo, Gilgameš aveva esaurito tutti i pali.
Allora egli [Uršanabi] slacciò la cintura,
quindi Gilgameš si spogliò dei suoi vestiti,
e li stese come le braccia[come fosse] l'albero della nave. | | Ša naqba īmuru [X: -] |
Facendo egli stesso da albero e usando il suo vestito come vela, Gilgameš riesce a far arrivare la barca nel Pû-nārāti, alla «bocca dei fiumi», dove
si trova la terra di Ūtnapištî, il «remoto» [rēqu]. Fino a ora, Ūtnapištî è stato presentato dallo Ša naqba īmuru come un personaggio arcaico, lontano, leggendario per lo stesso Gilgameš. Ma ora il mito viene sfatato. Ūtnapištî è un vecchio saggio che vive oziando nella sua isola ai confini del mondo. È sorpreso, e non troppo entusiasta, nel ricevere la visita inaspettata di Gilgameš. E quando il lugal di Uruk gli spiega di essere giunto fino a lui alla ricerca della vita, Ūtnapištî è costretto a dissuaderlo. La sua risposta è amara e terribile:
[× × t]a-ad-da-li-ip mi-na-a ta-⌜al-qu⌝
[ina d]a-la-pi tu-un-na-ḫ[a ra-man-ka]
⌜SA(=širʾānī)⌝-ka ni-is-sa-t[a] tu-mál-⌜la⌝
ru-qu-tu tu-qar-r[a-ab] U₄(=ūmī)-ka
a-me-lu-tum šá GIM(=kīma) GI(=qanê)
a-pi ḫa-ṣi-pi {×} šùm-šú
eṭ-la dam-qa KI.SIKILta(=ardata) da-me-eq-tum :
ur-[ru-ḫiš...]-šú-nu-ma i-šal-lal mu-ti
⌜ul ma⌝-am-ma mu-ú-tu im-⌜mar⌝ :
ul ma-am-m[a ša mu-ti i]m-⌜mar⌝ pa-ni-šú
⌜ul ma-am-ma⌝ ša mu-ti rig-⌜ma-šú⌝ [i-šem-me]
ag-gu ⌜mu-tum⌝ ḫa-ṣi-pi LÚ(=amēlu)-ut-tim
⌜im-ma⌝-ti-ma ni-ip-pu-šá É(=bīta) :
im-ma-ti-ma ni-qan-⌜na-nu⌝ qin-nu
⌜im⌝-ma-ti-ma ŠEŠ(=aḫḫū) i-zu-uz-[zu]
⌜im⌝-ma-ti-ma ze-ru-tum i-ba-áš-ši ina [KUR(=māti)]
im-ma-ti-ma ÍD(=nāru) iš-šá-a ILLU(=mīla) ub-lu
ku-li-li 〈iq〉-qé-lep-pa-a ina ÍD(=nāri)
pa-nu-šá i-na-aṭ-ṭa-lu pa-an UTUši(=šamši)
ul-tu ul-la-nu-um-ma ul i-ba-áš-ši mim-ma
šal-lu ù mi-tum ki-i KA(=pî) a-ḫa-meš-ma
šá mu-ti ul iṣ-ṣi-ru ṣa-lam-šú
LÚ.U₁₈.LUú(=lullû) LÚ(=amēlu) e-dil : ul-tu ik-ru-bu-[××]
a-nun-na-ki DIIR(=ilū) GAL(=rabûtu) paḫ-ru
ma-am-me-tum ba-na-at šim-ti
KI(=itti)-šú-nu ši-ma-tú i-ši[m-ma]
iš-tak-nu mu-ta u ba-la-ṭ[a]
šá mu-ti ul ud-du-ú U₄(=ūmī)-šú
[šá-niš ul-te-du-ú] | “Perché ti agiti privandoti del sonno? Che cosa hai ottenuto?
Ti sei indebolito con tutti i tuoi affanni,
hai solo riempito il tuo cuore di angoscia,
avvicinando la fine della tua vita.
La progenie dell'uomo viene recisa
come canne in un canneto.
Sia il giovane uomo che la graziosa giovane fanciulla,
tutti loro sono presto preda della morte.
Eppure nessuno vede la morte,
nessuno vede il volte della [morte],
nessuno [ode] la voce della morte:
la morte malefica è colei che recide l'umanità.
A volte possiamo costruire una casa,
a volte possiamo fondare una famiglia,
a volte i fratelli sono uno contro l'altro,
a volte vi sono scontri nel paese,
e i fiumi possono ingrossarsi e portare inondazioni.
Noi siamo come libellule che sorvolano il fiume:
il nostro sguardo si rivolge al sole
e un attimo non c'è più nulla!
Il dormiente e il morto come si somigliano!
Nessuno può disegnare la sagoma della morte.
Il morto non saluta più l'uomo sulla terra.
Gli anunnaki, i grandi dèi, sedettero a consiglio;
Mammitum, che forgia i destini,
decretò con essi:
stabilirono la morte e la vita;
e non contarono i giorni della morte
[a differenza di quelli della vita].” | | Ša naqba īmuru [X: -] |
Ūtnapištî racconta a Gilgameš la sua storia, ed è la storia del diluvio che aveva impressionato George Smith, mentre ordinava le migliaia di frammenti di tavolette accatastati nei magazzini del British Museum. Il racconto di Ūtnapištî occupa una buona metà dell'undicesima tavola (Ša naqba īmuru [XI: -]), ed è un racconto di cui ci siamo occupati
in altra sede. Un tempo, gli dèi, guidati da Enlil, avevano deciso di mandare il diluvio e sterminare l'umanità. Il saggio Ea aveva però avvertito Ūtnapištî, lugal di Šuruppak, dell'incombente catastrofe. Ūtnapištî
aveva costruito una grande imbarcazione, di forma cubica, su cui si
era imbarcato con la sua famiglia e con tutti gli animali che aveva
potuto caricare, ed era sfuggito alla furia del diluvio. Alla fine
del cataclisma, la strana nave era approdata sul monte Nimuš. Subito Ūtnapištî aveva imbandito un sacrificio agli dèi, i quali erano accorsi sentendo il profumo delle offerte che saliva al cielo.
Dapprima Enlil si era infuriato,
accorgendosi che qualcuno era sopravvissuto alla catastrofe, ma Ea l'aveva rimproverato per l'eccessiva crudezza della punizione. Riportato a più miti consigli, Enlil si era rivolto ad Ūtnapištî con queste parole:
i-na pa-na UD-ZI(=napišti) a-me-lu-tùm-ma
e-nin-na-ma UD-ZI(=napišti) u MUNUS(=sinništa)-šú lu-u e-mu-ú
ki-ma DIIR(=ilī) na-ši-ma
lu-ú a-šib-ma UD-ZI(=napišti) ina ru-ú-qí ina pi-i ÍD(nārāti) | “Prima, Ūtnapištî, era un uomo,
ora Ūtnapištî e sua moglie
sono simili agli dèi.
Risieda lontano Ūtnapištî,
nel Pû-nārāti.” | | | Ša naqba īmuru [XI: -] |
Dunque, la vita eterna che Ūtnapištî e sua moglie avevano ricevuto, era stata un dono degli dèi, un dono irripetibile. “E ora, chi potrà riunire per te l'assemblea divina?” [] è la domanda che Ūtnapištî rivolge a Gilgameš, una domanda a cui non c'è risposta. Inutili le insistenze di Gilgameš: vinto dalla stanchezza, l'eroe cade in un sonno profondo. Ūtnapištî fa disporre ogni giorno un pane appena sfornato vicino al corpo addormentato dell'eroe, e quando Gilgameš si sveglia, convinto di essersi appisolato
solo per poche ore, Ūtnapištî può dimostrargli che ha dormito sette giorni di fila. E se il potente lugal di Uruk si lascia vincere così facilmente dal sonno, gli chiede, come potrà resistere alla morte? (Ša naqba īmuru [XI: -]) A Gilgameš non resta che tornare indietro. “Cosa dovrei fare, Ūtnapištî? Dove dovrei andare? La morte dimora nella mia camera da letto” [-]. Ma prima che l'eroe parta, dietro consiglio della moglie, Ūtnapištî lo convoca un'ultima volta e gli riferisce di un
arbusto chiamato šammu nikitti, la «pianta dell'irrequietezza», che cresce sul fondo dell'Apsū. Ha radici simili a quelle di un rovo, ma le spine sono come quelle della rosa canina. La pianta ha la straordinaria virtù di far tornare giovani i vecchi e, se Gilgameš riuscirà a coglierla, potrà riottenere la perduta gioventù...
GIŠ-gím-maš an-ni-tú ina še-me-šú :
ip-ti r[a-a-ṭa...]
ú-rak-ki-is NA₄(=abnī) kab-tu-t[a a/ina šēpī-šú]
il-du-du-šu-⌜ma⌝ ana ABZ[U(=apsî) ...]
šu-ú il-⌜qé⌝ šam-ma-ma is-s[u-ḫa ...]
ú-bat-ti-iq NA₄(=abnī) kab-tu-t[a ina šēpī-šú]
⌜tam⌝-tum is-su-kaš-šú a-⌜na kib-ri⌝-šú
⌜⌝[GIŠ]-gí[m]-maš a-na šá-šu-ma
MUra(=izakkara) a-na ur-šánabi ma!-la-ḫu
ur-šánabi šam-mu an-nu-ú šam-mu ni-kit-ti
šá LÚ(=amēlu) ina lìb-bi-šú i-kaš-šá-du nap-BI(=šat!)-su
⌜lu-bil-šu⌝ ana lìb-bi UNUG(=uruk) su-pu-ri
lu-šá-kil ši-ba-am-ma šam-ma lul-tuk
⌜šum-šu⌝ ši-i-bu iṣ-ṣa-ḫir LÚ(=amēlu)
a-na-ku lu-kul-ma lu-tur ana šá ṣu-uḫ-ri-ia-a-ma | Appena Gilgameš udì ciò,
egli aprì un [... foro canale passaggio],
pesanti pietre [si legò ai piedi],
e s'immerse nell'Apsū [...];
egli, egli prese la pianta e la strappò [via...],
slegò quindi le pesanti pietre [dai suoi piedi],
e così il mare lo fece risalire fino alla riva.
Gilgameš parlò a lui,
a Uršanabi il battelliere:
“Uršanabi, questa è la «pianta dell'irrequietezza» [šammu nikitti];
grazie ad essa l'uomo può riottenere la sua vitalità,
io la porterò a Uruk, l'ovile,
la darò da mangiare ai vecchi e così proverò la pianta.
Il suo nome sarà: vecchio-torna-giovane.
Anch'io mangerò la pianta e così ritornerò giovane”. | | Ša naqba īmuru [XI: -] |
Animato da questo proposito, Gilgameš riprende, insieme ad Uršanabi, la via del ritorno verso Uruk. Essi si fermano per la notte presso una sorgente dalle acque fresche. Gilgameš si tuffa e si lava in quelle acque. Nel frattempo, un serpente,
strisciando, avverte la fragranza della pianta. Si avvicina e la divora. E subito
l'animale perde la pelle e torna giovane. Quando Gilgameš si avvede di quel che è accaduto, si siede e piange amaramente. Le lacrime scorrono sulle sue guance. In tal modo egli dovrà rinunciare al suo sogno di immortalità. Tornato a Uruk, Gilgameš mostra ad Uršanabi l'altezza e la robustezza delle mura, che egli stesso aveva fatto innalzare. E così termina l'epopea classica.
A mo' di epilogo, o forse di morale, possiamo citare l'antico poema
sumerico sulla morte dell'eroe, dove il dio Enlil compare in sonno a Gilgameš,
sussurrandogli:
kur gal en-líl-le a-a diir-re-e-ne-ke₄
en gilgaméš ma-mú-da […] × DU bal-da-bi
[...]
ní-gig ak nam-lú-u₁₈-lu-ke₄ ne-en de6-a ma-ra-dug₄
ní gi-dur kud-da-zu ne-en de₆-a ma-ra-dug₄
ud ku₁₀-ku₁₀ nam-lú-u₁₈-lu-kam sá mi-ri-ib-dug₄
ki dili nam-lú-u₁₈-lu-kam sá mi-ri-ib-dug₄
a-i₆ gaba nu-ru-gú sá mi-ri-ib-dug₄
⌜mè⌝ ka-re nu-me-a sá mi-ri-ib-dug₄
šen-šen nu-sá-a sá mi-ri-ib-dug₄
iš-iš-lá šu kar-kar-re nu-me-a sá mi-ri-ib-dug₄
⌜iri₁₁⌝-gal šag₄ zú kešé-zu nam-ba-du-un | La grande montagna Enlil ti ha destinato alla regalità,
o Gilgameš, non alla vita eterna.
[...]
Dovresti sapere qual è il destino comune a ogni uomo.
Dovresti sapere cosa significa il taglio del tuo cordone ombelicale.
Il giorno più buio di ogni uomo ti attende.
Il luogo solitario di ogni uomo ti attende.
Le onde inarrestabili del diluvio ti attendono.
La battaglia che non si può vincere ti attende.
La lotta ineguale ti attende.
Lo scontro da cui non si fugge ti attende.
Ma tu non scendere negli inferi con il cuore serrato nell'angoscia... |
Ursa [amgale] banu [E: - ... -] |
Gilgameš fu un grande sovrano e regnò in tutto per centoventi anni. Poi morì, come doveva essere.
[× × (×)] ur-⌜sa⌝ [ba-nú ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
[…] × [… ba-nú ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
⌜á-úr⌝ sag₉-[sag₉ (…) ba-nú ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
× [… ba-nú ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
ní-érim [… ba-nú ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
nitaḫ […] ba-[nú ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
⌜éšpu⌝ lirum ⌜šu du₇⌝-a ba-⌜nú⌝ [ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
⌜lú⌝ UM × DA ⌜ál⌝-e ba-⌜nú⌝ [ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
en kul-aba₄ki-ke₄ ba-⌜nú⌝ [ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi]
igi kug-⌜zu dug₄⌝-dug₄-ga ba-nú ḫur [nu-mu-e-da-an-zi-zi]
lib₄-lib₄ ma-⌜da⌝-e ba-nú ḫur nu-[mu-e-da-an-zi-zi]
ḫur-sa èd-dè-dè ba-nú ḫur nu-⌜mu⌝-[e-da-an-zi-zi]
iš-nú nam-tar-ra-ka ba-nú ḫur nu-mu-[e]-da-an-zi-[zi]
ki-nú ù-⌜u₈⌝-a-⌜u₈⌝ ba-nú ḫur nu-mu-e-da-an-zi-zi | [...] L'eroe [...] giace, non si alza;
[...] giace, non si alza;
Colui che aveva un corpo perfetto [...] giace, non si alza;
[colui che ha distrutto] il male [giace, non si alza];
il giovane che [...], giace, non si alza;
[colui che era] perfetto [...] di forza, giace, non si alza;
colui che [...] di forza, giace, non si alza;
colui che [...], giace, non si alza;
il signore di Kulaba, giace, non si alza;
colui che parlava saggiamente, giace, non si alza;
colui che ha saccheggiato (?) molti paesi, giace, non si alza;
colui che ha scalato le montagne, giace, non si alza;
nel letto di morte egli giace, non si alza;
nel letto dei singhiozzi egli giace, non si alza... |
Ursa [amgale] banu [A: -] |
| | A EST DELL'ALBA, A OVEST DEL TRAMONTO Se non avessimo posseduto la versione classica in dodici tavole del Ša naqba īmuru, trovata nella biblioteca di Aššur-bāni-apli a Ninive, sarebbe stato difficile dare un senso compiuto agli sparsi poemetti sumerici sull'eroe Bilgames. Da questo punto di vista gli orientalisti sono stati fortunati: non solo hanno a disposizione l'ultima e definitiva versione del poema mesopotamico, ma anche buona parte delle antiche fonti che sono venute a convergere nella narrazione ninivita. Possono dunque tentare di tracciare la storia del poema in fieri, durante i secoli della sua formazione. E questo è molto di più di quanto i classicisti non possano osare con i poemi omerici, di cui possiedono solo la versione
finale. Ci si può chiedere in quale modo gli scribi dell'epopea neo-assira, o più probabilmente i loro diretti antecessori, abbiano messo insieme le fonti che avevano sottomano. Basti pensare che la dodicesima e ultima tavola dell'epopea – che abbiamo saltato nel nostro resoconto – non è direttamente correlata al resto della narrazione. È una sorta di appendice dove si narra una versione alternativa della morte di Enkidu, tratta dal poema sumerico Ud rea ud sura rea, non coerente con la vicenda narrata nelle undici tavole precedenti. Invece, le tavolette antico- e medio-babilonesi contengono già quasi tutti gli elementi delle prime sette tavole dello Ša naqba īmuru. La parte relativa al viaggio di Gilgameš alla ricerca della vita è
però molto rara nelle versioni pre-ninivite. È limitata ai pochi episodi
attestati
nella tavoletta di Berlino/Londra: il dialogo con Šamaš, l'incontro con Šiduri/sābītu, e quello con
Uršanabi/Sursunabu, dove l'eroe afferma di voler incontrare Ūtnapištî (AB [B/L]). Possiamo avere una certa fiducia che la vicenda fosse già stata composta,
in una forma assai simile a quella che conosciamo, nella prima metà del Secondo millennio avanti Cristo. Anche la versione ḫittita, che dipende da quella antico-babilonese, è una preziosa indicazione in tal senso. Diverso il caso dei poemi sumerici, risalenti al Terzo millennio avanti Cristo, i quali sembrano presentarsi
come episodi slegati tra loro. Sebbene alcuni di essi presentino un riscontro nel ciclo accadico, il mito del viaggio di Gilgameš alla ricerca della vita è assente nei testi sumerici a noi noti. Ciò potrebbe significare,
semplicemente, che la versione sumerica del mito non è pervenuta fino a noi.
Oppure, questa parte del ciclo potrebbe essere stata del tutto
sconosciuta ai Sumeri per venire elaborata solo nelle versioni semitiche dell'epopea di Gilgameš. Questo secondo scenario apre delle interessanti prospettive, ma non sappiamo quanto sia realistico. Per analizzare efficacemente la cosmologia sottesa ai viaggi di Gilgameš è necessario partire dalla versione neo-assira del ciclo, la più tarda e meglio conservata: lo Ša naqba īmuru.
Primo mitotopo. Lo šadû Māšu
Ora, c'è parecchia di incertezza sull'itinerario percorso da Gilgameš. Si presume che il lugal di Uruk si sia diretto verso oriente, in direzione del sorgere del sole, ma anche questo dato non viene mai esplicitato in alcuna versione conosciuta del poema ninivita, bensì inferito dal fatto che il noè sumerico
Ziudsura venne traslato «in una regione al di là del mare, a Dilmun, dove si leva Utu» [kur-bal kur dilmun-na ki utu éd-šè mu-un-tìl-eš] («Poema di Ziudsura» [V: ]). Ma prima di trarre conclusioni dal confronto tra testi tanto differenti – procedimento legittimo ma da effettuare sempre con somma cautela – dobbiamo limitarci all'ermeneutica dello Ša naqba īmuru. Una prima difficoltà la incontriamo quando l'eroe si trova di fronte allo šadû Māšu. È un passo piuttosto importante per la nostra comprensione della cosmografia mesopotamica:
šá ša-di-i še-mu-šú ma-š[u-(um)-ma]
ana ša-ad ma-a-ši i-na ka-š[á-di-šu]
šá u₄-mi-šam-ma i-na-aṣ-ṣa-ru a-ṣ[e-e UTU(=šamši)
u e-reb UTU(=šamši)]
e-lu-šu-nu šu-pu-uk AN(=šamê) i[n-du]
šap-liš a-ra-le-e i-rat-su-nu ⌜kaš-da-át⌝
gír-tab-lú-u₁₈-lu i-na-aṣ-ṣa-ru KÁ(=bāb)šu
ša ra-áš-bat pu-ul-ḫat-su-nu-ma im-rat-su-nu mu-tú
gal-tu mi-lam-mu-šu-nu sa-ḫi-ip ḫur-sa-a-ni
ana a-ṣe-〈e〉 UTU(=šamši) u e-reb UTU(=šamši)
i-na-aṣ-ṣa-ru UTU(=šamši)-ma | Il nome della montagna è Māšu.
Appena giunse allo šadû Māšu
che giornalmente guarda il s[sorgere del sole
e il tramontare del sole]
– sulle loro cime grava la volta celeste,
l'Arallû tocca il loro petto –
gli aqrab-amēlû stanno a guardia della sua porta,
grande terrore incutono, c'è la morte nel loro sguardo,
il loro
melāmmu riempie le montagne,
essi stanno a guardia del sole, al tramonto del sole
e al sorgere del sole. | Ša naqba īmuru [IX: -] |
Il sostantivo māšu vuol
dire «gemello». Ma come dobbiamo intendere l'oronimo? Lo šadû Māšu è caratterizzato da due picchi gemelli che si rizzano fino al cielo, oppure è
un elemento di una coppia di montagne gemelle? Il problema non è di facile soluzione: bābšu, «la sua porta», al verso [IX: ], è caratterizzato dal pronome possessivo singolare -šu; mentre ēlūšunū e iratšunū, «le loro cime» e «il loro petto», ai versi [IX: -], portano il pronome possessivo plurale -šunū.
L'assiriologo Andrew R. George, curatore di quella che al momento è
l'edizione critica definitiva dello Ša naqba īmuru,
suggerisce la possibilità che il singolare si riferisca al monte che Gilgameš ha davanti,
che è quella posta dinanzi al sorgere del sole, e che il plurale comprenda idealmente
anche la montagna gemella situata all'altra estremità della terra,
dinanzi al tramonto (George 2003).
Altri studiosi, tuttavia, ritenendo che la montagna sia solo una, sostengono che i versi [IX: -] si riferiscano agli aqrab-amēlû, gli «uomini-scorpione», per quanto sia curiosa l'immagine di questi terrificanti esseri con la testa che tocca il cielo (ēlū è «alto, superiore») e l'Arallû che arriva al loro petto (Pettinato 1992). Altri ancora ritengono che il plurale si riferisca invece al numero dei picchi dello šadû Māšu. Il verso mutilo [IX: ] è di solito emendato in šá umišama inaṣaru a[ṣê šamši u ereb šamši], «che giornalmente guarda il sorgere del sole e il tramontare del sole», anche per analogia con il verso [IX: ], dov'è scritto che gli aqrab-amēlû «stanno a guardia del sole, al tramonto del sole e al sorgere del sole». Sembra però strano che il sole sorga e tramonti passando per la
medesima porta. Il professor George, notando che sulla tavola, in corrispondenza del verso [IX: ], non sembra esserci abbastanza spazio per un verso tanto lungo, ma forse anche per scrupolo di realismo, propone una lectio brevis della frase incriminata: šá umišama inaṣaru a[ṣê šamši], «che giornalmente guarda il sorgere del sole». Questa lezione rispecchia l'ipotesi che il monte Māšu sia la montagna dell'alba e che la rispettiva montagna del tramonto si trovi all'opposta estremità della terra
(George 2003). Il sole uscirebbe dunque al mattino dalla porta del massiccio orientale e, dopo aver attraversato il cielo, tramonterebbe attraverso un'analoga porta sul massiccio occidentale. Sembra una soluzione ragionevole. Però perdiamo l'analogia con il verso [IX: ] ed è permesso chiederci come possano gli aqrab-amēlû continuare stare a guardia del sole tanto nel suo sorgere e tanto nel suo tramontare. Sebbene lo šadû Māšu sia attestato solo nello Ša naqba īmuru, altre fonti ci riferiscono i possibili nomi delle montagne dell'alba e del tramonto. Un prezioso glossario accadico ci presenta una lista di oronimi tra i quali sembra di riconoscere diversi rilievi mitici o cosmologici. Il sumerogramma KUR, che introduce ogni termine, viene appunto letto in accadico šadû, «montagna»: |
Sumerogrammi | Lettura
fonetica | Significato |
Normalizzazione | KUR
[KUR s]a-a-bu
KUR ḪUR.SAG
KUR lil-mum
KUR bud-ug-ḫud-ug
KUR ḫa-ma-nu
KUR ḫa--bur
KUR ḫa--šur
KUR si-ra-ra
KUR la-ab-na-nu
KUR a-da-lú-ur | šá-du-ú
šá-ad en-líl
šu-bat be-let-DIIR(=ilī)
šá-ad IŠKUR(=adad)
né-reb UTU(=šamši) 〈ana〉 a-a
šá-ad e-re-ni
MIN MIN
MIN MIN
MIN MIN
MIN šur-i-ni
MIN MIN | montagna
montagna di Enlil
montagna di Bēlit-Ilī
montagna di Adad
ingresso di Šamaš ad Aya
montagna dei cedri
Idem idem
Idem idem [monte degli ḫašurru]
Idem idem
Idem [monte] dei cipressi
Idem idem | šadû
šad Enlil
šad Bēlit-Ilī
šad Adad
šadû Budugḫudug
šadû Erēn
šadû Habur
šadû Hašur
šadû Sirara
šadû Šurini
šadû Adalur | | SB [Hh XXII] |
Alla quinta riga troviamo citato un KUR bud-ug-ḫud-ug [šadû Budugḫudug], definito «l'ingresso di Šamaš ad Aya». Aya è il nome della sposa di Šamaš, tra le cui accoglienti braccia il dio-sole torna evidentemente a giacere ogni sera, una volta conclusa la lunga giornata di lavoro. All'ottava riga compare invece uno šadû Ḫašur, «il monte degli ḫašurrû» (una specie di cipresso o cedro), sul quale non vengono fornite ulteriori spiegazioni. Tuttavia, in un inno sumerico a Ninurta, il sole è detto sorgere appunto dallo šadû Ḫašur [utu ḫa.šu.úr.[t]a è.a] (TCL [XV: 7, ]), e in una preghiera bilingue a Šamaš si legge:
utu an.šá kú.ga.ta e.ti.a.zu.dè
kur ḫa.šur.ra.ta b[a]la.dè.zu.dè | O Šamaš, tu esci dalla pura sala del cielo
oltrepassando lo šadû Ḫašur... | UTU(=šamaš) ul-tu AN(=šamê) KÙ(=ellūti) ina a-ṣe-ka
šá-du-u ḫa-š[u]r ina na-bal-kut-ti-ka | O Šamaš, tu esci dai puri cieli
oltrepassando lo šadû Ḫašur... | BA X/1 [K 3052+5982: -] |
Non è dunque così azzardato avanzare l'ipotesi di due montagne, situate ai due opposti limiti della terra, il monte dell'alba e quello del tramonto, rispettivamente lo šadû Ḫašur a oriente e lo šadû Budugḫudug a occidente. In tal caso, šadû māšu, «monte gemello», potrebbe essere un epiteto attribuibile tanto all'uno quanto all'altro rilievo. Ciò non ci dice ancora, tuttavia, quale delle due montagne sia quella a cui giunge Gilgameš nel poema. Un secondo problema sorge allorché Gilgameš varca la «porta» [bābu] del Māšu e avanza nelle tenebre. Il testo definisce il percorso attraverso la montagna con il termine libbašū, «le sue viscere» [IX: ] (libbu può significare «cuore, ventre, viscere, animo, interno») e di solito lo si interpreta come un cunicolo, una caverna o una gola strettissima. Lo Ša naqba īmuru
chiama questo passaggio con la formula KASKAL UTU, in accadico ḫarran šamši, il «sentiero del sole» [IX: ]. Si tratta dunque della strada che il sole percorre prima di sorgere al mattino?  | | Utu/Šamaš (✍ 2300-2200 a.C.) | Impronta su argilla lasciata da sigillo cilindrico antico-babilonese.
British Museum [ME, 89110], Londra (Regno Unito). | | |
 | | Utu/Šamaš ed Enki/Ea (✍ 2300-2200 a.C.) | Impronta su argilla lasciata da sigillo cilindrico antico-babilonese.
British Museum [ME, 89115], Londra (Regno Unito). |
Questa interpretazione sembra avvalorata da alcuni sigilli cilindrici di età antico-babilonese, custoditi al British Museum [ME: 89110, 89531, 89548], dove il sorgere del sole è rappresentato dalla figura antropomorfa di Utu/Šamaš, ben riconoscibile dai raggi irradiati dai suoi omeri, che emerge maestosamente dalla concavità tra due monti, una gamba protesa come a scalare una delle cime. Queste rappresentano forse i picchi gemelli dello šadû Māšu
(qui raffigurati affiancati) e l'avvallamento la «porta» che si apre tra di essi. In uno di questi sigilli [ME: 89110], la «porta» è affiancata o rappresentata da due colonne, sulla cui cima stanno assisi due piccoli leoni, rivolti nella stessa direzione del dio-sole. In un altro sigillo [ME: 89115], è Enki/Ea, il dio della sapienza, signore dell'Apsū, riconoscibile dai flutti che sgorgano dalle sue spalle, che sembra scalare una delle due montagne. Qui Utu/Šamaš sta evidentemente tramontando: lo vediamo infatti scomparire nell'avvallamento tra le due cime, come se stesse accedendo a un passaggio ipoctonio. Inanna/Ištâr è la figura alata in piedi su una delle due vette, forse a rappresentare il pianeta Venere che
tramonta subito dopo il Sole. A sinistra, una figura maschile tiene un arco (il dio Nusku?); a destra Isimud/Usimu, il sukkal di Enki/Ea, è rappresentato con due volti. Nell'immagine compaiono anche diversi animali: un leone è dietro la figura armata d'arco, un maestoso uccello sta appollaiato sulla mano di Enki/Ea, e un piccolo toro è sotto i suoi piedi. L'iscrizione ci informa che che il sigillo venne fatto per un certo Adda.
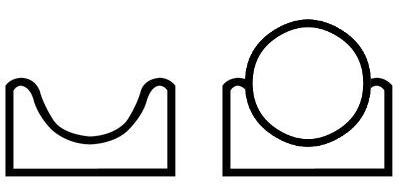 | | ḏew | | ẚḫet | | Rappresentazione dei geroglifici ḏw, «montagna», e зḫt, «orizzonte» |
Le immagini su questi sigilli potrebbero avvalorare
alcune delle diverse interpretazioni da noi avanzate. La «porta» da dove esce il sole all'alba (e/o da dove rientra al tramonto) sembra costituita da due monti «gemelli», oppure da un monte con due cime «gemelle». Ma più che un tema mitologico, la forma concava della montagna
sembra un motivo iconografico, legato all'idea della «porta» del sole. Un analogo motivo è attestato in questo senso anche in ambiti lontani dalla Mesopotamia. Nella scrittura geroglifica egizia la parola ḏew (ḏw), «monte», è rappresentato da un rilievo concavo, il quale rappresenta forse un wādī, con la possibile idea di un rivolo d'acqua dolce che ne scaturisce; invece la parola ẚḫet (ꜣḫt), «orizzonte», è rappresentata dal sole che cala nella concavità del monte (Betrò 1995). Ma parleremo più tardi del modello egizio e del misterioso dio ker
che presiede alle porte del sole. Possiamo chiederci: quale porta
ha attraversato Gilgameš? La porta del monte dell'alba, a oriente, o quella del monte del tramonto, a occidente? Nonostante i testi divulgativi sostengano di solito che lo šadû Māšu si trovi a est, la risposta non è affatto scontata. Alcuni studiosi hanno addirittura avanzato l'ipotesi che Gilgameš abbia varcato la porta del monte del tramonto, a occidente, e che quindi abbia percorso il cammino notturno e sotterraneo del sole, diretto a est. Il fatto che Gilgameš impieghi esattamente dodici bērû, cioè ventiquattro ore, a completare il suo tragitto lungo il ḫarran šamši, avvalora l'interpretazione di un viaggio «solare». Ma se egli percorre soltanto la metà notturna del corso giornaliero del sole, dovremmo aspettarci che il tragitto duri sei bērû, cioè dodici ore. Si può ribattere che Gilgameš non è Šamaš e che percorrere l'intero
diametro della terra in ventiquattro ore è, in ogni caso, un'impresa di tutto rispetto. Ma se il tragitto dura ventiquattro ore, perché Gilgameš non viene raggiunto dal sole che arriva alle sue spalle? Wayne Horowitz ha notato che nel testo ninivita viene ossessivamente ripetuto, allo scandire di ogni bēru, che a Gilgameš «non è concesso di vedere nulla dietro di sé» [ul i-nam-di-in-šú-ma a-na pa-la-sa EGIR(=arkat)-su] (Ša naqba īmuru [IX: , , , , , , , , ]), quasi tema che qualcosa o qualcuno possa coglierlo all'improvviso alle spalle, e si chiede se l'eroe non si aspetti di essere raggiunto da Šamaš (Horowitz 1998). Le lacunae e le difficoltà di interpretazione non permettono purtroppo di comprendere appieno il senso della vicenda. Più economico intendere questa natural burella percorsa da Gilgameš come un passaggio attraverso le viscere non di tutta la terra, ma del solo šadû Māšu. Ma rimane insoluto un problema: perché Gilgameš non incontra Šamaš, al suo sorgere, o al suo tramontare, mentre gli viene incontro attraverso la montagna? Forse i dodici bērû non vanno intesi come misura temporale (ventiquattro ore), ma spaziale (circa centotrenta chilometri). In tal caso, perdiamo una parte del sottotesto «solare» del percorso di Gilgameš, ma si spiega perché l'eroe non incontri il sole sul suo cammino. Egli precede l'ingresso del sole dall'uno o dall'altro lato della montagna ed è possibile che il suo dialogo con Šamaš, presente nella tavoletta di Berlino/Londra (AB [B/L: i, '-']), avvenga dopo che il sole è tramontato o prima che esso sorga. Se confrontata con la sequenza dello Ša naqba īmuru, questa breve scena sembra suggerire che il dialogo tra Gilgameš e Šamaš si svolga proprio all'uscita della montagna.
①▼
Inoltre, se lo šadû Māšu si trova a
est (o a ovest) perché, nel momento in cui Gilgameš
è al nono bēru del suo percorso lungo il ḫarran šamši,
sente soffiare sul viso il «vento del nord» (accadico iltānu, in
sumerogrammi SI.SÁ) [IX: ]?
Altro problema insoluto. Per ora non insistiamo oltre: queste note altro non
esprimono che la nostra ignoranza sullo šadû
Māšu in particolare e sulla cosmologia mesopotamica in generale.
In seguito proporremo una nostra soluzione.
Secondo mitotopo. Il Qišti Erēn
Anche il Qišti Erēn, la «foresta dei cedri», dove Gilgameš ed Enkidu si recano per procurarsi il legname, sembra essere un ulteriore esito del medesimo mitema
della montagna cosmica, un fossile proveniente da un passato ancora più antico. All'inizio della quarta tavola dell'epopea ninivita, nel loro viaggio verso il Qišti Erēn, Gilgameš ed Enkidu arrivano inizialmente in vista dello šadû Labnānu (mss. lab-na-nu o lib-na-nu) (Ša naqba īmuru [IV: ]). Questo oronimo è pure attestato nell'elenco delle montagne cosmologiche (SB [Hh XXII: ]) dov'è glossato come šadû Šurini, la «montagna dei cipressi». Che gli studiosi abbiano identificato šadû Labnānu
con l'attuale ǧabal Lubnān (il monte Libano) non deve però indurci a considerare chiusa la questione, e neppure dobbiamo prestare troppa attenzione a quanti hanno tentato di localizzare la foresta dei cedri sulle montagne dell'Elam. Certo, è probabile che in epoca babilonese il senso del mito originale fosse andato perduto e che il viaggio dei due eroi nel Qišti Erēn si fosse fuso con il racconto di qualche antica spedizione verso i contrafforti del Libano o del Tauro per procurarsi del prezioso legname. Ma i mitologi, torniamo testardi a ribadirlo, dovrebbero riuscire a liberarsi dell'abitudine di cercare sulla cartina dei luoghi che appartengono alla geografia mitica, o del malvezzo di considerare l'interpretazione del mito esaurita una volta localizzata una vicenda su una carta topografica e avanzata una rassicurante spiegazione naturalistica. Si rischia di ignorare dei segnali inquietanti
②▼ e
di non comprendere le chiavi di lettura più profonde.
Una volta entrati nella foresta, Gilgameš ed Enkidu ammirano, davanti a loro, un'imponente montagna ricoperta dai possenti cedri medio-orientali:
⌜e⌝-ma-ru KUR(=šadû) EREN(erēn)
mu-šab DIIR(ilī) pa-rak ir-ni-ni
[ina p]a-an KUR(=šadû)-im-ma
EREN(erēni) na-ši ḫi-ṣib-šú
[ṭ]a-a-bu ṣil-la-šú ma-li ri-šà-a-ti | Essi guardavano la montagna dei cedri [šadû Erēn],
dimora degli dèi, santuario delle dee;
sul volto della montagna
i cedri si levavano maestosi e lussureggianti
gradevole la loro ombra, deliziosa per chi entrava. | Ša naqba īmuru [V: -] |
Al lettore non sarà sfuggito che lo šadû Erēn, la «montagna dei cedri», è uno dei rilievi citati nell'elenco dei rilievi cosmologici (SB [Hh XXII, ]), dove glossa il KUR ḫa-ma-nu, di solito identificato dagli studiosi con il monte Amanós in Anatolia (od. Nur Dağları). Ma lo šadû Erēn ammirato da Gilgameš ed Enkidu è una montagna affatto diversa. Lo Ša naqba īmuru lo definisce «dimora degli dèi, santuario delle dee» [mušab ilī parak irnini] [V: ]
③▼. La formula è molto antica. Nella tavoletta di Baġdād, ad esempio, leggiamo che Gilgameš...
⌜di-× (×) × ir-ta⌝-ḫi-iṣ qi-iš-tam 〈ša〉⌜EREN(erēnim)⌝
mu-ša-bi-i-li e-nu-na-ki pu-zu-⌜ra⌝-mi-ip-te | ...avanzò pesantemente nel Qišti Erēn,
scoprì la dimora segreta degli
Anunnakī. | AB [Baġ: -] |
Che nei testi antico-babilonesi lo šadû Erēn sia definito mūšabī ilī Anunnakī (AB [Baġ: ]) o mūšab Anunnakī (AB [Ch: 38ʹ]), la «dimora segreta degli (dèi)
Anunnakī», è un altro prezioso ammonimento. A dispetto di tutti gli atlanti aperti dagli studiosi sulle loro ingombre scrivanie, non siamo ancora usciti di un passo dal contesto mitico. L'effettiva presenza di una montagna su una carta geografica non ne nega i simultanei significati mitologici, e i monti Ḥẹrmôn e Ólympos ce lo ricordano con molta chiarezza. Nelle due versioni sumeriche dell'episodio, l'En-e kur lu
tillaše e lo Ia lulu uluḫḫa sudsud, la destinazione di Bilgames ed Enkidu è definita semplicemente KUR, la «montagna», e si direbbe quasi sia la «montagna» per antonomasia. 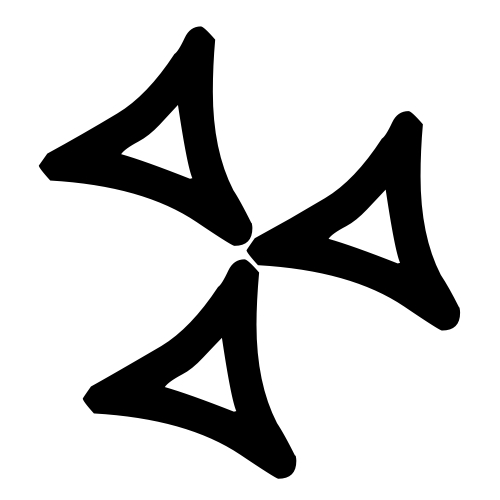 | | KUR | | Il sumerogramma per «montagna» |
Il significato del sumerogramma KUR – spiega Kramer – si è poi esteso a indicare una «landa straniera», ovvero le regioni montuose confinanti con la Mesopotamia, le cui popolazioni erano una costante minaccia per il popolo di Sumer. In seguito, kur ha finito per indicare «regione» in generale, tanto che la stessa Sumer era a volte definita kur-gal, la «grande
regione». Però kur rappresentava anche un sinonimo del sumerico ki-gal, la «grande terra», un termine per indicare l'Arali, l'oltretomba sumerico, e in questa accezione il termine compare tanto nell'Ud rea ud sura rea (il racconto sumerico che è argomento della tavola XII dello Ša naqba īmuru), tanto nell'An gal-ta ki gal-šè («Dal grande cielo alla grande terra», titolo informale La discesa di Inanna agli inferi). Avanzando lungo questa linea di interpretazione, Kramer definisce KUR un concetto cosmico: lo spazio tra la superficie della terra e le acque primordiali dell'AB.ZU (Kramer 1961). L'ipotesi di Kramer, per quanto sia oggi in parte ridimensionata, ci mette comunque sulla strada giusta: il KUR, la «montagna» raggiunta da Bilgames ed Enkidu nel poema sumerico, ha un valore soprattutto mitico, se non addirittura cosmologico. Nell'incipit di uno dei testi sumerici, il toponimo è ampliato dall'espressione
KUR LÚ TÌL.LA.ŠÈ (En-e kur lu
tillaše []), in genere tradotto come «montagna del vivente» oppure «montagna dove l'uomo vive» (Pettinato 1992). Ed ecco che si delinea ancora una volta il motivo del giardino dove sorge l'albero della vita. Samuel N. Kramer ha affermato che la «montagna dove l'uomo vive» sia tutt'uno con la terra di Dilmun.
en-e kur lú tìl-la-šè eštúg-ga-ni na-an-gub
en bilgames-e kur lú tìl-la-šè eštúg-ga-ni na-an-gub
arad-da-ni en-ki-du₁₀-ra gù mu-un-na-dé-e
en-ki-du₁₀ murgu uruš-e tìl-la
sa tìl-le-bi-šè la-ba-ra-an-è-a
kur-ra ga-an-kur₉ mu-u₁₀ ga-àm-ar
ki mu gub-bu-ba-àm mu-u₁₀ ga-bì-ib-gub
ki mu nu-gub-bu-ba-àm mu diir-re-e-ne ga-bì-ib-gub | Il signore rivolse la sua mente verso il kur dove l'uomo vive,
il signore Bilgames rivolse la mente verso il kur dove l'uomo vive.
Al suo servo Enkidu così parlò:
“O Enkidu, poiché nessun uomo finora l'ha avuta vinta
sull'eccelso mattone della vita
io voglio andare verso il kur, voglio porre colà il mio nome;
nel luogo dove ci sono già stele, voglio porre il mio nome;
nel luogo dove non ci sono stele, voglio porre il nome degli dèi.” | En-e kur lu
tillaše [-] |
Che cos'è il «mattone della vita» sul quale nessun uomo l'avrebbe mai avuta vinta? Un ragionamento che tenga conto dell'ideologia sottesa nelle versioni accadiche del ciclo di Gilgameš porta a considerare questa frase nel contesto dell'idea dell'inevitabilità della morte. Giovanni Pettinato suggerisce un'analogia con il concetto delle ṭupšīmāti, le «tavolette del destino», su cui la volontà degli dèi, una volta incisa, diviene legge cosmica, compresa la sorte di ogni uomo: quindi, di nuovo, l'idea dell'impossibilità di contrastare l'inappellabile sentenza di morte a cui gli dèi hanno condannato il genere umano (Pettinato 1992). In questi testi, Bilgames intende beffare la morte eternando il proprio nome. Non è tanto l'immortalità che sta cercando, quanto una fama immortale. Lo stesso motivo è presente anche nella versione ninivita, dove possiamo leggerlo come una prima fase della sua ansia di perennità: sarà solo dopo la morte di Enkidu che egli passerà dalla ricerca della fama eterna a quella della vita eterna.
Terzo mitotopo. Il Pû-nārāti
Sembra fuor di dubbio che il Pû-nārāti, dove gli dèi hanno traslato l'immortale Ūtanapištî, sia una versione posteriore dell'antico Dilmun, a sua volta residenza del noè sumerico
Ziudsura, di cui si narra un analogo destino di immortalità. Se gli studiosi tendono pacificamente a identificare Dilmun col Baḥrayn, ignorando gli inquietanti segnali dei poemi sumerici che insistono a porre questo paese là «dove sorge Utu»... con
il Pû-nārāti non c'è proprio nulla da fare: è un luogo che appare subito proiettato oltre i confini del mondo. Inutile dire che le attinenze tra il ciclo di Gilgameš e il mito biblico non sono passate inosservate. E non ci riferiamo all'ovvio mito del diluvio, che tanto aveva impressionato George Smith e i suoi contemporanei, ma anche e soprattutto alla relazione tra la pianta dell'immortalità e il serpente che priva l'uomo del dono della vita, legame che sussiste tanto nell'episodio del Bǝrēʾšîṯ quanto nel finale dello Ša naqba īmuru. Le analogie tra il mito ebraico e quello mesopotamico
sono molto forti e si può senz'altro parlare di motivi letterari comuni a entrambe le narrazioni, sebbene interpretate in senso affatto diverso. Gli apologeti, sempre preoccupati di ristabilire – naturalmente con argomentazioni «scientifiche» – il primato letterario e morale della Bibbia rispetto ai racconti mesopotamici, non hanno mai cessato di puntualizzare le ovvie differenze tra i due miti. Vero: nell'ermeneutica del Bǝrēʾšîṯ, Yǝhwāh aveva inizialmente destinato Āḏām e Ḥawwāh alla vita eterna, la caduta dell'uomo è il risultato della disobbedienza e del peccato, e il racconto della cacciata da ʿĒḏẹn spiega, teleologicamente,
la natura caduca e mortale dell'uomo. Nel mito mesopotamico, invece, l'inevitabilità della morte è dovuta all'arbitrio degli dèi, che hanno tenuto per loro la vita condannando l'umanità al declino e alla morte. In questo contesto, la «disobbedienza» di Gilgameš consiste nella sua ribellione a questo comune destino e al desiderio di ottenere per sé la vita eterna. Tale distinzione è importante dal punto di vista etico. I popoli della Mesopotamia avevano una visione piuttosto mesta e sconsolata del loro rapporto con gli dèi, diversamente dalla paternalistica teologia ebraica. Il Bǝrēʾšîṯ e lo Ša naqba īmuru si muovono in due contesti differenti. Il mito biblico è antropogonico: vuole dare una spiegazione eziologica dell'attuale condizione umana; il mito di Gilgameš è eroico: non è la storia di tutto il genere umano, ma la vicenda di un solo uomo che si ribella all'ingiusto decreto degli dèi.
Sebbene entrambi i racconti utilizzino una simbologia comune (la pianta, il serpente, l'immortalità...), i loro scopi e la loro ideologia sono profondamente diverse. Il sospetto è che lo Ša naqba īmuru implichi, quale necessaria premessa, proprio il Bǝrēʾšîṯ. La nostra può anche sembrare una provocazione, ma è nostro metodo cercare di illuminare i miti con il confronto tra le diverse tradizioni. Detto forse in maniera poco rigorosa ma indubbiamente efficace, Gilgameš sta tentando di ritornare nel giardino da cui Āḏām e Ḥawwāh erano stati cacciati.
Facciamo il punto Riassumendo, troviamo, incastonati nelle varie versioni del ciclo di Gilgameš, ben tre
mitotopi paralleli o, in un certo grado, sovrapponibili: - Il (la «montagna»), ovvero il .. (la «montagna dove l'uomo vive»), che nella semantica dei due poemi sumerici sembra indicare un monte, un paese straniero, un bosco di immortalità; nelle versioni accadiche questo luogo è chiamato Qišti Erēn, la «foresta dei cedri», e vi sorge lo šadû Erēn, la «montagna dei cedri», residenza e santuario degli dèi. È possibile che il KUR, in qualche fase anteriore del mito, si confondesse con quello che in seguito è divenuto lo šadû Māšu.
- Il frutteto degli «alberi degli dèi» [iṣû ilī], posto all'estremità del «sentiero del sole», appena oltre lo šadû Māšu; per quanto i testi non lo definiscano come un giardino d'immortalità, è il mitema esteriormente più simile al ʿĒḏẹn biblico.
- Il Pû-nārāti, la «confluenza dei fiumi», dove gli dèi hanno traslato Ūtanapištî affinché vi goda dell'immortalità, e dunque un luogo omologo al Dilmun sumerico. I testi non ne danno alcuna descrizione, né
mai lo rendono come un luogo paradisiaco (forse per interferenza con il precedente frutteto). È nei pressi del Pû-nārāti che Gilgameš si tuffa nel profondo dell'Apsū per cogliere la šammu nikitti, la «pianta dell'irrequietezza».
Ammettendo un certo grado di analogia tra questi mitotopi, possiamo chiederci: che rapporto hanno tra loro? in che modo si sono influenzati l'uno con l'altro nelle varie fasi di elaborazione dell'epopea unitaria? Queste domande sollevano interrogativi interessanti sulla coerenza dello Ša naqba īmuru. Con quale criterio furono collazionati i testi destinati a essere integrati nel poema neo-assiro? Quali libertà si presero Sîn-lēqi-unninni o i suoi antigrafi? Dobbiamo considerare significativo il fatto che i testi sumerici citino l'episodio della spedizione sulla «montagna dove l'uomo vive» ma non facciano alcun riferimento al viaggio di Bilgames/Gilgameš alla «confluenza dei fiumi»? Ma prima di cercare altre omologie significative e strutturanti, dobbiamo eliminare i molti echi i cui rimbombi rischiano di distrarci lungo il nostro cammino. Un dromedario ci condurrà a sud, distraendoci temporaneamente dai nostri rovelli, in un viaggio forse non utilissimo ma certamente necessario, nelle sabbie roventi del Rubʿ al-Ḫālī. |
②▲ Sarebbe interessante saperne di più su Ḫumbaba,
il guardiano che Enlil aveva posto
a sentinella del Qišti Erēn. Sappiamo che gli Ḫurriti conoscevano, accanto all'epopea di Gilgameš di presumibile provenienza mesopotamica, un'epopea incentrata su Ḫumbaba che costava di quattro o più tavole, segno che presso altri popoli il personaggio di Ḫumbaba era
qualcosa più di un mostro da abbattere o uccidere. Che nei poemi mesopotamici il nome di Ḫumbaba sia generalmente indicato col determinativo «» che segnala i nomi di divinità, è confermato dal fatto che il suo nome compare nella forma Ḫumban nelle liste divine degli Elamiti. In epoca sumerica, gli Elamiti erano stanziati
sulle montagne dell'Īrān, a oriente della Mesopotamia, e,
come ritengono molti linguisti, facevano parte di una fascia di popoli di lingua elamo-dravidica,
insieme con le popolazioni pre-vediche del Pakistān e dell'India,
tra cui probabilmente le civiltà di Mohenjodaṛo e Haṛappā. I discendenti di questo gruppo linguistico sono gli attuali popoli di lingua dravidica che vivono nel sud dell'India e nella parte nord-orientale dello Śrī Lāṃka, molti dei quali vantano civiltà e letterature di invidiabile antichità. Sono stati fatti tentativi di associare Ḫumbaba/Ḫumban a divinità indiane (ad esempio Hanumat, il dio-scimmia compagno di Rāma nel Rāmayāṇa), ma senza significativi risultati. |
| | |
①▲ Alcuni fantasiosi interpreti si sono proiettati un film dove il dio-sole, in quest'alba che precede l'alba, indugia a passeggiare nel suo bel frutteto, sembra, allo scopo di suggerire una correlazione con la scena biblica dove Āḏām e la donna odono la voce di «Yǝhwāh lōhîm che passeggiava nel giardino nella fresca brezza del mattino»
(Bǝrēʾšîṯ [3: ]).
Ma non vi è nulla, nella parte di testo antico-babilonese a
noi pervenuta, che possa giustificare l'associazione con il passo della Bǝrēʾšîṯ: nella tavoletta di Berlino/Londra, Gilgameš ode solo la voce di Šamaš e non vi è alcun riferimento agli iṣû ilī. |
| | | |
③▲ La maggior parte dei traduttori rende questo verso «la dimora degli dèi, il santuario di Irnina»,
quest'ultimo un epiteto di Ištâr. Accettiamo qui l'osservazione di Andrew R. George,
secondo il quale il termine irnini sia in realtà
usato per indicare in generale tutte le dee.
(George 2003) |
|
|
| DENTRO L'OCEANO DELLE STORIE: I VIAGGI DI BALŪQĪYA Con il crollo del mondo antico, la sapienza della Mesopotamia andò perduta. Le gloriose città che sorgevano sul Tigri e sull'Eufrate caddero in rovina. Le antiche lingue smisero di essere parlate, la scrittura cuneiforme venne dimenticata, le biblioteche sepolte dalla sabbia. Di una civiltà che per più di due millenni era stata faro di civiltà in tutto l'Oriente, non rimase che una vaga leggenda di vizio e corruzione. E di Gilgameš, il re che aveva visto le
profondità, fu perduto ogni ricordo. Tutto svanito.
 | | Šāhrazād narra le sue storie a Šāhriyār (✍ 1957) | | Gustav Tenggren, illustrazione (Soifer ~ Shapiro 1957) |
Per qualche ragione, però, il mito dell'antichissimo sovrano che aveva viaggiato ai confini del mondo alla ricerca della vita, mutò veste e apparenza, e sopravvisse. Per secoli, quando il nome di Gilgameš era ormai dimenticato, frammenti della sua leggenda si tramandavano nella memoria tenace dei popoli del deserto. Quando Richard Francis Burton
(1821-1890) intraprese la traduzione inglese delle Alf layla wa layla, le «Mille e una notte», non poteva sapere che una tra le tante fiabe che l'affascinante Šāhrazād incastonava notte dopo notte, barattandole con la sua stessa vita, risuonava un eco
della storia ormai dimenticata dell'antico lugal di Uruk.
La professoressa Stephanie Dalley ha ravvisato in questa fiaba di Bulūqiyā molti temi ed elementi derivati dall'antica epopea di Gilgameš (Dalley 1991). È una storia che conosciamo da tre fonti. Il Kitāb Bulūqiyā wa Ǧahān Šāh wa Ǧāmāsp wa-malikat al-ḥayyāt Yamlīḫā («Libro di Bulūqiyā, Ǧahān Šāh, Ǧāmāsp e di Yamlīḫā, la regina dei serpenti») è contenuto nel ms. Selden superius 55, custodito nella Bodleian Library a Oxford. Vi è poi la versione tramandata dalle Alf layla wa layla, dove le fiabe di Bulūqiyā e Ǧahān Šāh sono incastonate nel racconto Ḥāsib Karīm ad-Dīn wa-malikat al-ḥayyāt, «Ḥāsib Karīm ad-Dīn e la regina dei serpenti» (Burton 1885). C'è infine la
versione riportata nel ʿArāʾis al-maǧālis fī qiṣaṣ al-anbiyāʾ, «Le spose in assemblea: storie dei profeti» dell'esegeta Abū Isḥaq Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm aṯ-Ṯaʿlabī († 1035). Costui, che frequentava i circoli ṣūfī di Baġdād, cita come fonte del suo racconto Abū Bakr Muḥammad ibn ʿAbdallāh al-Ǧawzaqī († 988), un sapiente di Nīšāpūr, probabile indicazione che nel X secolo la fiaba di Bulūqiyā fosse ben nota nei circoli ascetici dell'Īrān nord-orientale. (Dalley 1994) La storia dei viaggi e delle avventure di Bulūqiyā, una fiaba incastonata in altre fiabe, more arabico, è narrata in prima persona da Yamlīḫā, la regina dei serpenti, ad Ḥāsib Karīm ad-Dīn...
La storia di Bulūqiyā Bulūqiyā è il figlio del re di una tribù israelita insediata ad al-Qāhira, in Egitto. Allorché succede al padre, rinviene un documento, custodito in uno scrigno di ferro, dove si predice il futuro avvento del rasūl Muḥammad
(pace e benedizioni su di lui). Ottenuto il permesso della madre di partire per la Siria al fine di scoprire altre notizie al riguardo, Bulūqiyā giunge in un luogo infestato da serpenti: la loro regina ha nome Yamlīḫā. I rettili sono concordi nel predire l'arrivo di Muḥammad e Yamlīḫā prega Bulūqiyā di salutare il Profeta per lei se mai fosse vissuto abbastanza per incontrarlo. Giunto a Ūršalīm (Gerusalemme), Bulūqiyā comincia a studiare le sacre scritture di ebrei e cristiani. Qui il sapiente ʿAffān, affascinato dal racconto dell'incontro di Bulūqiyā con Yamlīḫā,
gli propone di raggiungere l'isola dove è sepolto malik Sulaymān. Se riusciranno a impadronirsi del suo prodigioso anello, su cui è inciso il centesimo nome di Allāh, potranno attraversare il mare delle tenebre per andare a bere la māʾ al-ḥayāt, l'«acqua della vita». Allora potranno vivere abbastanza a lungo per assistere all'arrivo di Muḥammad. Per raggiungere l'isola è però necessario ungersi i piedi con il succo di una pianta speciale che li avrebbe resi in grado di camminare sulla superficie del mare. Ma per trovare la pianta bisogna prima catturare la malikat al-ḥayyāt, la «regina dei serpenti». Una volta giunti nel deserto, ʿAffān traccia allora un cerchio per terra e, dopo aver eseguito un certo rituale, i due penetrano nel regno sotterraneo di Yamlīḫā e qui prepararono una trappola con latte e vino drogati. Catturata la malikat al-ḥayyāt, la mettono in una gabbia e la trasportano verso una vicina montagna, sulle cui pendici,
in una sorta di meraviglioso verziere, crescono molte rarissime specie botaniche. Alla presenza di Yamlīḫā, ogni pianta comincia a parlare, svelando le proprie virtù. Trovata l'erba che stanno cercando, Bulūqiyā e ʿAffān ne spremono le foglie riempiendo una fiala con il suo succo. Poi riportano indietro Yamlīḫā, senza nasconderle le loro intenzioni. “Se una volta sulla montagna aveste colto direttamente l'erba della vita vi sareste evitati tutta questa fatica” obietta Yamlīḫā, una volta liberata. “Ma non raggiungerete mai il vostro scopo. Allāh ha decretato che a nessuno sarà permesso avere poteri maggiori di Sulaymān fino al giorno del giudizio.” E detto questo, la malikat al-ḥayyāt torna nel suo regno sotterraneo.  | | Yamlīhā, la regina dei serpenti (✍ 1957) | | Gustav Tenggren, illustrazione (Soifer ~ Shapiro 1957) |
Nonostante gli auspici sfavorevoli, Bulūqiyā e ʿAffān si ungono le piante dei piedi con il succo della magica erba e si mettono in cammino sulle onde. Attraversati sette mari, scorgono da lontano una montagna di smeraldo. Qui, in una caverna coperta da una cupola scintillante, trovano, assiso su un trono, il cadavere di un uomo, abbigliato con abiti regali. Sono le spoglie mortali di re Sulaymān, e al dito brilla ancora il suo portentoso anello. Bulūqiyā, ben ricordando l'avviso di Yamlīḫā, invita l'amico alla prudenza. ʿAffān respinge sprezzante
le sue obiezioni, ma quando si avvicina al corpo del malik per impadronirsi dell'anello, dalla terra scivola fuori un enorme serpente. Subito il rettile erutta una vampata di fuoco e lo incenerisce. Avvolto
anch'egli dalle fiamme, Bulūqiyā pronuncia il nome di Allāh:
subito compare il malʾak Ǧibrāʾīl e lo porta in salvo. Conosciute le intenzioni del giovane,
l'angelo deve deluderlo: “Va' per la tua strada, Bulūqiyā. Il tempo di Muḥammad non è ancora venuto. E tu non avrai mai l'anello di Sulaymān né mai attingerai alla sorgente dell'acqua della vita”. Rimasto ormai solo, Bulūqiyā si versa sui piedi altre gocce del magico succo e prosegue il suo cammino sulla superficie del mare, giungendo in luoghi lontanissimi dall'esperienza umana. Tocca isole paradisiache, gremite di animali parlanti, dove gli alberi ardono come fuoco, o sono carichi di frutti a forma di testa umana. Poi, per due mesi, Bulūqiyā avanza sulle onde del mare senza mai incontrare alcun lembo di terra; finché, affamato e stremato, avvista da lontano un'isola boscosa. Raggiuntala, il giovane si dirige verso un frutteto. Ma quando cerca di spiccare una mela da un albero, un gigante compare accanto a lui. “Questi frutti sono proibiti ai figli di Ādam. Lui ha tradito la fiducia di Allāh e ne ha mangiati.” Il gigante afferma di chiamarsi Šarahya e gli rivela di essere al servizio di Saḫr, re dei ǧinn. Offre qualcosa da mangiare a Bulūqiyā, ascolta la sua storia e poi lo invia dal proprio signore. Dopo dieci giorni di cammino per deserti e montagne, davanti al giovane
si profila lo spaventoso spettacolo di una battaglia tra due eserciti di ǧinn. Al suo arrivo, tuttavia, lo scontro si ferma: anche i ǧinn non hanno mai visto un essere umano. Bulūqiyā viene ben accolto da re Saḫr ed è stupito nell'apprendere che al signore dei ǧinn è ben noto il nome di Muḥammad. Egli è infatti un credente, devoto ad Allāh, e combatte i ǧinn infedeli. Il sovrano fornisce a Bulūqiyā molte informazioni sulla struttura dell'universo, sul monte al-Qāf e sul Baḥr al-muḥīṭ, l'oceano onniavvolgente. Gli narra come Allāh abbia creato il mondo e abbia preparato i sette
livelli del Ǧahannam per gli infedeli. In quanto a lui: non invecchierà e non morirà mai, in quanto ha bevuto la māʾ al-ḥayāt, l'«acqua della vita», la cui sorgente è custodita dal sapiente al-Ḫiḍr. Quando Saḫr ha terminato le sue spiegazioni, Bulūqiyā non ha nemmeno il tempo di fare qualche domanda. Un battito di ciglia e, come se nulla fosse accaduto, si ritrova magicamente nella sua casa, ad al-Qāhira. Questa
è la versione narrata da aṯ-Ṯaʿlabī nel ʿArāʾis al-maǧālis fī qiṣaṣ al-anbiyāʾ.
Invece, nella versione incastonata nelle Alf layla wa layla
tradotte da Richard Burton (The Book of the Thousand Nights and a Night [V: nights 487-499 e 531-533]), Bulūqiyā non torna subito in Egitto, ma, lasciato Saḫr, prosegue il viaggio a cavallo per terre deserte e disabitate, diretto ai confini del mondo. Un galoppo di settanta mesi viene compiuto in due giorni. Poi, sulla cima di un monte, Bulūqiyā
intravede la sagoma del malʾak Mīḫāʾīl, le cui ali coprono tutta la terra da oriente a occidente: egli ha il compito di alternare il giorno e la notte fino alla fine del mondo. Più tardi, ai piedi di un albero maestoso, Bulūqiyā vede inginocchiati quattro angeli: il primo ha forme umane, il secondo di leone, il terzo di uccello, il quarto di toro. Proseguendo il cammino, Bulūqiyā giunge infine in vista di una montagna gigantesca, sulla cui cima si trova un unico
malʾak, un angelo che muove le mani come tirando e allentando le redini di invisibili destrieri. Interrogato dal giovane, l'angelo risponde che il
monte su cui sta in piedi è il ǧabal
al-Qāf e che da quel luogo remoto tiene saldamente le redini di tutti i paesi della terra. Ogni volta che Allāh desidera causare un terremoto o una siccità, ordina all'angelo di attuare il suo comando ed egli ubbidisce tirando le sue redini invisibili.  | | La lettera qāf |
Nella cosmologia musulmana medievale, elaborata nei circoli teosofici arabo-persiani, al-Qāf è il nome
dell'immensa montagna che circonda e racchiude tutto il mondo,
sfiorando il cielo con la sua cima. Il suo nome si rifà alla lettera qāf
dell'alfabeto arabo, che viene tracciata con un guizzo
circolare. Sulla parete del ǧabal
al-Qāf, Bulūqiyā vede un'immensa porta guardata da due esseri giganteschi, l'uno simile a un leone, l'altro a un toro. Il giovane si presenta loro dicendo: “Sono un figlio di Ādam. Ho lasciato il mio paese e ho viaggiato in lungo e in largo per amore del rasūl Muḥammad, ma ho smarrito la strada. Di grazia, ditemi chi siete e che cosa c'è oltre questa porta”. Rispondono
i due malāʾika: “Questa è la porta della confluenza dei due mari, e noi ne siamo i guardiani. Ma cosa ci sia al di là di essa non sappiamo”. Dopo una lunga contrattazione, Bulūqiyā ottiene il permesso di passare e, varcando l'immensa soglia aperta sui fianchi della montagna di smeraldo, giunge sulle rive di un mare sconfinato. Bulūqiyā comprende di essere giunto al Baḥr al-muḥīṭ, l'oceano onniavvolgente che si trova sotto il trono di Allāh e alimenta tutte le acque del mondo. Alcuni
malāʾika ne dividono le acque e le mandano in ogni parte del mondo: quelle salate nei mari e quelle dolci nei laghi e nei fiumi. Dopo essersi unto un'ultima volta i piedi con il succo miracoloso, Bulūqiyā
si incammina sulle acque del Baḥr al-muḥīṭ. Giunge infine a un'isola paradisiaca, coperta da una ricca vegetazione, dove uccelli fatti di perle e smeraldi cantano le lodi di Allāh. Qui egli incontra al-Ḫiḍr, il guardiano della yanbūʿ al-ḥayāt,
la «sorgente della vita». Dopo avergli reso omaggio, gli narra le sue avventure ed espone la ragione per cui si è spinto così lontano dalla sua casa e dal suo paese. Al-Ḫiḍr prende atto della richiesta del giovane, ma non può accontentarlo. L'acqua della vita non è destinata a lui. Lo invita a tornare indietro e Bulūqiyā, affranto, gli chiede quanto tempo avrebbe richiesto il suo viaggio di ritorno in Egitto. “Novantacinque anni” è la risposta di al-Ḫiḍr. “Prega Allāh, tuttavia, affinché mi permetta di riportarti a casa.” Bulūqiyā implora Allāh di esaudire il suo desiderio. Dopo un po' al-Ḫiḍr gli dice di chiudere gli occhi e di prenderlo per mano. E quando Bulūqiyā riapre gli occhi, si ritrova con sgomento e sorpresa proprio davanti alla sua casa, in Egitto. Si gira per ringraziare al-Ḫiḍr, ma il sapiente immortale è scomparso. (Burton 1885) Così Bulūqiyā non ottenne l'immortalità, ma ebbe la pace dell'animo. | IN ARABIA: AL-ḪIḌR, LA GUIDA DEI PROFETI  | | Al-Ḫiḍr
(✍
xviii sec.?) | | Miniatura indiana d'epoca muġal | | Il curioso mezzo di trasporto ittico di al-Ḫiḍr richiama la mitologia indiana, dove ogni divinità dispone di un particolare animale come vāhana («veicolo»).
Il pesce di al-Ḫiḍr è
stato messo in correlazione con il Makara – sorta di bizzarro mostro marino, ibrido tra un pesce e un elefante, a volte simile a un coccodrillo – che è il tradizionale vāhana di Varuṇa. La corrispondenza del Makara con il segno del Capricorno permette agevolmente di ricondurlo al Suḫurmaššu, il capro-pesce che, nella mitologia mesopotamica, era il «veicolo» di Enki/Ea. |
Come le Alf layla wa layla sono storie che s'intrecciano le une
alle altre, così dovremmo fare noi seguendo il filo che ci viene pórto dal giovane e audace Bulūqiyā e che, dal misterioso al-Ḫiḍr, ci conduce dentro l'oceano delle
leggende. A dispetto dell'esiguità della tradizione canonica, l'enigmatica figura di al-Ḫiḍr è molto popolare in tutto il mondo
islāmico e pare che ancora oggi i mistici abbiano con lui un rapporto
assai speciale. Immortale, si diceva che al-Ḫiḍr vivesse in un'isola lontana nel mare (aṭ-Ṭabarī: Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk [1: 442]) o sopra un tappeto verde nella terra marina (al-Buḫārī: Tafsīr [XVIII: 3]). Pare avesse il potere di rendersi invisibile. Secondo gli ḥadīṯ, fu visto al funerale di Muḥammad, dove fece le condoglianze agli affranti compagni del rasūl. Pare che alcune sette minori della Šīʿah duodecimana identifichino in al-Ḫiḍr l'imām occulto (Corbin 1979). Personaggio affascinante come pochi altri, al-Ḫiḍr, il «verde», ha ispirato nel corso dei secoli una letteratura vastissima, che spesso attinge alle sottigliezze del misticismo
islāmico, alle sue derive teosofiche ed esoteriche. Seguire i mille rivoli di questa tradizione è compito superiore alle nostre forze. Ci limiteremo a ripetere qui i fatti elementari, quelli utili al nostro scopo di mitografi. Il mito di al-Ḫiḍr ha il suo baricentro in una storia allegorica del Qur˒ān che tratta della ricerca della verità da parte del rasūl Mūsá [il biblico Mōšẹh] e del suo incontro con un personaggio dalla soprannaturale veggenza, che il testo non chiama per nome. Allāh, la cui voce rimbomba in tutte le pagine del libro sacro dell'Islām, lo definisce semplicemente «uno dei nostri servi» [ʿabdā min ʿibādinā]. I commentatori ritengono tuttavia, in parte sulla base della tradizione degli ḥadīṯ, che il misterioso personaggio col quale Mūsá s'incontri non sia altri che l'eterno al-Ḫiḍr. In questo brano, che la Sūra al-kahf (la «sūra della caverna») introduce quasi ex abrupto, Mūsá sembra ben deciso a raggiungere un luogo a lui remoto, ma ben noto al lettore dell'epopea di Gilgameš...
| Wa iḏ qāla Mūsá lifatāhu lā abraḥu ḥattá abluġa maǧmaʿa al-baḥrayni aw amḍiya ḥuqubā. | E quando Mūsá disse al suo garzone: “Non avrò pace finché non avrò raggiunto la confluenza dei due mari, dovessi anche camminare per anni!”. | | Falammā balaġā maǧmaʿa baynihimā nasiyā ḥūtahumā fa āttaḫaḏa sabīlahu fī al-baḥri sarabā. | Quando poi giunsero alla confluenza dimenticarono il pesce che avevano portato con sé, e questo prese la sua via, libero, nel mare. | | Falammā ǧāwazā qāla lifatāhu ātinā ġadāʾanā laqad laqīnā min safarinā hāḏā naṣabā. | Quando poi furono andati oltre, [Mūsá] disse al suo garzone: “Tira fuori il nostro cibo mattutino, ché ci siamo affaticati in questo nostro viaggio”. | | Qāla araʾayta iḏ awaynā ilá aṣ-ṣaḫrati faʾinnī nasītu al-ḥūta wa mā ansānīhu illā aš-šayṭānu an aḏkurahu wa āttaḫaḏa sabīlahu fī al-baḥri ʿaǧabā. | Rispose [il garzone]: “Vedi un po'! Quando ci siamo rifugiati vicino alla roccia, ho dimenticato il pesce (solo Šayṭān mi ha fatto scordare di dirtelo) e meravigliosamente il pesce ha ripreso la via del mare”. | | Qāla ḏālika mā kunnā nabġi fārtaddā ʿalá āṯārihimā qaṣaṣā. | Disse [Mūsá]: “Questo è quello che cercavamo”. Poi entrambi ritornarono sui loro passi. | | Fawaǧadā ʿabdā min ʿibādinā ātaynāhu raḥmatan min ʿindinā wa ʿallamnāhu min ladunnā ʿilmā. | Incontrarono uno dei nostri servi, al quale avevamo concesso misericordia da parte nostra e al quale avevamo insegnato la nostra segreta sapienza... | | Al-Qur˒ān [XVIII: -] |
Più che raccontare, al-Qur˒ān si limita a evocare una vicenda che doveva essere ben conosciuta ai suoi ascoltatori. Nella sua potenza e bellezza,
il libro sacro dell'Islām accenna a un'infinità di antiche storie,
ma senza entrare nei particolari. Al-Qur˒ān
non ha intenti divulgativi: fa esempi morali. È un testo di allusioni lampeggianti, che se da un lato aumentano la suggestione, dall'altro annientano la chiarezza. Il testo qur˒ānico risulta frustrante per gli amanti del mito, i quali devono andare a cercare i dettagli delle vicende abbozzate nei testi degli esegeti e commentatori posteriori. Il brano che abbiamo appena citato risulterebbe del tutto incomprensibile se non conoscessimo l'intera tradizione, riportata
in questo caso nella compilazione degli ḥadīṯ di Abū ʿAbdallāh Muḥammad al-Buḫārī (810-870), il quale ci illustra i retroscena della vicenda:
| | Mūsá stava tenendo un sermone alla sua gente quando uno degli astanti gli chiese chi fosse l'uomo più sapiente. Mūsá rispose che era lui. Allāh (gloria a lui l'altissimo) lo rimproverò per la sua presunzione e per non essersi ricordato che tutta la sapienza appartiene solo a lui, e gli disse: “Invero alla confluenza dei due mari c'è uno dei miei servi che è più sapiente di te”.
“Signore”, esclamò Mūsá, “come potrò incontrarlo?”
“Prendi un pesce e mettilo in un cesto” rispose Allāh. “Nel luogo in cui perderai il pesce troverai quell'uomo”.
Mūsá prese un pesce, lo mise in un cesto e partì con il suo giovane servo... | | Abū ʿAbdallāh Muḥammad al-Buḫārī: Ṣaḥīḥ al-Buḫārī |
Questa misteriosa maǧmaʿa al-baḥrayni, «confluenza dei due mari», che il rasūl Mūsá decide di raggiungere, insieme al suo garzone Yušāʾ
①▼, ha dato seri grattacapi agli esegeti qur˒ānici, i quali nel corso dei secoli hanno avanzato molte diverse interpretazioni, senza mai arrivare a un consenso sulla locazione della vicenda. In arabo, baḥr è una parola ambigua: significa sì, «mare», ma anche «fiume» (è il nome arabo del Nilo). Allegoricamente, si è voluta intendere l'espressione come l'incontro dei due «mari di saggezza», Mūsá e al-Ḫiḍr, o come il confronto tra la conoscenza relativa dell'uomo e quella assoluta che
appartiene ad Allāh. Ma dando al testo una lettura prettamente geografica, tanto Abdallāh ibn ʿUmār al-Bayḍawī († 1286) che Abū Ǧaʿfar Muḥammad ibn Ǧarīr
aṭ-Ṭabarī (838-923) hanno interpretato la «confluenza dei due mari» come il luogo in cui l'Oceano Persiano si unisce al Mar Romano, cioè l'istmo di as-Suways. Altri, inclusi Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ʿUmār az-Zamaḫšarī (1074/1075-1143/1144) e, con suggerimento alternativo, sempre aṭ-Ṭabarī,
hanno indicato invece Ǧabal Ṭāriq, lo stretto di Gibilterra, luogo dove si incontrano il mar Mediterraneo e l'Atlantico. In quanto alla ṣaḫara Mūsá, «la roccia di Musá» presso la quale il rasūl e Yušāʾ sostano per desinare, viene da collocato dai geografi musulmani tra il Mediterraneo e il Caspio. La topografia che gli esegeti
islāmici stanno cercando di localizzare sulle mappe del mondo conosciuto non attiene alla geografia, ma al mito. Sebbene al-Qur˒ān non lo chiarisca e, anzi, accresca l'ambiguità, il maǧmaʿa al-baḥrayni è ancora una volta il Baḥr al-muḥīṭ, l'oceano onniavvolgente della cosmologia araba. Non rifiutiamo l'allegoria, perché la natura dei simboli è quella di suggerire infiniti significati, ma avendo seguito il viaggio di Gilgameš alla ricerca della vita, sappiamo benissimo che la «confluenza dei fiumi» (Pû-nārāti) era il luogo remoto dove risiedeva Ūtnapištî, unico mortale che avesse conquistato l'immortalità. Di al-Ḫiḍr si diceva che avesse bevuto la māʾ al-ḥayāt, l'«acqua della vita». Era appunto alla medesima sorgente
a cui intendeva attingere il giovane Bulūqiyā,
dopo aver varcato terre e mari remotissimi. I simboli, che
s'intrecciano e si confondono, continuano a condurci verso l'esterno. La maǧmaʿa al-baḥrayni,
«confluenza dei due mari», oltre la quale Bulūqiyā incontra al-Ḫiḍr, si trovava al di fuori del cingulus mundi rappresentato dal ǧabal
al-Qāf. Un analogo viaggio avevano evidentemente intrapreso Mūsá e Yušāʾ, i quali arrivano al maǧmaʿa al-baḥrayni per poi andare «oltre», come leggiamo in al-Qur˒ān [XVIII: ]. Ma «oltre» dove? Il pesce che fugge dal paniere è un simbolo ben noto nella tradizione levantina,
ma anche classica. “Quando ci siamo rifugiati vicino alla roccia, ho dimenticato il pesce” spiega Yušāʾ. La roccia è la roccia donde sgorga l'acqua della vita. Immerso in quel liquido vivificante, il pesce resuscita e è torna a tuffarsi nel mare. Ma avevamo appunto lasciato Mūsá e Yušāʾ senza pranzo sulla riva dell'oceano onniavvolgente. È qui che, come Allāh aveva loro annunciato, incontrano il nostro strano personaggio circonfuso della sapienza divina:
| Fawaǧadā ʿabdā min ʿibādinā ātaynāhu raḥmatan min ʿindinā wa ʿallamnāhu min ladunnā ʿilmā. | [Mūsá e Yušāʾ] incontrarono uno dei nostri servi, al quale avevamo concesso misericordia da parte nostra e al quale avevamo insegnato la nostra segreta sapienza... | | Al-Qur˒ān [XVIII: ] |
La sapienza di questo ʿabd («servo») di Allāh, di cui al-Qur˒ān non fa il nome, viene esplicitato dal seguito della
vicenda, in cui egli chiede a Mūsá di portare pazienza qualunque cosa gli veda fare. E la pazienza di Mūsá è certamente messa a dura prova, ché la sua guida si comporta in maniera
irrazionale, apparentemente folle. Dapprima fora la chiglia di una nave che aveva dato loro un passaggio; dopo ammazza un ragazzo senza motivo apparente; infine, giunti in una città i cui abitanti negano loro la più elementare ospitalità, raddrizza un muro che stava per crollare, senza domandare alcuna ricompensa. A questo punto Mūsá, disperato, chiede alla sua guida le ragioni di azioni tanto insensate. Il ʿabd Allāh, rimproverando Mūsá per la sua mancanza di fiducia, gli spiega che ha affondato la nave perché non se ne impadronisse un malvagio re corsaro, che ha ucciso il giovane perché non conducesse i suoi genitori sulla strada della miscredenza e dell'iniquità, e che ha riparato il muro affinché gli sgarbati abitanti della città non trovassero il tesoro che vi era sepolto sotto.
②▼ Era evidente che in tutte le sue azioni, apparentemente incomprensibili, la misteriosa guida aveva agito in base a una conoscenza superiore. Questa strana guida del rasūl Mūsá, di solito identificata con al-Ḫiḍr, ha messo in difficoltà gli esegeti qur˒ānici, i quali si sono più volte domandati come vada interpretata la sua figura. Più che di un nabī («profeta») o rasūl («inviato»), sembra trattarsi di un semplice wali, di un «amico» di Allāh. Ma se al-Ḫiḍr non ha un ruolo profetico, c'è qualcosa che lo pone in una dimensione superiore: è infatti un iniziatore, una guida dei profeti. In tal senso non è distante dal biblico Malkîṣẹḏẹq, l'enigmatico «iniziatore» di Aḇrāhām in Bǝrēʾšîṯ [14]. Al-Ḫiḍr simboleggia una conoscenza inaccessibile agli uomini: la storia del suo incontro con Mūsá traccia il profilo di un personaggio dotato di una visione soprannaturale, ispirata evidentemente da Allāh, delle cose future e segrete. Tale vicenda ha un suo parallelo in una leggenda ebraica, riportata da Nîssîm bẹn Yaʿaqoḇ (990-1062) nel suo commentario talmûḏico, dove rabbî Yĕhôšuʿ bẹn Lēwî (III sec.) compie un viaggio analogo in compagnia del naḇîʾ liyyāhû, altro personaggio in fama di immortalità. Anche qui, le azioni apparentemente insensate compiute da liyyāhû sono dettate da ragioni segrete che sfuggono alla comprensione di rabbî Yĕhôšuʿ (Bêṯ ha-Midrāš [V: 133-135]). Questa, l'immagine qur˒ānica di al-Ḫiḍr. Ma rimane ancora da indagare la parte della sua leggenda che ci porta diritti all'argomento del nostro lavoro: la ricerca della vita. Aṭ-Ṭabarī, nel suo Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk («Storia degli
inviati e dei re»), ci rivela un altro addentellato di questa tradizione. Scopriamo così alla base della favola di Bulūqiyā, alla base della storia di Mūsá e di al-Ḫiḍr, un'ulteriore leggenda.
| | Narrano che al-Ḫiḍr abbia partecipato alla spedizione del «bicorne», quando fece il giro della terra per restare vivo fino al giorno della resurrezione. Al-Ḫiḍr trovò l'acqua della vita, ma il «bicorne» non la trovò e morì. | |
Abū Ǧaʿfar Muḥammad
aṭ-Ṭabarī : Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk |
Non è certo un caso se, nel tessere i mille fili delle nostre storie, l'immortale al-Ḫiḍr ci abbia condotto, tutt'a un tratto, al cospetto di uno dei più suggestivi personaggi della tradizione
islāmica, Ḏū ʾl-Qarnayn, il «bicorne». E sarà ora necessario fare un lungo respiro, prima di tuffarci in questa nuova corrente, e capire come l'epopea di Gilgameš si sia fusa con le leggende alessandrine per produrre uno dei più vasti, ricchi e universali cicli epici della tarda antichità e del Medioevo. |
①▲ Il «garzone» di Mūsá è Yušāʾ ibn Nūn, cioè il biblico Yĕhôšuʿ bẹn Nûn, successore di Mōšẹh e conquistatore della Palestina.
Il nome del padre di questo personaggio, ebraico Nûn,
arabo Nūn, vuol dire «pesce» nelle lingue semitiche. Questo nome, nella cosmologia araba, è anche quello della balena che nuota nell'oceano cosmico e che sorregge la terra sul suo dorso; al riguardo si è parlato di una paraetimologia con il Nûn egizio, l'oceano increato che circonda l'universo. |
| | |
②▲
Per qualche ragione, i geografi musulmani concordano nel collocare questi avvenimenti sul mar Caspio. Scrive il gerosolimitano Šams ad-Dīn Abū ʿAbdallāh Muḥammad al-Muqaddasī (945-?), «la gente dice che la ṣaḫara Mūsá [la roccia di Musá] sia in Širwān, che il mare sia il Caspio, il villaggio sia Baǧarwān e l'uccisione del giovane sia avvenuta presso il villaggio di Ḫazarān» (Aḥsan al-taqāsīm fī maʿrifat al-aqālīm [46]). Sia Abū al-Qāsim ʿUbaydallāh ibn Ḫurdāḏbih (820-912) che Ibn al-Faqīh al-Hamaḏānī (❀ X sec.) asseriscono che «la ṣaḫara è la roccia di Širwān, il mare è il mare di Ǧīlān, la città è Baġrawān» (Kitāb al Masālik w’al Mamālik [123] | Muḫtaṣar Kitāb al-Buldān [287]); l'enciclopedico Yāqūt ibn ʿAbdullah ar-Rūmī al-Hamawī (1179-1229) descrive Širwān come il luogo «in cui si trova la ṣaḫara Mūsá,
che la pace sia su di lui, che è vicino alla yanbūʿ al-ḥayāt,
la «sorgente della vita» (Kitāb muʿǧam al-buldān [I: 160]). |
|
| DA ORIENTE A OCCIDENTE: I VIAGGI DEL BICORNE | | Sulaymān e Bilqīs, regina di Sabāʾ (✍ I-III sec.) | | Miniatura persiana |
Al-ǧāhiliyya, «la sregolatezza», è il termine con cui gli Arabi definiscono l'epoca che precedette l'avvento di Muḥammad e l'irresistibile ascesa dell'Islām. Posta tra l'impero bizantino e quello sāsānide, e difesa dai suoi sconfinati deserti, la penisola araba era stata, per secoli, luogo di transizione delle linee carovaniere.
Molto tempo dopo la caduta di Tilmun/Dilmun, una nuova stagione di commerci aveva reso particolarmente fiorenti
i regni collocati nell'odierno Yaman – Ḥaḍramawt, Sabāʾ, Qataban, Maʿīn, Awsān –, i cui corruschi splendori avevano creato il mito dell'Arabia felix. Ottimi navigatori, conoscitori dei cicli monsonici, i popoli sudarabici importavano dall'India legno di sandalo, ebano, spezie, seta, pietre semipreziose; dall'Africa avorio, schiavi, cinnamomo, essenze profumate; dal Vicino Oriente stoffe, armi, vino e frumento. Ma era la coltivazione dell'incenso, di cui mantenevano un geloso segreto, a costituire il fiore all'occhiello della loro economia. Grandi architetti, i Sabei innalzarono templi, palazzi a più piani e un complesso sistema di dighe. Quella di Maʾrib, costruita intorno all'875 a.C., e destinata a irrigare i campi e i giardini della capitale, fu amorevolmente mantenuta in efficienza da tutti i mukarrib che si succedettero sul trono di Sabāʾ per quasi quindici secoli. Il suo crollo, nel 575 d.C., segnò la fine dell'Arabia felix. Se gli Arabi meridionali avevano potuto costruire fiorenti regni e città, gli Arabi del nord, eternamente alla ricerca di acqua e di pascoli, conducevano un'esistenza troppo stentata perché avessero potuto darsi degli ordinamenti sociali tanto sofisticati. Divisi in qabāʾil, in tribù in continua faida le une con le altre, non disdegnavano, a volte di assaltare le carovane dei mercanti. Alcune qabāʾil si erano stabilite nelle città carovaniere e nelle oasi, controllando i traffici che dai porti del Mar Rosso o del
golfo Persico conducevano le merci in Siria o in Armenia. Tutti gli altri, gli orgogliosi nomadi del deserto, i beduini, continuavano a condurre la vita errabonda dei pastori. I loro riti e culti non erano molto diversi da quelli degli antichi regni vicini, quelli dei Moabiti, degli Edomiti, dei Nabatei. Nel gran numero di divinità, soprattutto astrali e femminili, gli studiosi scorgono similarità con gli dèi della Mesopotamia o di Kǝnaʿan. Difficile pensare che mitemi risalenti all'epoca Babilonesi e degli Assiri non continuassero ad aleggiare in ʿIrāq e in Siria, come pietre preziose in attesa di trovare nuovi castoni. Hubal era il dio tribale della qabīla dei banū Qurayš, adorato nel santuario della Kaʿba, alla Makka, il quale ospitava trecentosessanta idoli di divinità tribali ed era, già nella ǧāhiliyya, meta di pellegrinaggi. Nel Ḥiǧāz erano popolari tre divinità femminili, al-Lāt, al-ʿUzzá e Manāt, ricordate in Qur˒ān [LIII: -], il cui culto era associato a quello di un dio privo di santuario e, forse, senza una rappresentazione visibile: Allāh. Così mentre la storia ci sospinge verso il
VII secolo, sembrano prevalere forme di enoteismo: ogni singola qabīla aveva una sua divinità tribale, pur non negando l'esistenza di tutti gli altri dèi. Ma la tradizione parla anche degli ḥunafāʾ, coloro che, pur nella ǧāhiliyya, si mantenevano fedeli alla ḥanīfiyya: il culto
dell'unico dio secondo la dottrina del comune progenitore Ibrāhīm. In questa situazione, il monoteismo era una brace che covava sotto la cenere, pronta a divenire fuoco e a tramutarsi in incendio, pure rinfocolata dalle grandi religioni ufficiali degli imperi circostanti. Dall'Īrān filtravano lo zoroastrismo e il cristianesimo nestoriano, dall'Etiopia la dottrina monofisita, mentre nel nord Arabia e in Siria era diffuso il cristianesimo ebionita. Comunità ebraiche, sia ortodosse che eretiche, erano stanziate tanto alla Makka
tanto alla Madīna. Sospeso in questa confluenza di spazio e tempo, il popolo arabo avevano funto per secoli da collettore di un'infinità di tradizioni, finché, con l'avvento del Profeta e la turbinosa spinta verso un monoteismo assoluto e definitivo, molti di questi miti erano divenuti, d'un tratto, storia sacra. Nel suo stile rapido e frastornante, al-Qur˒ān accenna a tradizioni ereditate dai popoli medio-orientali e sudarabici, come il ciclo di Bilqīs, regina di Sabāʾ, o la leggenda
della tribù perduta degli ʿĀd, del
loro orgoglioso malik Šaddād e della sua città-giardino, Iram ḏāt al-ʿimād, su cui ritorneremo tra poco. Vi compare una gran quantità di tradizioni parallele a quelle bibliche, in varianti stranamente deformate, spesso tratte dalle tradizioni apocrife, lontane dalle versioni «canoniche» note a ebrei e cristiani. Anche alcuni tratti del folklore beduino – come la credenza nei ǧinn, negli ʿafārīt e negli spiriti del deserto –, troppo radicati per poter essere eliminati, finirono per diventare parte integrante del credo
islāmico. Al-Qur˒ān è uno specchio fin troppo fedele della cultura eclettica, aperta, altamente suggestionabile, di un mercante qurayš del VII secolo. La fierezza e il rigore del popolo arabo, che alla fine ne accolse il messaggio, avrebbe trasformato questo coacervo di tradizioni eterogenee, intricate, spesso poco critiche, in un monumento teologico destinato ad avere un impatto decisivo sulla storia umana. Queste note possono dare il barlume di un'idea di quali e quante tradizioni si siano inestricabilmente intrecciate tra i fasti di Bisanzio, la Siria, i contrafforti dell'Armenia e i roventi deserti dell'Arabia per portare alla formazione del ciclo del misterioso e affascinante
«bicorne». Non stupisce sottolineare che il cuore della vicenda di
Ḏū ʾl-Qarnayn sia ancora una volta un passo suggestivo quanto
oscuro del Qur˒ān. La sua vicenda, sospinta anch'essa dagli āyāt della Sūra al-kahf, inizia proprio dove si era conclusa la storia di Mūsá e al-Ḫiḍr. È una leggenda importante e vale la pena riportarla per intero:
| Innā makkannā lahu fī al-arḍi wa ātaynāhu min kulli šayʾin sababā. | In verità demmo [a Ḏū ʾl-Qarnayn] ampi mezzi sulla terra e modo di riuscire in ogni impresa. | | Faʾatbaʿa sababā. Ḥattá iḏā balaġa maġriba aš-šamsi waǧadahā taġrubu fī ʿaynin ḥamiʾatin wa waǧada ʿindahā qawmā qulnā yā Ḏā al-Qarnayni immā an tuʿaḏiba wa immā an tattaḫiḏa fīhim ḥusnā. | Seguì una via. E quando giunse all'[estremo] occidente, vide il sole che tramontava in una sorgente ribollente, e nei pressi c'era un popolo. Dicemmo: “O Ḏū ʾl-Qarnayn, puoi punirli oppure esercitare benevolenza nei loro confronti”. | | Qāla ammā man ẓalama fasawfa nuʿaḏibuhu ṯumma yuraddu ilá rabbihi fayuʿaḏibuhu ʿaḏābā nukrā. | Disse: “Puniremo chi avrà agito ingiustamente e poi sarà ricondotto al suo Signore che gli infliggerà un terribile castigo. | | Wa ammā man āmana wa ʿamila ṣāliḥā falahu ǧazāʾan al-ḥusná wa sanaqūlu lahu min amrinā yusrā. | “E chi crede e compie il bene avrà la migliore delle ricompense e gli daremo ordini facili”. | | Ṯumma atbaʿa sababā. Ḥattá iḏā balaġa maṭliʿa aš-šamsi waǧadahā taṭluʿu ʿalá qawmin lam naǧʿal lahum min dūnihā sitrā. | Seguì poi una via. E quando giunse dove sorge il sole, trovò che sorgeva su di un popolo cui non avevamo fornito alcunché per ripararsene. | | Kaḏālika wa qad aḥaṭnā bimā ladayhi ḫubrā. | Così avvenne e Noi conoscevamo tutto quello che era presso di lui. | | Ṯumma atbaʿa sababā. Ḥattá iḏā balaġa bayna as-saddayni waǧada min dūnihimā qawmā lā yakādūna yafqahūna qawlā. | Seguì poi una via. E quando giunse alle due barriere, trovò tra di loro un popolo che quasi non comprendeva alcun linguaggio. | | Qālū yā Ḏā al-Qarnayni inna Yaʾǧūǧa wa Maʾǧūǧa mufsidūna fī al-arḍi fahal naǧʿalu laka ḫarǧā ʿalá an taǧʿala baynanā wa baynahum saddā | Dissero: “O Ḏū ʾl-Qarnayn, invero Yaʾǧūǧ e Maʾǧūǧ portano grande disordine sulla terra! Ti pagheremo un tributo se erigerai una barriera tra noi e loro!” | | Qāla mā makkananī fīhi rabbī ḫayrun faʾaʿīnūnī biqūwatin aǧʿal baynakum wa baynahum radmā. | Disse: “Ciò che il mio signore mi ha concesso è assai migliore. Voi aiutatemi con energia e porrò una diga tra voi e loro. | | Ātūnī zubara al-ḥadīdi ḥattá iḏā sāwá bayna aṣ-ṣadafayni qāla anfuḫū ḥattá iḏā ǧaʿalahu nārā qāla ātūnī ufriġ ʿalayhi qiṭrā. | “Portatemi masse di ferro”. Quando poi ne ebbe colmato il valico disse: “Soffiate!” Quando fu incandescente disse: “Portatemi rame, affinché io lo versi sopra”. | | Famā asṭāʿū an yaẓharūhu wa mā astaṭāʿū lahu naqbā. | Così [Yaʾǧūǧ e Maʾǧūǧ] non poterono scalarlo e neppure aprirvi un varco. | | Al-Qur˒ān [XVIII: -] |
Annunciatore del monoteismo ibrāhīmico, Ḏū ʾl-Qarnayn viene presentato come uno dei tanti nabiyyūn, o «profeti» inviati da Allāh ai popoli del mondo. Ḏū ʾl-Qarnayn, in particolare, è presentato come un ammonitore che annuncia lo yawm ad-dīn, il «giorno della
fede», cioè il giorno del giudizio. La sua missione ai confini della terra implica che nessun popolo – neppure prima di Muḥammad – era stato lasciato da Allāh privo di un messaggio di salvezza. I popoli di Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ sono considerati, nei tafāsīr
(commentari qur˒ānici), un segno della fine dei tempi, allorché «sarà aperta via libera a Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ ed essi si precipiteranno giù da ogni altura» (al-Qur˒ān [XXI: ]). Chi sono costoro? La Bibbia cita Māô nella «tavola delle nazioni»: è un nipote di Yāẹṯ (Bǝrēʾšîṯ [10: ]), antenato di una
stirpe che la tarda antichità identificherà appunto con i popoli delle steppe (Sciti, Sarmati e Alani), come attesta già Isidorus Hispaliensis (Etymologiae [IX: ii, 26-31]). Sempre nella Bibbia, però, un passo escatologico accenna a un certo Gô, sovrano di una indeterminata terra settentrionale di Māô, di cui si profetizza il suo attacco contro Israele, alla fine dei tempi (Yǝḥẹzqêl [38-39]). A questa profezia corrisponde, nel Nuovo Testamento, il passo giovanneo dov'è
lo stesso Śāṭān che, sciolto dai ceppi, uscirà per sedurre le nazioni e adunare a battaglia Gô e Māô: allora un fuoco scenderà dal cielo e li divorerà tutti (Apokálypsis [20: -]). Nel suo affannoso tumulto di temi e vicende, il nostro passo qur˒ānico [XVIII: -] mostra due motivi apparentemente separati, a cui ne aggiungiamo un terzo: - Ḏū ʾl-Qarnayn viaggia ai confini
della terra, dal «corno» occidentale a quello orientale. Ammira il sole sprofondare nelle acque ribollenti dell'oceano o levarsi talmente caldo da bruciare i popoli sottostanti.
- Ḏū ʾl-Qarnayn costruisce una «barriera» [sadd] nel varco tra due montagne, di cui al-Qur˒ān non fornisce una localizzazione precisa, per tenere lontani Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ.
- Ḏū ʾl-Qarnayn
compie i suoi viaggi per ottenere l'immortalità. Tuttavia
non è lui, ma al-Ḫiḍr, a trovare la māʾ al-ḥayāt, l'«acqua della vita». Questo lo apprendiamo, tra gli altri, da aṭ-Ṭabarī:
| Narrano che al-Ḫiḍr abbia partecipato alla spedizione del «bicorne», quando fece il giro della terra per restare vivo fino al giorno della resurrezione. Al-Ḫiḍr trovò l'acqua della vita, ma il «bicorne» non la trovò e morì. | | Abū Ǧaʿfar aṭ-Ṭabarī: Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk |
 | | Ḏū
ʾl-Qarnayn innalza la barriera (✍ XVI sec.) | Miniatura su pergamena.
Chester Beatty Library, Dublin (Irlanda) | | I
ǧinn costruiscono la barriera di ferro contro Ya’ǧūǧ
wa Ma’ǧūǧ, in questa pregevole miniatura proveniente da un manoscritto persiano del XVI sec. |
Riconosciamo d'istinto alcuni elementi del mito di Gilgameš, sebbene ricomposti in maniera slegata. Al-Qur˒ān non collega esplicitamente il mito della spedizione di Ḏū ʾl-Qarnayn ai confini del mondo al tema della ricerca della vita, sebbene lo schema riposi su una vasta letteratura. Come la spedizione di Gilgameš, anche quella di Ḏū ʾl-Qarnayn non avrà successo, in quanto non sarà il «bicorne» a bere l'acqua della vita, ma al-Ḫiḍr. Anche il tema della barriera elevata contro Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ trova un'eco nell'epopea di Gilgameš, sebbene rielaborato in modo irriconoscibile: è il motivo della porta dello šadû Māšu, a cui stanno a guardia gli aqrab-amēlu. Questo tema, nel racconto di Ḏū ʾl-Qarnayn, è interpretato
in maniera quasi opposta. L'eroe non deve più contrattare il
passaggio attraverso la porta con i guardiani della montagna. Al contrario: l'eroe
islāmico ha il compito di chiudere il passaggio tra i monti per impedire alla minaccia escatologica di irrompere sulla terra. Cercare l'origine di questo inestricabile groviglio di leggende può essere un'avventura vertiginosa. Chi era Ḏū ʾl-Qarnayn? Un ḥanīf, un monoteista preislāmico, conferma lo storiografo e agiografo Muḥammad ibn Isḥāq ibn Yasār ibn Ḫiyār († 761/767), nella sua raccolta di sīrat («viaggi» o «vite» dei messaggeri e profeti). E riporta alcuni versi che lui stesso attribuisce a uno dei re di Ḥimyar, l'ultimo regno sudarabico: tubbaʿ Abū Kariba Asʿad (♔ 390-420), solitamente citato per essere stato il primo di una serie di re sudarabici convertiti al giudaismo. In questa lirica si afferma, tra l'altro, che Ḏū ʾl-Qarnayn sia stato istruito da un «saggio erudito», nel quale si può probabilmente intravedere lo stesso al-Ḫiḍr (Guillaume 1955):
| | Che sia d'esempio a questi uomini affinché comprendano.
Ḏū ʾl-Qarnayn prima di me fu un muslim:
i re vassalli affollavano la sua corte,
governava l'oriente e l'occidente, eppure cercò
la vera conoscenza da un saggio erudito.
Vide dove il sole affonda sotto gli occhi
in una pozza di fango e di fetida melma.
Prima di lui li governava Bilqīs, sorella di mio padre,
fino al giorno in cui l'upupa arrivò a lei. | Abū Karib Asʿad apud Muḥammad ibn Isḥāq: Sīrat rasūl Allāh |
Ma ecco che l'affascinante Bilqīs, regina di Sabāʾ, rischia di distrarci dal nostro proposito. Tratteniamo l'immaginazione, pur rimanendo con i piedi ben calcati nelle sabbie roventi dello Yaman. Troviamo infatti Ḏū ʾl-Qarnayn citato in una composizione del poeta Hassān ibn Ṯābit († 674), che fu amico dello stesso Muḥammad; ma ancor prima, è attestato da Maymūn ibn Qays al-Aʿšá (570-625), una delle principali voci poetiche della ǧāhiliyya.
Ḏū ʾl-Qarnayn sembra infatti trarre le sue origini da un ciclo regale sudarabico, conosciuto in Arabia soprattutto grazie agli scritti un antiquario yamanita, Wahb ibn Munabbih († 728-729 o 732-733). Sebbene l'opera di quest'ultimo sia andata perduta, viene spesso citato dagli autori successivi. Ci sono particolarmente utili, in questo caso, due testi arabi: il Kitāb at-tīǧān li-maʿrifa mulūk az-zamān fī aḫbār Qaḥṭān (il «Libro delle corone per la conoscenza dei re al tempo delle cronache sul Qaḥṭān»)
di Abū Muḥammad ʿAbd al Mālik ibn Hišām († 828 o 833),
celebre biografo del Profeta, e lo Aḫbār al-Yaman wa-ašʿāruhā wa ansābuhā («Notizie dello Yaman,
della sua poesia e delle sue genealogie») attribuito a un non meglio
noto antiquario ʿAbīd ibn Šariya al-Ǧurhūmī (VII-VIII sec.). In questi testi si fa riferimento a un
antico re di Ḥimyar, chiamato tubbaʿ al-Aqran
①▼, ma soprannominato Ḏū ʾl-Qarnayn, del quale si ricordano le imprese guerresche, i viaggi ai confini del mondo, la ricerca della māʾ al-ḥayāt, l'«acqua della vita», la costruzione del
sadd contro Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ, e la
sua morte
a centocinquantatré anni, dopo un tempestoso regno di viaggi e di conquiste (Di
Branco 2011 | Bohas ~ Saguer ~ Sinno 2012).
Storia di tubbaʿ Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid Il racconto di Wahb ibn Munabbih e Mālik ibn Hišām viene ripreso e ampliato in un testo posteriore, anonimo, tradito da un codice conservato nella British Library di Londra (ms. ) e conosciuto con il titolo informale di Aṣ-Ṣaʿb Ḏu ʾl-Qarnayn.
Ed eccone il riassunto. Tubbaʿ Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid al Ḥimyarī, contemporaneo del nabī Ibrāhīm, è un tirannico oppressore dello Yaman atterrito da una serie di sogni inquietanti. In uno primo sogno, si trova sulla cima di un monte, dove vede i re della terra umiliarsi di fronte ad Allāh, mentre
gli arroganti vengono scagliati nel fuoco del ǧahannam; in un secondo sogno, vola in cielo e conficca la spada nella costellazione delle Pleiadi, poi agguanta il sole con la mano destra e la luna con la sinistra, e scende di nuovo sulla terra trascinandosi dietro l'intero firmamento; in un terzo sogno, affamato, divora una dopo l'altra tutte le regioni e le montagne della terra, quindi prosciuga il mare a sorsi; in un quarto sogno, tutti gli uomini si uniscono ai ǧinn, agli animali e ai venti per soggiogarlo. Poiché nessuno dei suoi sapienti è in grado di spiegare tali visioni, tubbaʿ Ṣaʿb si reca ad al-Quds (Gerusalemme) per interrogare
«Mūsá al-Ḫiḍr» (si noti la fusione dei due nomi). Costui lo chiama per la prima volta Ḏū ʾl-Qarnayn e gli rivela la sua missione profetica: dovrà soggiogare la terra e portare la parola di Allāh fino ai popoli più lontani. Secondo Ibn Hišām, tutta la terra può essere percorsa in cinquecento anni: trecento sono necessari per attraversare i mari, cento per varcare i deserti, e cento per percorrere il mondo
abitato. Di quest'ultimo quinto, l'ottanta per cento appartiene a Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ, il diciannove per cento
ai negri del Sūdān e solo l'un per cento agli uomini civili. La missione profetica di aṣ-Ṣaʿb/Ḏū ʾl-Qarnayn inizia
appunto con la conquista del Sūdān. Il re yamanita non va per il sottile: preferisce sterminare i non credenti piuttosto che soggiogarli e riscuotere il ḏimmī. La sua trionfale marcia di conquista gronda di sangue. E le nazioni che crollano dinanzi alla sua avanzata, una dopo l'altra, sono elencate secondo il loro posto nella discendenza di Ḥām, Šām e Yāfiṯ, figli di Nūḥ. È in pratica l'intera umanità a venire soggiogata da Ḏū ʾl-Qarnayn. A ovest, egli sottomette la terra di Mārīʿ ibn Kanʿān ibn Ḥām ibn Nūḥ, poi al-Andalus, popolata dalle genti di Yāfiṯ ibn Nūḥ; cadono sotto il suo dominio le nazioni di al-Baskunis, al-Qurt, al-Afranǧ, al-Ǧalāliq, al-Barbar, al-Zaǧd (una lista inarrestabile, in cui si riconoscono baschi, franchi, galiziani, berberi, etc.). La sua spedizione lo conduce in al-Armaniya, dove respinge le genti di ʿAlǧān ibn Yāfiṯ ibn Nūḥ. Dopo aver conquistato la Siria e gli altopiani di al-Hāmada, arriva in India, dove incontra il popolo dei Turǧamanīn, anch'essi discendenti di ʿAlǧān ibn Yāfiṯ ibn Nūḥ. Giunto a Samarqand, affronta al-Kurd (i curdi) e li massacra, lasciando in vita i pochi che si convertono al monoteismo. Arriva infine presso il popolo di aṣ-Ṣīn (i cinesi), detti discendenti della tribù di Ḥām ibn Nūḥ, e anche qui stermina tutti i miscredenti. In questo fragoroso, cruento percorso, non manca il gusto dell'esplorazione, l'orgoglio di testare i limiti dello spazio, il confronto con il meraviglioso e il soprannaturale. Tubbaʿ aṣ-Ṣaʿb si spinge ai confini occidentali del mondo, oltre una regione di oscurità impenetrabile, detta semplicemente
aẓ-Ẓulumat, le «tenebre», dove, su una montagna così bianca che solo a fissarla si rimane accecati, sta appollaiata un'aquila misteriosa e solitaria; non lontano il sole tramonta in un gorgo di fango. Ma si reca anche ai confini orientali della terra, i cui abitanti, con occhi stretti e facce scimmiesche, lasciano le loro caverne soltanto la notte
e vi rientrano prima dell'alba per sfuggire all'ardore del sole. Sul ǧabal aṣ-Ṣaḫra, aṣ-Ṣaʿb giunge in un palazzo innalzato da ʿĀbar ibn Šālaǧ ibn Arfḥašid ibn Šām ibn Nūḥ al tempo della torre di Bābil e della confusione delle lingue:
questo ʿĀbar aveva copiato il manoscritto di Nūḥ contenente l'alfabeto arabo e, di conseguenza, era stato il primo uomo a parlare in arabo; quale unico interlocutore, suo figlio, il nabī Hūd. Poi aṣ-Ṣaʿb salpa sull'oceano meridionale e, dopo aver attraversato di nuovo
aẓ-Ẓulumat, giunge a una terra coperta da un deserto di ghiaccio, il cui riverbero ha un'intensità sconosciuta al genere umano. Aṣ-Ṣaʿb si lascia indietro le truppe e cammina fino a quando non arriva a un palazzo candido, con due
malāʾika sulla porta. Uno di loro tiene un corno in mano e guarda verso il cielo, come aspettando il momento di soffiarlo: ma lo suonerà solo nello yawm ad-dīn, il giorno del giudizio.
Il
malāk rimprovera aṣ-Ṣaʿb per la sua ambizione e lo invita a tornare indietro. Più tardi, guidato da al-Ḫiḍr, aṣ-Ṣaʿb nuovamente attraversa le tenebre fino a una roccia dalla quale sgorga la māʾ al-ḥayāt,
l'«acqua della vita». A Ṣaʿb verrà proibito di bere:
e inoltre una voce misteriosa gli predice la prossima morte in un luogo chiamato Ḥinū Qarāqar. Dopo aver costruito la barriera contro Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ, tubbaʿ aṣ-Ṣaʿb intraprende la via del ritorno. Giunto in ʿIrāq, scopre che il luogo in cui si è accampato si chiama
proprio Ḥinū Qarāqar. Comprende che la sua ora è arrivata e anche
al-Ḫiḍr ne è consapevole: “Ḏū ʾl-Qarnayn, la tua speranza per il futuro si è ormai esaurita: il tempo della morte è ormai giunto. Ora non rimane che quello che hai già fatto”. Riferisce ibn Hišām, sull'autorità di Wahb, che aṣ-Ṣaʿb si ammalò in Ḥinū Qarāqar e dopo otto giorni morì. Dopo la sua morte, al-Ḫiḍr – che aveva bevuto la māʾ al-ḥayāt – scomparve e nessuno lo vide più, tranne, come sappiamo, molti secoli dopo, Mūsá ibn ʿAmrān. (Saccone 1997 | Zuwiyya 2012). Questa stranissima leggenda diventerà l'argomento dei prossimi capitoli. I suoi sviluppi nella letteratura
islāmica sono altrettanto affascinanti, e li esploreremo con
attenzione, anche perché ci riveleranno dei frammenti e degli
sprazzi di una cosmologia antichissima. Tuttavia, prima di marciare
nel mondo arabo e, soprattutto, persiano, dovremo immergerci in una
nuova corrente dell'oceano delle leggende, le cui acque arrivano da
molto lontano...
|
①▲ Tubbaʿ è un titolo usato dagli autori arabi (comparabile con il
Caesar per gli imperatori romani, il prʿꜣ dei
faraoni egizi e il Kisrā dei sovrani sāsānidi) con
cui designare i re della dinastia ḥimyari, che fra il
II
sec. a.C. e il VI sec. d.C. giunse a controllare tutta
l'area sud-occidentale della penisola araba. |
|
| ALÉXANDROS, MITO UNIVERSALE
 | | Mégas Aléxandros (✍ 100 a.C.) | Mosaico romano (particolare), dalla Casa dei Fauni a Pompei.
Dimensioni originali: 272 cm × 513 cm.
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Italia). | | Immagine [Mosaico completo] |
Per quanto vi siano dei dissensi, buona parte dell'esegesi qur˒ānica
identifica il misterioso Ḏū ʾl-Qarnayn con Mégas Aléxandros
(356-323 a.C.),
il conquistatore dell'Asia, innalzandolo alla statura di un profeta
dell'unico dio. Il sogno del condottiero macedone di fare del mondo un
unico impero, in cui l'ellenismo fungesse da traît-d'union tra la sapienza occidentale e quella orientale, viene a identificarsi con il
tema utopico, caro al mondo musulmano, del dār al-Islām,
di una terra unita nella fede in Allāh. Non è
facile seguire tutti i rivoli delle leggende su Aléxandros, da cui il mondo arabo-persiano trasse la figura di questo «bicorne»
islāmico, che viaggiò ai confini del mondo alla ricerca della sapienza e dell'immortalità. La figura di Mégas Aléxandros ha, di per sé, un enorme fascino mitopoietico. Le
vicende delle sue spedizioni e delle sue vittorie, della fondazione
delle sue città e della sua prematura morte, anche senza abbellimenti fantastici, sembrano appartenere più alla leggenda che alla storia. Sorta di naturale attrattore di miti, il
grande macedone ha raccolto su di sé, nel corso del tempo, una quantità di mitemi che da secoli andavano alla deriva nell'oceano delle storie. Tanto in Occidente
quanto in Oriente, dalla tarda antichità alla fine del Medioevo, si aveva una concezione di Aléxandros che poco doveva alla realtà storiografica: il condottiero macedone veniva classificato nello stesso spazio epico di Héktōr, Arthur e Carolus Magnus, o nello stesso ciclo della rivelazione profetica di Ibrāhīm, Mūsá e Muḥammad.
La tradizione greca e occidentale
Alla base della leggenda alessandrina vi è il romanzo greco Bíos Alexándrou toû Makedónos dello pseudo Kallisthénēs, la cui recensio α fu redatta probabilmente ad Alexándreia alla fine del III secolo. Qui, Alexánder è figlio del faraone Nektanebṓ (Neḫetnebef II, ♔ 360-342 a.C.) e di Olympiás, moglie di Phílippos
di Macedonia. Il faraone, presentandosi alla regina in aspetto di un
profeta, le annuncia le sue nozze sacre con Ámmōn,
il dio dalle corna d'ariete, il quale si sarebbe unito a lei anche sotto gli aspetti di Hērakls e Diónysos (le
due divinità che preludono e incarnano la tensione alessandrina di
arrivare ai confini del mondo). Ma naturalmente è Nektanebṓ, dopo aver fatto bere un filtro a Olympiás, a infilarsi nel letto della regina e a metterla incinta. (Bíos Alexándrou toû Makedónos α, β, γ [I: 1-8]) Il Bíos Alexándrou fu costantemente riscritto e ampliato, man mano che nuove tradizioni vi venivano incorporate, ed ebbe grande fortuna in epoca bizantina, allorché venne adattato in greco medievale e
nel primo greco moderno, e messo sia in prosa che in versi (Stoneman 2007). Se nella recensio α l'episodio dell'acqua della vita non compare affatto, lo troviamo nelle recensiones più tarde, in forme via via più elaborate. Nella recensio β (IV-V sec.), Aléxandros vuole
giungere dove la terra finisce: dopo una marcia attraverso la
caligine giunge sulla riva del mare. Salpa allora al comando di una
piccola flotta e arriva in isole sconosciute. Aléxandros ode delle voci chiamare in lingua greca, ma non vede nessuno.
Fa scendere dei marinai, i quali vengono divorati da crostacei giganti. Rimessosi in mare, giunge
a una «terra dei beati» [makáron khṓra]. Il luogo è avvolto dalle tenebre, ed Aléxandros vi si inoltra insieme ai suoi uomini... (Bíos Alexándrou toû Makedónos β [II: 38-39]). E qui segue, in forma breve,
l'episodio che prelude al famoso racconto qur˒ānico di Mūsá e al-Ḫiḍr: | | E così percorremmo per quindici
skhoînoi una via buia e vedemmo un luogo in cui c'era una sorgente limpidissima: in essa l'acqua brillava come il lampo. Mi venne fame e desiderai farmi dare del cibo: e, chiamato il cuoco, gli dissi: “Preparaci da mangiare”. Quello, preso del pesce sotto sale, andò all'acqua limpida della fonte per lavare la vivanda. Appena immersa nell'acqua, questa si animò e sfuggì dalle mani del cuoco. Tutti quei luoghi erano ricchi di acqua. Il cuoco non riferì a nessuno l'accaduto. | Pseudo Kallisthénēs: Bíos Alexándrou toû Makedónos β [II: 39, -] |
Nelle recensiones γ e λ dello pseudo Kallisthénēs (non precedenti al VI secolo), la vicenda si amplifica. Il pesce sfugge ancora una volta dalla mano del cuoco, qui chiamato Andréas, il quale non riferisce nulla ad Aléxandros, «ma prese un po' di quell'acqua e la conservò in un vaso d'argento» (γ [II: 39, ]). Poi Aléxandros riprende il cammino e, come era accaduto nella recensio β,
giunge in un luogo dove il cielo è privo di sole, luna e stelle; due uccelli dagli occhi umani si avvicinano al macedone e gli dicono, in greco: “Perché, Alessandro, calpesti una terra che è solo della divinità? Torna indietro, misero: non
puoi calpestare le isole dei beati [makáron nḗsoi].
Torna indietro, uomo, calca la terra che a te è concessa, e non ti procurare pene” (β-γ [II: 40, ]). Aléxandros obbedisce e, quando lui e i suoi uomini tornano alla luce del sole, si accorgono che le pietre raccolte nella terra dell'oscurità sono in realtà pezzi d'oro e gemme. A questo punto Andréas
riferisce ad Aléxandros la
faccenda del pesce, tacendo però di aver bevuto egli stesso alla sorgente:
il macedone comprende che, a causa del silenzio del cuoco, ha perduto la possibilità di divenire immortale e, infuriato, lo fa frustare. Qui si innesta il tema del racconto aṭ-ṭabariano su Ḏū ʾl-Qarnayn, ma lo fa in maniera ancora più romanzesca: | | Quel cuoco malvagio, accostatosi alla figlia che Aléxandros aveva avuto dalla concubina Oúnēs, e che si chiamava Kal, la sedusse promettendo di darle da bere l'acqua della fonte dell'immortalità: cosa che fece. Aléxandros, quando lo seppe, invidiò la loro immortalità, e, chiamata la figlia, le disse: “Prendi le tue vesti ed esci di qui: ricevuta l'immortalità, sei diventata un demone. Sarai chiamata Neraḯs, poiché dall'acqua hai avuto l'eternità, e abiterai qui”. Ella, piangendo e lamentandosi, si allontanò da lui e se ne andò in luoghi deserti con i demoni. Per ordine di Aléxandros, il cuoco fu gettato in mare con una pietra legata al collo. Dopo che vi fu gettato, divenne un demone e abitò lì, quel tratto di mare, che da lui fu detto Andreatikós. Questa è la storia del cuoco e della figlia di Aléxandros. | Pseudo Kallisthénēs: Bíos Alexándrou toû Makedónos γ [II: 41, -] |
Riconosciamo in questa versione della vicenda un'interferenza con
il mito classico del dio marino Glaûkos.
Un giorno, dopo aver trascinato le sue reti su una spiaggia, il
pescatore Glaûkos si accinge a contare
i pesci che ha catturato e li dispone in fila su un prato poco
lontano. Ma quelli d'un tratto riprendono vita e, avanzando sulla
terra come fossero in acqua, tornano in mare l'uno dopo l'altro.
Glaûkos si rende conto che causa di
quel fenomeno è stata l'erba sulla quale ha posato i pesci. Ne
mangia un ciuffo e, d'un tratto, avverte in petto una passione
impetuosa per il mare: si tuffa in acqua e diviene un dio marino. (Ovidius: Metamorphoseon
[XIII: -]). I motivi, però, si intrecciano e si
combinano in maniera molto complessa: il destino di Andréas
è certamente parallelo a quello di Glaûkos,
ma spiega anche, alla lontana, alcuni dettagli dell'iconografia di
al-Ḫiḍr, che attraversa il mare sul dorso di un pesce. Se il
tema dei pesci che pigliano vita e ritornano in mare presentano un
immediato confronto con il racconto del Bíos Alexándrou
e del Qurʾān, è curioso notare
che nel racconto di Ovidius il medium dell'immortalità non è
l'acqua di una sorgente soprannaturale, ma un'erba dalle particolari
proprietà, così come nel racconto di Gilgameš.
(Szalc 2012)
Dalla recensio α deriva la Res gestae Alexandri Macedoni, traduzione latina di Iulius Valerius Alexander Polemius (IV sec.), che fu di capitale importanza per la diffusione della leggenda alessandrina in Europa. Da essa deriva anche la traduzione armena, la Patmowt‘iwn Ałek‘sandri Makedonac‘woy, eseguita forse nel V secolo e da alcuni attribuita
a Movsēs Korenac‘i (Stoneman 2007
| Vacca 2013). In Europa, a partire dal XII secolo, Aléxandros è il protagonista di un vero proprio ciclo di gesta. È forse da una perduta recensio *δ, alcuni frammenti della quale sono conservati in un codice vaticano, che deriva una nuova riduzione latina, la Nativitas et victoria Alexandri Magni (o Historia de preliis Alexandri Magni), effettuata questa volta da un certo Leo, archipresbyter di Napoli, negli anni tra il 951 e il 969. È soprattutto a partire da questa versione, che avrà straordinaria diffusione, che fioriscono adattamenti, poemi e romanzi in tutte le principali lingue europee: in italiano, antico francese, medio inglese, scoto, medio
alto tedesco, slavo, ungherese, irlandese e norreno (Stoneman 2007). È una letteratura vasta e complessa quanto la matière de bretagne ed è impresa superiore alle nostre forze –
e ai nostri scopi – seguirne i rivoli. Analogamente a quanto era accaduto in Oriente, anche l'Europa vede in Aléxandros uno strumento divino, un
re dotato di insaziabile curiositas, un perfetto e cortese cavaliere, ora esaltato per la sua magnanimità, ora condannato per la sua hýbris. Tra le opere più ampie del ciclo, il Roman d'Alexandre in medio francese (✍ 1180-1190) di Alexandre de Bernay (o de Paris), riporta i principali episodi legati ai viaggi oltremondani del
macedone, tra cui appunto quello alla sorgente della vita. Ma il racconto è ormai solo un superficiale divertissment: tutti i vecchi al seguito
di Alexandre si bagnano per tornare giovani e cominciano subito ad amoreggiare con bellissime fanciulle. Più che la sapienza mitica prevale il senso del meraviglioso. Di grande interesse, ai nostri fini, è però il vasto sviluppo che il mito alessandrino ebbe nella letteratura orientale, tanto in arabo quanto in persiano. Sebbene gli elementi presenti nelle versioni orientali mostrino chiare affinità con alcune delle versioni più tarde dello pseudo Kallisthénēs, il passaggio del mito alessandrino nella letteratura araba non sarebbe avvenuto direttamente attraverso il greco ma rivela un complesso dialogo con le comunità sudarabiche, ebree e cristiane del Medio Oriente, in particolare con i gruppi aramaico-siriaci.
La tradizione siriaca
La Tašʿitā d-ʾAleksandrōs bar Fīlīpōs malḵā d-māqdūniyē, «Storia di Aleksandrōs figlio di Fīlīpōs, re di Macedonia», è una traduzione siriaca dello pseudo Kallisthénēs, tradita in cinque tardi manoscritti, tutti in grafia nestoriana (il più antico, conservato al British Museum, è stato ricopiato solo nel 1708-1709). Essa concorda in modo significativo con la recensio α, sebbene in alcuni punti segua piuttosto la versione latina di Iulius Valerius. Il Tašʿitā d-ʾAleksandrōs non è però una pura e semplice traduzione di α, sia per il diverso ordine in cui sono trattati certi argomenti, sia soprattutto per la presenza di alcuni episodi che non sono testimoniati da nessuna delle versioni greche a noi note. L'insieme di tali discordanze rispetto allo pseudo Kallisthénēs ha fatto supporre al primo editore del Tašʿitā d-ʾAleksandrōs, l'inglese Sir Ernest Alfred Wallis Budge (1857-1934), che il testo siriaco fosse la traduzione, effettuata da un cristiano nestoriano tra il VII e il IX secolo, di una versione araba dell'originale greco (Budge 1889).
Un anno dopo l'edizione di Budge, l'orientalista tedesco Theodor Nöldeke
(1836-1930), analizzando le trascrizioni di nomi e termini del Tašʿitā d-ʾAleksandrōs, non solo dimostrò l'infondatezza della teoria di Budge, ma avanzò l'ipotesi di un intermediario
medio-persiano di epoca tardo-sāsānide (VII-VIII sec.), viste le
numerose ambiguità fono-ortografiche presenti nel sistema grafico del
pehlevico. Secondo Nöldeke, inoltre, la traduzione medio-persiana sarebbe stata effettuata sulla perduta redazione *δ dello pseudo Kallisthénēs (Nöldeke 1890). A lungo l'ipotesi di Nöldeke ha goduto di notevoli consensi da parte della maggior parte degli orientalisti. Solo di recente è stata oggetto di critiche. Richard Frye (1920-2014) ha notato come difficilmente negli ambienti sāsānidi, in cui Aléxandros era considerato un malvagio distruttore della regalità iranica e un avversario della religione zoroastriana, qualcuno avesse potuto prendersi la briga di tradurre un testo come lo pseudo Kallisthénēs, dove il condottiero macedone era presentato in una luce positiva (Frye 1985 | Franco 1999). In seguito, Claudia Ciancaglini ha dimostrato l'infondatezza degli argomenti di Nöldeke: le grafie dei nomi trovavano plausibile spiegazione nel procedimento di dettatura degli scriptoria, eliminando così il problema dovuto alla presenza di un ciclo alessandrino nell'Īrān preislāmico. L'autrice ha abbassato la data di compilazione del Tašʿitā d-ʾAleksandrōs, nella forma in cui ci è pervenuta, al VII secolo.
Rimane tuttavia la possibilità, come nota la stessa Ciancaglini, di
una traduzione medio-persiana effettuata nell'ambito della chiesa
nestoriana (Ciancaglini 1998). Possiamo così stabilire uno stemma codicum delle varie redazioni e traduzioni dello pseudo Kallisthénēs. Lo schema che segue è tratto, con qualche variazione, da Richard Stoneman (Stoneman 2007): 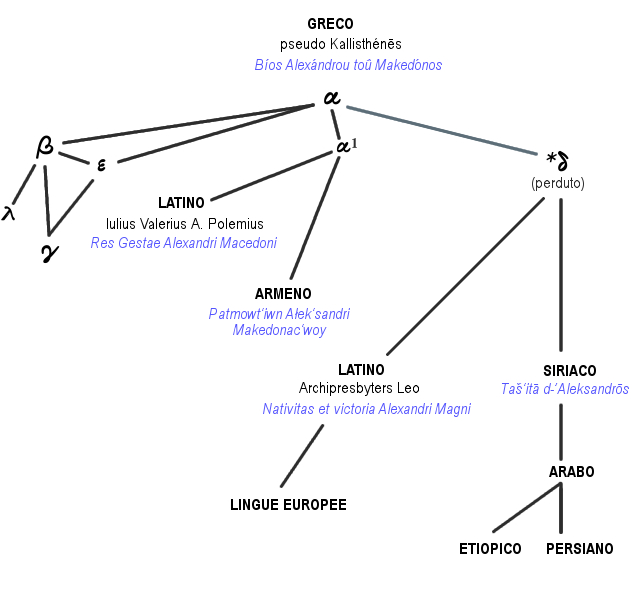
Il Tašʿitā d-ʾAleksandrōs è dunque derivato da una tradizione autonoma, forse piuttosto antica, all'interno del ramo α dello pseudo Kallisthénēs (la fantomatica recensio *δ?):
non conosce l'episodio della sorgente della vita, del cuoco e del
pesce, né quello della muraglia. Ma questi ultimi temi, ignoti alla recensio α, erano ben conosciuti presso le comunità siriache,
come testimonia un altro testo, il Neṣḥānā d-leh d-ʾAleksandrōs, «Le gloriose imprese di Aleksandrōs». Sebbene esistano dei seri dissensi riguardo alla sua datazione, si ritiene che il Neṣḥānā sia stato scritto intorno al 629, come testo propagandistico per celebrare la vittoria dell'imperatore Phlábios Hērákleios (♔ 610-641) sui Sāsānidi e per supportare la politica espansionistica dell'impero bizantino. Il Neṣḥānā si articola in tre episodi principali. Nel primo, Aleksandrōs intraprende un viaggio ai confini della terra. Giunge inizialmente al
«mare fetido» [yamā saryā] che tenta inutilmente di attraversare, senza successo. Quindi raggiunge il luogo dove il sole tramonta, passando, con le sue truppe, attraverso la «finestra del cielo»: da qui, seguendo il tenebroso percorso notturno del sole, Aleksandrōs giunge nel luogo dove il sole sorge. Nella seconda parte, Aleksandrōs arriva tra i monti del Caucaso e segue l'episodio della costruzione della barriera contro Aǧūǧ wa Maǧūǧ, identificati con gli Unni. Nella terza parte del testo, Aleksandrōs si scontra con Tūbarlaq, re dei Persiani, e lo sconfigge. Dopo aver stipulato un patto di pace, il macedone arriva a Gerusalemme, dove stabilisce il suo trono e gli viene applicato l'epiteto di «bicorne». Se la terza parte del Neṣḥānā va considerata una creazione originale del suo autore, che retro-proietta nel passato la vittoria di Hērákleios sui Sāsānidi, gli elementi della prima e seconda parte appartengono alla tradizione. L'orientalista Tommaso Tesei nota, giustamente, le relazioni della prima parte del Neṣḥānā con gli itinerari cosmologici presenti nell'epopea di Gilgameš, dove lo yamā saryā, il «mare fetido», può essere messo in correlazione con le mê mūti, le «acque della morte», e il viaggio lungo il percorso notturno del sole ricorda quello lungo il ḫarran šamši, il «sentiero del sole», del lugal sumerico. Ciò proverebbe la presenza di reminiscenze del mito di Gilgameš nel mondo aramaico-siriaco, recuperate con sostituzione dell'eroe mesopotamico con la figura di Aleksandrōs (Tesei 2013). In quanto alla seconda parte del Neṣḥānā, la leggenda della barriera eretta da
Aléxandros nel Caucaso può essere fatta risalire a un passo dello storico ebreo-romano Titus Flavius Iosephus (37-100), il quale riferisce, quasi en passant, che gli Alani, maturato il progetto di saccheggiare la Media, avevano intavolato trattative con il re dell'Hyrcania, il quale controllava «la via d'accesso che re Aléxandros aveva sbarrato con delle porte di ferro» (Bellum Iudaicum [VII: 7, ])
①▼.
È nel Neṣḥānā
che il tema della barriera alessandrina viene associato per la prima volta alla profezia biblica sull'irruzione escatologica di Gô e Māô (Yǝḥẹzqêl [38-39]).
Il testo, peraltro, attribuisce allo stesso Aleksandrōs una profezia sulla futura rottura della barriera, alla fine dei tempi, a cui seguiranno due invasioni da parte degli «Unni». La profezia fornisce le date delle invasioni con notevole precisione: gli anni Graecorum 826 e 940 che, convertiti dal calendario seleucide, dànno rispettivamente il 614-615 e il 628-629. Queste date sembrano riferirsi alle invasioni dei Sábiroi (614-615) e dei Hazary (intorno al 627): due popoli turchici, provenienti dall'Asia centrale, che potevano ben ricadere nella
vaga definizione di «Unni». Si tratta di un vaticinium ex eventu: la retro-profezia messa in bocca ad Aleksandrōs aveva lo scopo di collegare le due recenti invasioni, di cui i fruitori del testo avevano memoria, al prossimo stabilimento – questo sì, escatologico – di una cosmocrazia dell'impero bizantino su tutta la terra.
Tale ideologia va inscritta nel tormentato rapporto che i cristiani
di Siria avevano con le autorità persiane: le ricorrenti, cruente
persecuzioni religiose da parte dei Sāsānidi erano motivate dal
sospetto di connivenza – molto spesso fondato – dei cristiani col nemico
bizantino. (Di Branco 2011) Il Neṣḥānā d-leh d-ʾAleksandrōs godette di una rapida diffusione subito dopo la sua composizione e ispirò un certo numero di opere escatologiche, tra cui la Apokálypsis
dello pseudo Methódios, i poemi apocalittici dello pseudo Aphrêm Sûryāyâ e il Mēmrā dʿal Aleksandrōs bar Pilipūs
dello pseudo Yaʿqûḇ Sǝrûāyâ. Se il
lettore si sentirà un po' confuso da questa sequela di «pseudo»
autori, ne ha ben donde: stretti tra zoroastriani e musulmani, le
comunità cristiane di Siria cercavano di dare veridicità ai loro
testi apocalittici attribuendoli ai teologi e ai dottori della
chiesa dei secoli precedenti, utilizzando il tema alessandrino in chiave
politico-religiosa. Tali testi possono essere interpretati come una
sorta di risposta cristiana al diffondersi dei cicli sudarabici incentrati sulla misteriosa figura di Ḏū ʾl-Qarnayn
(Di Branco 2011).
Nella Apokálypsis falsamente
attribuita a Methódios di Ólympos († 311), l'imperatore che
stabilirà la cosmocrazia su tutta la terra, alla fine dei tempi,
e che innalzerà la santa croce sul Gagûltâ/Golgothás, è rappresentato come
un secondo Aleksandrōs,
appartenente alla casata del macedone. Invece, nel poema falsamente attribuito a Aphrêm Sûryāyâ (Ephraím Sŷros, 306-373), ma
redatto in realtà tra il 640 e il 680, la profezia di Aleksandrōs
sull'avvento di Aǧūǧ wa Maǧūǧ
annuncia la distruzione del nascente impero arabo, dopo la
quale verrà ristabilito il dominio glorioso di Bisanzio, cui farà
seguito però la venuta dell'Anticristo (Di
Branco 2011).
Particolarmente interessante, ai nostri fini, il Mēmrā dʿal Aleksandrōs bar Pilipūs, il «Sermone su Aleksandrōs figlio di Pilipūs».
Falsamente
attribuito al poeta-teologo Yaʿqûḇ Sǝrûāyâ (Iacopo di Serug, 451-521),
anche questo testo è stato probabilmente elaborato nel VII secolo: è infatti una riscrittura metrica del Neṣḥānā, del quale riprende l'episodio caratteristico della battaglia tra Aleksandrōs e Tūbarlaq, ma da cui elimina la propaganda a favore dell'imperatore Hērákleios, la cui politica di unificazione ecclesiastica
– tesa a diffondere nell'impero la dottrina monotelita – era malvista nei circoli monofisiti.
Ogni azione terrena assume nel Mēmrā
una luce effimera: Aleksandrōs sa
bene che anche il suo impero cadrà e che l'umanità
raggiungerà il proprio compimento solo nel regno dei cieli
(Di Branco 2011). Ma è nel Mēmrā che ricompare l'episodio della sorgente della vita e della resurrezione del pesce, in forma simile a quella presente nella recensio β dello pseudo Kallisthénēs (Bergson 1975). Infatti, dopo uno spaventoso viaggio attraverso la terra delle tenebre, Aleksandrōs si ferma presso una sorgente e ordina al suo cuoco di preparargli da mangiare...
| | E quando il cuoco venne all'acqua, si chinò per inumidire
quel pesce essiccato; e quello non venne alla vita nelle sue mani, come è stato detto,
ma
quando finalmente [il cuoco] venne alla sorgente dalla quale sgorgava l'acqua della vita
e si accostava per lavare il pesce in quell'acqua, quello ritornò alla vita e scappò via. | Pseudo Yaʿqûḇ Sǝrûāyâ: Mēmrā dʿal Aleksandrōs bar Pilipūs [48] |
Il cuoco balza nella sorgente, nel tentativo di riacchiappare la cena del grande conquistatore, e diviene immortale. Non trovando l'acqua della vita, Aleksandrōs non può sfuggire alla propria mortalità e in seguito erige la barriera contro i «figli di Maǧūǧ» (Mēmrā dʿal Aleksandrōs [184]). I temi sviluppati dai testi siriaci hanno una rapida eco in Occidente. A rendere popolarissimo in Europa il mito di Gô e Māô, oltre che facilmente manipolabile a fini propagandistici, sarà la Apokálypsis dello pseudo Methódios, tradotta in greco, latino e slavo a partire dagli inizi dell'VIII secolo. Qui Aléxandros è figlio di Phílippos II Makedṓn e di una principessa etiope. Nel corso delle sue spedizioni a Oriente, incontra i discendenti di Yāẹṯ,
esseri dai costumi osceni e dall'orribile sembiante: Gô e Māo e altre ventuno
animalesche tribù. Dopo aver ricacciato a nord queste popolazioni mostruose e impure, Aléxandros provvede a isolarle oltre i confini dello spazio. Chiede ad Allāhā di ricongiungere due montagne e, tra di esse, innalza due porte di bronzo e le salda con una speciale sostanza, l'asincitum, che non può essere distrutta né dal ferro né dal fuoco né dalla stregoneria. Ma il pericolo da essi rappresentato è solo rimandato: alla fine del mondo si adempierà la profezia di Yǝḥẹzqêl, e Gô e Māo spezzeranno la barriera per invadere Israele (Dronke 1997). L'immediato riflesso in Europa dello pseudo Methódios è la Chronographia latina attribuita a
Æthicus Ister (VII-VIII secolo), dove la barriera costruita da Aléxandros ha un significato escatologico e gli «Alani» di Flavius Iosephus hanno ormai lasciato il posto all'apocalittica irruzione di Gô e Māô. Queste rielaborazioni cristiane di un racconto alessandrino in chiave apocalittica sono davvero affascinanti: Aléxandros si assume il compito di un alter Christus che espelle e controlla la minaccia d'incrinamento della storia, e nel contempo adempie al ruolo di Antichristus, dal momento che nella chiusura dei confini dello spazio ne inserisce il presupposto della propria distruzione, la sottile ma minacciosa frattura attraverso la quale si manifesterà l'esaurimento della storia (Dronke 1997). Con il Mēmrā dʿal Aleksandrōs tutt'e tre le tessere del nostro mosaico sono finalmente disponibili: il motivo del viaggio ai confini del mondo, quello della sorgente della vita e quello della barriera alessandrina. I tre elementi presenti in nuce in al-Qur˒ān [XVIII: -]. Che rapporto
c'è, dunque, tra il Mēmrā e i testi arabi?
L'influenza sudarabica Secondo Tesei, tanto il Mēmrā
tanto al-Qur˒ān [XVIII: -] dipenderebbero dal Neṣḥānā d-leh d-ʾAleksandrōs (Tesei 2013). Ma questa è solo una piccola parte della complessa evoluzione e trasmissione della leggenda dell'acqua della vita.
Ma prima di arrivare al «bicorne» qur˒ānico, e ai solerti tafāsīr che si impadroniranno della sua figura identificandola infine con quella di Mégas Aléxandros, bisognerà cercare di dipanare il complesso gomitolo di motivi e mitemi che si sono avvicendati e stratificati tra la penisola araba, la Siria e il ʿIrāq, tra il I secolo a.C. e il VII d.C. Ḏū ʾl-Qarnayn non è una semplice trasposizione musulmana della figura di Mégas Aléxandros: è un personaggio semimitico su cui sono progressivamente confluiti elementi legati alla leggenda del Macedone, in un processo iniziato prima dell'avvento dell'Islām e che ha poi trovato il suo culmine nei secoli
subito dopo la hiǧra. Come abbiamo premesso, il primo nucleo della figura del «bicorne»
②▼ va localizzata nel ciclo regale sudarabico, in una figura di re/condottiero poi identificata con tubbaʾ Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid. Delle origini sudarabiche di Ḏū ʾl-Qarnayn erano consci molti importanti autori arabi, i quali rifiutavano la sua identificazione con Aléxandros, affermandone invece l'origine yāmānita. Uno di questi è il matematico e astronomo Abū
ar-Rayḥān Muḥammad ibn Ahmad al-Bīrūnī (973-1048), il quale,
nel suo studio comparativo dei calendari di differenti culture e
civiltà, dedica un capitolo intero al problema dell'identità di Ḏū ʾl-Qarnayn:
| | Alcuni dicono che Ḏū ʾl-Qarnayn era aṣ-Ṣaʿb [ibn Ḏī Marāṯid] ibn al-Ḥammāl al-Ḥimyarī, mentre altri lo identificano con Abū Karib Šāmir ibn ʿAbīr ibn Afrīquš al-Ḥimyarī [forse il re ḥimyarī Abīkarib Asʿad, ♔ IV-V sec.], e credono che fosse così chiamato a causa di due riccioli che gli pendevano sulle spalle e che egli raggiunse le regioni orientali e quelle occidentali della terra, che attraversò il nord e il sud, che sottomise i paesi e soggiogò completamente i popoli; e di lui si è vantato uno dei principi dello Yaman […], dicendo: “Attraversò le contrade d'oriente e d'occidente, sempre cercando il potere regale proveniente da un signore generoso e liberale. Poi egli vide il luogo in cui il sole tramonta, quando tramonta in una pozza paludosa e nel fango puzzolente. Prima di lui v'era Bilqīs, mia zia […]”. Di tutte queste identificazioni, quella vera mi sembra questa, perché i principi i cui nomi iniziano per
Ḏū ricorrono solo nella storia dello Yaman e in nessun altro luogo. Inoltre, le tradizioni riguardanti questo principe yamanita, Ḏū ʾl-Qarnayn, sono molto simili a ciò che dice di lui al-Qur˒ān. | | Al-Bīrūnī: Kitāb al-ātār al-bāqiya ʿan al-qurūn al-ḫāliya |
Anche il geografo curdo Abū ʾl-Fidāʾ Ismāʿīl ibn ʿAlī ibn Maḥmud
ad-Dimašqī al-Ḥamawī al-Malik ʾl-Mūaʾyyad ʿImād ad-Dīn (1273-1331),
ci invita a non procedere a frettolose identificazioni. Citando il
maġrebino Ibn Saʿīd al-Maġrībī al-Andalūsī († 1286), che a sua volta
cita l'esegeta qur˒ānico Ibn ʿAbbās († 686-687), Abū
ʾl-Fidāʾ mostra chiaramente di essere a conoscenza del «grande
equivoco» relativo a Ḏū ʾl-Qarnayn
(Di Branco 2011):
| |
Alcuni aggiungono che [al-Iskandar],
dopo aver viaggiato da oriente a occidente, abbia circondato con
un muro i popoli chiamati Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ.
Ma se vuoi la verità, ciò non è stato fatto da questo Iskandar,
bensì da Ḏū ʾl-Qarnayn,
del quale Allāh fece menzione nel
Qur˒ān. Costui fu un re molto antico,
dell'epoca di Ibrāhīm [...]. Dunque
coloro i quali hanno ritenuto che il costruttore di quel sadd
fosse al-Iskandar ar-rūmī,
hanno sbagliato. Ed è ugualmente errato chiamare quest'ultimo
Ḏū ʾl-Qarnayn: Ḏū
è infatti parola meramente araba e tale soprannome è
utilizzato dai re dello Yaman, che sono arabi per nascita [...].
Ibn Saʿīd al-Maġrībī riferisce che Ibn ʿAbbās [...], interrogato
su quel Ḏū ʾl-Qarnayn
che Allāh menzionò nel libro sacro,
abbia risposto: “era un ḥimyarī”. | |
Abū ʾl-Fidāʾ: Al-muḫtaṣar fī
aḫbār al-bašar |
Il grande Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn al-Ḥusayn ibn ʿAlī al-Masʿūdī
(896-956), l'Hēródotos della storiografia araba, nel suo
Murūǧ aḏ-ḏahab wa maʿādin al-ǧawhar
(«I prati d'oro e le miniere di gemme»), scrive:
| |
Non c'è accordo sull'identità [di
al-Iskandar] con Ḏū ʾl-Qarnayn:
gli uni l'affermano; gli altri la contestano. Ḏū ʾl-Qarnayn
ha sollevato molte discussioni. Gli uni ritengono che questo
epiteto gli sia stato donato a causa delle sue spedizioni agli
estremi confini della terra e che era il malʾak preposto alla
custodia del ǧabal Qāf a
soprannominare così al-Iskandar.
Secondo altri questo titolo gli venne da altri malāʾika: quest'ultima
opinione è attribuita a ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb, mentre la prima
appartiene a Ibn ʿAbbās. Secondo un'altra interpretazione, che
si deve ad ʿAlī ibn Abī Tālib, il soprannome di
Iskandar deriverebbe da due
riccioli di capelli d'oro. Ci sono in proposito molte altre
teorie. Noi ci limiteremo, per il momento, a parlare della
divergenza di opinioni emesse dagli uomini di studio e di
religione dei popoli che dispongono di libri rivelati. | |
Al-Masʿūdī:
Murūǧ aḏ-ḏahab wa maʿādin al-ǧawhar
[II] |
L'identificazione tra il re yamanita aṣ-Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid e il condottiero macedone al-Iskandar creava inoltre degli anacronismi difficili da giustificare, resi ancora più ardui dal fatto che il rasūl Mūsá era sicuramente vissuto molto prima di Iskandar, rendendo quindi contraddittorio il suo incontro con al-Ḫiḍr in al-Qur˒ān [XVIII: ]. Molti storici musulmani, tra cui aṭ-Ṭabarī, risolvono ipotizzando l'esistenza di due personaggi chiamati Ḏū ʾl-Qarnayn: appunto il re yamanita e il condottiero macedone, e
solo al primo dei due andrebbe attribuito l'episodio dell'acqua della vita (Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk). Anche l'anonimo autore del Ṣaʿb Ḏū ʾl- qarnayn effettua una distinzione analoga. Sembra tuttavia che già nel ciclo regale sudarabo comparissero – del tutto decontestualizzati – elementi provenienti dalle vicende di Mégas Aléxandros. Le immagini mitizzate di alcuni dei
principali mukarrib dello Yaman preislāmico, quali Karibʾīl Watār e Abīkarib Asʿad – che le iscrizioni sudarabiche presentano come
sovrani valorosi e instancabili fondatori di città – si sarebbero fuse già in epoca antica con i racconti sul conquistatore macedone, formando un primo nucleo del ciclo di Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid (Bohas ~ Saguer ~ Sinno 2012). Saranno proprio le élites ḥimyarī, insediate in Egitto dopo la conquista araba, a realizzare la fusione finale della saga yamanita con le storie di Aléxandros, dando alla südarabische Sage la forma in cui essa sarebbe pervenuta ai tafāsīr musulmani (Vadet 1969). Ma nel ciclo sudarabico concorrevano anche alcuni importanti elementi di substrato, alcuni dei quali provenivano dall'antico mito di Gilgameš. Se il Tašʿitā d-ʾAleksandrōs deriva da un ramo α dello pseudo Kallisthénēs, il Neṣḥānā d-leh d-ʾAleksandrōs e, soprattutto, il Mēmrā dʿal Aleksandrōs attestano il racconto dell'acqua della vita e della resurrezione del pesce che non sono contenute dalla recensio α, ma solo nelle recensiones β e γ.
Se il tema del pesce che ritorna in vita, presente in Ovidius, fa
pensare a uno strato molto antico, il tema dell'acqua della vita
deve essersi diffuso da est a ovest in epoca più recente. Alla base
si riconoscono le tradizioni indoiraniche sulla haoma (medio persiano hōm), originariamente una pianta da cui si estraeva un succo rituale, in seguito divenuto il nome di un mitico
elixir vitae: tale trasformazione è parallela a quella che porterà la šammu nikitti, la «pianta dell'irrequietezza» raccolta da Gilgameš sul fondo dell'Apsū,
a trasformarsi nella māʾ al-ḥayāt,
l'«acqua della vita» di Ḏū ʾl-Qarnayn. Il fatto di trovare questo
motivo attestato tanto nella recensio β dello pseudo Kallisthénēs (IV-V
sec.) quanto nelle tradizioni sudarabiche su Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid, fa pensare che,
già intorno al 300 d.C., questo complesso di leggende doveva essersi
integrato nelle varie versioni del mito alessandrino presenti dallo
Yaman al Mediterraneo.
Sia nel periodo preislāmico, sia in quello successivo alla rivelazione muḥammadica, i poeti yamaniti frequentavano tanto le corti arabo-cristiane dei Ġassāsīna di al-Ǧabiya, a sud di Dimašq,
tanto quelle dei Laḫmiyyūn di al-Ḥīra, nell'odierno ʿIrāq. Quest'ultimo era senza dubbio il più importante centro urbano dell'epoca preislāmica e svolse un fondamentale ruolo di contatto tra gli intellettuali di lingua araba e di lingua aramaica. Gli stessi Laḫmiyyūn,
peraltro, provenivano dallo Yaman, e uno dei loro mukarrib, al-Munḏir al-Akbar III ibn Māʾ al-Samāʾ, era stato identificato a sua volta con Ḏū ʾl-Qarnayn. Sembra dunque plausibile che l'epopea sudarabica di Ḏū ʾl-Qarnayn sia entrata nel milieu cristiano-siriaco proprio ad al-Ḥīra,
dove aveva avuto tutte le opportunità di incrociarsi con le
tradizioni greche. Questo complesso ciclo di leggende, portate alla Makka e alla Madīna dai poeti yamaniti e dai mercanti arabi, era pronto, dopo la predicazione di Muḥammad, a passare al Qur˒ān.
L'influenza giudaica
Ma tra le possibili fonti che hanno contribuito alla definizione conclusiva della leggenda vi erano probabilmente anche le tradizioni giudaiche,
le quali pure svilupparono una letteratura alessandrina di tutto
rispetto, che ha il suo culmine nel Sēẹr
tôlǝḏōṯ Alẹksandrôs ha-maqdônî («Libro delle imprese di Alẹksandrôs
il macedone»), un romance elaborato dal matematico
franco-ebreo Immanuel ben Jacob Bonfils (1300-1377)
(Kazis 1962). Interessanti elementi alessandrini sono
però già presenti nella letteratura talmûḏica e midrāšica, dove si accenna al viaggio di
Alẹksandrôs attraverso la terra
delle tenebre e al suo arrivo alle porte del gan ʿĒḏẹn.
Queste leggende hanno il loro archetipo in un breve episodio del Talmûḏ Bāḇlî
(Wheeler 1998), che inizia con un dialogo tra il macedone
e un gruppo di saggi anziani del sud:
| | Ed
[Alẹksandrôs] disse loro: “Voglio andare in terra d'Africa”.
Risposero: “Non è possibile arrivare, perché lungo la strada si
ergono le montagne delle tenebre”. Ed egli disse loro: “Questo non mi impedirà di andare.
Perciò sono qui a chiedere il vostro consiglio. Ditemi cosa devo
fare”. “Prendi asini libici, che possono viaggiare nel buio, e
porta rotoli di corda e fissali ai lati [della strada]. Così
potranno guidarti al tuo ritorno e raggiungere la tua
destinazione.” Così egli fece e partì. | | Talmûḏ Bāḇlî [tamīd 32a] |
Dopo aver attraversato la terra delle tenebre e quella delle
amazzoni, l'Alẹksandrôs talmûḏico
arriva a una sorgente:
| |
Mentre era in viaggio si sedette vicino l'acqua e cominciò a mangiare. Aveva con sé alcuni pesci essiccati, e mentre li lavava essi emanarono un
dolcissimo profumo. [Alẹksandrôs] disse: “Ciò
prova che quest'acqua viene dal gan ʿĒḏẹn”.
Alcuni dicono che egli raccolse un po' d'acqua e si lavò il viso.
Altri dicono che [Alẹksandrôs]
proseguì il cammino finché arrivò al cancello del gan ʿĒḏẹn.
Gridò: “Aprite le porte!” Risposero: “Questa è la porta di
Ăḏonāy, per essa passano i giusti”
(Tǝhillîm [118: ]). A ciò,
[Alẹksandrôs] replicò: “Io sono un
grande signore e re, e ho una certa statura. Concedetemi
qualcosa!” Gli diedero un bulbo oculare. [Alẹksandrôs]
lo pesò, ma tutto il suo oro e argento non poté eguagliarne il
peso. Egli disse ai rabbānîm: “Cosa significa?”
Risposero: “Che quest'occhio appartenne a un uomo insaziabile”. | | Talmûḏ Bāḇlî [tamīd 32b] |
Nonostante sia stato riabilitato da Brannon Wheeler (Wheeler 1998), questo passo talmûḏico era stato precedentemente respinto come fonte per la tradizione siriaca dallo stesso Nöldeke, e anche da Israel Friedländer, i quali ne avevano sottolineato i punti di divergenza con il Mēmrā dʿal Aleksandrōs bar Pilipūs, così come la presenza di elementi pagani e l'assenza del motivo dell'acqua della vita, negando in definitiva una sostanziale interazione tra il
Talmûḏ e il testo siriaco, nonostante il soggetto comune (Nöldeke 1890 | Friedländer 1913).
Tuttavia, il testo talmûḏico esplicita il tema del
regressus ad paradisum, che è il motivo centrale e portante
delle leggende che stiamo analizzando in questa pagina, sebbene vi
si accenni solo implicitamente nel racconto di
Gilgameš e nelle rielaborazioni
islāmiche. Possiamo chiederci se il
Talmûḏ abbia ereditato una versione della
leggenda priva di inutili orpelli, dove l'eroe – identificato
con Alẹksandrôs – tentava un vero
e proprio ritorno al gan ʿĒḏẹn,
o se i suoi autori l'abbiano rielaborata evidenziandone i
significati nascosti. Non lo sappiamo: e anche il tema
del pesce reca qui una rielaborazione interessante:
l'animale immerso nell'acqua non ritorna direttamente in vita, ma
evidenzia con il proprio profumo la natura stessa dell'acqua, che
proviene dal giardino d'immortalità.
Il passaggio talmûḏico sembra attingere a una letteratura
ancora anteriore e testimonia, se mai ce ne sia bisogno, che il
ruolo attribuito ad Aléxander/Alẹksandrôs
non era certo un'innovazione nel tema che stiamo indagando. |
①▲ I passaggi transitabili attraverso il Caucaso, oggetto di fortificazioni fin da tempi remoti, erano essenzialmente due: la Porta Caucasica e le
Portae Caspiae, che i geografi antichi confondevano sovente l'una con le altre, come testimonia Gaius Plinius Secundus (Naturalis Historia [VI: 12, | 15, ]). La Porta Caucasica corrisponde alla gola di Darialis, che corre per una decina di chilometri alla base del monte azbek, presso l'odierno confine tra Georgia e Russia: il suo nome georgiano, Darialis seoba, deriva dal persiano Dar-e Alān, «porta degli Alani», suggerendo che possa trattarsi della via d'accesso indicata da Flavius Iosephus. Ma poiché l'Hyrcania era situata presso il Caspio meridionale, è probabile che Flavius intendesse invece le
Portae Caspiae, ovvero il passo di Fīrūzkūh, alle propaggini orientali dell'Elburz, nell'Īrān nord-orientale. Si tratta di una gola angusta, lunga circa dodici chilometri, che termina presso la fortezza sāsānide di Derbend (od. Derbent, Dāġestān russo, a circa sessanta chilometri a sud-est dell'attuale Tehrān). Ma quali che siano le identificazioni geografiche del passo murato da Aléxandros (o Ḏū ʾl-Qarnayn), le lasciamo a quanti ritengono che i miti si esauriscano una volta messe a nudo le loro radici storiche. |
| | |
②▲ Sull'epiteto Ḏū ʾl-Qarnayn, «quello dalle due corna», gli esegeti musulmani si sono accaniti tentando le interpretazioni più differenti. Poiché in arabo qarn significa, oltre «corno», anche «cima» o «sommità», oppure «secolo», ma anche può indicare il primo spicchio del sole che spunta dietro l'orizzonte, gli esegeti si sono sbizzarriti a spiegare l'epiteto Ḏū ʾl-Qarnayn con locuzioni del tipo «signore dell'oriente e dell'occidente», o «signore del giorno e della notte» o «signore di due secoli», e via dicendo. Verranno date anche spiegazioni mistiche del tipo «signore del mondo visibile e di quello invisibile» o simili. (Saccone 1997). Ma le corna sono legate alla rappresentazione biblica di Aléxandros che, nella seconda visione di Dāniyyêl, è descritto, senza essere nominato, come un grande «capro» che «percorreva tutta la terra senza toccare il suolo; tra gli occhi aveva un grosso corno» (Dāniyyêl [8: ]) e combatte contro un «montone» con due corna simboleggiante, forse, il regno dei Medi e quello dei Persiani. |
|
| VERSO LE CITTÀ DI SMERALDO: IL MITO ARABO DI AL-ISKANDAR | | La fortezza sāsānide di Darbend | Persiano Darbend, russo Darbent, avaro Derbend, azərbaycano Dǝrbǝnd, lezgo K‘verar, lak Čurul. Repubblica del Dāġestān, Federazione Russa. Gli arabi chiamarono la cittadella Bāb al-abwab, «porta delle porte», vagheggiando di aver trovato la mitica sadd al-Iskandar, la barriera eretta da Ḏū ’l-Qarnayn. |
Una manciata di anni dopo la morte di Muḥammad, al tempo del ḫalīfah ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb (579-644), i soldati arabi, nel corso delle loro inarrestabili conquiste, entrarono in Armenia. Giunti alle
Portae Caspiae, fu grande il loro sgomento quando si trovarono di fronte alle imponenti mura della fortezza sāsānide di Derbend, la «porta serrata» che controllava l'unica via di accesso alle province occidentali dell'impero persiano. Bāb al-abwab, «porta delle porte», fu il suggestivo nome che
gli arabi diedero alla cittadella, vagheggiando di aver trovato il sadd al-Iskandar, la mitica barriera eretta da Ḏū ʾl-Qarnayn. Da questo punto in poi non ci sono più scuse: il mosaico mostra una figura vivida, significativa, di rara potenza, che viene a collegare in una struttura coerente motivi che da secoli andavano alla deriva nei rivoli delle tradizioni della Siria, dell'Arabia, dello Yaman, della Mesopotamia, dell'Īrān. L'elaborazione del mito
islāmico-alessandrino comincia solo ora a rivelare in controluce la complessità dei motivi che hanno concorso alla sua formazione. Sotto le sapienti elaborazioni di una nuova generazione di esegeti qur˒ānici, di storici e geografi arabi, e soprattutto di poeti persiani, una gran quantità di mitemi, da secoli sparpagliati nell'oceano delle leggende, trovano d'un tratto la loro collocazione e il loro significato. Numerosi autori arabi si succederanno ad analizzare le relazioni tra Ḏū ʾl-Qarnayn e al-Iskandar: si ricordano, tra gli altri, ad-Dīnawarī (IX sec.), aṭ-Ṭabarī (IX-X
sec), al-Masʿūdī (X sec.), al-Bīrūnī (X sec.), aṯ-Ṯaʿlabī (X-XI sec). Ma cosa avevano realmente tra le mani, impiegarono un bel po' a capirlo. Anche quando l'eredità del Profeta era entrata, tenace, nella memoria dei nuovi conquistatori del mondo, l'episodio del pesce suscitava profonde perplessità presso i primi esegeti
islāmici, i quali non riuscivano bene a definire la natura della disavventura occorsa a Mūsá e Yušāʾ, e soprattutto cosa fosse esattamente accaduto al loro pranzo nel laconico passo di al-Qur˒ān [XVIII: -]. Sì, qualcosa di strano era successo a quel pesce secco e salato che, dopo aver ripreso vita, sembrava essere fuggito tra le rocce del deserto (Vacca 2013).
Ma bisognerà attendere almeno tre o quattro secoli affinché la storia raggiunga una forma canonica nei tafāsīr ed è interessante notare che il senso della vicenda verrà esplicitato nelle fonti persiane: il pesce essiccato resuscita e nuota via perché è stato lavato nella yanbūʿ al-ḥayāt, la «sorgente della vita». Come puntualizza Brannon Wheeler, «fu solo nel XII secolo, o comunque non prima dell'XI, che gli esegeti arabi cominciarono a capire, grazie ai romanzi persiani, che al-Qur˒ān [XVIII: -] alludeva alle vicende di Aléxandros», più che a quelle di Mūsá e Yušāʾ (Wheeler 1998). Ma Wheeler è forse eccessivamente prudente. L'episodio dell'acqua della vita è già presente in un certo numero di
narrazioni arabe incentrate su al-Iskandar, risalenti già all'VIII secolo. In
alcuni articoli, il professor David Zuwiyya ha illustrato il Maǧmuʿ qiṣṣat al-Iskandar wa ma fīha min al-ʿamr al-ʿaǧīb, «La storia di al-Iskandar con
tutti i suoi fatti meravigliosi», opera di un certo ˓Umāra ibn Zayd (❀ VIII
sec.): si tratta di un testo ancora inedito, tradito in un manoscritto
cinquecentesco conservato alla British Library (ms. Add. 5928). Agli episodi principali presenti nello pseudo Kallisthénēs si aggiungono in questo Qiṣṣat al-Iskandar molti dettagli inerenti alla geografia e alla cosmologia
islāmiche. Analoghi romances arabi provengono dalla Spagna moresca: sono il Qiṣṣat Ḏū ʾl-Qarnayn, il Ḥadīṯ Ḏū ʾl-Qarnayn e il Rrekontamiento del rrey Ališandre. Quest'ultimo testo è in lingua aragonese, sebbene trascritto usando l'alfabeto arabo: questo tipo di grafia, conosciuta come aljamiado/ʿaǧamiyah, è tipica delle traduzioni dai testi arabi, effettuate in genere da interpreti moriscos. (Zuwiyya 2011 | Zuwiyya 2012) Il Qiṣṣat al-Iskandar è un romanzo di ampio respiro, ricco di episodi fantastici. ˓Umāra ibn Zayd riferisce di aver ricavato il suo materiale da notizie e aḥadīṯ tratti da molteplici fonti, nessuna delle quali è posteriore all'VIII secolo (cita Ibn Isḥaq, Hišām al-Kalbī, Kaʿb al-Aḥbār, al-Ḥasan al-Baṣrī, ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās, Muqātil ibn Sulaymān...). Gli episodi che a noi interessano riguardano i viaggi di Ḏū ʾl-Qarnayn/al-Iskandar verso la terra del sole nascente e del sole calante, narrati da ˓Umāra con gran dovizia dei dettagli. Come Bulūqiyā, anche al-Iskandar di ˓Umāra cammina sulle onde del mare, sostenuto dalla sua fede e, quando la fede viene meno, sprofonda. Dopo essersi spinto fino alle estreme propaggini della terra, sia in oriente che in occidente, giunge al ǧabal
al-Qāf, la montagna che circonda la terra. Al-Qāf è di un intenso verde smeraldo, ma nei suoi pressi al-Iskandar è costretto a procedere in una tenebra assoluta. Il monte è talmente imponente che riesce a nascondere la luce del sole anche a mezzogiorno: e noi ancora una volta riconosciamo in questa tenebra una reminiscenza del ḫarran šamši nel racconto di Gilgameš. Varcata la montagna, Iskandar trova due meravigliose città: Ǧābarsā a occidente e Ǧābalqā
a oriente. Sono abitate dai discendenti del nabī preislāmico Ḥūd (o dei nabiyyūn Ḥūd e Ṣāliḥ nel Rrekontamiento). Vi ritroviamo l'episodio dell'«angelo della montagna» [al-malʾak bi ǧabal] che, seduto sul
Qāf, obbedisce agli ordini di Allāh e, tirando invisibili redini, scatena
dovunque terremoti. E naturalmente l'episodio della māʾ al-ḥayāt, l'«acqua della vita», che viene bevuta da al-Ḫiḍr
ma non da al-Iskandar. Le tradizioni sul ǧabal
al-Qāf e sulle favolose città di Ǧābarsā e Ǧābalqā tornano insistentemente a riaffacciarsi nella letteratura araba. L'uno e le altre erano già citate nel ciclo di Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid
(Ṣaʿb Ḏū ʾl-Qarnayn), e
avranno degli interessantissimi sviluppi presso i teosofi persiani, come ben sanno i lettori di Henry Corbin, che ne ha analizzato la vertiginosa portata esoterica (Corbin 1979). Del ǧabal
al-Qāf tratta il geografo Yāqūt ibn ʿAbdullah al-Hamawī ar-Rūmī (1179-1229):
| | Al-Qāf è il monte che circonda la terra e la racchiude. Al-Qāf è menzionato nel Qurʾān. Gli esegeti dicono che la montagna circonda la terra. Dicono che è fatta di cristallo verde e che il
verde del cielo deriva dal suo colore verde. Dicono che ha per base una roccia verde, dal quale si sviluppa il ǧabal
al-Qāf, che si trova sulla sua cima. Dicono anche che le radici di tutte le montagne derivano dal ǧabal
al-Qāf. Alcuni hanno stabilito che la cima [del Qāf] dista dal cielo quanto l'altezza di un uomo. È pure detto che il cielo si poggia su di esso. Oltre al-Qāf, dicono alcuni, vi sono mondi e creazioni che solo Allāh conosce. Tra questi, altri affermano che tutto ciò che si trova oltre [al-Qāf] appartiene al mondo futuro e alle sue leggi, e che il sorge e tramonta da esso. [Al-Qāf] scherma il sole alla terra. Gli antichi lo chiamavano al-Burz. | | Yāqūt al-Hamawī ar-Rūmī: Kitāb muʿǧam al-buldān |
Questo spiega lo strano potere dell'«angelo della montagna». Poiché le radici del Qāf sono collegate a quelle di tutte le montagne della terra, quando al-malʾak bi ǧabal agisce sulle connessioni del Qāf, tirando gli invisibili collegamenti che lo uniscono agli altri sistemi montuosi, può causare terremoti e catastrofi in qualsiasi paese del mondo. Riporta lo storico Šihāb ad-Dīn Abū al-˓Abbās Aḥmad ibn Faḍl Allāh al-˓Umarī
(1300-1384): «Tutti i monti sono diramazioni della montagna che circonda
il mondo. È chiamata ǧabal al-Qāf, ed è la madre di tutti i rilievi, che dipendono da essa. In qualche punto [al-Qāf] si estende ininterrotto, in altri tratti presenta dei varchi. Essendo un circolo, per essere precisi, non ha né un inizio né una fine. La curva del ǧabal
al-Qāf non è quella di una sfera, ma quella, pressappoco, di un recinto» (Hopkins ~ Levtzion 2000). Interessanti informazioni sono fornite dal Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk di aṭ-Ṭabarī,
nella traduzione persiana di Abū ʿAlī Muḥammad al-Balʿamī (❀ X sec.),
il quale integra del materiale aggiuntivo
(Zotenburg 1958). Un'illuminante digressione sul ǧabal
al-Qāf viene fatte risalire all'autorità degli aḥadīṯ di Muḥammad:
| | Il rasūl ha detto: Allāh creò il ǧabal
al-Qāf tutto intorno alla terra. È anche chiamato il palo della terra, così come si dice nel Qurʾān: «[noi abbiam fatto della terra un'amaca] e le montagne sono pali alti» [XLVIII: -]. Questo mondo è al centro del ǧabal
al-Qāf come il dito è in mezzo all'anello. La montagna è color smeraldo. Nessun uomo vi può arrivare, a meno di non avanzare per quattro mesi nelle tenebre. Non vi sono [sul
Qāf] né sole, né luna, né stelle: ma [il monte] è di un
verde talmente intenso che lo smeraldo del cielo è il riflesso della montagna che si riflette sulla volta celeste, che sembra perciò di questo colore. Se così non fosse, il cielo non sarebbe
verde. Tutte le montagne che tu puoi vedere nel mondo appartengono al ǧabal
al-Qāf. Sappi che se il ǧabal
al-Qāf non esistesse, tutto il mondo vacillerebbe e nessuna creatura potrebbe vivere su di esso. | | Aṭ-Ṭabarī / al-Balʿamī: Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk [VI] |
Anche al-Qurṭubī, Ibn Kaṯir e lo stesso Yāqūt enfatizzano il collegamento tra al-Qāf
e il cielo, il cui color smeraldo (secondo il cromatismo arabo, che
associa al verde concetti di purezza e perennità) nasce dal riflesso dello smeraldo
della montagna che circonda l'orizzonte, suggerendo che al-Qāf sia lo specchio del cielo
(o il cielo lo specchio del
Qāf), ma pure che il monte simboleggi il paradiso (Wheeler 2002). Si noti che un eco del Qāf era presente nelle versioni siriache, laddove si legge che Aleksandrōs «guardò la montagna che circondava tutto il mondo, il grande limite che Allāhā aveva stabilito in eterno (pseudo Yaʿqûḇ Sǝrûāyâ: Mēmrā dʿal Aleksandrōs bar Pilipūs [178]). In quanto alle città di Ǧābarsā e Ǧābalqā, non è stata proposta un'etimologia soddisfacente per spiegarne i nomi. Poiché il toponimo Ǧābalqā sembra una corruzione di ǧabal Qāf, ci si è chiesti se Ǧābarsā non possa essere interpretato in modo analogo, anche considerato che questo toponimo, in alcune fonti persiane, compare come Ǧābalsā, con sostituzione di
rāʾ con lām. Se l'arzigogolata etimologia
da un ǧabal Sīnāʾ, cioè «monte Sinai», fosse confermata, Ǧābarsā e Ǧābalqā esprimerebbero forse, metaforicamente, l'occidente e l'oriente del mondo.
Ma concentriamoci piuttosto sulle città stesse. Su di esse ci è di notevole aiuto aṭ-Ṭabarī, il quale, nel suo tafsīr, il Ǧāmiʿ al-bayān ʿan tāʾwīl āy al-Qurʾān, nel corso della dettagliata esegesi a Qurʾān [XI: ] – dove si parla del «viaggio notturno» [al-isrā˒] di Muḥammad – inserisce una
bella digressione sulle due città:
| | Ti meravigli del comando di Allāh? È quello stesso dio che creò due città: una a oriente e l'altra a occidente. Il popolo della città a oriente è costituito dagli ʿĀd, i discendenti di quanti di loro credettero [a Ḥūd]. Il popolo della città a occidente sono è costituito dai Ṯamūd, i discendenti di quanti di loro credettero a Ṣāliḥ. Il nome [della città] a oriente è
Marqīsīyā in siriaco, e Ǧābalqā in arabo. Il nome della città a occidente è
Barǧīsīyā in siriaco e Ǧābarsā in arabo. Entrambe le città hanno diecimila porte, un farsaḫ di distanza tra ogni coppia di porte. Ogni giorno, diecimila sentinelle armate fanno la guardia a ciascuna porta della città, [e ci sono là così tanti uomini che ciascun gruppo di diecimila sentinelle] farà un unico turno fino al giorno della tromba [del giudizio]. Se, per volere
di colui nelle cui mani è l'anima di Muḥammad, non ci fossero là così tante persone e il suono delle loro voci non fosse così forte, tutti i popoli del mondo potrebbero udire il fragore del sole quando sorge e quando tramonta. Oltre a queste [città] ci sono altre tre nazioni: Mansak, Tāqīl e Tārīs, e prima di esse ci sono Yaʾǧūǧ e Maʾǧūǧ. | | Aṭ-Ṭabarī: Ǧāmiʿ al-bayān ʿan tāʾwīl āy al-Qurʾān |
Molti pittoreschi dettagli vengono riferiti in una fitta serie di aḥadīṯ presenti nella traduzione di al-Balʿamī del Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk. Apprendiamo così che le città di Ǧābarsā e Ǧābalqā sorgono accanto al Qāf, nel mezzo della tenebre, tanto che i loro abitanti non sanno nemmeno che Allāh ha creato il sole, la luna e le stelle. Essi ricevono luce dal ǧabal
al-Qāf. Essendo inoltre le due città composte del medesimo smeraldo
ricavato dalle pendici del monte – e alzi la mano chi non ha pensato al palazzo del mago di Oz –, gli edifici e le mura risplendono di luce propria. In questo testo, tuttavia, un ḥadīṯ nega che Ǧābalqā e Ǧābarsā siano situate non lontano dal luogo dove il sole sorge e declina, e anche che il clamore delle due città dissimuli il fragore prodotto dal sole all'alba e al tramonto. Le città di Ǧābalqā e Ǧābarsā sono fastose e immense: ampie dodicimila farsaḫ in larghezza e dodicimila in lunghezza. Ciascuna comprende diecimila fortificazioni, e in ciascuna una guarnigione di diecimila sentinelle sta di guardia ogni notte. Ci sono così tanti soldati che una guarnigione sta di servizio soltanto una notte all'anno.
Gli abitanti di Ǧābalqā e Ǧābarsā sono infatti minacciati dai popoli di Tāqīl e Tārīs,
che notte e giorno, incessantemente, tentano di assalire le due città e
sterminare coloro che vi dimorano. Questi sono descritti come un popolo assai virtuoso. Sono tutti maschi, non avendo femmine tra loro; non indossano abiti e si nutrono dell'erba prodotta dalla terra. Pur appartenendo al genere umano, non hanno mai sentito parlare di Ādām, né del demonio Iblīs. Tuttavia, secondo un ḥadīṯ, nella notte del miʿrāǧ, Muḥammad sarebbe stato condotto a Ǧābarsā e Ǧābalqā
dal malʾak Ǧibrāʾīl. Il rasūl chiese ai popoli delle due città di seguire la sua religione e la sua legge, ed essi subito credettero in Allāh e aderirono all'Islām. Dopo di che il profeta si recò dai popoli di Tāqīl e Tārīs, di Yaʾǧūǧ e Maʾǧūǧ, ma questi rifiutarono di ascoltare la sua parola e rimasero infedeli. (Aṭ-Ṭabarī/al-Balʿamī: Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk [VII]) Mentre aṭ-Ṭabarī pone Ǧābarsā a occidente e Ǧābalqā a oriente, Yāqūt ne inverte le posizioni. Ma esistono anche altre opinioni. Ǧābarsā e Ǧābalqā sono state correlate alla «città del sole» dello pseudo Kallisthénēs, a cui Aléxandros giunge nel corso del suo viaggio in India, con il suo meraviglioso giardino i cui alberi gli profetizzeranno la prossima morte (Bíos Alexándrou toû Makedónos γ [II: 44]). È significativo il fatto che gli abitanti di Ǧābarsā e Ǧābalqā vengano fatti discendere dalle mitiche tribù degli ʿĀd e dei Ṯamūd. Costoro sono a più riprese ricordati nel Qurʾān come due antichissimi popoli della stirpe di Šām ibn Nūḥ, sterminati da Allāh a causa della loro idolatria, avendo ignorato il messaggio dei due nabiyyūn mandati a convertirli: rispettivamente Ḥūd e Ṣāliḥ. Aṭ-Ṭabarī dedica alle vicende degli ʿĀd e dei Ṯamūd due lunghi e affascinanti capitoli nel Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk, su cui tuttavia non è il caso di soffermarci. Ma di uno dei loro re, l'orgoglioso Šaddād ibn ʿĀd, si narra abbia voluto innalzare una città meravigliosa, Iram ḏāt al-ʿimād, «dalle alte colonne», così da rivaleggiare con i giardini del paradiso. Sebbene al-Qurʾān si limiti ad alludere all'episodio in una sola abbagliante terzina, nella Sūra al-faǧr (la «sūra dell'aurora»),...
Alam tara kayfa faʿala rabbuka bi ʿĀdi
Irama ḏāti al-ʿimādi
āllatī lam yuḫlaq miṯluhā fī al-bilādi? | Non hai visto quel che fece il signore alla gente di ʿĀd,
a
Iram dalle alte colonne,
che non aveva pari su tutta la terra? | | Al-Qur˒ān [LXXXIX: -] |
...le fiabe arabe non cessano di favoleggiare sull'arrogante bellezza della città di Iram, la cui costruzione avrebbe richiesto trecento anni. Ma la leggenda, che ha la sua autorità negli ḥadīṯ provenienti dalla cerchia del Profeta, è ben attestata tanto nei tafāsīr tanto nei testi storici. Secondo lo storiografo Abū Zayd ʿAbd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Ḫaldūn
al-Ḥaḍrami (1332-1346), che riporta la vicenda pur reputandola poco plausibile, Šaddād e Šadīd sarebbero stati figli di ʿŪṣ figlio di Iram della stirpe di Šām. Alla morte di Šadīd, Šaddād gli succedette quale unico sovrano degli ʿĀd. Un giorno, avendo sentito decantare le bellezze del paradiso, Šaddād decise che avrebbe costruito lui stesso un paradiso in terra. Progettò la costruzione di Iram da qualche parte nel deserto di ʿAdan, nello Yaman. Le colonne che sorreggevano la città erano monoliti alti quasi quanto le montagne da cui erano stati scolpiti. Sopra di essi, centomila palazzi erano decorati di gemme e perle, i pavimenti ricavati da legni pregiati, i giardini composti da alberi di diaspro e crisolite, con foglie di metalli preziosi e frutti di smeraldi e rubini. Uccelli meravigliosi riempivano le verzure con il loro canto e la luce di innumerevoli lampade rivaleggiava con il bagliore del sole. Ma
non appena Šaddād e i suoi uomini accedettero a Iram, un agghiacciante grido risuonò dal cielo e ogni vita si spense. (Ibn Ḫaldūn: Muqaddima). Dopo di che, Iram sprofondò nelle sabbie del Rubʿ al-Ḫālī, trasformandosi in una sorta di «atlantide del deserto», i cui ritrovamenti formano un ciclo a parte nella novellistica araba. La leggenda è anche nota nei paesi anglosassoni per la romantica versione che ne offre Richard Burton nella sua traduzione delle Alf layla wa layla (The Book of One Thousand and One Nights [IV: 277-279]). Cosa ci sia sotto questa affascinante leggenda, di
probabile origine sudarabica, è difficile dirlo: è arrivata a noi già
bella e incastonata nel ciclo profetico e quindi riletta in chiave
fortemente islāmizzata. Chi erano Šaddād e Šadīd? E il loro congiunto Luqmān, sapiente e longevo, non potrebbe prefigurare al-Ḫiḍr? Non abbiamo risposte, ma certo gli scrittori arabi seguivano una loro idea quando ponevano i discendenti degli ʿĀd e dei Ṯamūd (o dei nabiyyūn Ḥūd e Ṣāliḥ, i quali appartenevano alle rispettive
qabāʾil) nelle favolose città di Ǧābarsā e Ǧābalqā, ai confini del mondo. Secondo aṭ-Ṭabarī/al-Balʿamī, solo tre uomini degli ʿĀd, convertiti da Ḥūd, riuscirono a giungere a Ǧābarsā e Ǧābalqā (ma non Ḏū ʾl-Qarnayn, il quale avrebbe arrancato nelle tenebre per soli due mesi, e non i quattro necessari per arrivare alle due città) (Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk [VII]). Ma al-Iskandar è legato a Šaddād a filo doppio. Entrambi sono segnati dalla loro hýbris:
l'uno cerca la via per ritornare al paradiso, l'altro il paradiso
intende costruirselo in terra. Al-Masʿūdī narra che al-Iskandar avrebbe rinvenuto, nel luogo
prescelto per fondarvi la futura città di Iskandariyya/Alexándreia, un'iscrizione in caratteri sudarabici in cui re Šaddād ibn ʿĀd affermava di aver voluto erigere, in quello stesso sito, «riparato dai colpi del tempo, dalle cure e dai mali», una città simile a Iram, ma di non aver avuto il tempo di farlo.
L'iscrizione si concludeva con l'invito a non lasciarsi sedurre
dall'ingannevole fortuna e dalle lusinghe del mondo (Murūǧ aḏ-ḏahab wa maʿādin al-ǧawhar [II:
]) (Di Branco 2011). Troveremo altri
traîts-d'union tra questi due orgogliosi sovrani.
L'enciclopedico al-Masʿūdī è
particolarmente utile, ai nostri fini, in quanto ci fornisce un
equivalente islāmico della «tavola delle nazioni» che collega
esplicitamente i Greci ai popoli sudarabici, fornendoci al tempo stesso
la giustificazione dello strano viluppo di equazioni tra al-Iskandar
e i sovrani dello Yaman. Ai suoi tempi, infatti, gli storici arabi
sostenevano opinioni genealogiche piuttosto discordanti sulle origini
dei popoli ellenici: alcuni autori ritenevano che gli Yūnaniyyūn
(i «Greci») e i Rūm (i «Romani»,
cioè i Bizantini) discendessero da
Yūnān ibn Yāfiṯ ibn Nūḥ
(il biblico Yāwān bẹn Yāẹṯ bẹn
Nōḥ
(Bǝrēʾšîṯ [10: ])),
altri li ritenevano di stirpe ibrāhīmica, discendenti di
Ṣūfar ibn ʿĪsaw ibn Yiṣḥāq ibn Ibrāhīm
(un figlio del biblico ʿĒśāw bẹn Yiṣḥāq bẹn Aḇrāhām
non riconosciuto dal Bǝrēʾšîṯ).
Al-Masʿūdī, negava una parentela tra gli Yūnaniyyūn
e i Rūm, e teneva ben distinte le
due stirpi. Inoltre riteneva che Yūnān
fosse fratello di Qaḥṭān ibn
Ġābar ibn Šālaḫ ibn Arfaḫšaḏ ibn Sām ibn Nūḥ, il
mitico antenato di tutte le popolazioni dell'Arabia meridionale: «Il
tubbaʿ [?] ha cantato al-Iskandar nelle
sue poesie e ha sfruttato la gloria di questo principe facendolo
discendere da Qaḥṭān. Secondo una
tradizione, un tubbaʿ s'impadronì di una città dei Rūm e la
popolò di coloni venuti dallo Yaman: da questi arabi, restati in
queste città, discenderebbe Ḏū ʾl-Qarnayn,
cioè al-Iskandar. Ma
Allāh sa di più» (Murūǧ aḏ-ḏahab wa maʿādin al-ǧawhar
[II: -]). E, con maggiori
dettagli:
| |
Studiosi molto esperti nella storia dei tempi antichi dicono che
Yūnān era fratello di Qahṭān
e discendeva da ʿĀbar ibn Šālaḫ, e che
dalla sua separazione dal fratello sono nate tutte le incertezze che
coinvolgono la sua comunità di origine: Yūnān
uscì dallo Yaman accompagnato dai suoi figli, dalla sua famiglia e
da tutti coloro che vollero unirsi a lui. Giunto nelle lontane
regioni d'Occidente, vi si stabilì, e la sua famiglia si moltiplicò.
Là la sua lingua perse la sua purezza e prese i caratteri
dell'idioma barbarico di cui si servivano i Faranǧ [Franchi] e i Rūm che abitavano quelle contrade. Allora tutte le tracce della sua
parentela scomparvero, tutti i suoi legami furono spezzati e il
ricordo del suo nome si cancellò nello Yaman, dove infatti i
genealogisti lo ignorano. Yūnān era
dotato di una grande forza e di una notevole corporatura; alla
bellezza del corpo si aggiungeva l'intelligenza, la sicurezza del
giudizio, la nobiltà degli istinti e un alto valore personale. | |
Al-Masʿūdī: Murūǧ aḏ-ḏahab wa maʿādin al-ǧawhar
[II: -] |
Yūnān si stabilisce ad Āṯīnā (Athnai)
dove fonda il suo regno. Alla sua morte, gli succede il figlio
Ḫarbiyūs
(Kékrops?), il quale – annullando la
distanza temporale tra Grecia classica e impero bizantino – estende il
dominio ellenico su tutto l'occidente (Murūǧ aḏ-ḏahab wa maʿādin al-ǧawhar
[II: -]). Questa strana parentela
tra Sudarabici e Greci ha forse origini più antiche di quanto non si
pensi: la via dell'incenso aveva probabilmente stabilito rapporti tra lo
Yaman e gli Yawān forse addirittura a partire dalla fine del
VII secolo a.C., rapporti che tra l'altro
potrebbero aver esercitato un influsso sulla formazione stessa
dell'alfabeto sudarabico (Di Branco 2011). Oltre a
narrare il ciclo leggendario di Ḏū ʾl-Qarnayn/al-Iskandar nel Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk, aṭ-Ṭabarī – il quale sta diventando una guida di tutto rispetto in questa nostra ricerca – analizza nel suo tafsīr gli āyyāt qur˒ānici su Ḏū ʾl-Qarnayn. Anch'egli identifica il «bicorne» con un re sudarabico,
che chiama, nella coincisa onomastica araba, Ḏū al-Aḏʿār ibn Abrahah
Tubbaʿ Ḏū al-Manār ibn ar-Rāʾiš ibn
al-Qays ibn Sayfī ibn Sabaʾ ar-Rāʾid. In un ḥadiṯ,
ripreso ancora una volta da Wahb ibn Munabbih, aṭ-Ṭabarī spiega che Ḏū ʾl-Qarnayn viaggiò verso i quattro punti cardinali, attraversando interamente «la lunghezza della terra» [wasṭ al-arḍ] e «la larghezza della terra» [ṭawl al-arḍ]. I popoli che abitano alle quattro estremità del mondo sono chiamati rispettivamente Mansik e Nāsik, e Hāʾwil e Tāʾwīl. La barriera di Yaʾǧūǧ wa Maʾǧūǧ
viene invece posta al centro dello schema. (Ǧāmiʿ al-bayān ʿan tāʾwīl āy al-Qurʾān) Analogamente, tra le narrazioni moraleggianti sui nabiyyūn e sui rusul riportate nella sua deliziosa assemblea delle spose, Abū Isḥaq Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm aṯ-Ṯaʿlabī († 1035) descrive i popoli di Hāwīl e Tāʾwīl, stanziati alle estremità della larghezza della terra, e i popoli di Mansik and Nāsik, alle estremità della lunghezza della terra (ʿArāʾis al-maǧālis fī qiṣaṣ al-anbiyāʾ). Nella storia universale di Sibṭ ibn al-Ǧawzī († 1257), al-Iskandar viaggia in
aẓ-Ẓulumat, la terra delle tenebre, in compagnia dei suoi consiglieri al-Ḫiḍr e Afšaḫīr,
e quando esce dall'oscurità incontra i popoli di Hāwīl e Tāʾwīl (Mirʾāt az-zamān fī taʾrīḫ al-aʿyān). La cosmologia presente nei racconti arabi non è sempre di facile confronto con quanto avevamo trovato nel racconto di Gilgameš: troppi elementi e apporti l'hanno ridisegnata; senza contare che al-Qurʾān, con il suo dettato della «sorgente del sole» [ʿayn aš-šamsi], che sorge e tramonta in una pozza fetida e melmosa, ha un po' – se ci si perdona il bisticcio –
intorbidito le acque. Ma al fine di contestualizzare in un ambito più
ampio il ǧabal al-Qāf e le città di smeraldo, dobbiamo spostarci in Īrān nel tentativo di trovare un po' di... chiarezza cosmologica. | DEMONIO, SOVRANO, FILOSOFO, PROFETA: I VOLTI PERSIANI DI ESKANDAR
La tradizione iranica non aveva molte ragioni per nutrire simpatia nei confronti di Aléxandros, su cui gravava il peso della memoria storica. I persiani non avevano dimenticato che il condottiero macedone aveva invaso l'Īrān, sbaragliato Dārayavauš III Haxāmanišiya (Dario III Codomano, 336-330 a.C.) e causato il crollo dell'impero achemenide. Aleksandar, Sikander o Eskandar era visto come un sovrano malvagio, campione della druǰ. La letteratura medio-persiana lo definisce goǰāstag, «odioso, dannato, maledetto» e lo classifica, con Dahāg/Zaḥḥāk e Frāsiyāk/Afrāsiyāb, tra i nemici storici del popolo iranico e i principali avversari della religione zoroastriana. (Saccone 1997 | Manteghi 2010) L'immagine che gli ambienti medio-persiani avevano di Aléxandros è ben illustrato nell'incipit dell'Ardā
Wīrāz-nāmag, uno dei lontani antenati letterari della Commedia dantesca:
| ēdōn gōwēnd kū ēw-bār ahlaw zardušt dēn ī padīrift andar gēhān rawāg be kard tā bawandagīh [ī] sēsad sāl dēn andar abēzagīh ud mardōm andar abē-gumānīh būd hēnd |
Si narra che, in altri tempi, il santo Zardušt avesse
diffuso in tutto il mondo la religione ricevuta [da Ohrmazd] e
per trecento anni la religione rimase pura e gli uomini conservarono la fede. | | ud pas gizistag gannāg mēnōg [ī] druwand gumān kardan ī mardōmān pad ēn dēn rāy ān gizistag aleksandar ī hrōmāyīg ī muzrāyīg-mānišn wiyābānēnīd ud pad garān sezd ud nibard ud wišēg ō Ērānšahr frēstīd u-š ōy ērān dahibed ōzad ud dar ud xwadāyīh wišuft ud awērān kard | Poi, il maledetto spirito maligno [Ahriman], il dannato, per seminare il dubbio tra gli uomini e far loro perdere la fede, istigò il maledetto Aleksandar, di Hrōm [Bisanzio], che abitava in Meṣr [Egitto], in modo che venisse in Ērānšahr per portarvi l'oppressione, la guerra e la devastazione. Egli uccise i governatori di Ērān e distrusse la
«porta dei re» [la capitale], e tutto rese desolato. | | ud ēn dēn čiyōn hamāg abestāg ud zand [ī] abar gāw pōstīhā ī wirāstag pad āb ī zarr nibištag andar staxr [ī] pābagān pad diz [ī] nibišt nihād ēstād ōy petyārag ī wad-baxt ī ahlomōγ ī druwand ī anāg-kardār aleksandar [ī] hrōmāyīg [ī] muzrāyīg-mānišn abar āwurd ud be sōxt | E la religione, l'Avestā e lo Zand, scritte in lettere d'oro
su pelli di bue, era depositata negli archivi di Staxr-ī-Pābagān; e l'ostilità di colui che era destinato al male [Ahriman], il dannato, il malfattore, fece sì che [questi libri] venissero portati davanti a Aleksandar di Hrōm, che abitava in Meṣr, e vennero bruciati davanti a lui. | | ud čand dastwarān ud dādwarān ud hērbadān ud mowbadān ud dēn-burdārān ud abzārōmandān ud dānāgān ī Ērānšahr rāy be kušt ud mehān ud kadag-xwadāyān ī Ērānšahr ēk abāg did kēn ud an-āštīh ō mayān abgand ud xwad škast [ud] ō dušox dwārist | E [Aleksandar] uccise molti dastwarān, dādwarān, hērbadān e mowbadān e difensori della religione, e tutti gli eruditi e i saggi di Ērānšahr. E mescolando odio e dissidio, mise una con l'altra le nobili casate di Ērānšahr, e annientato
anche lui, si precipitò all'inferno. |
Ardā Wīrāz-nāmag [I: -] |
Questa visione negativa del condottiero traspare in tutta la letteratura medio-persiana (si vedano anche il Denkard e, in misura minore, il Bundahišn). Aleksandar è dunque un personaggio ahrimanico che mette a dura prova l'esistenza stessa del popolo iranico e della sua religione. Gli si imputa la distruzione dei libri sacri dell'Avestā (i quali pare fossero andati distrutti nell'incendio della reggia di Pārša/Persépolis (Ardā
Wīrāz-nāmag [I: -] | Dēnkart [3: ]))
e l'uccisione di magi, sapienti e, in generale, di tutti i depositari della tradizione mazdea (i dastwarān, dādwarān, hērbadān e mowbadān). In seguito gli sarà anche imputata,
sebbene a torto, la distruzione dei templi del fuoco. Nessun compromesso è possibile con Aleksandar,
il goǰāstag. Nei testi medio-persiani non viene mai
nominato come portatore di un ideale universalistico e di una civiltà cosmopolita, bensì soltanto di odî e divisioni. Visti i lumi di luna, e la diffidenza iranica nei confronti del condottiero macedone, è possibile che la buona accoglienza che gli Arabi fecero subito al mito alessandrino, dove Ḏū ʾl-Qarnayn aveva finito per essere annoverato tra i profeti preislāmici, dipendesse da qualche vis polemica durante il periodo in cui l'Islām si trovò a convivere fianco a fianco con le minoranze zoroastriane. Solo con la graduale islāmizzazione dell'Īrān, l'immagine di Eskandar comincia a mutare anche in ambito persiano. Quando, e siamo ormai a cavallo tra il IX e il X secolo, il persiano aṭ-Ṭabarī scrive in arabo il suo Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk, le tradizioni
islāmiche e quelle zoroastriane corrono fianco a fianco nella sua opera, illuminandosi a vicenda. Ma sarà Ferdowsī, nel suo Šāhnāmè, a far giungere a completo sviluppo l'iranizzazione di Eskandar. Poiché Aléxandros era stato l'unico sovrano straniero, dall'Īrān
primordiale all'avvento dell'Islām, ad ascendere al trono d'avorio, nella compilazione del suo poema Ferdowsī si trova di fronte all'urgenza della legittimizzazione di questo re
rūmī, che la non sopita tradizione zoroastriana continuava a indicare come un empio usurpatore. L'identificazione del condottiero macedone con il Ḏū ʾl-Qarnayn qur˒ānico poneva, se non altro, sotto una luce diversa la distruzione dei templi del fuoco e quello dell'Avestā. Ferdowsī opera una censura della storiografia zoroastriana, riscrivendo la realtà storica in nome delle convenienze poetiche e politiche. La tradizione tolomaica dei natali «egiziani» di Alexánder, figlio del faraone Nektanebṓ e della regina Olympiás (Bíos Alexándrou toû Makedónos α, β, γ [I: 1-8]), riappare nella letteratura siriaca e non era ignota agli autori arabi. È citata da al-Bīrūnī nel Kitāb al-ātār al-bāqiya ʿan al-qurūn al-ḫāliya. Tuttavia, accanto a questa versione, ne esisteva un'altra in cui al-Iskandar era di origine persiana. È citata dal solito aṭ-Ṭabarī, secondo cui il condottiero sarebbe stato il figlio illegittimo di Key Bahman, šāhan-šāh d'Īrān,
sebbene cresciuto alla corte di Fīlakūs (Phílippos), re di Rūm (Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk). Ma ancor prima era stata attestata dal geografo, astronomo, matematico, storico e naturalista Abū Ḥanīfa ad-Dīnawarī (828-896), secondo il quale il padre di al-Iskandar sarebbe stato Dārā al-Akbār («Dārā il vecchio», cioè Dārayavauš II, ♔ 424-404 a.C.) (Kitāb al-aḫbār aṭ-ṭiwāl). È possibile che la fonte di questa leggenda fosse il perduto
Xwadāy-nāmag, il «libro dei signori», una cronaca medio-persiana, forse risalente al VI-VII secolo, dove si riportava l'intero ciclo regale iranico, dalle origini mitologiche
all'epoca contemporanea. Non ne conosciamo esattamente il contenuto, ma sappiamo che conservava tradizioni in contrasto con quelle «ufficiali» sacerdotali. È possibile dunque che lo
Xwadāy-nāmag avesse riservato ad Aleksandar un trattamento diverso, in tutto o in parte, da quello dei testi zoroastriani. Si ritiene – pur senza certezze – che questo libro sia stato tradotto in arabo dal mazdeo Rūzbih pūr-i Dādūyè, convertitosi all'Islām con il nome di Abū Muḥammad ʿAbd Allāh Rūzbih ibn Dādūya al-Muqaffaʿ († 756/757). È però probabile che del materiale tratto dallo
Xwadāy-nāmag sia stato adattato in opere storiche arabe (aṭ-Ṭabarī in primis). Dallo
Xwadāy-nāmag attinsero diversi autori persiano-classici per i loro šāhnāmè: Abū ʾl-Mūʾayyad di Balḵ, citato da Balʿamī nel X secolo; un certo Abū ʿAlī, pure di Balḵ, citato da al-Bīrūnī all'inizio dell'XI secolo; e Abū Manṣūr di Ṭūs, governatore del Ḵorāsān, che lavorò su fonti appositamente
raccolte da alcuni sapienti zoroastriani (Bausani 1968). Questi tre šāhnāmè in prosa furono fonti dirette di Daqīqī e Ferdowsī. Abū Manṣūr Muḥammad ibn Aḥmad Daqīqī (935/942-976/980) fu probabilmente il primo
poeta a tentare di scrivere uno šāhnāmè in metrica,
ma non riuscì che a buttar giù un migliaio di versi: morì ucciso da uno schiavo e il suo lavoro fu ereditato a Ferdowsī, che ne incluse i versi nel suo Šāhnāmè. Molti iranisti hanno presunto di poter ricostruire, almeno in parte, il contenuto dello
Xwadāy-nāmag, confrontando gli episodi che Ferdowsī ha in comune con gli storici arabi. Ma tanto Ferdowsī, quanto gli storici arabi, erano musulmani: i racconti forniti dall'uno e dagli altri sono quindi, quanto minimo, oculatamente selezionati e adattati. (Ionescu 2012 | Manteghi Amín 2014)
 | | Lamento di Eskandar alla morte di Dārā (✍ XVII sec.) | | Miniatura da una copia dello Šāhnāmè di epoca ṣafawīyān (1502-1736). |
Anche in Ferdowsī,
Eskandar è di stirpe iranica. Nello Šāhnāmè, Key Dārāb (Dārayavauš II), dopo aver sconfitto Feylqūs (Phílippos), ne sposa la figlia Nāhīd (lezione persiano-classica
del nome della dea Anāhitā/Anāhīd). Poco dopo il matrimonio, però, Dārāb ripudia la ragazza, a causa del suo alito cattivo, e la rispedisce a casa del padre. Ella è incinta e dà alla luce Eskandar.
①▼ Intanto lo šāhan-šāh Dārāb ha, da un'altra moglie, il figlio Dārā (Dārayavauš III, conosciuto alle fonti medio-persiane come Dārā-ī-Dārāyān), che succede al padre a dodici anni di età. Nel frattempo, Eskandar, divenuto re di Rūm, sceglie Arsṭālīs (Aristotélēs) come consigliere. Ma smette di pagare il tributo a Dārā figlio di Dārāb e muove guerra all'Īrān. Dopo essere stato sconfitto in battaglia, Dārā cade in una congiura di palazzo, ucciso dai suoi consiglieri Māhīyār e Ǧānūšīyār. Eskandar arriva troppo tardi: ha appena il tempo di rivelare a Dārā la loro parentela e lo šāhan-šāh spira con la testa sulle ginocchia del fratellastro – scena frequente raffigurata nelle miniature persiane – pregandolo di sposare sua figlia Rowšanak. Eskandar fa innalzare un doḵmè – una «torre del silenzio» – per Dārā, secondo l'uso zoroastriano, poi sposa la principessa e si proclama legittimo šāhan-šāh dell'Īrān, in quanto appartenente alla stirpe dei Keyānīyān. Dopo aver portato a termine la conquista dell'India, Eskandar si reca in Arabia, compiendo una sorta di
ḥaǧǧ alla Makka e completando l'identificazione con Ḏū ʾl-Qarnayn, profeta e coerente assertore della ḥanīfiyya ibrāhīmica. (Saccone 1997 | Manteghi 2010) Al contrario del Ṣaʿb Ḏū Marāṯid sudarabico, l'Eskandar ferdowsiano è un messaggero di pace: utilizza la diplomazia più di quanto non faccia ricorso alle armi. Eskandar non è solo un nabī qurʾānico, ma soprattutto un re-profeta persiano. Se la tradizione zoroastriana lo aveva accusato di aver fatto strage della nobiltà iranica, in Ferdowsī Eskandar spartisce il regno tra i nobili dell'Īrān. L'immagine zoroastriana del re
rūmī, feroce e devastatore, è ormai rovesciata. Anche le famose spedizioni di Eskandar ai confini del mondo sono assai più articolate che non in Qurʾān [XVIII] e nei testi arabi più antichi. L'Eskandar ferdowsiano si muove dapprima a est e, giunto in Andalos, salpa sul mare esterno, dove avvista una montagna che si rivela essere il dorso di un pesce gigantesco. Dopo essere tornato indietro, dopo aver debellato giganti in Abissinia e un drago in Arabia, Eskandar decide di raggiungere l'estremo occidente, il luogo dove il sole tramonta. E qui, dopo essere penetrato nel Ẓolmat, la terra delle tenebre, si affida alla guida di Ḵeżr (trascrizione persiana di al-Ḫiḍr) e va alla ricerca della yanbūʿ al-ḥayāt, la «sorgente della vita». Ma quando arrivano a un bivio, ciascuno segue un sentiero diverso e solo Ḵeżr trova l'acqua che rende immortali: la beve e si dilegua. La sorgente scompare anch'essa e a Eskandar non resta che accettare la propria mortalità. I suoi compagni, che tornano dalle terra delle tenebre recando delle pietre, scoprono al ritorno che queste sono in realtà delle gemme preziose. Eskandar ritorna in Īrān e in seguito erige la celebre barriera contro Yaʾǧūǧ e Maʾǧūǧ. Poco dopo, su una montagna, ha la visione di un morto seduto su un trono: ed è la stessa immagine di
malik Sulaymān deceduto sul suo scranno che si era presentata agli occhi esterrefatti di Bulūqiyā. Difficile dire come questo tema si sia incastonato nel nostro ciclo: qui prefigura forse il destino dello stesso Eskandar, la cui breve ma turbinosa esistenza si avvicina ormai alla fine. Con Ferdowsī, Eskandar è ormai elemento canonico del ciclo regale iranico. Gli scrittori successivi, liberi di approfondire il personaggio, lo iranizzeranno in modi assai più sottili. È il caso del grandissimo Ǧamal ad-Dīn Abū Muḥammad Ilyās ibn Yūsuf Neẓāmī (±1141-±1209). Di etnia probabilmente āzerī (all'epoca di lingua iranica) e di madre curda, Neẓāmī era nato a Ganǧè, nell'attuale Azǝrbaycan, all'ombra delle porte alessandrine di Darbend. Autore di pregevoli ġazal e qaṣīdè,
egli deve la sua fama ai suoi cinque celeberrimi maṯnavi, noti anche come panǧ ganǧ, i «cinque tesori». Nel primo di essi il Maḵzan al-asrār, o «tesoro dei misteri», intreccia nell'eleganza dei suoi apologhi temi filosofici, teologici ed etici; con Ḵosrow o Šīrīn mette in scena una vicenda cavalleresca che ruota attorno all'impossibile passione tra un re sāsānide e una principessa armena; con Leylā o Maǧnūm definisce l'archetipo orientale di tutte le storie d'amore; nelle Haft Peykar, i «Sette ritratti», conduce i suoi lettori nel gioco di specchi erotico-planetario delle sue sette principesse, in una fantasia abbagliante di colori e di sensualità; e infine, nell'Eskandarnāmè, la sua opera più lunga e ideologicamente più complessa, Neẓāmī conduce il condottiero Eskandar da un angolo all'altro del mondo. Neẓāmī afferma, nell'introduzione all'Eskandarnāmè, di essere stato spinto a scrivere la storia del condottiero
rūmī da un colloquio avuto in sogno con lo stesso Ḵeżr, il quale lo aveva spinto a riprendere l'episodio alessandrino di Ferdowsī sottolineando la triplice dimensione di Eskandar: di politico, filosofo e profeta, secondo l'immagine dell'uomo ideale teorizzata da Abū Naṣr Muḥammad al-Fārābī (±872-±950).
Neẓāmī si mantiene neutrale riguardo alla vexata quaestio sui natali di Eskandar. Egli
ricorda la versione iranica della leggenda, dove Eskandar è il figlio di Dārāb, adottato da Feylqūs, ma
riporta anche una versione nuova di zecca, che definisce «greca», dove Eskandar è il figliolo neonato di una donna che muore in mezzo al deserto; passa per caso Feylqūs, re di Rūm, il «miglior sovrano della terra», e lo raccoglie. Dopo aver riportato entrambe le leggende, Neẓāmī aggiunge però che, secondo lui, Eskandar era davvero figlio di Feylqūs. Al poeta di Ganǧè non serve imbastire una parentela con Dārā per fare di Eskandar il legittimo successore al trono
d'avorio. Il ragazzo viene educato dal filosofo Neqūmāḵos (Nikómakhos), padre di Arsṭālīs, mostra grande impegno e desiderio di conoscenza e, alla morte di Feylqūs, gli succede nel regno. Gli abitanti del Meṣr (gli egizi), avendo avuto notizia del suo senso di giustizia, lo chiamano in aiuto contro gli Zangihā (gli abitanti del Zangebār, o «costa dei negri»). Dopo una sanguinosa battaglia, Eskandar ammira il campo costellato dei corpi dei caduti e Neẓāmī effonde un grido incredulo e lucido di fronte all'inevitabile futilità della guerra:
| | Con sguardo edificato [Eskandar] rimirò quegli uccisi, in apparenza ridendo di gioia, ma nascosto piangeva. Perché tante creature, pensava, in lotta feroce bisogna uccidere dunque con spada e con frecce? Se attribuisco a quei morti la colpa, non è cosa giusta, e pur se la prendo con me, sono ancora in errore! | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Šarāfnāmè |
Divenuto re del Meṣr, Eskandar si dichiara libero dall'ingiusto e pesante tributo che Rūm deve all'Īrān. Tuttavia, pur di evitare una guerra, tenta la via della diplomazia e invia a Dārā ricchissimi doni, ma questi rendono lo šāhan-šāh ancora più avido e invidioso. Il confronto armato è inevitabile. Eskandar passa con il suo esercito in Asia e incontra quello persiano in ʿIrāq. Dopo aver tentato invano di dissuadere Dārā dallo scendere in battaglia, Eskandar è costretto ad accettare lo scontro, e grazie alla sua superiore strategia, sbaraglia il nemico. Dārā ripiega ma, come da copione, cade in una congiura, colpito dai suoi stessi generali. Il dialogo tra Eskandar e lo šāhan-šāh morente è uno dei passi più efficaci del poema; Dārā riconosce Eskandar degno del trono d'avorio e lo prega di esaudire tre sue richieste: di succedergli alla guida dell'impero, di punire i suoi assassini e di prendere in sposa sua figlia Rowšanak. Il macedone adempie alle tre condizioni e si ritrova sovrano di un regno sterminato. Neẓāmī è un troppo esperto conoscitore dei più sottili tropi del linguaggio poetico per limitarsi a una intronizzazione semplicemente politica, ed è col semplice ma significativo rendere omaggio al mausoleo di Key Ḵosrow, fondatore della dinastia dei Keyānīyān, che Eskandar viene legittimato šāhan-šāh
dell'Īrān. Poi beve alla proverbiale coppa di Ǧemšīd, nella quale si riflette l'intero universo, e questa è la sua consacrazione a šāh-ǧahāndār, «re del mondo». Infine, per diffondere il monoteismo che ha ereditato dal suo antenato, il nabī Ibrāhīm, distrugge i templi zoroastriani e spegne i fuochi sacri. È solo a questo punto che Eskandar parte per le sue spedizioni attraverso i paesi della terra. Circondato da una corte di sapienti l'Eskandar neẓāmiano esplora i quattro angoli del mondo, ben tenendo l'Īrān al centro del suo compasso, e in tal modo
va incontro al suo destino. Ma Neẓāmī, il brillante poeta di Ganǧè, lo squisito stilista, il miniaturista della penna, il gioielliere della parola, l'autore delle più raffinate e leziose metafore della letteratura persiana, era anche un fine erudito, un difensore della scienza e della filosofia, un razionalista ante-litteram. E l'Eskandarnāmè è sostenuto da una precisa posizione ideologica: in un periodo in cui le autorità religiose contrastavano le posizioni dei filosofi, Neẓāmī difende il libero pensiero contro tutte le derive fondamentaliste. Il suo Eskandar è un personaggio complesso e sfaccettato, e i suoi viaggi rivelano un inesausto desiderio di conoscenza, un confronto con i limiti della propria umanità, un autentico spirito utopistico. È un viaggio etico, prima che epico. Due secoli dopo Neẓāmī, anche il ṣūfī Nūr ad-Dīn ʿAbd ar-Raḥmān Ǧāmī (1414-1492) celebrerà Eskandar quale sovrano illuminato e apostolo della ḥanīfiyya. Ma allo spirito eclettico e «laico» del poeta di Ganǧè corrisponde in Ǧāmī una polemica antifilosofica e una difesa dell'interpretazione religiosa. Nel suo maṯnavi Ḵiradnāmè-i Eskandarī prevalgono gli apologhi morali, conferendo all'opera la funzione di un Fürtenspiegel, un testo didattico per l'ammaestramento dei sovrani. Dopo essersi confrontato con l'esempio di un principe che ha deciso di vivere da eremita, l'Eskandar di Ǧāmī s'incammina sulle onde del mare – come già Bulūqiyā nella fiaba araba – fino a raggiungere il ǧabal
al-Qāf che circonda il mondo. Anche qui un faraštè (un angelo) lo mette al corrente di come invisibili radici o «vene» colleghino al-Qāf a tutte le regioni della terra: “Se l'ira di Allāh è sopra una regione, io la rimuovo attraverso questa vena dal suo posto. In un solo momento, semino il caos e stravolgo le sue fondamenta» (Ḵiradnāmè-i Eskandarī [p. 992, -]).
②▼
 | | Ḵeżr e Ilyās (✍ XVII sec.) | | Miniatura di epoca ṣafawīyān (1502-1736). |
Sia in Neẓāmī che in Ǧāmī la spedizione di Eskandar alla ricerca dell'acqua della vita avanza attraverso Ẓolmat, la terra delle tenebre, e anche qui è Ḵeżr a trovare la fonte della māʾ al-ḥayāt, ed è lui,
e non Eskandar, a bere alla fonte prodigiosa. Neẓāmī aggiunge anche un'altra tradizione, che afferma tramandata dai poeti di Rūm, secondo cui sarebbero stati Ḵeżr e Ilyās a cercare l'acqua della vita. La storia le conosciamo già: essi si fermano a mangiare un pesce, il quale però cade nel ruscello e... Ora, sia
Ilyās che Ḵeżr godono di un'esistenza immortale e sono i protettori dei viandanti, l'uno sulla terraferma e l'altro sul mare. Nella versione di Ǧāmī, come anche nell'Āyena-e Eskandar del ṣūfī indiano Amīr Ḵusrow Dehlavī (1253-1325), tanto Ḵeżr che Ilyās sono compagni di Eskandar nella spedizione alla ricerca della vita. Il terreno su cui ci stiamo muovendo è ben noto. Le affinità tra l'epopea di Gilgameš e
le tradizioni dei viaggi di al-Iskandar/Eskandar sono state analizzate
nei dettagli dagli studiosi. Esiste al riguardo una letteratura
scientifica molto vasta, e non ci resta che rimandare a testi ben più paludati del nostro per eventuali approfondimenti. Giustamente nessuno ha mai preteso di identificare tout-court il condottiero macedone con l'antico lugal sumerico: ma è indubbio che il ricordo dello smagliante Aléxandros abbia attratto su di sé motivi mitici che permeavano la secolare cultura del Medio Oriente. Già le definizioni con cui Gilgameš veniva presentato nell'incipit dello Ša naqba īmuru, «colui che vide le profondità» e «percorse vie lontane», non stonano affatto addosso ad
al-Iskandar/Eskandar. Il livello più superficiale di questo ciclo di narrazioni ci presenta una figura di sovrano che si spinge ai confini del mondo, ai confini dell'umano, cercando un modo per vincere la morte. Ma il senso della spedizione è ancora più profondo. Gilgameš e
al-Iskandar/Eskandar
sono grandi signori sulla terra e soprattutto il macedone ha ultimato la missione di unire sotto di sé tanto l'oriente quanto l'occidente. Gilgameš e
al-Iskandar/Eskandar hanno percorso l'intera ampiezza dello spazio: ora vogliono diventare signori del tempo. Non più limitati dalla morte, desiderano estendere il loro regno nel futuro remoto. Una presunzione che non ha soltanto un aspetto dimensionale: i due sovrani vogliono trascendere la loro natura umana e condividere l'essenza degli dèi. Questo percorso si concretizza nella spedizione oltre i confini del mondo. Lo scopo – lo ricordiamo ancora una volta – è ritornare al giardino meraviglioso da cui l'umanità era stata esiliata all'inizio del tempo. È un luogo situato non solo all'esterno dello spazio, ma anche all'inizio della storia, dove ancora sussiste l'età aurea. È un percorso, quello di Gilgameš, di
al-Iskandar/Eskandar e anche di Bulūqiyā, che li conduce in una terra disabitata oltre, il mare, nel luogo dove il sole sorge o tramonta e il mondo sfuma nell'oceano cosmico. Qui, alla «confluenza dei fiumi», si trova il giardino dove spunta l'albero
della vita, fiorisce la pianta della giovinezza, sgorga la sorgente
dell'immortalità. È il luogo dove Ūtnapištî e al-Ḫiḍr/Ḵeżr incrociano il loro diverso modo di
aver superato la morte: il primo immortale dai tempi del diluvio, il secondo
immortale fino al giorno del giudizio. La leggenda
islāmico-alessandrina vuole anche spiegare come al-Ḫiḍr abbia raggiunto il suo invidiabile status. L'intento crea però grossi problemi di coerenza letteraria. Le ragioni che impediscono a
al-Iskandar/Eskandar di bere alla stessa sorgente a cui ha attinto al-Ḫiḍr appaiono spesso pretestuose. Il destino dei due personaggi segue una predestinazione metaletteraria, se non addirittura teologica. La morale, alla fine, è che a uno viene permesso di
attingere alla sorgente e all'altro no. Inšāʾallāh, e non c'è altro da aggiungere. L'ironia in quest'ineffabile scelta divina è sottolineata da Neẓāmī in un distico divenuto proverbiale: Eskandar, che l'acqua della vita a lungo cercò, non la vide,
ma l'acqua della vita giunse a Ḵeżr che non l'aveva cercata. | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Šarāfnāmè [69: ] |
Ma è ora di cominciare a localizzare il luogo dove si recano Gilgameš e Ḏū ʾl-Qarnayn/Eskandar. Prima di addentrarci nel cuore turbinoso del mito e ritrovare la strada per il giardino meraviglioso, dobbiamo però tirare un respiro lungo e
comprendere la forma del mondo. |
①▲ Lo stesso giorno nasce il cavallo destinato a essere montato da Eskandar, chiamato già in aṭ-Ṭabarī (A)būkefārasb (Bouképhalos). Nelle fonti greche esso ha una macchia a forma testa di toro sulla coscia, ma diviene una testa di leone in Ferdowsī. |
| | |
②▲ Vi è anche un'Eskandarnamè, anonimo, in prosa, databile tra il XII e il XIV secolo, che identifica Eskandar con il Ḏū ʾl-Qarnayn qurʾānico. Il racconto mostra un'evoluzione verso le componenti esotiche e favoloshe e presenta una quantità di episodi secondari non più rapportabili né alla tradizione
islāmica né a quella greca. Qui Eskandar esplora un gran numero di paesi meravigliosi (la terra dell'oro, dei giganti e dei cannibali, il paese delle streghe), è oggetto di intrighi e di avventure erotiche. Vi è nominata ancora la città di Ǧābalqā, governata da un re chiamato Šāhmalik e posta a ridosso del luogo dove sorge il sole. (Saccone 1997 | Wheeler 2002 | Wiesehöfer 2012) |
|
| | L'ĪRĀN IN UN CONTESTO COSMOLOGICO. L'OIKOUMÉNĒ L'Eskandarnāmè, il maṯnavī alessandrino di Neẓāmī, è diviso in due parti ben distinte tra loro: lo
Šarāfnāmè, o «libro dell'onore», e l'Eqbālnāmè, o «libro della fortuna». I due tomi sono
pure chiamati, specie in India, l'Eskandarnāmè-i barrī e l'Eskandarnāmè-i baḥrī, il «libro di
Eskandar sulla terra» e «libro di
Eskandar in mare», vista la netta separazione delle tipologie di viaggio operata da Neẓāmī (Chelkowski 1977). In realtà il nostro autore distingue,
assai più sottilmente, il percorso dell'Eskandar condottiero da quello dell'Eskandar filosofo, e scinde il tema della vana spedizione alla ricerca della māʾ al-ḥayāt, l'«acqua della vita», che frustra le ambizioni del
rūmī di superare i limiti della propria umanità, da quello delle sue esplorazioni dei confini del mondo, che è invece argomento della seconda parte del libro, la quale è anche conosciuta come
Ḵiradnāmè, o «libro della saggezza». Terremo anche noi ben distinti i due percorsi, dimostrando come il viaggio conoscitivo ed esoterico di Eskandar si muova, dallo
Šarāfnāmè all'Eqbālnāmè/Ḵiradnāmè, ampliandosi verso un superiore ordine di grandezza, dall'oikouménē al kósmos, ovvero, da un contesto geografico a uno cosmologico. Vedremo poi – una volta depurati i testi dalle interpretazioni «scientifiche» di Neẓāmī – come essi sottendano a una visione del mondo che attinge tanto alle concezioni avestiche quanto a quelle mesopotamiche. Ma soffermiamoci sullo
Šerāfnāmè. Le imprese di Eskandar, in questo primo tomo dell'Eskandarnāmè, segnano una serie di percorsi nelle quattro direzioni. Il punto di partenza e di arrivo è il regno di Rūm, nome con cui l'Oriente
islāmico conosceva l'impero bizantino, e non poteva essere altrimenti viste le origini storiche di Aléxandros. Gli spostamenti di Eskandar tracciano uno schema a croce che ha il suo centro in Īrān e toccano alternativamente i quattro punti estremi del mondo abitato dagli uomini: - Ovest. Eskandar parte da Rūm, si ferma in Meṣr [Egitto], poi arriva in Īrān, dove sconfigge Dārā.
- Sud. Compie il pellegrinaggio alla Makka, tocca lo Yaman e quindi risale verso il ʿIrāq e torna in Īrān.
- Est. Si reca in Hind e poi in Čīn, per poi ripiegare attraverso il Tūrkestān [la Transoxiana] per tornare in Īrān.
- Nord. Sale a Bardaʿ, nel Caucaso, e combatte contro i Rūs. Poi inizia il suo viaggio verso il settentrione...
Lo
Šerāfnāmè sta ormai volgendo ai suoi ultimi capitoli quando Eskandar tiene udienza nella sua corte e ognuno dei sovrani vassalli vanta dinanzi a lui le attrattive del proprio regno. Per un ultimo parla un misterioso vecchio (nel quale si ravvisa lo stesso Ḵeżr), il quale dice:
| | “Di ogni terra, la migliore è la terra dell'oscurità,
nella quale scorre un'acqua che dà la vita.
Non pesare la tua vita con il peso dei tesori,
ché sui tesori polvere si accumula e su chi li custodisce.
Di rimanere a lungo sulla terra è il tuo desiderio,
e il desiderio può
solo esaudirlo l'acqua della vita. [...]
C'è un velo [di tenebra] sotto la stella polare,
e sotto il velo una sorgente di limpida acqua.
Da questa tenebra, il cui nome è Ẓolmat,
sgorga fluente l'acqua della vita.
Chiunque beva quest'acqua di vita
la sua vita preserva dalla divoratrice del mondo.
Se fede non presti alle mie parole,
chiedi pure a qualche altro vecchio sapiente.” | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Šarāfnāmè [68: - ... -] |
Nelle fonti extrapersiane, e nello stesso Ferdowsī, l'episodio della māʾ al-ḥayāt veniva solitamente posto nel corso della spedizione verso
i confini orientali o occidentali del mondo. La meravigliosa sorgente sgorgava nella terra delle tenebre, e questa, nelle fonti arabe, coincideva con l'ombra impenetrabile del ǧabal
al-Qāf.
Avendo separato i viaggi per «terra» del rūmī da quelli per «mare», o per meglio dire, quelli «geografici» da quelli «cosmologici», Neẓāmī non ha più alcuna ragione di collocare le prodigiose sorgenti
nell'estremo oriente o nell'estremo occidente della terra. Nel tentativo di dare alla mitica Ẓolmat, la terra delle tenebre, una collocazione «scientifica», la localizza
a settentrione, in un nord definito in senso astronomico, «sotto il polo celeste». Eskandar si mette allora in marcia verso nord e, partendo dall'Īrān, attraversa l'immenso deserto della terra dei Bolġār (identificabile con il qanato protobulgaro fiorito tra il VII e il XIII secolo alla confluenza del fiume Kama con il Volga) e prosegue in direzione della stella polare. È un viaggio affascinante, quello con cui ci delizia Neẓāmī, un percorso insieme geografico e astronomico. Sono infatti l'eclittica e l'asse celeste a segnare il progredire del rūmī verso il nord, verso la tenebrosa terra di Ẓolmat:
| | Quando ebbero viaggiato per un mese verso nord
il tracciato del sole aveva mutato la sua posizione.
La sua luce filtrava bassa sotto il polo del cielo:
un chiarore che si accendeva e subito si spegneva.
L'eclittica era calata lungo il cerchio dell'orizzonte,
lo zenith coincideva ormai con il polo celeste.
Giunsero infine in un luogo dove la luce del sole,
come un fantasma in un sogno, era del tutto svanita.
Giunti veloci al confine del mondo,
nella terra delle tenebre innalzarono gli stendardi.
La terra carpiva chiarore dall'aria,
un velo di tenebra si stendeva su Ẓolmat.
Da un lato l'oscurità segnava il confine,
dall'altro un mare profondo chiudeva il cammino.
La sapiente guida li aveva guidati a nord,
nella direzione indicata dalla sfera celeste:
allontanandosi poco a poco dall'eclittica,
la luce si era fatta più remota a ogni passo.
Il percorso li
condusse infine laddove
il sole si era reso del tutto invisibile.
L'oscurità si rivelò [a Eskandar], giunti alla meta.
“Il mondo è sgradevole, quando tutto s'abbuia”. | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Šarāfnāmè [68:
-] |
Nel descrivere l'abbassamento dell'eclittica e l'elevarsi in verticale del polo celeste, Neẓāmī ci sta descrivendo il progredire verso nord sulla superficie di una Terra sferica, in modo coerente con le concezioni astronomiche del suo tempo. La sfericità della Terra, accettata dall'astronomia ellenistica fin dal III secolo avanti Cristo, era ben nota nel mondo
islāmico mille anni più tardi. Quando il ḫalif Abū Ǧaʿfar ʿAbd Allāh al-Maʾmūn (♔ 813-833) aveva chiesto all'astronomo persiano Aḥmad ibn Muḥammad ibn Kaṯīr al-Farġānī di calcolare la circonferenza terrestre, questi gli aveva fornito una stima di 20˙376 miglia arabe, corrispondenti a 40˙248 km (recte: 40˙068 km). Un secolo e mezzo più tardi, lo sviluppo di nuovi metodi trigonometrici aveva permesso ad Abū
ar-Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī (973-1048) di definire la misura del raggio terrestre in 6339,6 km (recte: 6356,7), migliorando la stima di 6314,5 km compiuta da Eratosthénēs nel 230 avanti Cristo. Per meglio illustrare il modello cosmologico degli astronomi
islāmici, che è anche quello di Neẓāmī, ci rifacciamo a una nota che il ṣūfī Šaraf ad-Dīn Dāwūd ibn Maḥmūd ibn Muḥammad al-Qayṣarī († 1350) inserisce nel suo libro dedicato proprio al tema della ricerca dell'acqua della vita, il Taḥqīq māʾ al-ḥayaṱ fī kašf asrār aẓ-ẓulumāt. Ironicamente, gli editori hanno criticato l'inserimento di questa notazione «scientifica» in un testo teosofico, tanto più che contraddice in parte l'interpretazione simbolica del mito (Martini 2012); ma poiché a noi interessa più il substrato mitico che non le posteriori incrostazioni esoteriche, l'annotazione ci va a fagiolo:
| | Nella scienza dei corpi celesti e delle misurazioni, è noto che il globo solare misura centosessantaquattro volte quello terrestre e, se questa è la situazione, di conseguenza più della metà della terra si trova di fronte al sole, e dunque ne è illuminata. Non v'è che un luogo sulla terra al quale la luce non giunga e dove quest'ultima non si diffonda almeno in una certa misura e questo luogo è sotto il polo settentrionale [al-quṭb al-šimālī] Questo è l'asse attorno al quale avviene la rotazione del sole e riceve [una luce] media tra il giorno e la notte. [Al polo] è giorno per sei mesi e notte per sei mesi, poiché per tre mesi il sole si alza finché non raggiunge l'elevazione massima e poi per tre mesi ridiscende e scompare [sotto la linea dell'orizzonte], proseguendo nella discesa per altri tre mesi, fino a ricoprire la distanza equivalente alla precedente, dopo di che torna indietro fino a raggiungere [nuovamente] l'orizzonte. In questi luoghi è difficile trovare degli animali a causa dell'estrema calura durante il giorno e dell'estremo freddo durante la notte. [Invece] la parte di terra situata di fronte al polo meridionale [al-quṭb al-ǧanūbī] è sommersa sotto le acque e le tenebre non sono visibili, così come la tenebra non persiste in tutti i luoghi che si trovano al di sotto del polo settentrionale. | | Al-Qayṣarī: Taḥqīq māʾ al-ḥayaṱ fī kašf asrār aẓ-ẓulumāt [3] |
La cosmografia abbozzata da al-Qayṣarī deriva dalla banale osservazione che la traiettoria diurna del sole non ha sempre la stessa altezza sull'orizzonte. Essa si alza e si abbassa nel corso dell'anno, raggiungendo la massima altezza nel solstizio d'estate e la minima nel solstizio d'inverno. Ma varia anche con la latitudine: andando verso nord, l'eclittica si abbassa e il corso del sole si avvicina all'orizzonte meridionale. Di conseguenza, salendo di latitudine, la durata del giorno e della notte varia sempre di più e, come i nostri geografi
islāmici correttamente deducono, al polo nord il giorno dura sei mesi e la notte sei mesi. Secondo al-Qayṣarī, inoltre, abbassandosi sempre più il sole sull'orizzonte, la regione circumpolare godrebbe di una luminosità «media tra il giorno e la notte». Questo luogo è definito da Neẓāmī «terra semi-illuminata», da cui la bellissima descrizione che fa dell'affievolirsi della luce solare a cui va incontro Eskandar mentre sale verso nord. Ciò che manca ai nostri autori, oltre all'esperienza diretta delle regioni sopra il circolo polare artico, è la cognizione della rotazione della terra e dell'inclinazione dell'asse terrestre. Il problema nasce dall'identificazione della regione polare, dove la notte dura sei mesi, con la mitica terra di Ẓolmat, dove le tenebre sono eterne.
Qualche secolo dopo, l'instancabile viaggiatore maġribino ʾAbū ʿAbd
Allāh Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Lawātī aṭ-Ṭanǧī ibn
Baṭṭūṭa
(1304-1368/1369) localizzerà aẓ-Ẓulumat/Ẓolmat
a quaranta giorni di cammino a nord di Bulġār/Bolġār, e la
descrive come una terra tenebrosa, ghiacciata, nella quale i
mercanti arrivano solo a fatica, a bordo di slitte trainate da cani
(Tuḥfat al-naẓār fī ġarāʾib al-amṣār wa ʿaǧāʾib
al-asfār). Tuttavia, con la sua digressione astronomica,
al-Qayṣarī vuole evidentemente rispondere a una qualche polemica – che forse faceva
capo alle osservazioni dei viaggiatori, come quelle riportate da Ibn
Baṭṭūṭa – dove si cercava di collocare
geograficamente la terra delle tenebre verso il polo
settentrionale, e insieme ribadisce la natura spirituale e metaforica di
aẓ-Ẓulumat/Ẓolmat, che corrisponderebbe – nella sua interpretazione – all'ottenebramento dello spirito e dell'intelletto, non certo a una regione geografica. Ma che dire dell'interpretazione di Neẓāmī? Il poeta di Ganǧè si rende ovviamente conto di questa difficoltà e descrive il trapasso dalla «terra semi-illuminata» alla regione di buio totale con colorite metafore cromatiche, senza però spiegare nei dettagli cosa stia accadendo:
| | Quando cadde la notte, la terra semi-illuminata
cambiò in muschio nero il legno di aloe.
La sfera si confuse come la sabbia calpestata da un folle
e il kašmirī divenne uno zangī [negro].
La strada si fece più sottile di un capello;
e l'oscurità più buia della notte. | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Šarāfnāmè [68: -] |
In precedenza, Neẓāmī aveva descritto il progredire di Eskandar verso il nord con il distico «da un lato l'oscurità segnava il confine / dall'altro un mare profondo chiudeva il cammino» [68: ]. Sebbene alcuni studiosi avessero letto questa allusione al «mare profondo» nel senso di un arrivo di Eskandar sulla sponda del Baḥr al-muḥīṭ, l'oceano onniavvolgente (Clarke 1881), tale interpretazione ha poco senso, visto che il macedone sta avanzando attraverso il cuore dell'Eurasia: il «confine» e il «mare profondo» sono a nostro avviso le masse di oscurità che si addensano ai lati del sentiero. La vecchia guida, che tra poco si scoprirà essere Ḵeżr, sta guidando Eskandar lungo un percorso sempre più tenebroso. Arrivati al confine con Ẓolmat, in cui la luce ha cangiato la sua carnagione, dall'olivastro al nero, e si è fatta «più buia della notte», una massa di oscurità preme addosso a Eskandar, ed è talmente densa che il sentiero appare più sottile di un capello. A questa strana via, tuttavia, Neẓāmī aveva accennato in precedenza, in un inciso piuttosto interessante: «vicino a Ẓolmat c'è una montagna alla quale mena una strada sottile come un capello» [63: ]. La presenza di questa montagna comincia a delineare le ragioni dell'oscurità. Sebbene Neẓāmī non la chiami mai con il nome del ǧabal
al-Qāf, è evidente che il mitema è analogo. Eskandar
si sta recando verso una sorta di montagna polare, talmente immensa
da cancellare del tutto la luce del sole... o quel poco che ne
arriva in latitudini tanto estreme. E come il ǧabal
al-Qāf sostiene il cielo, anche questa montagna funge da axis mundi: è il perno intorno al quale rotea tutto il firmamento, quello che gli astronomi persiani chiamano, con affascinante ellenismo, falak al-Aṭlas, il «cielo di Átlas». La montagna coincide con «l'asse attorno al quale avviene la rotazione del sole» a cui aveva accennato Al-Qayṣarī (Taḥqīq māʾ al-ḥayaṱ fī kašf asrār aẓ-ẓulumāt [3]). Il luogo viene descritto da Neẓāmī in termini di concavità: sembra una sorta di «grotta» quella in cui il manipolo di Eskandar sta accedendo, anche se forse l'immagine è solo dovuta al fatto che la montagna è talmente
grande da occupare l'intera volta celeste, apparendo essa stessa come una cupola. E il sentiero sottile come un capello ricorda il ponte escatologico Ṣirāṭ che nello yawm ad-dīn i risorti dovranno solcare per arrivare all'altro mondo. Per il beato, il ponte è una strada ampia e comoda che lo mena al delizioso giardino di Ǧannaṱ;
ma sotto i passi del dannato, il ponte si assottiglia fino a farsi
sottile come un crine, facendogli perdere l'equilibrio e facendolo
precipitare tra le fiamme del Ǧahannam. Ma teniamo d'occhio questo ponte, come il monte-asse a cui è collegato: l'uno e l'altro ci daranno altre informazioni preziose. Arrivati sul confine della tenebrosa terra di Ẓolmat, Eskandar si chiede come faranno a ritrovare la strada del ritorno. Ḵeżr gli propone un metodo infallibile, per quanto crudele: entrare in Ẓolmat con una cavalla che abbia da poco figliato e uccidere il suo puledro sul limitare delle tenebre: l'amore materno farà infallibilmente ritrovare la strada del ritorno all'animale. Eskandar entra così nel buio «celandosi come la luna nelle fauci del drago»
(Eskandarnāmè > Šarāfnāmè [69: ]). “D'ora in poi sei tu il nostro capo, nessuno è sopra di te” dice Eskandar a Ḵeżr. Gli raccomanda di procedere per primo, facendosi luce con lo splendore di una speciale gemma. “E quando troverai l'acqua della vita, bevi. Poi mi condurrai alla sorgente, e io ti ricompenserò.” E Ḵeżr, «colui che verdeggiando avanza», si muove dinanzi al drappello, tenendo davanti a sé la gemma. La marcia nel Ẓolmat dura quaranta giorni. Poi, Ḵeżr vede una sorgente sgorgare dalla roccia. La scena esce dalla penna di Neẓāmī, vivace e suggestiva:
| | La sorgente si profilò d'argento,
argento
liquido che sgorgava dal cuore della roccia.
Non una semplice sorgente... che parola lontana dal suo senso!
era una sorgente di luce, certo non d'acqua.
Era forse come la stella del mattino?
come la stella del mattino era la sorgente.
Era forse come la luna piena nella notte?
come la luna piena e ancora più brillante.
E il suo flusso non certo facile da cogliere:
era come mercurio nella mano di un vecchio paralitico.
Descrivere la sua purissima natura, io non saprei,
non trovo paragoni, né forme di confronto.
Quel fulgore non brilla certo in ogni gemma:
la potremmo chiamare tanto acqua quanto sole. | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Šarāfnāmè [69: -] |
Ḵeżr beve alla sorgente e subito si sente trapassare alla vita immortale. È davvero la māʾ al-ḥayāt, quella che ha trovato, l'«acqua della vita». Il vecchio ne dà da bere al suo cavallo, poi si volta per avvertire Eskandar, ma la sorgente scompare. Il vecchio riconosce da quel segno che Allāh nega al re l'immortalità, dopo averla invece concessa a lui. Ed è per questo, non certo per timore di una punizione, che decide di non far più ritorno al suo cospetto. Un
farastè compare quindi dinanzi a Eskandar e lo invita a tornare indietro. “Del
mondo tutto intero ti sei impadronito e la tua mente non è ancora sazia di vane fantasie?”
[69: ], lo investe l'angelo, e aggiunge: Eskandar, che l'acqua della vita a lungo cercò, non la vide,
ma l'acqua della vita giunse a Ḵeżr che non l'aveva cercata. | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Šarāfnāmè [69: ] |
Nelle rappresentazioni geografiche persiane, ai tempi di Neẓāmī, s'intersecavano due diverse immagini del mondo. Alcuni geografi seguivano la concezione ellenistico-tolemaica trasmessa dai geografi arabi – presente nel Kitāb nuzhat al-muštāq fī iḵtirāq al-āfāq, «Il sollazzo per chi si diletta a girare il mondo» (✍ 1153), del berbero Muḥammad al-Idrīsī (1099-1165) –, secondo la quale la terra abitata andava suddivisa in sette fasce climatiche, parallele tra loro, chiamate in greco klíma, «inclinazione» (da
intendersi l'inclinazione apparente del cielo con il progredire della latitudine), parola passata in arabo nella forma aqlīm, persiano eqlīm. Nel seguente mappamondo sferico, costruito secondo le concezioni geografiche
islāmico-persiane, evidenziamo i sette «climi». Ẓolmat
va da identificarsi con il polo settentrionale: 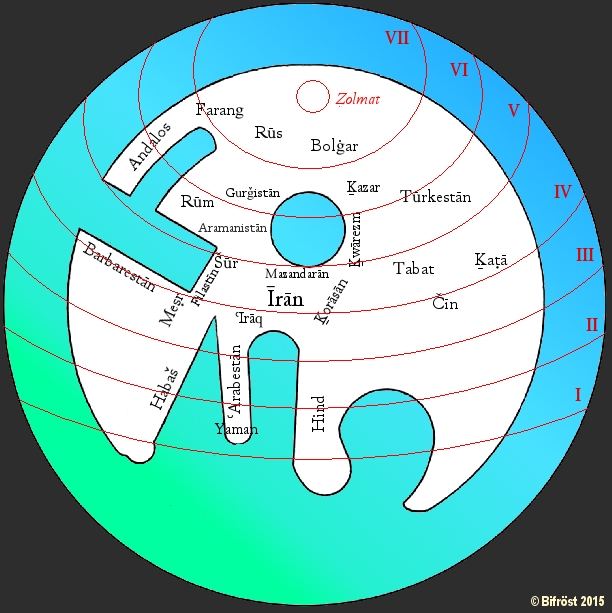
Il greco ha una bella parola,
assai compatta, per indicare l'insieme delle terre abitate dall'uomo: oikouménē. Il lettore non si dispiacerà se, da qui in poi, la utilizzeremo come «termine tecnico», in contrasto con kósmos, con il quale indichiamo la terra nella sua struttura cosmologica. L'oikouménē è una piccola parte del kósmos. In persiano classico, la terra abitata dall'uomo (oikouménē) veniva definita
Ḵonīras (a volte, nella formula Ḵonīras-e bāmi, la «splendida Ḵonīras»). Questo termine risale ai primordi della civiltà iranica: deriva infatti dal medio persiano Xwanirah, a sua volta dall'avestico aniraθa. Nelle fonte più tarde, Ḵonīras appare divisa a sua volta in sette «regioni», dette kešwar in persiano medio e classico (a loro volta da un avestico karvąr, cfr. karš- «arare, tracciare i confini»). Al centro di Ḵonīras si collocava
Ērānšahr (dall'antico persiano *Aryānām Xšaθra), o
Ērān, la terra degli Irani
(avestico Airya-, medio persiano Ēr-). Intorno ad
Ērānšahr, i sei kešwarān nei quali l'etno-geografia
iranica ripartiva il resto del mondo abitato (anērān,
«non-iranico»). Il aniraθa/Xwanirah/Ḵonīras era a sua volta circondato dall'oceano onniavvolgente, chiamato in
medio persiano Warkaš o
Fraxwkard (avestico Vourukaa); solo nel periodo classico entrerà nel lessico l'arabismo Baḥr-i-moḥīṭ. Nonostante l'antichità della struttura e della sua terminologia, la divisione dello Xwanirah/Ḵonīras in sette kešwarān compare solo nelle speculazioni medio-persiane, che i cosmografi d'epoca sāsānide
avevano rielaborato a partire dalle antiche cosmologie mazdee. Esse traevano la loro autorità dall'etnogenesi stabilita negli equivalenti iranici delle «tavole delle nazioni». Ecco ad esempio,
la redazione minore o «indiana» del Bundahišn (±VIII-IX sec.), dove si narra della moltiplicazione del genere umano dai comuni progenitori Mašya e Mašyānē, della distinzione dei popoli e della loro migrazione nelle sedi storiche:
| u-šān haft ǰuxt aziš būd hēnd nar [ud] mādag. hamāg brād ud xwah nar [ud] zan būd hēnd. u-šān har ē pad panǰāh sāl frazand azist zād hēnd, ud xwad pad sad sālag be murd hēnd. az ān haft ǰuxt ek siyāmak nām [ī] mard ud zan wašāg. u-šān ǰuxt-ē aziš zād, kē mard frawāg ud zan frawagēn nām būd hēnd. az awēšān panzdah ǰuxt zād hēnd kē har ǰuxt-ē sardag-ē būd hēnd. u-šān purr-rawišnīh paywand [ī] gēhān aziš būd. | E da quelli [Mašya e Mašyānē] nacquero sette coppie, maschio e femmina, ciascuna di un composta fratello e di una sorella-sposa, e ciascuna coppia, a cinquanta anni, ebbe dei figli, e a cento anni morì. Di queste sette coppie, Siyāmag era il nome dell'uomo e Wašāg quello della donna, e da essi nacque un'altra coppia, i cui nomi erano Frawāg l'uomo e Frawagēn la donna. Da essi nacquero quindici coppie, da ognuna delle quali discese una stirpe [sardag]; e da costoro, con il perpetuarsi delle generazioni, il mondo venne popolato. | | az har pānzdah sardag īšān nō sardag pad pušt ī gāw ī srisōg, pad ān ī frāxwkard zrēh, ō ān šaš kišwar dudīgar widārd, ud ānōh būd hēnd. ud šaš sardag mardōm pad xwanirah mānd hēnd. az ān šaš sardag ǰuxt-ē mard tāz ud zan tāzag nām būd hēnd, ud [pad] dast ī tāzīgān šud hēnd. ud ǰuxt-ē hōšang mard ud zan gūzag nām, u-šān ērānagān az awēšān būd hēnd. ud ǰuxt-ē māzandarān aziš būd hēnd, pad āmār, ān ī pad ērān dēhān. ān ī pad anēr deh: ān ī pad tūr dēhān, ān ī pad salm deh, ast ī hrōm. ān ī pad sind deh, ān ī pad čīnestān, ān ī pad gāy deh, ān-iz pad šaš kišwar, hamāg az paywand frawāg ud siyāmak ud mašī hēnd. | Mentre si moltiplicavano le quindici stirpi, nove di esse si spostarono sul dorso del bue Srisōg, attraversarono [l'oceano] Frāxwkard, si spostarono sugli altri sei kešwarān e si stabilirono lì. Le rimanenti sei stirpi umane rimasero in Xwanirah. Tra queste sei stirpi, il nome dell'uomo di una coppia era Tāz, quello della donna Tāzag ed essi andarono nella terra dei Tāzīgān [gli Arabi]. Il nome dell'uomo di [un'altra] coppia era Hōšang e quello della donna Gūzag, e da loro discendono gli Ērānagān [gli Irani]. Da un'altra coppia discendono i Māzandarān. Questo il novero di coloro che erano nella terra di Ērān. E questi coloro che erano nelle terre anērān: quanti erano nel paese di Tūr, quanti erano nel paese di Salm, cioè Hrōm, quanti erano nel paese di Sind, quanti erano nel Čīnestān, quanti erano nel paese di Gāy. Tutti coloro che abitano nei sette kešwarān sono tutti della stirpe di Frawāg, figlio di Siyāmag, figlio di Mašya. | Zand-āgāhīh Bundahišn [15: -] |
Questo testo applica due divisioni: la prima, tra coloro che rimasero in Xwanirah e coloro che attraversarono l'oceano Frāxwkard. Questi ultimi sono gli antenati dei mitici popoli proiettati ai confini cosmologici del mondo. La seconda divisione, riguarda coloro che erano rimasti in Xwanirah, i quali daranno origine alle nazioni della
terra: Ērānagān (Irani), Tāzīgān (Arabi) e Māzandarān (abitanti del Ṭabarestān) sono – secondo il Bundahišn – i tre popoli che abitano in Ērānšahr; i popoli
anērān («non-iranici») sono invece: Turān/Turkān (turchici), Hrōmāyīgān (greci), Hindūgān o Sindīgān (indiani), Čīnegān (cinesi) e Gāyīgān (ebrei). In epoca medio-persiana e, soprattutto, persiano-classica, i geografi daranno dettagliate ripartizioni dei regni e dei popoli del mondo nei sette kešwarān. Non è necessario entrare nei dettagli, tanto più che gli autori sono raramente d'accordo con loro. Lo stesso Neẓāmī definisce un sistema di sette kešwarān o eqlīm (egli usa i due termini come sinonimi) nel suo maṯnavī Haft peykar, dove ciascuna delle sette affascinanti spose del re Bahrām Gūr è originaria di un diverso «continente», e questi sono: (I) Hindūstān, (II) Rūm, (III) Ḵārezm, (IV) Ṣaqlāb («Slavonia»), (V) Barbaristān, (VI) Čīn e (VII) Īrān. Il dizionario Burhān-i Qāṭiʿ dà invece un novero appena diverso: (I) Hindūstān, (II) Čīn e Ḵaṭā, (III) Tūrkistān, (IV) ʿIrāq e Ḵorāsān (e quindi l'Īrān), (V) Ḵwārezm, (VI) Rūm, (VII) Ẓolmat. Il poeta-geografo Ḥamdallāh Mustawfī Qazwīnī (1281–1349), nel suo Nozhat al-qolub, tira le fila dell'argomento e, prima di fornirci un resoconto dettagliato di tutto il mondo a lui conosciuto, regione per regione, eqlīm per eqlīm, ci fornisce un rapido sunto etnogeografico, che è quanto ci basta in questa sede: | | La terra è divisa in sette kešwarān, a forma di sette cerchi, uno al centro e gli altri sei che lo circondano separatamente. Il primo di questi, a sud, è
il Sind [India]; il secondo comprende i Tāzīgān
[Arabi], con Yaman e Habaš [Abissinia]; il terzo Šūr, Meṣr e
Barbarestān [Siria, Egitto e Maġrib]; il quarto, che è il kešwar centrale, è l'Īrānistān; il quinto è il kešwar
di Rūmiyān, Farangān e Rūsiyān
[Greci, Franchi e Russi]; il sesto comprende Turkān
e Ḵazarān [Turchici e Xazari], mentre il settimo è il kešwar di Čīn, Ḵaṭā e
Tabat [Cina, Kotan e Tibet]. | | Ḥamd-Allāh Mustawfī Qazwīnī: Nozhat al-qolub [3, 1] |
Possiamo trarre un diagramma da tali informazioni, integrandole con i dati forniti da al-Bīrūnī: 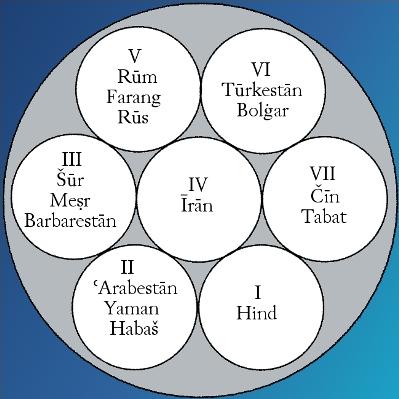
- Sud-est. Hind o Sind (Hindūstān), «India».
- Sud-ovest. ʿArabestān (< Arwāstān), «Arabia» | Yaman | Habaš (Habašistān), «Abissinia, Etiopia».
- Ovest. Šūr/Ašūr (Šūrestān/Ašūrestān), «Siria/Assiria» | Meṣr, «Egitto» | Barbarestān, «Barberia, Maġrib».
- Centro. Īrān
- Nord-ovest. Rūm (o Yūnān), «Bisanzio/Grecia» | Farang (Farangestān), «[terra dei] Franchi» | Rūs o Ṣaqlāb, «Russi/Slavi».
- Nord-est. Tūr(k)estān, «terra dei popoli turchici» | Bolġar (Bolġarestān), «Balğarestan» o «[terra dei] Bulgari del Volga» | Ḵazar, «Xazari».
- Est. Čīn (Čīnestān), «Cina» | Tabat, «Tibet».
Possiamo ora tracciare una mappa dell'itinerario di Eskandar alla ricerca della sorgente della māʾ al-ḥayāt, secondo lo Šarāfnāmè di Neẓāmī. Varcato il mar Caspio, Eskandar si muove in direzione nord, lungo la linea di separazione tra i kešwarān V e VI. Superata la terra dei Bolġar egli procede verso settentrione, attraverso il disco di Ḵonīras. La mappa che riportiamo qui sotto, disegnata estrapolando la topografia medio-persiana all'alba della cultura
islāmica, non è in proiezione, essendo costruita su una rappresentazione «piatta» del mondo. I kešwarān esterni, solitamente immaginati di forma circolare, sono qui definiti – con un po' di arbitrio da parte nostra – da linee equidistanti poste a 60° l'una dall'altra. Per capire come Neẓāmī possa riuscire a identificare Ẓolmat con il polo nord, collocando questo punto sulla perpendicolare dell'asse terrestre, sotto la stella polare, dobbiamo sovrapporvi la tavola precedente. Dall'insieme delle due concezioni scaturisce la cosmografia neẓāmiana. 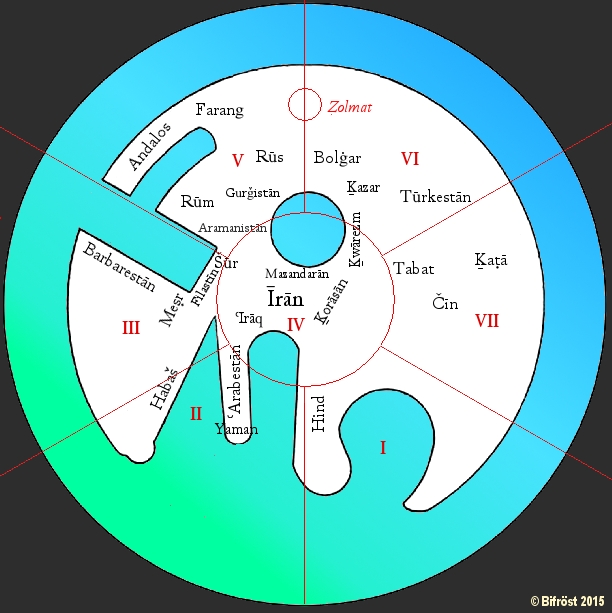
| L'ĪRĀN IN UN CONTESTO COSMOLOGICO. IL KÓSMOS Se lo
Šarāfnāmè narra le spedizioni di Eskandar attraverso l'intera estensione del mondo abitato dagli uomini (Ḵonīras), nel secondo libro del suo maṯnavī alessandrino, l'Eqbālnāmè, Neẓāmī amplia la visuale, sale di un ordine di grandezza, e invia il suo eroe ben oltre
i limiti del mondo abitato. Si passa così dall'oikouménē al kósmos. Dopo aver fallito nella propria ricerca dell'acqua della vita, ridimensionato nel proprio orgoglio, Eskandar è tornato in Rūm e i sette maggiori filosofi affollano la sua corte, e cioè, anacronisticamente: Arsṭālīs, Wālīs, Balīnās, Soqrāṭ, Farfūrīyūs, Hermes e Aflāṭūn (Aristotélēs, Thalḗs?, Apollṓnios Tyaneús, Sōkrátēs, Porphýrios, Herms Trismégistos e Plátōn), che è chiamato «maestro di tutti». Sono fiumi di sapienza quelli a cui il grande rūmī ora si disseta. Dopo una lunga parte normativa, Eskandar decide di partire per la sua missione profetica e si mette in cammino da Rūm, diretto verso occidente. Attraversa il Meṣr, il Maġrib e giunge in Andalos. Eskandar si trova così dinanzi alla distesa oceanica. Decide di mettersi in mare e passare oltre. È un brano davvero sorprendente quello che Neẓāmī ci propone: | | Per tre mesi, [Eskandar] navigò con i suoi per il mare, da esso soltanto traendo i viveri, e la prua tenendo sempre volta là dove il sole tramontava. Molte isole scoprì interamente spopolate, sbarcandovi per esplorarle palmo a palmo. Molte creature gli si fecero incontro, vuoi umane, vuoi di altre specie, ma nessuna si mescolò con i suoi, anzi, subito fuggivano da un monte all'altro a gambe levate. Finalmente, dopo un lungo navigare, il declivio di una terra riapparve all'orizzonte. Era un nuovo deserto, dalla sabbia straordinariamente luminosa, che non era fatto d'altro che d'argilla gialla... | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Eqbālnāmè |
Ma dov'è arrivato Eskandar? Il testo non sembra lasciare dubbi. Partito dalla costa ispanica, diretto verso occidente, si direbbe abbia scoperto un altro continente! Ma prima di pensare ad Eskandar inopinato precursore di Colombo – come hanno avanzato alcuni ingenui interpreti – dobbiamo imporci prudenza e ricordare a noi stessi che non siamo mai usciti dalla scenografia dei miti. Anche Gilgameš, dopo aver traversato il «mare» [tâmtu] e le «acque della morte» [mê mūti], era giunto nel Pû-nārāti, alla «bocca dei fiumi», nella lontana terra dove abitava Ūtnapištî. Ciò che stiamo inseguendo sembra essere appunto il mito di una terra posta oltre l'oceano. Una volta sbarcato in questa «America» ante-litteram, Eskandar si mette in marcia con i suoi uomini attraverso il deserto. La sabbia, che sembra fatta di zolfo, emette fiamme e scintille sotto gli zoccoli dei cavalli. Dopo aver galoppato per un mese su quella distesa abbagliante, davanti al rūmī si profila una nuova distesa marina. Scrive Neẓāmī: | | Dinanzi a quella profonda distesa d'acqua, che i Greci chiamano Baḥr-i-Oqiyānūs, Eskandar rimase sbalordito: essa circondava il mondo intero sollevando ondate spaventose sicché, chiaramente, non era dato a nessuno di poter proseguire oltre. Qui, in questo mare profondissimo, il tramonto del sole all'orizzonte non pareva più nascosto a nessuno, ché se pur un magico velo ricopriva quella distesa, esso non nascondeva però agli occhi umani il luccichio del sole che vi affondava. Ebbene il cielo, al volgere d'ogni giorno, precipitava il globo di luce nella sua sorgente marina, lontano dai nostri occhi; e noi uomini, in effetti, al tramonto del sole, abbiamo appena un indizio di questa sorgente e di quell'immenso mare. | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Eqbālnāmè |
Il tema della «sorgente del sole» [ʿayn aš-šamsī], dove l'astro si tuffa al tramonto, ha la sua autorità nel Qur˒ān, dove già abbiamo letto riguardo a Ḏū ʾl-Qarnayn: «E quando giunse all'[estremo] occidente, vide il sole che tramontava in una sorgente ribollente» [Ḥattá iḏā balaġa maġriba aš-šamsi waǧadahā taġrubu fī ʿaynin ḥamiʾatin] (al-Qur˒ān [XVIII: ]). Ma pare che il tema sia di origine preislāmica, se possiamo fidarci della citazione che Muḥammad ibn Isḥāq attribuisce ad Abū Karib Asʿad: «[Ḏū ʾl-Qarnayn] vide dove il sole affondare sotto gli occhi in una pozza di fango e di fetida melma» (Sīrat rasūl Allāh). È anche il «mare fetido» [yamā saryā] del siriaco Neṣḥānā d-leh d-ʾAleksandrōs. Ma il dettaglio curioso è che Neẓāmī definisce questo nuovo
mare, che si spalanca davanti agli occhi di Eskandar,
baḥr-i-oqiyānūs, il «mare Ōkeanós». L'uso di questo termine di origine greca doveva creare un'impressione di maggior lontananza e antichità rispetto agli equivalenti arabo-iranici che Neẓāmī aveva a disposizione. L'autore distingue
così due regioni oceaniche concentriche. Un primo mare, il più interno, circonda Ḵonīras, la terra degli uomini: e questo è l'oceano terrestre; un secondo mare, posto al di là delle isole e dei continenti esterni, è l'oceano cosmico tout-court. Se il mare interno lo aveva definito semplicemente baḥr, per il mare esterno Neẓāmī utilizza il forestierismo, l'ellenismo, il
baḥr-i-oqiyānūs. L'inesausto Eskandar vorrebbe mettersi in mare ancora una volta, attraversare anche questo
baḥr-i-oqiyānūs e andare a scoprire il mistero della «sorgente del sole». I suoi sapienti lo sconsigliano: l'acqua è densa come il mercurio, le onde sono possenti e le correnti tremende: nessuna nave riuscirebbe a navigare su quell'oceano insidioso. Vi è inoltre un mostro marino (memoria del Gaṇdǝrǝβa- avestico? (Yašt [V: 38])) che sale dai neri pozzi dell'abisso e non lascia scampo. Ma il più tremendo pericolo, spiegano a Eskandar, viene dalle innumerevoli pietre, scintillanti di colori vivi e accesi, che ricoprono il litorale. È così incontenibile il piacere che si sprigiona alla loro semplice vista, che solo a guardarle si muore di gioia. E concludono i sapienti: “Perciò i piloti, accusandolo di sottrarre la vita ai naviganti, chiamano questo mare baḥr-i-mard, la «distesa della morte»”. Ed eccoci di nuovo alle mê mūti, le «acque della morte», di
babilonica memoria. A fatica distolto dalla sua intenzione di avventurarsi sul
baḥr-i-oqiyānūs, Eskandar si mette in cammino attraverso il deserto. Il seguito non fa che testimoniare l'interesse per il favoloso e l'esotico che animava gli scrittori arabi e persiani alla fine dell'epoca selçukide. Una volta
che Eskandar è tornato dall'occidente, Neẓāmī, simmetricamente, gli fa esplorare il mondo anche a sud, a est e a nord, intrecciando l'inesausto piacere dell'affabulazione agli apologhi filosofici e morali. Egli risale il Nilo fino alle sue sorgenti, arriva a una montagna che chiunque scali scompare nel nulla, incontra popoli semiumani corrono veloci come fiere e si cibano del sangue di draghi caduti dal cielo. Più tardi arriva alla favolosa città di Iram, e si riposa nei suoi giardini, in cui l'antico re Šaddād aveva piantato alberi d'oro, dai frutti d'ambra, di perle e rubino, «e da ogni parte pendevano mele e melagrane, né si capiva se fossero melagrane simili a rubini o viceversa!». Più tardi, Eskandar arriva in un villaggio di adoratori di teschi dalle usanze raccapriccianti, attraversa un sentiero di pietre aguzze che spezzano i ferri dei cavalli, varca un torrente pieno di diamanti sorvegliati da serpenti, e giunge in una terra dai campi fertili ma perennemente abbandonata perché i suoi abitanti non riescono ad accordarsi sulla spartizione dei raccolti...
(Eskandarnāmè > Eqbālnāmè). Ma non dobbiamo troppo indugiare su questo materiale o rischiamo di essere attirati assai lontano dal nostro argomento. Al poeta di Gānǧè non interessa seguire il percorso su una carta geografica e non è chiaro se, tra una spedizione e l'altra, Eskandar ritorni ogni volta alla base (in Rūm o in Īrān) prima di ripartire per un nuovo viaggio, o se il suo sia un unico, vastissimo periplo. Nessuno dei paesi visitati da Eskandar può essere ricondotto con certezza a una geografia reale, con l'eccezione del viaggio a oriente, in cui riconosciamo l'Afġanistān e il Čīnestān: poi Eskandar salpa di nuovo per mare, questa volta in direzione dell'alba, e torniamo di nuovo in un contesto cosmologico: | | Quindi si staccò dal litorale, prese il largo spingendo la nave sul mare infinito e su quelle acque salmastre attraversò un mondo nuovo dopo l'altro, mentre la sorte intanto gli mandava incontro prove tremende. Infatti, dopo un po' che le navi scivolavano placide sull'onda, ecco si produsse un gigantesco tifone a sconvolgere il mare e le correnti d'acqua cominciarono a spingere in direzione del Baḥr-i-moḥīṭ. [...]. D'un tratto, un'isola di lontano apparve ai loro occhi, qualcosa che luccicava come un punto di luce, e lì riuscirono ad approdare trovando un po' di tregua, ancora intimoriti dal tifone oceanico. A quel punto, uno dei marinai anziani così parlò all'esperto sovrano: “Quest'isola è una stazione pericolosa e, secondo le carte nautiche, è comunque l'ultimo approdo possibile. Non essere temerario o re, ché le correnti di queste profonde acque spingono inesorabilmente al largo verso il Baḥr-i-moḥīṭ! Se andremo anche solo un po' oltre in quella direzione, sii certo che non troveremo più altri approdi”. | | Neẓāmī: Eskandarnāmè > Eqbālnāmè |
Mentre a occidente, il mare esterno veniva chiamato
baḥr-i-oqiyānūs, a oriente ricompare il termine di origine araba baḥr-i-moḥīṭ. Eskandar vorrebbe varcare anche
questo nuovo mare esterno ma viene bloccato dal giudizio dei suoi sapienti e dei suoi marinai. La distinzione tra i due idronimi è però artificiosa, un guizzo di erudizione gocciolato dalla penna di Neẓāmī: sia il baḥr-i-moḥīṭ sia il
baḥr-i-oqiyānūs sono nomi che si riferiscono allo stesso oceano onniavvolgente che la cosmografia tradizionale iranica chiamava Warkaš. Ma torniamo alla nave di Eskandar, risucchiata – come quella di Odysseús – da un gigantesco vortice marino. Dopo essere sfuggita per un pelo alla distruzione, la nave torna indietro e approda in una terra che Neẓāmī afferma essere il Čīnestān. Ma è una «Cina» sospinta in un oriente cosmologico, dove si ode, ogni mattina, il cupo rimbombo del sole che, sorgendo, sfonda la superficie del mare, terrorizzando ogni anima viva. Le avventure di Eskandar sono però quasi giunte alla fine: muovendo per via terra in qualche vaga direzione nord-occidentale, arriva alla fine in una landa utopica, serena, in una sorta di Shangri-la i cui abitanti coniugano la saggezza alla virtù. Eskandar innalza la grande barriera in un passo tra i monti per proteggere questi gentili valligiani dal feroce popolo di Māʾǧūǧ e si capisce che Neẓāmī riporta
il famoso episodio del sadd al-Iskandar per dovere di buon musulmano. Il rūmī è ormai ricco di sapienza e di virtù, ma la sua vita è quasi giunta alla fine. Dopo Eskandar muoiono, uno dopo l'altro, i sette filosofi, e alla fine lo stesso Neẓāmī mette in scena la propria morte, congedandosi cerimoniosamente dai suoi lettori: «...il sonno lo rapì e, avresti detto, fu come se mai fosse stato desto» (Eskandarnāmè > Eqbālnāmè). I critici hanno puntualizzato che al rigore geografico-astronomico dello
Šarāfnāmè si contrappone, nell'Eqbālnāmè, una fantasia più sbrigliata. Non si può negare che in questo secondo tomo Neẓāmī lasci prevalere il senso del meraviglioso. Nondimeno rimangono molti spunti interessanti, soprattutto in questa strana presenza di «continenti» transoceanici, i quali peraltro costringono Neẓāmī a distinguere tra un mare interno, «terrestre», e un oceano esterno, «cosmico». Il baḥr guarda verso la terra ed è ancora navigabile dagli esseri umani; il
baḥr-i-oqiyānūs e il baḥr-i-moḥīṭ appartengono invece a un contesto
cosmologico: il sole vi si tuffa nel tramonto e vi emerge dall'alba, e sono del tutto impenetrabili alle navi costruite dall'uomo. Ma una volta lasciata l'infantile ipotesi «americana» ai talk-show, possiamo chiederci: a quali terre, isole e continenti si riferisce Neẓāmī? Tutto questo è il parto di una sua fantasia, o corrisponde a una tradizione esistente? La spiaggia ricoperta da pietre preziose che si staglia davanti alle sorgenti del sole rimanda, mutatis mutandis, a un motivo che troviamo attestato fin dallo pseudo Kallisthénēs: le pietre che gli uomini al seguito di Aléxandros hanno raccolto nella terra delle tenebre si rivela trattarsi di gemme. Gli alberi d'oro carichi di frutti simili a pietre preziose che Eskandar trova nei giardini di Iram corrispondono ovviamente agli iṣû ilī, gli «alberi degli dèi», carichi di pietre preziose, che Gilgameš ammira una volta emerso dagli oscuri interstizi del monte Māšu (Ša naqba īmuru [IX: ]). Il baḥr-i-mard, la «distesa della morte», è un evidente memoria delle mê mūti, le «acque della morte» dell'epopea ninivita (sebbene Gilgameš
osi attraversarle ed Eskandar no). Vi riconosciamo incagliati motivi più antichi e sembra senz'altro ragionevole che i «continenti» transoceanici scoperti da Eskandar siano dei lontani parenti mito-geografici di Dilmun e del Pû-nārāti. Ma è davvero così? Per rispondere dobbiamo contestualizzare storicamente la divisione del Ḵonīras in sette kešwārān/eqālīm, a cui abbiamo accennato parlando dei viaggi narrati nello Šarāfnāmè. Questa rappresentazione dell'oikouménē eptapartito sembra essere un'innovazione dei geografi dell'epoca sāsānide e del primo periodo
islāmico, i quali l'avevano però elaborata a partire da una concezione cosmologica precedente, risalente alla fase più antica dello zoroastrismo, dove non era la terra abitata (l'avestica aniraθa) a essere suddivisa in sette «climi», ma era concepita essa stessa come elemento centrale di un ampio sistema cosmo-geografico formato da sette «continenti», uno centrale e gli altri sei periferici. L'antichità di questa tradizione è testimoniata nell'Avestā, in uno yašt dedicato allo yazatā Miθra, di cui riportiamo un ampio stralcio. I sette «continenti» o karvąr (forma avestica di kešwar) sono elencati per nome: | miθrǝm vouru-gaoyaoitīm ... ǰaγaurvåŋhǝm yō paoiryō mainyavō yazatō tarō harąm āsnaoiti paurva-naēmā amǝahe hū ya aurva-aspahe, yō paoiryō zaranyō-pīsō srīrå barǝnava gǝrǝwnāiti aδā vīspǝm ādiδāiti airyō-ayanǝm sǝvištō, yahmya sāstārō aurva paoiriš īrå rāzayeṇte yahmya garayō bǝrǝzaṇtō pouru-vāstråŋhō āfǝṇtō θātairō gave frāδayeṇte yahmya ǰafra varayō urvāpåŋhō hištǝṇte yahmya āpō nāvayå pǝrǝθwiš xaoδaŋha θwaxǝṇte āiatǝm pourutǝmca mourum hārōyum gaomca suxδǝm airizǝmca avi arǝzahi savahi avi fradaδafu vīdaδafu avi vouru-barǝšti vouru-ǰarǝšti avi ima karvąrǝ ya aniraθǝm bāmīm gavaayanǝm gavaitīmca baēazyąm miθrō sūrō ādiδāiti. | Sacrifichiamo a Miθra, signore degli ampi pascoli [...], instancabile e sempre vigile, che è il primo yazatā del mondo celeste a superare il monte Harā [Bǝrǝzaitī], prima del sorgere del sole immortale, dai veloci destrieri; che primo, in un abbigliamento tutto d'oro, prende le belle cime e là, con occhio benevolo, osserva la dimora conquistata dagli Airya, dove i valenti capi trascinano le molte truppe, dove le alte montagne, ricche di pascoli e acqua, producono quantità al bestiame; dove si stendono i profondi laghi di acqua salata, dove i fiumi che scorrono ampi si gonfiano e scorrono veloci verso Āiata e Pourita, Mouru e Hārōyu, Gava-suxδa e airizǝm: su Arǝzahī e Savahī, su Fradaδafu e Vīdaδafu, su Vourubarǝštī e Vouruǰarǝštī, su questo luminoso karvąr di aniraθa, la dimora del bestiame, l'abitazione del bestiame, il potente Miθra guarda con occhio che porta salute. | | yō vīspāhu karvōhu mainyavō yazatō vazaite arǝnō-då yō vīspāhu karvōhu mainyavō yazatō vazaite xaθrō-då, aēąm gūnaoti vǝrǝθraγnǝm yōi dim dahma vīduš-aa zaoθrābyō frāyazǝṇte. ahe raya ... tåscā yazamaide. | Colui che muove tutto il karvąr, uno yazatā non visto, e porta arǝnāh, colui che si muove lungo tutto il karvąr, uno yazatā non visto, e porta sovranità, e cresce la forza per la vittoria a coloro, i quali con pio intento, gli offrono santamente libagioni. Al suo splendore e gloria, io offrirò un sacrificio degno di essere esaudito. | Yašt Mihr [10: -] |
Questa descrizione, integrata da altre fonti, ci fornisce una sorta di rappresentazione del kósmos stabilita nella tavola successiva. aniraθa,
la terra abitata dagli uomini, è posta al centro di un sistema di coordinate che vede i sei karvąr extramondani situarsi a corona intorno ad essa. 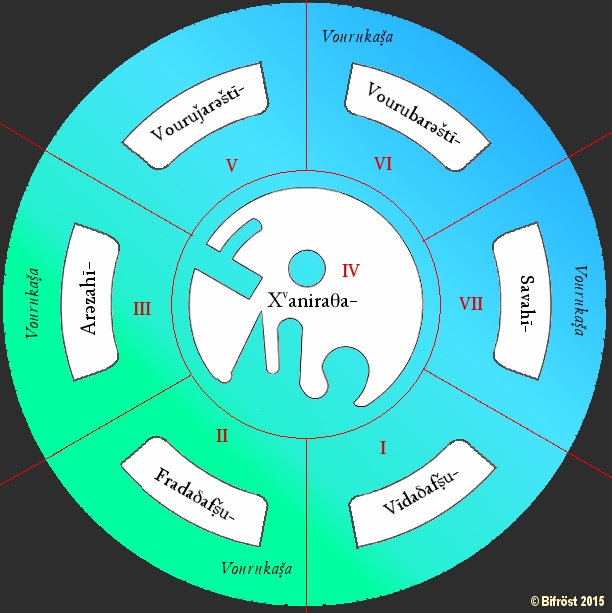
Questa è dunque la situazione antico-iranica: - Est. Arǝzahī- (medio persiano: Arzah)
- Sud-est. Fradaδafu- (medio persiano: Fradadafš)
- Sud-ovest. Vīdaδafu- (medio persiano: Wīdadafš)
- Centro. aniraθa- (medio persiano: Xwanirah > persiano classico: Ḵonīras)
- Ovest. Savahī- (medio persiano: Sawah)
- Nord-ovest. Vourubarǝštī- (medio persiano: Wōrūbaršt)
- Nord-est. Vouruǰarǝštī- (medio persiano: Wōrūǰaršt)
I dettagli di questo sistema sono chiariti nei testi di epoca medio-persiana, soprattutto nel Bundahišn, a cui ritorniamo. Un primo passo ci fornisce i nomi e le posizioni relative dei sette karvąr/kešwarān, e aggiunge – se abbiamo bene interpretato il testo – che la dimensione complessiva dei sei «continenti» periferici raggiunge, in dimensioni, il solo Xwanirah: | | ...Una parte è al centro, sei parti intorno ad essa, e queste parti sono [grandi] quanto Xwanirah: il nome kešwar si applica a tutte queste parti, in quanto hanno forma rotonda. | | | Come alcuni dicono, la parte a oriente è il kešwar di Arzah, la parte a occidente è il kešwar di Sawah, le due parti a meridione sono i kešwarān di Fradadafš e Wīdadafš, le due parti a settentrione sono i kešwarān di Wōrūbaršt e Wōrūǰaršt. Costoro chiamano Xwanirah la parte che è al centro, e che è grande quanto le altre. | Bundahišn [8: -] |
I kešwarān sono separati gli uni dagli altri: tra di essi si estendono mari invalicabili, ovvero bracci dell'oceano cosmico Warkaš/Frāxwkard, ma anche montagne e boschi che impediscono il passaggio da un kešwar a un altro: | | Non è possibile andare da un kešwar a un altro kešwar, se non con la guida e l'illuminazione degli yazatā. | | | Come costoro dicono, tra Arzah, Sawah e Xwanirah c'è il mare: li circonda un tratto dell'oceano Frāxkward; tra Fradadafš [e Wīdadafš] vi è una foresta nel mezzo; tra Wōrūbaršt e Wōrūǰaršt si erge una montagna.
Sebbene vi possa essere una connessione tra un kešwar e un altro kešwar, non è possibile passare dall'uno all'altro. | Bundahišn [5B: -] |
Un passo molto importante ci fornisce le esatte coordinate astronomiche dei sei kešwarān periferici:
| Da dove viene il sole nel giorno più lungo a dove viene nel giorno più corto è il kešwar orientale di Arzah; da dove viene nel giorno più corto a dove va nel giorno più corto si trovano i kešwarān meridionali di Fradadafš e Wīdadafš; da dove va nel giorno più corto a dove va nel giorno più lungo, si trova il kešwar occidentale di Sawah, da dove viene nel giorno più lungo a dove va nel giorno più lungo sono i kešwarān settentrionali di Wōrūbaršt e Wōrūǰaršt. Quando il sole viene, illumina i kešwarān di Arzah, Fradadafš, Wīdadafš e metà di Xwanirah; quando va sull'altro lato del monte Tērag, illumina i kešwar di Sawah, Wōrūbaršt e Wōrūǰaršt e metà di Xwanirah. Quando è giorno qui è notte là. | Bundahišn [5B: -] |
Questa descrizione astronomica – non del tutto coerente con la visione avestica – ci dà delle informazioni importanti. I kešwarān, come nota acutamente Henry Corbin, non sono semplicemente situati nello spazio ma situativi dello spazio stesso (cfr. Bundahišn [8: -]) (Corbin 1979). Detto in parole nostre, i kešwarān, definiti secondo parametri astronomici, relazionano la geologia terrestre con i movimenti del sole e stabiliscono i punti calendariali. In pratica, fungono essi stessi da paralleli e meridiani, da tropico del Cancro e tropico del Capricorno. Arǝzahī-/Arzah si estende dal punto dove il sole sorge nel solstizio d'estate al punto dove sorge nel solstizio d'inverno; Savahī-/Sawah dal punto dove il sole tramonta al solstizio d'estate al punto dove tramonta al solstizio d'inverno (si noti che nella redazione indiana del Bundahišn, Sawah si trova invece a est, Arzah a ovest). Lo strano ordine di illuminazione dei sette kešwarān viene spiegato dal Bundahišn ipotizzando una struttura cosmologica assai particolare:
| Il monte Harborz circonda il mondo; il monte Tērag è al centro del mondo. Il sole, girando come una corona intorno al mondo, ritorna, puro, oltre il monte Harborz, intorno a Tērag. Come qualcuno ha detto: il Tērag di Harborz, dietro cui roteano il mio sole, la luna e le stelle.” | | | In Harborz, vi sono centottanta apertura a est e centottanta a ovest: il sole entra attraverso un'apertura e esce da un'apertura ogni giorno. La luna e anche le costellazioni e i pianeti, sono tutti connessi tra loro e si muovono insieme: ogni giorno illuminano tre kešwarān e mezzo. | Bundahišn [5B: -] |
Il Bundahišn è attentissimo ai dettagli astronomici, soprattutto astrologici, e l'interpretazione di questo passo ha messo a dura prova gli iranisti. Ci limiteremo per ora a brevi osservazioni nel tentativo di spiegarne i dettagli più esteriori. Nel Bundahišn (sebbene tali concezioni abbiano un eco nei passi dell'Avestā è dubbio che fossero interpretate nello stesso modo in epoca anteriore) la terra risulta circondata da un'ininterrotta montagna circolare, il Harborz (cfr. avestico Harā Bǝrǝzaitī; persiano classico Alborz). Essa ha la stessa funzione del ǧabal Qāf nella tradizione araba e, come abbiamo visto, il geografo Yāqūt al-Hamawī identifica
esplicitamente i due rilievi: «[al-Qāf] gli antichi lo chiamavano al-Burz» (Kitāb muʿǧam al-buldān). Al centro del mondo, in Xwanirah, sorge il monte Tērag (cfr. avestico Taēra). Nonostante il Tērag
sembri assai distante dalla catena del Harborz, nondimeno viene considerato un elemento di questa
(viene infatti esplicitamente chiamato Tērag-ī-Harborz), come del resto tutte le montagne della terra, che anche la cosmologia iranica considera collegate nel sottosuolo da vaste, invisibile radici. Il monte Tērag funge da axis mundi e il sole vi rotea attorno illuminando così metà del mondo per volta, l'altra metà rimanendo in ombra. Il modello di un monte centrale intorno al quale gira il sole presenta però un problema non da poco: nel cosmo reale, l'eclittica, sulla quale si muovono il sole e i pianeti, interseca l'equatore celeste a un angolo di 23,5° e l'orizzonte visibile a un angolo che che varia a seconda della latitudine. Ciò è ovviamente incompatibile con un modello in cui il sole e i pianeti si muovano su un piano parallelo alla superficie della terra e i persiani erano dei troppo buoni astronomi per non rendersi conto di questa difficoltà. Se ne esce in due modi: (1) ipotizzando che la terra non sia un piano ma una sezione di sfera e che il monte Tērag
coincida con l'asse terrestre: ma questa concezione la troviamo compiuta
letterariamente soltanto in epoca islāmica; (2) che l'eclittica non sia – ovviamente – parallela al piano della terra e che, quindi, il movimento del sole attorno al monte Tērag-ī-Harborz sia assai più complesso. Questa sembra essere l'idea suggerita dal Bundahišn:
| | In Harborz, vi sono centottanta rōzan a est e centottanta a ovest: il sole entra attraverso un rōz e esce da un rōz ogni giorno. La luna e anche le costellazioni e i pianeti sono tutti connessi tra loro e si muovono insieme: ogni giorno illuminano tre kešwar e mezzo. | Bundahišn [5B: ] |
La parola rōz,
che qui indica una sorta di porta situata lungo la catena del
Harborz, significa letteralmente «giorno». Centottanta rōzan a est e centottanta rōzan a ovest, per far sorgere e tramontare il sole, sono dovuti al fatto che, nel corso dell'anno, il sole non sorge e non tramonta mai dallo stesso punto. Poiché il calendario mazdeo contemplava 360 giorni (più cinque giorni epagomeni), durante i quali
i punti in cui il sole sorge e tramonta si spostano, verso nord d'estate e verso sud d'inverno, ritornando due volte all'anno nel punto equinoziale, i rōzan o «giorni» da ciascun lato sono appunto 180. Ogni dì, dunque, il sole sorge da uno dei rōzan
orientali situati lungo la catena del Harborz, si alza nel cielo con un angolo pari a quello dell'eclittica, rotea attorno al monte
Tērag-ī-Harborz, e quindi declina a ovest, rientrando da uno dei rōzan
occidentali del Harborz. Lo schema successivo è tratto da uno splendido lavoro di David Neal MacKenzie (MacKenzie 1964): 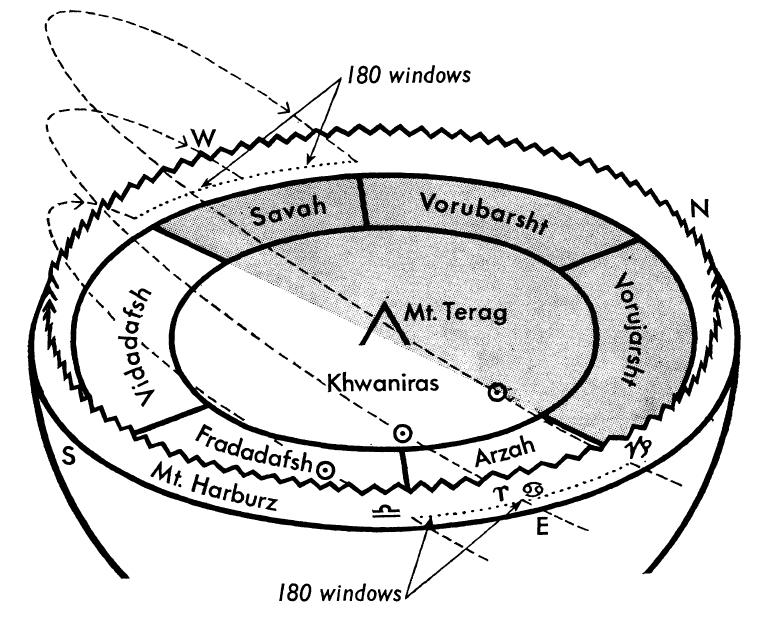
Ci soffermeremo in seguito sulle implicazioni cosmologiche della «montagna centrale», entrando nel merito delle non poche difficoltà di interpretazione dei testi zoroastriani. Ciò che ci preme sottolineare, a questo punto, è la struttura del mondo che affiora nei testi iranici e che possiamo riassumere in questo modo, con qualche semplificazione: -
esternamente il mondo è circondato da una vasta montagna circolare (avestico Harā Bǝrǝzaitī, medio persiano Harborz, persiano classico Alborz), attraverso le cui numerose «porte» (il termine iranico è rōzan «giorni») il sole esce all'alba e rientra al tramonto;
- la terra è suddivisa in sette kešwarān: un «continente» centrale (il mondo abitato dagli uomini) e altri sei periferici, disposti all'esterno del disco terrestre;
- i kešwarān sono separati tra loro dalle acque dell'oceano cosmico (avestico Vourukaa, medio persiano Frāxwkard e Warkaš), ma anche da montagne e boschi, rendendo impossibile, o difficoltoso, il transito dall'uno all'altro.
Questa cosmologia spiega efficacemente i viaggi di Eskandar nell'Eqbālnāmè. Si ricorderà che il condottiero rūmī era salpato da Andalos (sulla costa spagnola), diretto verso ovest e, dopo una lunga navigazione, era sbarcato in un altro «continente». Si trattava
naturalmente di uno degli altri kešwarān
(presumibilmente Savahī-/Sawah). Eskandar aveva dovuto attraversarne i deserti di zolfo prima di arrivare di fronte a un nuovo oceano, e qui, finalmente, aveva potuto vedere il sole tramontare nel mare (secondo il dettato qur˒ānico della «sorgente del sole» [ʿayn aš-šamsi], un motivo non presente nei testi zoroastriani). La cosmologia zoroastriana, nella sua formulazione conclusiva, quella attestata nel Bundahišn e nei testi collegati, viene di solito ricondotta alle concezioni indiane. Nei Purāṇa
la terra abitata dagli uomini corrisponde al Jambudvīpa,
il «continente» centrale di una serie di sette dvīpa, immaginati però come anelli concentrici, separati gli uni dagli altri da oceani intermedi. Anche qui, Jambudvīpa è suddiviso a sua volta in una serie di regioni minori [varṣa], il cui numero è, a seconda delle fonti, nove o quattro. Al centro di Jambudvīpa si leva il monte Meru, centro dell'universo, attorno al quale ruotano il sole, la luna e l'intera volta celeste: la notte è dovuta all'ombra del Meru allorché il sole scivola sul lato opposto della montagna. Una
montagna, detta Lokāloka (ovvero loka «mondo» + aloka «non-mondo»), percorre sul lato esterno il confine della terra, separandola dall'oscuro spazio esterno. Molti dettagli, nelle concezioni iranica e indiana, hanno sicuramente una comune origine, sebbene la differente storia religiosa e filosofica di Īrān e India li abbiano sviluppati in maniera affatto diversa. La mitologia indiana, così come quella greca, produce però un singolare effetto sui mitologi: una volta che questi riescono a ricondurre alcuni elementi di un qualsivoglia sistema mitico all'India o alla Grecia, sentono di essere arrivati a destinazione. Come se l'alto magistero della tradizioni vedica o ellenica basti per dare l'ultima, definitiva parola, a una ricerca. Nel nostro caso, se anche le comparazioni con l'India possano spiegare efficacemente alcuni elementi della cosmologia iranica, possiamo chiederci se quest'ultima, o l'intero spettro cosmologico indoiranico, non possano essere considerati un esito particolare di un sistema più generale e più diffuso. | | UNO SPECCHIO MESOPOTAMICO:
L'IMAGO MUNDI BABYLONICA Per rispondere dobbiamo rivolgerci alla cosiddetta
Imago mundi Babylonica, una tavoletta d'argilla rinvenuta a Sippar o a Borsippa e oggi custodita al British Museum, dov'è stata catalogata nel 1899 con la collazione BM 92687. Il sito di rinvenimento è datato al V secolo avanti Cristo, ma la tavoletta è più antica di cento o duecento anni ed è stata incisa probabilmente a Babilonia. Secondo le note presenti nel colophon, sarebbe stata ricopiata da un esemplare più antico, che si ritiene risalente al IX secolo. Riportiamo l'immagine e una trascrizione delle didascalie che accompagnano la mappa.
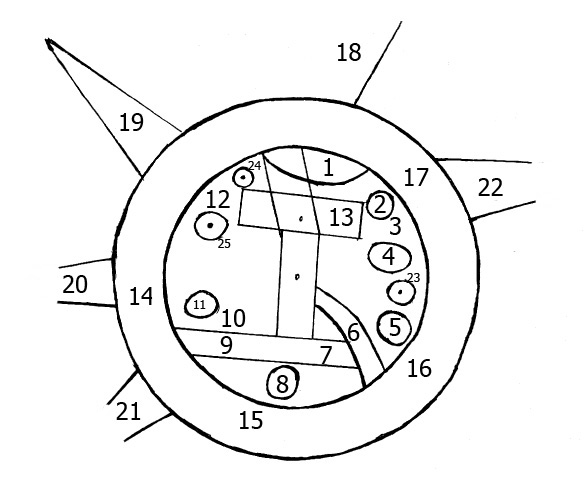
- šá-du-⌜ú⌝
- URU
- ú-ra-áš-tu[m]
- aš+šurk
- BAD.AN(=dér)
- ×-ra-[...
- ap-pa-r[u]
- [M]ÚŠ.⌜EREN⌝[](=[š]uša[n])
- bit-qu
- bῑt-ia-ʾ-ki-n
- URU
- ḫa-ab-ban
- TIN.TIR
- mar-ra-tum
- [⁽⁾mar-ra-tum]
- [⁽⁾m]ar-ra-tum
- mar-r[a-tum]
- BÀD.GULA
⌜6⌝ bēru
ina bi-rit
a-šar šamaš
la NU.IGI.LÁ(=innammaru) - na-gu-ú
6 bēru
ina bi-rit - [na-gu]-⌜ú⌝
[... - [na]-gu-ú
[... - na-gu-ú
⌜8⌝ bēru
ina bi-rit
|
- montagne
- città
- Urartu
- Assiria
- Dēr
- (?)
- palude
- Susa (Elam)
- canale
- Bīt-Yakin
- città
- Ḥabbān
- Babilonia
- amaro
- [⁽⁾ amaro]
- [⁽⁾ a]maro
- am[aro]
- grande muro
6 bēru
in mezzo
dove Šamaš
non è visto - regione
6 bēru
in mezzo - [na]gû
[... - [na]gû
[... - nagû
8 bēru
in mezzo
|
Imago mundi Babylonica [recto: didascalie nell'immagine] |
L'oikouménē, il mondo abitato dagli uomini, è qui rappresentato in forma circolare. Babilonia è rappresentata al centro, in forma rettangolare e divisa in due dal corso dell'Eufrate. Intorno sono rappresentate delle regioni circostanti, tra cui si riconoscono Urartu, l'Assiria e l'Elam; Bīt-Yakin, il «paese del mare», è la regione dei Caldei, presso il golfo Persico; la località di Ḥabbān, nell'odierno Yaman, porta ancora oggi questo nome. Šadû, le «montagne», sono i monti Zāgros o, più probabilmente, l'altopiano armeno. Appāru, la «palude», è forse l'odierna regione dello Šaṭṭ al-ʿArab, alla confluenza del Tigri e dell'Eufrate, nel sud del ʿIrāq. Intorno all'oikouménē, in un perfetto circolo, vi è il Marratu, il fiume «amaro» (il termine è infatti contrassegnato con il determinativo «» che contrassegna i nomi dei fiumi). L'idronimo mar-ra-tum appare
ben quattro volte. Nel Primo millennio questo termine è un sinonimo di tâmtu, «mare». In una iscrizione, il re assiro Šarru-kīn II (Sargon II, ♔ 721-705 a.C.) dichiarava orgogliosamente che gli dèi gli avevano conferito la regalità su tutti i popoli «dal marratu superiore al marratu inferiore» [ištu marrati elîti adi marrati šaplīti], intendendo l'intera regione compresa tra il Mediterraneo e il golfo Persico, mentre abbiamo già citato l'analoga formula con la quale, quindici secoli prima, re Šarru-kīnu di Akkad (♔ 2335-2279 a.C.), dichiarava di essere sovrano del «mare superiore e inferiore» [tiāmtam alîtam u šapiltam]. In questa concezione del Marratu, dunque, i mari noti alla geografia accadica
venivano considerati come estensioni, o parti, di un oceano esterno
che circondava il mondo ad anello, a guisa di un vasto fiume. Tutti
i fiumi interni e i canali tracciati sull'Imago
mundi sfociano infine nel Marratu, dando un senso all'espressione pû-nārāti, la «confluenza dei fiumi». Sul lato esterno del Marratu spuntano, in forma di triangoli allungati, delle «isole» che sembrano protendersi nello spazio cosmico, dando a tutto l'insieme l'aspetto di una stella. Nella terminologia della mappa esse sono definite dalla parola nagû, «regione»: questo termine, raro nei testi letterari babilonesi, è però abbastanza frequente nei testi assiri per indicare le unità amministrative (province o distretti) dell'impero. Il significato del termine è diverso nei testi mitologici. Nel racconto del diluvio fatto da Ūtnapištî a Gilgameš, ad esempio, è un nagû quello che compare dinanzi alla sua nave mentre le acque si ritirano, una sorta di isola temporanea che emerge dal mare:
ap-pa-li-is kb-ra-a-ti pa-ṭú A.AB.BA(=tâmti)
a-na 12 (var. 14)⋅ i-te-la-a na-gu-ú
a-na ni-muš i-te-mid MÁ(=elippu)
šadû ni-muš elippa iṣ-bat-ma a-na na-a-ši ul id-din | Scrutai la distesa delle acque in cerca di una riva:
finché a 12 (var.
14) (leghe) apparve un nagû.
La nave s'incagliò sul monte Nimuš,
il monte Nimuš prese la nave e non la fece più muovere. | | Ša naqba īmuru [XI: -] |
Nei testi neo-assiri il termine nagû può indicare delle isole o terre lontane sul mare: in un'iscrizione di
Aššur-bāni-apli (♔ 668-±627 a.C.), la Lydia è descritta come un nagû oltre il mare (Asb. [XX: -]). In un caso ci si riferisce agli isolotti sul fiume Tigri come a dei nagi˒ānu.
 | |
L'Imago mundi Babylonica (✍
VI sec. a.C.) | | British
Museum, Londra (Regno Unito) |
Il numero complessivo dei nagi˒ānu sull'Imago
mundi non è subito evidente, dato il cattivo stato della tavoletta, ma dalle iscrizioni sul verso si presume fossero otto. Le didascalie sulla cartina non sono molto precise: si limitano a indicare la distanza tra i nagû in termini di sei o otto bēru. Soltanto nel caso del nagû settentrionale (n. 18 nel nostro schema) troviamo una breve scritta: «grande muro [...] dove Šamaš non è visto». L'assiriologo Wayne Horowitz, che ha dedicato uno studio memorabile all'Imago
mundi, pensa ovviamente alla scena dove Gilgameš segue lo ḫarran šamši, il «sentiero del sole», nella cavità del monte Māšu, ma anche alla tradizione letteraria riguardante re Šarru-kīnu di Akkad, il quale, in un enigmatico passaggio, ha la visione di un viaggio attraverso le tenebre: «il presagio di Šarru-kīnu, che avanzava
nell'oscurità, e una luce brillava per lui» [...a-mu-ut ⌜šar-ru⌝-ki-in ša ek-le-tam il₈-ti-ku-ma nu-ru-um û-ṣi-aš-šu-um...] (Scheil RA27 [149: -]) (Horowitz 1998). Al contrario, ci sembra piuttosto improbabile che i Babilonesi – come suggerisce Horowitz
– possano aver spiegato il fatto che, al di sopra del tropico del
Cancro, il sole non salga mai nella metà settentrionale del cielo a
causa di un «grande muro».
Altri studiosi hanno identificato il «grande muro» con i monti
del Caucaso, a dispetto del fatto che l'Imago
mundi riporta l'iscrizione ben oltre il cerchio del Marratu. A questo punto l'intuito vola subito alla muraglia di Ḏū ʾl-Qarnayn, che le esigenze del mito avevano innalzato ai confini del mondo ma che i geografi musulmani, sulla scolta di Iosephus Flavius,
avevano localizzato tra le vette del Caucaso. Ma alternativamente
possiamo vedere in questo «grande muro» una versione babilonese
della montagna assiale che nasconde il sole allorché vi ruota dietro. La larghezza fornita nel testo, sei bēru, se intesa in termini temporali, dà dodici delle nostre ore, cioè il tempo che il sole impiegherebbe – negli equinozi – per transitare nel lato notturno del mondo. Alternativamente, il «grande muro» potrebbe essere un esito mesopotamico del cingulus mundi, simile al monte al-Qāf della tradizione arabo-islāmica, o al suo antemito iranico, il monte Harā Bǝrǝzaitī (Harburz, Alborz) che circonda il mondo, e che solo Miθra «supera prima del sorgere del sole immortale» (Yašt Mihr [10: ]).
Se l'Imago mundi non porta altre didascalie presso i nagi˒ānu, nel verso della tavoletta compaiono ventisette righe di testo nelle quali si offrono brevi e suggestive descrizioni di ciascun nagû. È veramente un peccato che il testo non sia ben conservato:
...] × [...
...tab]-ra-[ti...
...tam-t]u₄ ra-bi-tú [... | ...] × [...
...me]ravi[glie (?)...
...mar]e grande [... | | [maḫ-ru na-gu-ú ina e-re-b]i-šú tal-l[a-ku 7 bēru... | [Il primo (?) nagû (?) quando si en]tra, camm[ini 7 bēru... | [a-na šanû na-gu-ú] ⌜a⌝-šar ta-la-ku 7 bē[ru...
[...] × × × šap-[liš/lat... | [Al secondo nagû] dove tu cammini 7 bē[ru...
[...] ...sot[to... | [a-na šalšu]⌜⌝ na-du(=gu)-ú a-šar tal-la-ku 7 bēr[u...
[iṣ-ṣu]-ru mut-tap-ri-ši la ú-šal-l[a-am uruḫ-šu] | [Al terz]o nagû dove tu cammini 7 bēr[u...
un [uc]cello alato non può compl[etare il suo tragitto] | [a-na re]-bi-i na-gu-ú a-šar tal-la-ku 7 bē[ru...
[× × ×]-du ik-bi-ru ma-la par-sik-tum 20 ŠU.S[I](=ubān) [... | Al qua]rto nagû dove tu cammini 7 bē[ru...
[...] sono spessi come un parsiktum, 20 ubān [... | [a-na ḫanš]u⌜⌝ na-gu-ú a-šar tal-⌜la⌝-ku 7 bēru [...
[× ×] mi-lu-šú 1 UŠ⋅ ṣu-up-pan × [...
[× × ×] × zi-nu-šú a-na aš-la⋅ [...
[× ×]-×-mi da-mi-šu ul im-mar [...
[× × ×] ni-il-lu aš-ri tal-la-[ku...
[× × × × ta/]-al-la-ku ⌜7⌝ bē[ru...
[× × × × × ×].A a-ṣi-⌜i šá ina šu⌝-[...
[× × × ×]-šú i-bi-ri [... | [Al quin]to nagû dove tu cammini 7 bēru [...
[...è] l'inondazione/l'altezza, 1 UŠ e 2 ṣuppān (= 840 cubiti)
[...] pioggia/fronde, tanto quanto 1 ašlu (= 120 cubiti) è...
[...] il suo sangue non può essere visto [...
[...che noi sca]liamo (?) dove tu cammini...
[...tu/] io camminerò [7 bēru...
[...] la partenza che (?) è in [...
[...] la sua [...] ha attraversato [...] | [a-na šeššu] na-gu-ú a-šar tal-la-ku [7 bēru...
[× × × × × ina] muḫḫi a-na-ku KIM/DÍM-m[u... | [Al sesto] nagû dove tu cammini [7 bēru...
[... sulla (?)] cima, io [...] | [a-na sebî]⌜⌝ na-gu-ú a-šar tal-la-ku [7 bēru...
ša GU(=alpu) qar-nu šak-nu [...
i-⌜la⌝-as-su-mu-ma i-kaš-šá-du-⌜u⌝[... | [Al sett]imo nagû dove tu cammini [7 bēru...
dove il bestiame è fornito di corna [...
corrono veloci e raggiungono... | a-na [šam]anî na-gu-ú a-šar tal-ka-ku 7 bēr[u...
[× × × ×] a-šar-ti-še-ʾ-ru ina ḫa-an-du-ri-šú ⌜ú/šam⌝-[×-×] | All'[ott]avo nagû dove tu cammini 7 bē[ru...
[...il l]uogo dove [...] l'alba sorge alla porta [... | [× × × × × -t] šá kib-ra-a-ti er-bet-ti šá kal × [...]
[× × × × ×] × : qé-reb-ši-na man-na la ⌜i⌝ -[du-ú] | [...] dei quattro quadranti dell'intero [...]
[...] che nessuno può comprend[ere] | [× × × × ×] × ki-ma la-bi-ri-i-šu ša-ṭi-ir-ma ba-r[i]
[× × × × ×] mār-šú šá iṣ-ṣu-⌜ru⌝ [mā]r IDIM(=ea)-EN(=bēl)-il[ī] | [...] copiato da un vecchio esemplare e collaz[ionato]
[...] il figlio di Iṣṣuru, [discend]ente di Ea-bēl-il[ī]. |
Imago mundi Babylonica [verso] |
Le prime tre righe introduttive sono quasi del tutto perdute: si legge malamente la parola tabrâti, «meraviglie», alla riga [], mentre l'ipotetico [tâmt]u rabitu «grande mare» alla riga [] potrebbe riferirsi al Marratu. La riga [], che conserva la frase ina erēbīšu, «quando si entra», si riferisce probabilmente al primo nagû, ma su questo e sul secondo nagû [-] lo stato del testo non permette di cogliere alcun dato significativo. Il terzo nagû [-] viene definito come un luogo in cui gli uccelli non possono
giungere: formule simili sono utilizzate per indicare luoghi deserti ostili alla vita animale e umana (Horowitz 1998). Incomprensibile anche la nota al quarto nagû [-]. La descrizione del quinto nagû è la più lunga [-] ma le lacune e le difficoltà di lettura non la rendono affatto chiara. Le due possibili interpretazioni, secondo Horowitz, dipendono dall'ambiguità dei cuneiformi . e . alle righe [] e []. Se leggiamo . come mēlû «altezza» e . come zinû «fronde», allora ci troviamo in una regione di vaste foreste; la parola damīšu, «il suo sangue», alla riga [] potrebbe riferirsi alla linfa degli alberi: il termine damu indica infatti sia il sangue degli animali che la linfa delle piante. In tal caso, il verbo nillu, «che noi scaliamo», alla riga [],
potrebbe suggerire l'idea di una faticosa ascesa sui pendii boscosi
delle montagne. Se questa interpretazione è corretta, il quinto nagû potrebbe essere messo in correlazione con il Qišti Erēn, la «foresta dei cedri» raggiunta da Gilgameš e da Enkidu tanto nei poemi sumerici quanto nella tavola IV dello Ša naqba īmuru. Alternativamente, però, il quinto nagû potrebbe essere una terra di avverse condizioni meteorologiche, se leggiamo . come mīlu «inondazione» e . come zinnu «pioggia»; difficile in questo contesto spiegare la parola damu. Un più preciso significato dei termini . e . potrebbe essere suggerito dalle misure di lunghezza presentate nel testo, rispettivamente 840 cubiti e 120 cubiti, il cui senso era probabilmente spiegato nella parte mancante delle righe [] e []: l'altezza degli alberi, l'estensione della foresta o il livello raggiunto dall'inondazione? Ma le ambiguità non sono ancora finite: se accettiamo l'emendamento della riga [] in mi-lam-mi-šu ul im-mar, «il suo splendore non può essere visto», il quinto nagû viene a essere una terra di tenebre, identificandosi con il nagû settentrionale sull'Imago
mundi. (Horowitz 1998) Ma procediamo. Il settimo nagû [-] è descritto come un luogo ricco di bestiame cornuto. È probabile che la notazione «corrono veloci e raggiungono», conservata nella riga [], si riferisca proprio agli animali, a meno che non vi sia un precedente cambio di soggetto. L'ottavo nagû [-] è probabilmente localizzato a est, visto che viene descritto come il luogo da cui il sole sorge all'alba. Interessante in questo contesto la parola ḫandūru, «porta», che ci riconduce a piè pari nello schema cosmologico che stiamo analizzando in questa pagina. Nella cosmologia mesopotamica, non solo i cieli sono connessi da una serie di «porte» (si veda il racconto della scalata celeste di Etana, primo miʿrāǧ della storia della letteratura universale), tra cui sono contemplate quelle che il sole utilizza per sorgere e tramontare. Abbiamo
dati importanti. Teniamoli da conto non è ancora tempo di tirare i
nostri fili. Piuttosto, tiriamo un bel respiro lungo e lasciamo i
crudeli splendori del Medio Oriente. È tempo di tornare in
Occidente. |
IN GRECIA: COLUI CHE DI GRAN LUNGA FU IL PIÙ FORTE DEGLI UOMINI
Hērakléa Diòs hyiòn aeísomai, hòn még' áriston
geínat' epikhthoníōn Thḗbēıs éni kallikhóroisin
Alkmḗnē mikhtheîsa kelainephéï Kroníōni:
hòs prìn mèn katà gaîan athésphaton ēdè thálassan
plazómenos pompısin hýp' Eurysthos ánaktos
pollà mèn autòs érexen atásthala, pollà d' anétlē:
nŷn d' ḗdē katà kalòn hédos niphóentos Olýmpou
naíei terpómenos kaì ékhei kallísphyron Hḗbēn
Khaîre ánax Diòs hyié: dídou d' aretḗn te kaì ólbon. | Hērakls, figlio di Zeús canterò, che, di gran lunga il più forte
degli uomini, generò a Thbai dalle belle danze
Alkmḗnē, unitasi al figlio di Krónos, [Zeús] dagli oscuri nembi;
Hērakls, che dapprima, sulla terra infinita e sul mare,
soffrì errando e battendosi con vigore agli ordini di re Eurysteús,
molte cose inaudite compì egli stesso, e molto sofferse:
ma ora, nella bella dimora dell'Ólympos nevoso
vive lieto, e ha come sposa Hḗbē dalle belle caviglie.
Salve, signore figlio di Zeús; concedimi valore e prosperità. | Homḗrou hýmnoi [XI] |
 | | Hērakls
con i frutti delle Hesperídes | |
Copia romana di originale greco (V sec. a.C.) |
Nella sua eloquente concisione, questo inno omerico accenna al destino di Hērakls:
il più popolare e allo stesso tempo il più enigmatico degli eroi greci. Le vicende della sua vita, i suoi trionfi, le sue imprese turbolente, a cui abbiamo
già accennato parlando di Promētheús
Ⓐ▼, sono troppo numerose perché si possa narrarle nei dettagli, tanto più che a noi interessano solo alcuni momenti della sua sterminata biografia,
quegli episodi che lo proiettano di prepotenza nel maestoso scenario che stiamo indagando. Tra tutti gli eroi
ellenici, infatti, Hērakls è quello che più degli altri sembra muoversi su uno sfondo cosmologico, più degli altri è proiettato in viaggi e ricerche compiute ai confini del mondo, più degli altri è sospeso in bilico tra la mortalità degli esseri umani e l'immortalità degli dèi.
Di Hērakls si potrebbe parlare a lungo, enumerando minutamente le numerosissime imprese che gli hanno attribuito i mitografi. Ci limiteremo qui ai fatti essenziali, approfondendo quanto interessa al nostro studio riservandoci in seguito di approfondire altri dettagli. Figlio di Zeús e di Alkmḗnē, sposa di Amphitrýōn, un principe di stirpe argolide, Hērakls era stato generato grazie a un inganno. Un giuramento impegnava Amphitrýōn a rispettare la giovane moglie finché non fosse riuscito a vendicare i fratelli di lei, caduti durante un'incursione da parte dei Tēlebóai
(na popolazione pre-ellenica stanziata allora sull'isola di Táphos, sulle coste dell'Akarnanía). Lasciata la sposa a Thebai, Amphitrýōn partì per la spedizione. Ma approfittando della sua
assenza, Zeús prese il suo aspetto, si presentò da Alkmḗnē e, annunciandole la vittoria del marito,
giacque con lei. Zeús rese interminabile quella notte d'amore, trattenendo nelle loro stalle i cavalli del sole: intendeva infatti generare un eroe superiore a ogni altro mai esistito prima. Ad Amphitrýōn, al suo ritorno, non rimase che
accettare di essere stato cornificato dal re degli dèi. (Apollódōros: Bibliothḗkē [II: 4, ]) Hērakls venne alla luce segnato dalla gelosia di Hḗra, regina degli dèi, e poiché Zeús aveva dichiarato che il bimbo che stava per nascere avrebbe regnato sull'Argolís, Hḗra ritardò la nascita di Hērakls e anticipò quella di un cugino di Amphitrýōn, Eurysteús,
che nacque lo stesso giorno. A causa di tale astuzia, e poiché Zeús non poté rimangiarsi quanto aveva decretato, il possente e coraggioso Hērakls fu costretto agli ordini del pavido Eurysteús, re al suo posto per diritto di nascita, e spese la sua intera esistenza affrontando e sconfiggendo i mostri che la gelosa dea non cessava di porre dinanzi al suo cammino, a partire dai due serpenti che spedì alla sua culla quand'egli era ancora infante.
| | Quando il bimbo ebbe otto mesi, Hḗra inviò contro la sua culla due serpenti smisurati con l'intenzione di ucciderlo; ma mentre Alkmḗnē gridava chiamando in soccorso Amphitrýōn, Hērakls si destò, afferrò i due serpenti e li strangolò con le proprie mani. | | Apollódōros: Bibliothḗkē [II: 4: 8] |
La giovinezza di Hērakls è costellata da un'inarrestabile moltitudine di imprese eroiche, con continui eccessi di violenza e brutalità. È molto giovane quando sposa la tebana Mégara, che ha diversi anni più di lui. Non è un matrimonio felice. Colto da improvvisa follia, Hērakls massacra i suoi figli
e quelli di suo fratello Iphikls
①▼. Ma è stata Hḗra ad ottenebrare la sua mente costringendolo a macchiarsi di un così orrendo delitto. In tal modo la dea ha caricato Hērakls di un'impurità morale che lo costringerà a sottomettersi a un'espiazione. Condannatosi a un esilio volontario, l'eroe si reca Delphoí per sottoporsi al giudizio del dio, ed è appunto in questa circostanza che la pythía si rivolge per la prima volta a lui col nome di Hērakls, «gloria di Hḗra», e così egli sarà per sempre conosciuto (prima di questo momento, infatti, veniva chiamato Alkídēs). Il giudizio dell'oracolo è incontestabile: Hērakls sarà condannato a servire suo cugino Eurysteús, re di Mykḗnē e di Tíryns, per dieci lunghi anni. (Apollódōros: Bibliothḗkē [II: 4, ]) In questi anni – che diverranno dodici –, l'imbelle Eurysteús, nel tentativo di sbarazzarsi dell'ingombrante nipote, obbligherà Hērakls a viaggiare da un angolo all'altro della Grecia, e poi del mondo, per compiere una serie di imprese ai limiti delle forze umane. È così che Hērakls compie le sue dodici érga, o «fatiche». Quali fossero e in quale ordine venissero compiute, c'è discordanza tra gli autori; la lista più comunemente accettata
(Bibliothḗkē [II:
5]) è la seguente: - l'uccisione del leone di Neméa,
- l'uccisione dell'hýdra di Lérnē,
- la cattura della cerva di Kerýneia,
- la cattura del cinghiale di Erýmanthos,
- la caccia agli uccelli del lago Stymphalídes,
- la pulizia delle stalle di re Augeías,
- la cattura del toro di Krḗtē,
- il furto delle giumente di Diomḗdēs,
- il furto della cintura di Ippolytē, regina delle Amazónes,
- il furto del bestiame di Gēryṓn,
- il furto dei frutti d'oro nel giardino delle Hesperídes,
- la cattura di Kérberos.
Entrare in dettaglio in tutte queste avventure, con tutte le avventure
accessorie di cui sono costellate, è compito che esula dai nostri scopi. Menzioniamo come significativi il primo érgon, l'uccisione dell'invulnerabile leone di Neméa, col cui cranio e con la cui pelle Hērakls si confezionerà un elmo e un mantello, e il settimo érgon, la cattura del toro sacro a Poseidn, che Hērakls trascinò vivo, a nuoto, da Krḗtē nell'Attikḗ. Ma la parte centrale del ciclo di Hērakls, la più elaborata e complessa, è costituito da due érga, la decima e l'undicesima «fatica», rispettivamente il furto del bestiame di Gēryṓn e la ricerca dei frutti delle Hesperídes. I temi che ci interessano sono infatti concentrati in questi due episodi:
sul secondo in particolar modo. Mentre le prime «fatiche» hanno per teatro il Pelopónnēsos, in seguito Eurysteús spedisce Hērakls
in luoghi sempre più lontani, con la segreta speranza che il leonuto e clavuto
nipote finisca per farsi ammazzare in qualche remota contrada del mondo. Quando il re pretende che Hērakls gli porti il bestiame di Gēryṓn, l'eroe capisce che questa volta il suo viaggio sarà particolarmente lungo e difficile. Gēryṓn custodiva infatti le sue rosse giovenche nella remota isola di Erýtheia, ai confini occidentali della
terra. Dopo un lungo cammino attraverso l'Aígyptos e la Libýē, costellato di
avventure di ogni genere, Hērakls arriva nello stretto tra Africa ed Europa. Non era possibile procedere oltre, e qui Hērakls pone due «colonne» [stlai] che ebbero per sempre il suo nome. Dopo di che, giunto sulle coste
atlantiche della penisola iberica, Hērakls
si trova di fronte ai flutti del potamós Ōkeanós, che nessun uomo aveva mai attraversato prima d'allora. Solo il dio-sole
Hḗlios aveva la facoltà di traversare quelle acque: quando
tramontava, la sera, nell'estremo occidente, si imbarcava con i suoi
cavalli su un'enorme coppa d'oro, e durante la notte il potamós
Ōkeanós lo trasportava lungo la sua corrente, tutto intorno al mondo, conducendolo nelle lontane sponde di
Aithiopía, a oriente, da dove Hḗlios sarebbe di nuovo sorto il mattino successivo. Ora, durante la lunga marcia attraverso il deserto africano, poiché i raggi cocenti del sole gli arrostivano la schiena, Hērakls aveva minacciosamente teso l'arco contro il carro del sole, ed
Hḗlios, ammirato per il suo coraggio, aveva acconsentito a prestargli la
sua coppa d'oro.
| | Ed Hērakls tese contro di lui il suo arco come per colpirlo e Hḗlios gli impose di desistere, così Hērakls ebbe paura e desistette. In cambio
Hḗlios gli attribuì la coppa d'oro che lo portava insieme ai cavalli quando durante la notte si trasferiva verso oriente nella direzione in cui il sole sorge. Allora Hērakls su quella coppa raggiunse Erýtheia. E quando fu in mare aperto, Ōkeanós per metterlo alla prova fece beccheggiare tremendamente la coppa tra le onde. Hērakls stava per rivolgergli contro l'arco ma Ōkeanós s'intimorì e lo pregò di desistere. | | Pherekýdēs apud Athḗnaios: Deipnosophistaí [XI, 38, c-d] = FGrHist [3 F 18a] |
 | | Hērakls nella coppa d'oro di Hḗlios (✍
500-450 a.C.) | Immagine in
una kýlix greca a figure rosse, attribuito a Doûris.
Da Vulci, Etruria (Viterbo, Italia).
Museo Gregoriano-Etrusco:
Musei Vaticani, Roma (Città del
Vaticano) |
A bordo di questa coppa, Hērakls
può intraprendere la traversata del fiume
Ōkeanós, primo uomo a tentare tale impresa. Venuti meno i venti e le correnti, utilizza la sua pelle di leone come vela, facendo egli stesso da albero (Servius: Scholia in Vergilii Aeneidem [VIII, ]). Giunto nell'isola di
Erýtheia, Hērakls uccide Gēryṓn e gli altri mandriani. Dopo di che, imbarcate le rosse giovenche sulla coppa del sole, torna in Ibēría. Riconsegnata la coppa d'oro al legittimo proprietario, Hērakls sospinge le mandrie attraverso l'Ibēría, la
Keltikḗ e l'Italía prima di tornare in Hellás, e questo vasto periplo diviene occasione per inventarvi sopra una gran quantità di vicende, amori, miti eziologici e fondazioni di città. Non soddisfatto di un così straordinario bottino, anzi, contrariato dal fatto che Hērakls, a dispetto di ogni pronostico, sia tornato vivo, Eurysteús impone al cugino un érgon ancora più arduo del precedente: di portargli i
krýsea mla, i «frutti d'oro», che crescono nel giardino delle Hesperídes. Questi
frutti provenivano da un albero sacro che la terra Gaîa aveva donato ad Hḗra nel giorno del suo matrimonio con Zeús e che la dea stessa aveva piantato nel
Kpos Hesperídōn, affidandone la cura alle nýmphai che
colà vivevano. Questa volta l'eroe comincia a vagare senza una direzione precisa, perché non sa dove si trovi il giardino meraviglioso. Si reca dapprima in
Makedonía, e quindi in Illyría, dove, sulle rive del fiume Ēridanós,
riesce a catturare il saggio Nēreús, nonostante le sue inaudite metamorfosi, e dopo averlo strettamente legato, riesce a farsi indicare la strada da seguire. Seguendo i consigli di Nēreús, Hērakls scende dall'Illyría di nuovo in Libýē, dove allora regnava Antheús figlio di Poseidn. Costui costringeva gli stranieri a lottare con lui, ma essendo superiore in forza e vigore, finiva per ucciderli. Antheús traeva dalla terra la sua forza, ragione per cui molti dicono che proprio la terra Gaîa fosse sua madre, e infatti, prima del combattimento, mentre il suo avversario si spalmava il corpo d'olio, Antheús si cospargeva di sabbia affinché il contatto con la terra aumentasse il suo vigore e la sua forza. Come altri viaggiatori, Hērakls è costretto a misurarsi con lui, ma riesce a tenerlo sollevato sopra di sé, interrompendo il contatto di Antheús con la terra, ne serra le costole tra le braccia e lo uccide. Sconfitto Antheús, Hērakls giunge in Egitto, dove rischia di essere sacrificato dal locale re Boúsiris
e accoppa anche lui. Poi scende verso sud. Alcuni dicono abbia risalito
il Nílos, altri l'Arabía. Quale che sia il giusto itinerario, giunto
ancora una volta dinanzi alle acque del potamós Ōkeanós, sebbene dal lato sud-orientale, Hērakls s'imbarca di nuovo sulla coppa aurea del sole, con la quale può lasciarsi trasportare dall'instancabile corrente fino al
Kaúkasos. Qui, Hērakls libera Promētheús e uccide l'aquila che lo tormentava
da secoli. Il titán gli fornisce finalmente la giusta rotta da seguire:
il kpos, il giardino delle Hesperídes, si trova nell'estremo settentrione del mondo, oltre la terra degli Hyperbóreoi, là dove il cielo e la terra si toccano. Salito di nuovo a bordo della coppa d'oro del sole, Hērakls
naviga attraverso gelidi mari boreali. Giunge così alla remotissima
terra in cui si trova il mitico giardino. Qui, Átlas è condannato a reggere sulle spalle
l'intera volta celeste.
Abbiamo parlato altrove di come Átlas tenta di ingannare Hērakls, cercando di imporre a lui il peso del cielo
Ⓑ▼. Quel che ci interessa sottolineare è che i
frutti dell'immortalità erano protetti da Ládōn, il drákōn hespérios. Nella versione di Apollódōros, Hērakls
deve uccidere il serpente per impadronirsi dei krýsea mla (Bibliothḗkē [II:
5, ]). E lasciato Átlas a reggere il cielo sulle spalle, porta
tre frutti d'oro ad Eurysteús. Questi li regala allo stesso Hērakls, ed Hērakls li restituisce ad Athēnâ, la quale
li riporta al Kpos Hesperídōn, non essendo giusto che quei sacri pomi si
trovino in un luogo diverso dal mitico giardino. Concluso il suo impegno con Eurysteús, Hērakls trascorre gli anni successivi viaggiando per tutta la Grecia, dove ha diversi conti da saldare con chi aveva tentato di approfittarsi di lui nel periodo della sua schiavitù. Nel frattempo prende per sposa Dēiáneira, figlia di Oineús, per amore della quale lotta contro il dio fluviale Akhelos (sul quale ritorneremo). Qualche tempo dopo, conducendo con sé Dēiáneira, Hērakls giunge al fiume Eúēnos, dove il kéntauros Néssos traghetta i viandanti dietro compenso. Hērakls guada il fiume, mentre il kéntauros prende in groppa Dēiáneira. Giunto al centro della corrente, Néssos tenta di approfittarsi della donna ma Hērakls trae una freccia dalla faretra e lo colpisce. Il sangue velenoso dell'hýdra di Lérnē, di cui è intrisa la punta della freccia, procura al kéntauros un'atroce agonia. Prima di morire, Néssos dice a Dēiáneira, mentendo, che se raccoglierà il suo sangue, potrà trarne un filtro d'amore per ricondurre a sé Hērakls il giorno in cui egli darà segno di trascurarla. Tempo dopo infatti, Hērakls s'invaghisce di una schiava, Iólē, e temendo di perderlo, Dēiáneira cosparge un chitone col filtro tratto dal sangue di Néssos e lo invia ad Hērakls in dono. Hērakls lo indossa, ma...
| | Non appena il chitone cominciò a scaldarsi, il veleno dell'hýdra cominciò a corrodergli la pelle. Hērakls [...] cercò di strapparsi il chitone che gli aderiva al corpo, ma insieme a quello si laceravano anche le carni. Prostrato da questa sciagura, venne trasportato a Trakhís. Dēiáneira, quando apprese l'accaduto, s'impiccò. [...] Hērakls raggiunse il monte Oítē, che si trovava nel territorio di Trakhís, e lì, dopo avere fatto innalzare una pira, vi salì e diede ordine di accendere il fuoco. Nessuno voleva obbedire, fino a che un certo Poías, che era di passaggio alla ricerca delle sue gregge, accese il rogo: a lui Hērakls donò il proprio arco. Mentre la pira ardeva, si racconta che una nuvola l'abbia avvolto e trasportato in cielo tra i tuoni. Lì [Hērakls] ottenne l'immortalità, e riconciliatosi con Hḗra, sposò sua figlia Hḗbē... | | Apollódōros: Bibliothḗkē [II: 7: 7] |
|
①▲
Euripídēs, che nella sua tragedia Hērakls ci dà un crudo, toccante resoconto della follia di Hērakls e della macabra uccisione dei suoi stessi figli, pone il massacro dopo il ritorno dell'eroe dal compimento delle dodici «fatiche». Secondo Károly Kerény questa versione risalirebbe alla tradizione tebana e sarebbe più arcaica di quella fornita da Apollódōros,
dove le «fatiche» vengono compiute in espiazione
dell'omicidio (Kéreny 1963). Si
veda sotto per una discussione al riguardo. |
|
|
| HĒRAKLS: RADIOGRAFIA DI UN HĒMÍTHEOS In un sistema mitico in cui Apóllōn
ricorda brutalmente che «saranno sempre due razze distinte, quella degli dèi immortali e quella degli umani che camminano sulla terra» (Ilías [V: -]), Hērakls presenta lo strano paradosso di un eroe che è riuscito a colmare lo iato con la divinità. Tra tutti gli eroi greci, Hērakls è quello che più degli altri si muove in bilico tra l'umano e il divino; è l'unico a innalzare da sé il proprio rogo funebre, l'unico a cui venga concessa l'apoteosi. Quando Odysseús scenderà nella casa di Áıdēs, troverà solo la sua ombra terribile, perché egli in realtà era contemporaneamente presente sull'Ólympos come un dio:
| | E poi conobbi la grande forza d'Hērakls,
ma la parvenza sola: lui tra i numi immortali
gode il banchetto, possiede Hḗbē dalle belle caviglie
figlia del gran Zeús e di Hḗra dai sandali d'oro... | Hómēros: Odýsseia [XI: -] |
La figura di Hērakls sembra il risultato di una complessa stratificazione di temi mitici che sono venuti a sovrapporsi nell'area del Mediterraneo orientale nella seconda metà del Secondo millennio avanti Cristo, e dall'identificazione di personaggi appartenenti a tradizioni differenti, con interessanti scambi di attributi e valenze. Stabilire le tappe di questo percorso mitogenetico è difficile, se non impossibile. Possiamo solo identificare alcuni degli apporti che, nel corso del tempo, hanno dato vita all'immagine di Hērakls, in particolare quella attestata dal mito ellenico, che conosciamo più approfonditamente, a cui possiamo affiancare gli «eracli» eterogenei consegnatici dalle tradizioni italica, etrusca e fenicia. Gli apporti più facilmente distinguibili alla base della figura di Hērakls sono tre:
1) il dio-tuono indoeuropeo, 2) il dio fenicio Melkqart, 3) il Gilgameš mesopotamico,
a cui si aggiunge il confronto con l'Hercules/Hercle
italico. Entriamo nel dettaglio.
1. Il dio-tuono indoeuropeo Dietro l'iconografia, fin troppo nota, di Hērakls, che la tradizione greca ci propone come figura essenzialmente eroica, traspare il profilo dell'antico dio-tuono indoeuropeo. In uno studio successivo delineeremo con maggiore precisione i tratti comuni ai vari esiti di questo comune mitema: il lettore ci scuserà se per ora daremo per scontate delle conclusioni che richiederebbero una più attenta argomentazione. Gli esiti del dio-tuono indoeuropeo sono facilmente
individuabili: Indra in India, Tarḫunta in Anatolia,
Þórr in Scandinavia, Taranis in Gallia, Perunŭ tra gli Slavi orientali sono alcuni degli esempi più evidenti. A nostro avviso, queste figure non sono soltanto analoghe (cioè non condividono semplicemente la medesima funzione), ma sono anche omologhe, cioè derivate – sebbene con modifiche e apporti – da una figura comune,
appartenente all'antica religione indoeuropea. In alcuni dei casi sopra elencati, l'omologia dei personaggi è evidenziata dalla radice stessa del nome (da un indoeuropeo
*(S)TENH₂-, cfr. sanscrito tanyati, greco
sténō, latino tonare «tuonare», antico germanico *þunraz,
medio irlandese torand/torann, antico slavo stenǫ «brontolare»). L'originaria mitologia di questa figura può essere dedotta dagli elementi comuni ai vari esiti. La funzione principale del dio-tuono sembra essere quella di difendere l'ordine cosmico dalle minacce
presenti ed escatologiche: si sposta lungo i confini del mondo per spacciare mostri e giganti; è rissoso, irascibile, vorace, gran bevitore, dotato di un gagliardo appetito sessuale. Sembra che in origine il dio-tuono fosse considerato il re degli dèi, sebbene nei limiti
di una regalità guerriera di seconda funzione. Tra gli schemi mitici comuni alla maggior parte degli esiti del dio-tuono ne ricordiamo tre: (a) lo scontro con il tricefalo, identificabile in alcune tradizioni al titano incatenato; (b) un paradossale difetto di virilità che lo porta a travestirsi da donna o ad assumere attribuiti femminili; (c) la lotta escatologica con il serpente-delle-acque. In alcuni casi, la figura del dio-tuono appare trasposta in forma eroica: è il caso di Θraētaona/Frēdōn in Īrān o Tullus Hostilius a Roma. A volte, egli sviluppa dei sodali che appaiono in forma triplice o come terzo elemento di un terzetto: è il caso di Trita Āptya in India, dello stesso Θraētaona in Īrān, dei tre Horatii a Roma
o dei Clanna Tuirenn in Irlanda.
 |
| Hēraklês contro Akhelôos
(✍ 1824) |
François-Joseph Bosio (1769-1845), scultura in bronzo
Musée du Louvre, Paris (Francia). |
In Grecia, l'esito del dio-tuono indoeuropeo è, appunto, Hērakls. Ce ne danno una prima indicazione il carattere e gli attribuiti del dio, compatibili con quelli del dio-tuono indoeuropeo (forza fisica, voracità, appetito sessuale, etc.); la clava di Hērakls
può essere messa in correlazione con il vajra di Indra, il mjǫllnir di Þórr,
la clava di Θraētaona/Frēdōn, etc. In secondo luogo, vi è la funzione generica del personaggio, che
viaggia ai confini del mondo e combatte mostri di ogni sorta. In terzo luogo, i tre schemi mitici sopra riferiti, trovano un puntuale riferimento nel ciclo di Hērakls:
(a) lo scontro con Gēryṓn; (b) l'episodio in cui,
abbigliato da donna, deve servire la regina
Omphálē; (c), la lotta contro l'hýdra di Lérnē
e/o quella contro il dio fluviale Akhelos.
Difficile dire come sia avvenuto, in Grecia, il declassamento di questa divinità a hēmítheos. Una delle ragioni, se non forse la principale, è stata la progressiva crescita di importanza di Zeús, che ha portato a una ridefinizione dell'intero pántheon protoellenico. Il dio-cielo indoeuropeo, a giudicare dal suo omologo indiano, Dyauṣ Pitā, era probabilmente avvertito come un essere lontano e inaccessibile: assente nella mitologia,
presentava probabili caratteristiche di deus otiosus. Ma nello sviluppo della mitologia greca, Zeús dovette subire l'influenza degli dèi supremi medio-orientali, in particolare Enlil, Yǝhwāh e Baʿal, divinità temporalesche tanto nel carattere quanto negli attributi (e abbiamo visto come Zeús abbia sostituito puntualmente Enlil nelle riletture esiodee dei miti mesopotamici). Questa interpraetatio orientalis finì col conferire a Zeús una sorta di regalità atmosferica, assai differente dalla regalità guerriera
tipica del dio-tuono, dandogli nel contempo il dominio sui fulmini e sui lampi. Questo passaggio dovette provocare il declassamento del dio-tuono, il quale, perduta la regalità guerriera, trasformata la sua arma folgorante in una semplice clava, venne restituito come un semplice semidio, o eroe.
In un certo senso, l'apoteosi finale di Hērakls, è il processo formale che, all'interno del canone mitico, ristabilisce la giusta statura di un personaggio
che nel corso della sua evoluzione storica aveva subito il processo inverso. Il mito dell'apoteosi doveva anche giustificare, a posteriori, il culto tributato al «dio» Hērakls, culto che ovviamente risaliva a epoche più antiche del suo declassamento a eroe.
2. Il dio fenicio Melkqart Melkqart, il «re della città», era il dio poliade di Týros/Ṣūr (baʿal Ṣūr), il cui culto fu diffuso dai Fenici in tutto il Mediterraneo. La sua identificazione con l'Hērakls classico appare piuttosto antica e, tenendo conto della profonda influenza culturale che i Fenici ebbero sulla civiltà greca (basti pensare all'alfabeto...), ci si può chiedere quali elementi siano passati dal dio fenicio all'eroe greco. Disgraziatamente sappiamo pochissimo sulla mitologia di Melkqart. Una storia piuttosto interessante viene riportata da Athḗnaios Naukratítēs († 392 a.C.):
| Eúdoxos d' ho Knídios en prṓtōi gs periódou toùs Phoínikas légei thýein ti Hērakleî órtygas dià tò tòn Hērakléa tòn Asterías kaì Diòs poreuómenon eis Libýēn anairethē̂nai mèn hypò Typhnos, Ioláou d' auti prosenénkantos órtyga kaì prosagagóntos osphranthénta anabinai. Échaire gár, phēsí, kaì periṑn tō̂i zṓiōi toútōi. | Eúdoxos Knídios, nel suo Gs periódos [«Descrizione della terra»], dice che i Fenici sacrificano quaglie a Hērakls, perché Hērakls, figlio di Astería (= Aštart?) e Zeús (= Hadad?), andò in
Libýē e fu ucciso da Typhn. Ma Iólaos gli portò una quaglia e la mise accanto a lui; egli ne annusò il profumo e tornò alla vita. Finché egli rimase in vita, dice Eúdoxos, Hērakls fu ghiotto di tali uccelli. | | Athḗnaios Naukratitēs: Deipnosophistaí [IX: 392d-e] |
Inoltre, nelle pseudepigrapha Clementis, serie di omelie attribuite al teologo Klḗmēns Alexandreús († 215), vi è un passo dove si compiange la follia del politeismo e si citano i sepolcri di diverse divinità, inclusa la tomba «di Hercules di Tyrus, che
venne bruciato col fuoco» (Pseudo Clementines recognitiones [X, 24] = Homilíai [XX]). Se la testimonianza delle pseudoepigrapha non dipende dal mito greco, se cioè riporta un'effettiva tradizione fenicia, potremmo ipotizzare un'ispirazione medio-orientale alla base del mito della morte sulla pira dell'Hērakls ellenico. Dal racconto di Athḗnaios si suggerisce
anche il motivo della resurrezione dell'eroe, che potrebbe essere alla base del mito dell'apoteosi di Hērakls, oltre alla presenza, accanto all'Hērakls fenicio, di un suo compagno, qui identificato con Iólaos. Anche nei frammenti del mitografo fenicio Saŋkouniáthōn, di cui rimane solo una parafrasi parziale di Phílōn di Býblos/Gebal, Melkqart (Melkathros) viene identificato con Hērakls (Eusébios Kaisareús: Euaŋgelikḕ proparaskeuḗ / Praeparatio Evangelica
[X]). Ma avremo modo in seguito di approfondire alcuni dettagli legati al culto dell'Hērakls fenicio.
3. Elementi dall'epopea di Gilgameš Un certo numero elementi epico/mitologici presenti nel ciclo di Hērakls, in particolare la dinamica dei suoi viaggi ai confini del mondo e la ricerca dei
frutti dell'immortalità nel giardino delle Hesperídes, trovano un confronto particolareggiato e puntuale con l'epopea di Gilgameš. Come cercheremo ora di dimostrare, vi è probabilmente alla base di entrambi i cicli – ellenico e mesopotamico – un mito più antico di ricerca dell'immortalità, di cui ne analizzeremo le varianti e che, nei miti indoeuropei, viene solitamente collegato
al dio-tuono. Le divergenze, anche profonde, tra il ciclo di Gilgameš e quello di Hērakls sono in parte spiegabili attraverso la complessa storia di apporti che, nel caso di Hērakls, ha modificato l'ideologia del personaggio,
e nella millenaria rielaborazione letteraria che, nel caso di Gilgameš,
ha alterato alcuni tratti del suo mito originario.
L'Hercules/Hercle italico
 | |
Uni allatta Hercle
(✍
±325-300 a.C.) |
Specchio etrusco, in bronzo, da Volterra.
Museo Archeologico di Firenze (Italia) | |
L'iscrizione sullo specchio riporta: eca sren tva iχnac
hercle unial clan θrasce «Questa immagine mostra come
Hercle figlio di Uni poppava». La scena ricorda il mito
ellenico dell'allattamento del piccolo Hēraklês
da parte di Hḗra, ma il fatto di trovare qui
l'eroe adulto e barbuto, attaccato al seno della dea, non ha
ancora un'interpretazione convincente. Tra le letture
proposte: (1) una forma rituale di riconciliazione tra
Hercle e la sua avversaria storica Uni; (2) una variante etrusca
del mito d'immortalità. |
Sembra che a Roma, ancora intorno al V secolo avanti Cristo, Hercules fosse adorato come una delle principali divinità del pántheon locale e a lui
fosse dedicata l'ara maxima sul mons Boarius. Il nome latino del dio, d'altra parte, non è teoforico come quello di Hērakls; cioè non è legato né al nome della dea Hēra, né a quello della sua interpraetatio romana Iuno. E nonostante ancora
Marcus Terentius Varro consideri la lezione latina derivata dalla greca
(De lingua latina [V: 45 |
66]), tra i nomina Hērakls ed Hercules non
sembrano esservi elementi corradicali. Che in origine Hercules fosse stato un dio ce ne dà certezza anche il fatto che a Roma
gli si tributavano onori divini prima ancora che la sua figura venisse interpretata sulla scolta dei miti greci, e dal fatto che un dio a tutti gli effetti era sempre stato
Hercle tra gli Etruschi. È curioso
che questo ercole tirrenico fosse stato definito dagli Etruschi Unial clan, «figlio di Uni», che altri non era che la Iuno
romana. Si profila l'immagine, paradossale, di un Hērakls figlio di Hḗra. E questo a totale dispetto del mito greco, in cui incontriamo una Hḗra gelosissima del figlio di suo marito, che
cerca anzi di contrastare in tutti i modi. È davvero possibile che in un certo stadio della sua formazione il mito sia stato capovolto? Sembrerebbe
proprio di sì, se pensiamo che il nome
ellenico dell'eroe significa «gloria di Hḗra», e che ai miti che descrivono la gelosia della dea, se ne affiancano altri dove Hḗra ha un diverso contegno nei confronti di Hērakls. Si comincia a delineare una diversa figura di Hērakls. Un antico dio del tuono, legato alla dea Hḗra, ma interpretato
in maniera diametralmente opposta nella narrativa mitologica, declassato da dio a semplice eroe.
Un eroe sui generis, tuttavia, talmente preso dalla nostalgia delle sue origini divine, da sfidare il fato per riconquistare il suo posto nel consesso degli immortali. |
| LA STRADA PER LE HESPERÍDES Prima di proseguire, dobbiamo fare il punto su una questione di non secondaria importanza. Dov'era localizzato, con esattezza, il giardino delle Hesperídes? E quale tragitto aveva percorso Hērakls per arrivarci?
 |
|
Il giardino delle Hesperídes (✍
±1892) |
Frederic Leighton (1830-1896).
Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight (Regno Unito). |
Questa domanda non ha una risposta univoca. Come vedremo, gli stessi mitografi antichi mostrano un certo grado di incertezza su dove collocare il favoloso kpos
dove crescevano i frutti dorati dell'immortalità. Il nostro affaticatissimo Hērakls,
come abbiamo visto, dovette recarsi due volte ai confini del mondo, per compiere due distinti érga: la decima «fatica», il furto del bestiame di Gēryṓn, e l'undicesima, quella, appunto, per procurarsi i frutti delle Hesperídes. Poiché riconosciamo agilmente nella prima impresa uno dei classici miti indoeuropei legati al ciclo del dio-tuono (la lotta con il tricefalo), possiamo facilmente escluderla dal nostro lavoro. Tuttavia, molti elementi geografici e cosmologici legati a Erýtheia,
l'isola dove dimorava Gēryṓn, risultano perfettamente sovrapponibili ad alcune delle tradizionali localizzazioni del
Kpos Hesperídōn, al punto che possiamo considerare i due
itinerari di Hērakls come
la duplicazione letteraria di un percorso singolo.
Effettivamente, alcune delle avventure minori vissute da Hērakls nel corso di questi peripli (con la lotta con Antaîos, o lo scontro con Boúsiris) sono indifferentemente assegnate dai mitografi all'uno o all'altro érgon. E ancora, Erýtheia, la «rossa», è tanto il nome dell'isola di Gēryṓn, quando
il nome di una delle nýmphai Hesperídes. Possiamo dunque utilizzare senza problemi il materiale
geografico tratto dal decimo érgon di Hērakls per tentare di localizzare il kpos raggiunto nell'undicesimo.
Le nome delle Hesperídes
deriva dal sostantivo greco hespéra, nei suoi significati
convergenti di «occidente» e di «tramonto». Il sostantivo maschile
hésperos (< *wésperos) vuol dire «sera» ma
Hésperos è anche la stella della
sera, il nome che il pianeta Venere assume quando segue il sole nel
tramonto (all'alba porta il nome di Phósphoros);
come aggettivo, hésperos vuol dire «serotino» e
«occidentale». La radice deriva da un indoeuropeo centro-occidentale *WESPER-/*WEKER-,
del medesimo significato (cfr. latino vesper, armeno
gišer, lituano vãkaras, antico russo večerŭ «sera»).
Le Hesperídes erano dunque le nýmphai
dell'occidente e del tramonto. Le tradizioni non sono univoche nell'elencare i loro nomi. Secondo un incerto frammento esiodeo, erano in numero di tre, e si chiamavano: Aíglē, la «radiosa», Erýtheia, la «rossa», ed Esperéthousa, la «rapida sera» dai dolci occhi bovini (Hēsíodos: Phragmenta [360
dub MW]). Apollódoros scinde
però l'ultimo nomen e ci propone quattro distinte fanciulle: Aíglē, Erýtheia, Espéra e Aréthousa (Bibliothḗkē [II: 5, ]). Aíglē, Erýtheia ed Espérē tornano invece ad essere in Apollṓnios Rhódios (Tá Argonautiká [IV: -]). Esistono anche altre tradizioni, ma elencarle è un giochino da mitografi. In quanto alla loro paternità, non vi è nemmeno qui uniformità di vedute. Hēsíodos le enumera – giustamente – tra i figli delle «notte», Nýx dalle nere ali (Theogonía [-]). In seguito altri mitografi diranno che erano figlie di Zeús e Thémis (Servius: Scholia in Vergilii Aeneidem [IV, ]); di Phórkys e Ketṓ (Scholia in Apollonium Rhodium [IV, ]);
o di Átlas (Pherekýdēs: FGrHist [3 F 16a]; Diódōros Sikeliṓtēs: Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 26]; Hyginus: De Astronomia [II: 3]), identificandole
in tal caso con le Atlantídes.
Ritorniamo alla nostra domanda: dove si trovava il giardino delle Hesperídes?
A giudicare dall'etimologia del nome, verso il tramonto, a occidente, ed è questa la più antica e razionale localizzazione del meraviglioso giardino. Nella Theogonía, Hēsíodos colloca le Hesperídes in una sorta di occidente cosmologico. Le nýmphai
del tramonto abitavano «verso la notte» [], «al di là del famoso Ōkeanós» [ | ]:
...Hesperídas th', hs mla pérēn klytoû Ōkeanoîo
chrýsea kala mélousi phérontá te déndrea karpón. | ...le Hesperídes che, al di là del famoso Ōkeanós, si prendono
cura delle mele d'oro e degli alberi che ne portano il frutto. | | Hēsíodos: Theogonía [-] | ...Gorgoús th', haì naíousi pérēn klytoû Ōkeanoîo
eschati pròs Nyktós, hín' Hesperídes ligýphōnoi... | ...e le Gorgónes, che hanno dimora al di là del famoso Ōkeanós,
verso la notte, agli estremi confini, dove sono le Hesperídes dalla voce acuta... | | Hēsíodos: Theogonía [-] | Átlas d’ ouranòn eurỳn échei kraters hyp’ anáŋkēs
peírasin en gaíēs, própar Hesperídōn ligyphṓnōn,
hestēṑs kephal te kaì akamátēısi chéressin;
taútēn gár hoi moîran edássato mētíeta Zeús. | Átlas regge il vasto cielo, soggiacendo a dura necessità,
ai confini della terra, davanti alle Hesperídes dalla voce sonora
stando ritto, con la testa e le braccia instancabili:
tale sorte gli assegnò, infatti, Zeús prudente. | | Hēsíodos: Theogonía [-] |
Sebbene Hēsíodos citi le nýmphai e non il kpos, sembra
ovvio inferire che esse dimorino in qualche terra o isola posta oltre il fiume Ōkeanós, non lontano dal luogo dove il
titán Átlas è condannato a sorreggere il cielo. Ci troviamo in un luogo oltremondano, che si confonde tanto con l'isola di Erýtheia, tanto con le Makárōn Nsoi, le «isole dei beati» del mito
ellenico. Autori successivi cercheranno di razionalizzare la materia situando il
Kpos Hesperídōn non al di là del fiume Ōkeanós, ma prima di esso, sulle coste occidentali della terra abitata. Identificando il
titán con il monte omonimo, alcuni mitografi
pongono il giardino nei pressi del monte Átlas (il massiccio occidentale dell'Atlante, nel Maġrib). Il primo a suggerire questa localizzazione sembra
sia stato Pherekýdēs (FGrHist [3 F 16a]). Secondo Diódōros Sikeliṓtēs
i krýsea mla crescevano in «certi giardini delle Hesperídes in Libýē» (Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 26]). Apollṓnios Rhódios colloca il kpos
presso il semimitico lago Tritōnís, sempre in Libýē (Tá Argonautiká [IV: -]). Hyginus lo localizza sul monte Átlas (De Astronomia [I: 30]). Saltando dalla sponda africana a quella europea, Strábōn compie prodigi
di geografia localizzando le Hesperídes,
come pure Erýtheia e le Makárōn Nsoi, in Ibēría, tra le isolette poste di fronte a Gádeira (od. Cádiz, Spagna) (Geōgraphiká [III: 1, ]). L'identificazione del
titán Átlas con l'óros Átlas viene portata a compimento in un racconto di Publius Ovidius Naso,
che attiene però al ciclo di Perseús. L'eroe
– antenato di Hērakls –
tornando vittorioso dall'impresa contro Médousa, vola, sospeso sui suoi sandali alati, sopra il meraviglioso giardino di Átlas, che il brillante poeta augusteo pone in un luogo non lontano dal punto dove il sole tramonta tuffandosi in mare:
Iamque cadente diem veritus se credere nocti,
constitit Hesperio, regnis Atlantis, in orbe,
exiguamque petit requiem. [...]
Hic hominum cunctos ingenti corpore praestans
Iapetionides Atlas fuit, ultima tellus
rege sub hoc et pontus erat, qui Solis anhelis
aequora subdit equis et fessos excipit axes.
Mille greges illi totidemque armenta per herbas
errabant, et humum vicinia nulla premebant.
Arboreae frondes auro radiante nitentes
ex auro ramos, ex auro poma tegebant. | E ormai il giorno volgeva alla fine, e non osando volare di notte
[Perseús] su fermò nella regione di Hespería, nel regno di Átlas,
per concedersi un po' di riposo. [...]
Di statura enorme, superiore a quella di qualsiasi uomo,
Átlas, figlio di Iapetós
regnava sull'estremo lembo della terra
e sulle distese marine che accolgono nel loro grembo
i cavalli ansimanti e il cocchio stanco del sole.
Aveva mille greggi e altrettanti armenti che gli erravano
per i prati, e nessun vicino premeva ai suoi confini.
Sugli alberi, fronde lucenti, d'oro sfavillante,
coprivano rami d'oro, frutti d'oro. | | Publius Ovidius Naso: Metamorphoseon [IV: -] |
Perseús chiede ad Átlas di permettergli di scendere nel meraviglioso kpos per ristorarsi dalle fatiche del viaggio, ma il
titán rifiuta, in quanto gli è stato profetizzato che il suo giardino sarà spogliato da un discendente di Zeús.
Perseús non ha modo di sapere che la profezia riguarderà il suo futuro bisnipote Hērakls. Irritato, trae la testa mozzata di Médousa dalla bisaccia e con quella pietrifica Átlas, trasformandolo nel monte che porta il suo nome.
Dopo di che, senza badare al groviglio di contraddizioni nelle quali, così facendo, infilerà Hērakls tre generazioni più tardi, Ovidius si appresta a seguire Perseús
verso le sponde di Aithiopía, dove l'immaginario erotico legato alla
nudissima Andromédē incatenata al suo scoglio darà modo al giovane eroe di cominciare a pensare a una discendenza...
Ma vi è anche una terza localizzazione del Kpos Hesperídōn: nell'estremo settentrione della terra, ed è questa la versione fornita da Apollódōros il quale,
dopo aver raccontato il furto del bestiame di Gēryṓn,
passa alla ricerca dei krýsea mla delle Hesperídes
e, cercando di variare l'itinerario del viaggio, abbraccia la variante boreale, arrivando al punto di duplicare la catena africana dell'Atlante nella terra degli Hyperbóreoi:
| [I frutti delle Hesperídes] non si trovavano, come alcuni hanno detto, in Libýē, ma sull'Átlas tra gli Hyperbóreoi, ed erano i doni che G aveva fatto a Zeús quando aveva sposato Hḗra. | | Apollódōros: Bibliothḗkē [II: 5] |
Nel racconto di Apollódōros, che tra
quelli che ci sono pervenuti è il più completo e coerente, una volta giunto nella terra degli Hyperbóreoi, Hērakls trova Átlas che sostiene il cielo sulle sue spalle, e lo sostituisce nell'ingrato compito il tempo necessario affinché questi vada a prendere per lui i frutti d'oro nel
Kpos Hesperídōn. Questa vicenda è anche riportata, tra gli altri, da
Euripídēs, che localizza Átlas «sotto il centro del cielo»:
| Fra le vergini che
cantano là negli orti delle Hesperídes, per afferrare piombò
quel bel frutto dorato da foglie di melo
e uccidere quel fulvo serpente vigile
custode, in spire attorto.
Entrò fin laggiù, nel fondo pelago
a infondere, in chi remiga, serena calma.
Sotto il centro del cielo
quindi punta le braccia,
nella casa di Átlas,
sedi astrali di dèi, la sua
forza umana sostenne. |
Euripídēs: Hērakls |
Meno chiaro è capire come possa il mitico giardino, etimologicamente legato all'occidente e al tramonto, essere stato traslato nell'estremo nord. Una possibile risposta
potrebbe derivare da una considerazione astronomica: il luogo più ovvio dove Átlas sia posto a sorreggere il cielo non può trovarsi nell'estremo occidente, come afferma Hēsíodos,
ma sotto il polo celeste, a settentrione. Se così è, i mitografi, d'accordo con gli astronomi, hanno agguantato il possente
titán e, a dispetto della sua mole, gli hanno cambiato residenza. Questa rivoluzione
sembra aver avuto l'effetto di spostare tutto il tragitto di Hērakls,
lasciando tracce profonde nel groviglio di tradizioni incoerenti che ci sono pervenute. Parte del primitivo tragitto occidentale di Hērakls è stato dirottato sull'érgon gerioneo; un'altra parte è stata duplicata e alterata in modo che l'eroe potesse volgere i suoi passi a nord.
Almeno questa è l'impressione generale. Ma non ci stupiremmo se,
al contrario, proprio la versione boreale sia la più antica. Dunque, riassumendo le varie versioni, il
Kpos Hesperídōn è localizzato: - in una terra oltre il fiume Ōkeanós, presso il luogo dove il sole tramonta, nell'estremo occidente del kósmos;
-
presso l'óros Átlas, in Libýē, nell'estremo occidente della terra abitata
o oikouménē;
- nella terra degli Hyperbóreoi, nell'estremo settentrione,
in prossimità del polo celeste.
Ma affronteremo poi i dettagli di questa rivoluzione «copernicana». È ora di prendere il nostro forzuto campione, di certo il più arcaico degli eroi greci, e cominciare a distinguere quali tratti della sua figura nascondano degli elementi del mito di Gilgameš. |
| GILGAMEŠ ED HĒRAKLS: DUE EROI A CONFRONTO Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, mentre l'epopea di Gilgameš ritornava alla memoria dell'umanità dopo un oblio di duemila anni, i filologi cominciarono a rilevare i punti di contatto che l'epopea mesopotamica suggeriva tanto con i testi biblici, tanto con l'epica classica. Ciò che gli archeologi portavano alla luce dai loro scavi nei tilāl ˓irāqeni erano versioni parallele, certamente più antiche, sia delle ben note vicende bibliche, sia degli usuali miti classici su cui si credeva non vi fosse nient'altro da aggiungere, ma che ora, nel confronto con il mito mesopotamico, proiettavano ombre di cui non si era mai sospettata l'esistenza. Eppure l'atteggiamento degli studiosi di fronte al nuovo materiale non fu sempre positivo. Sebbene fosse divenuto possibile contestualizzare la Bibbia nell'ambito della riscoperta letteratura dell'antico Vicino Oriente, vi fu (e c'è ancora) chi cercò di difendere il primato morale e letterario delle sacre scritture.
Per quanto possa apparire strano, una resistenza di questo genere si verificò anche nella comparazione con la cultura greca, la cui «purezza» fu strenuamente difesa da molti classicisti. La presenza di forti radici medio-orientali nel mito ellenico stentò parecchio a farsi strada presso gli specialisti. Certo, non si poteva negare che molti dettagli del mito di Hērakls avessero già avuto una loro più antica formulazione nella storia di Gilgameš. Lo scontro del re di Uruk contro il toro celeste e i leoni del deserto aveva un parallelo in due delle fatiche di Hērakls; la lotta tra Gilgameš ed Enkidu richiamava (forse) quella tra Hērakls ed Antheús; la strana scena di Gilgameš che attraversa in barca le acque della morte, usando i suoi vestiti come una vela, era un doppione sputato della strana variante riferita da Servius Honoratus, dove Hērakls naviga verso
Erýtheia usando a mo' di vela la sua pelle di leone (Scholia in Vergilii Aeneidem [VIII, ]). Tuttavia, nessuno specialista aveva mai avanzato l'ipotesi di una omologia profonda e consistente tra il mito del re urukita e quello dell'eroe ellenico: ci si accontentava di segnalare una lista di episodi «minori» che sembravano essersi trasmessi dal mondo mesopotamico a quello ellenico. Questi episodi similari erano interpretati come frammenti erratici di antiche epopee medio-orientali o mediterranee, irrimediabilmente scisse dai racconti originali e venute a incagliarsi in questo o quel punto del ciclo greco di Hērakls. Questa spiegazione è tuttora considerata sufficiente: d'altra parte, l'ipotesi di un'omologia tra Gilgameš ed Hērakls cozza contro la distanza ideologica tra i due personaggi, i quali paiono muoversi in direzioni diametralmente opposte. Il primo, un eroe tragico che ambisce all'immortalità, beffato dall'intervento di un serpente; il secondo, un eroe epico, che i serpenti li strangola nella culla e che, alla fine di una carriera di viaggi e avventure, viene reso immortale suo malgrado. Si aggiunga che il mito classico è parte integrante della nostra cultura: è difficile scrollarci di dosso le fisionomie degli dèi e degli eroi greco-romani, acquisite in venticinque secoli di poesia, teatro, pittura, scultura, romanzi, cinema,
cartoni animati e libri per ragazzi. Non è facile decostruire vicende che abbiamo assorbito per osmosi insieme alla nostra stessa cultura, e che conosciamo in maniera talmente intima da non riuscire più a intravederne lo stampo originario. Come abbiamo più volte sottolineato, un tema mitico, trasferito da un popolo all'altro, o ereditato da una cultura di substrato, può mutare fino a rendersi quasi irriconoscibile. Individuare dei singoli temi è abbastanza facile (il serpente e la pianta dell'immortalità; la lotta contro il
serpente/drago; la navigazione sulla barca del sole...). Assai più difficile è individuare schemi dettagliati e complessi in cui a ogni punto in un mito corrisponda un punto simmetrico in altro. Ma solo
così possiamo individuare la metamorfosi di un racconto attraverso il tempo e lo spazio, distinguere quei temi che, mutate le ideologie di base, sono andati trasformandosi o, addirittura, capovolgendosi.
Attenzione. Non stiamo sostenendo un'omologia «forte» tra Gilgameš ed Hērakls: è evidente che i personaggi abbiano un'origine
affatto differente. La nostra ipotesi è che alcuni dei più importanti racconti del ciclo di Hērakls siano stati disegnati sugli schemi del medesimo mito della ricerca dell'immortalità che ha animato l'epopea di Gilgameš.
Tale ipotesi richiede però un'ulteriore precisazione: a quali
livello di sviluppo del ciclo del lugal sumerico dobbiamo
fare riferimento? Lo Ša naqba īmuru
è una composizione letteraria neoassira, risalente – nella sua
versione definitiva – al 700 a.C. In quest'epoca il ciclo di Hērakls
si era già formato. Analizzando il ciclo di Gilgameš,
dobbiamo dunque sforzarci di filtrare quegli elementi che potrebbero
essere un'innovazione del poema ninivita, lo Ša naqba īmuru,
e concentrarci, dove possibile, sui testi più antichi. Le analisi
che seguono ci aiuteranno in questo lavoro.
Il protagonista
Soffermiamoci su quello che potremmo chiamare il character design di Gilgameš ed Hērakls. A prima vista possono comparire delle differenze incolmabili: il primo è un sovrano ossessionato dalla paura della morte; il secondo un eroe ridotto in servitù
che non ha paura di nulla. Tuttavia, se andiamo ad analizzare i due personaggi a una risoluzione più sottile, si rivelano alcune precise affinità. La natura di Gilgameš ed Hērakls, ad esempio, non è interamente contenibile nella definizione di «umanità», ma straborda. Quando Gilgameš fa la sua comparsa, stanco ed emaciato, dal deserto, i due uomini-scorpione si guardano l'un l'altra. Dice il maschio: “chi arriva a noi è carne degli dèi” [šá il-li-kan-na ši UZU(=šīr) DIIR(=ilī) zu-mur-šu]; ribatte la femmina: “costui è per due terzi dio ma un terzo è uomo” [šit-ta-šu DIIR(=ilum)-ma šul-lul-ta-šú a-me-lu-tú] (Ša naqba īmuru [IX: | ). Gilgameš avrebbe dunque le carte quasi in regola per ambire a un
seggio nel consesso degli dèi. Ma nonostante egli si avvicini alla divinità più di ogni altro
uomo, quel terzo di natura umana condanna Gilgameš al comune destino di
tutti i mortali. Il suo dolore per la morte di Enkidu passa attraverso un riconoscimento dei propri limiti, limiti che egli misura con
la consapevolezza del suo essere quasi un dio e che, per questa ragione,
non può accettare. Come Gilgameš, anche Hērakls ha una parte preponderante di carne divina.
Ma anche in una mitologia come quella greca, dove tutti i maggiori eroi sono stati generati dal connubio tra un dio e una mortale (più raramente una dea e un mortale), la superiorità di Hērakls rispetto agli altri hēmítheoi è spesso sottolineata. Zeús aveva triplicato la lunghezza della notte trascorsa con Alkménē affinché il figlio
generato da quelle nozze fosse il più possente di tutti gli eroi. Ma alle fine anche il vantaggio di nascita di Hērakls si rivela insufficiente, sebbene sotto un profilo differente da quello di Gilgameš: il trono di Tíryns e Mikḗnē, a cui Zeús lo ha destinato, viene assegnato a Eurysteús, la cui nascita è stata affrettata
da Hḗra. Queste scelte letterarie sono spiegate dal fatto che il mito di Hērakls è
naturalmente orientato verso l'apoteosi. Sebbene gli antenati degli Elleni avessero riletto l'intero ciclo del dio-tuono indoeuropeo in forma di carriera eroica, avevano comunque mantenuto un posto a Hērakls nel pántheon e nel culto. Questa schizofrenia – di cui troviamo traccia nel
duplice destino dell'eroe, in Odýsseia [XI: -] – rende inevitabile l'apoteosi finale dell'eroe e impedisce a Hērakls un percorso tragico simile a quello di Gilgameš. Per tale ragione, gli episodi che nell'epopea mesopotamica erano legati a un'estenuante ricerca dell'immortalità, vengono qui adattati
a un diverso contesto. Il mito presenta Gilgameš ed Hērakls come due eroi quasi sulla soglia della divinità, ma non abbastanza per poter godere dei diritti a cui sono stati (o sentono di essere stati) destinati. Gilgameš è un possente lugal («grande uomo», re), ma
gli dèi gli hanno negato l'immortalità; Hērakls, a cui le esigenze del mito e del culto hanno assegnato un destino di immortalità, si vede negare la regalità da Hḗra. Come si vede, una stessa dinamica di base, associata a diversi contesti ideologici, ha prodotto un'inversione dei motivi mitici.
| | Regalità | Immortalità | | Gilgameš | Concessa dagli dèi | Negata dagli dèi | | Hērakls |
Negata da Hḗra | Concessa dagli dèi |
L'avversaria Il dramma centrale che cambia la vita di Gilgameš è dovuto al modo offensivo con cui tratta Inanna/Ištâr:
è la dea a inviare Gudanna, il toro del cielo, la cui uccisione provoca –
come contrappasso – la morte di Enkidu. Di fronte a questo lutto, che lo mette di fronte alla propria natura e mortalità, Gilgameš scende dal trono e, vestito di una pelle di leone, si avventura nel deserto alla ricerca della vita. Analogamente, la carriera eroica di Hērakls è segnata dal suo rapporto conflittuale con Hḗra, regina del cielo. È la dea a fare impazzire Hērakls, il quale, nel trovarsi di fronte i
corpi dei figli da lui stesso uccisi, anch'egli in pelle di leone si consegnerà – nella versione di Apollodórōs – in servitù per dodici anni a Eurysteús. Il ruolo della dea
avversaria, nelle carriere di Gilgameš ed Hērakls, sebbene si esplichi in maniera
diversa, è fondamentale nel provocare un lutto che è anche una crisi: dinanzi alla morte di Enkidu, o
ai corpi dei propri figli, sia Gilgameš che Hērakls rinunciano alla
loro vita e intraprendono – direttamente o indirettamente – l'avventura eroica che li porterà ai confini del mondo. La ragione dell'ira
di Ištâr, nell'epopea ninivita, è
lo sprezzante rifiuto di Gilgameš
alle sue profferte amorose (Ša naqba īmuru [VI: -]).
A questo tema – che sembra però un escamotage letterario, al fine di elencare
i molti amanti della dea,
in un'esibizione di sapienza mitologica sul filo di Madamina il catalogo è questo – corrisponde però, nei testi sumerici, un motivo affatto diverso: per quanto i testi non siano chiarissimi,
l'impressione è che Inanna abbia rifiutato delle
precise richieste da parte di Bilgames insieme ai doni che
l'en le aveva offerto. L'interpretazione degli studiosi è che
Bilgames avesse preteso più poteri e competenze di quanti gli spettassero, vista la
ferma, secca risposta della dea:
am-u₁₀ lú-u₁₀ ME.EN.NE.EN šu nu-ri-bar-re
en gilgaméš am-u₁₀ lá-u₁₀ NE
šu nu-ri-bar-re
é-an-na-ka di kud-dè šu nu-ri-bar-re
i₆-par₄ kug-á ka-aš bar-re šu nu-ri-bar-re
é-an-na an-né ki á di kud-dè šu nu-ri-bar-re
gilgaméš za-e ù-NE ḫé-me-en za-e gud ḫé-e | “Il mio bestiame, di qualunque specie esso sia, non ti concedo;
en Bilgames, il mio bestiame, di qualunque specie esso sia,
non ti concedo;
di giudicare nell'Eanna non ti concedo;
di dare ordini nel mio santo ipar non ti concedo;
di giudicare nell'Eanna che An ama non ti concedo;
o
Bilgames che tu sia... che tu sia...” | | Šul meka šul meka [B, -] |
Le due varianti
attestate nella tradizione mesopotamica, la gelosia offesa e il conflitto di competenze, sembrano entrambe presenti nel ciclo di Hērakls, sebbene in maniera adattata al carattere di Hḗra. Nella forma a noi pervenuta del mito ellenico, infatti, la fedeltà coniugale di Hḗra non viene mai messa in discussione. Il re e la regina degli dèi si muovono in direzioni
opposte: tanto Zeús estende il suo desiderio a legioni di amanti immortali e mortali, tanto Hḗra, di contrasto, difende il principio di monogamia (l'unica volta che le capiterà di avere un figlio, Hḗphaistos, senza concorso del marito, sarà per partenogenesi). Nel ciclo di Hērakls, il rifiuto da cui scaturisce lo sdegno di Hḗra è in realtà dovuto a Zeús, che le preferisce il letto di Alkménē, e questo provoca l'inimicizia tra la dea ed Hērakls. Ma allora, si dirà, perché sostituire alla lussuriosa Ištâr
proprio la morigerata Hḗra? Effettivamente, nell'interpraetatio graeca,
la grande dea medio-orientale era di solito identificata con Aphrodítē, con la quale condivideva il carattere appassionato e libertino.
Quella di Inanna/Ištâr era
tuttavia una figura dalle funzioni piuttosto diversificate: spacciarla per
una smeplice «dea dell'amore» è piuttosto riduttivo. Già il suo nome sumerico,
NIN.AN.AK,
la «regina del cielo», le conferisce una sorta di regalità celeste che la porta
al livello di Hḗra; dea astrale legata al pianeta Venere, Inanna/Ištâr
viene a diventare, in epoca assira, una dea della guerra.
| | Mesopotamia | Grecia | | Regalità celeste | Inanna/Ištâr | Hḗra | | Sensualità | Aphrodítē |
Il fatto che, nel ciclo di Hērakls, sia Hḗra a interpretare la parte che era stata di Inanna/Ištâr nel ciclo di Gilgameš,
è forse un'indicazione del fatto che il mito ellenico debba venir
confrontato non tanto sullo Ša naqba īmuru,
ma sulle versioni più antiche dell'epopea gilgamešaica. Nel mito
greco, infatti, il dissidio tra l'eroe e la dea si basa su un
conflitto di competenze. I litigi tra Zeús ed Hḗra sono spesso di natura politica: capita che il re e la regina degli dèi parteggino per partiti avversi. Hḗra, inoltre, è spesso gelosa, oltre che delle amanti, anche dei poteri e delle prerogative di Zeús.
Ora l'Árgolis era una regione che apparteneva alle tímai di Hḗra, la quale vi era particolarmente venerata con l'epiteto di Hḗrē Argeíē.
Il tempio principale della dea, il Hēraîon Árgous, si trovava tra Mikḗnē e Mídeia, proprio al centro del
territorio di cui, secondo il decreto di Zeús, Hērakls era destinato a diventare re. Come Inanna/Ištâr era la dea poliade di Uruk, Hḗra lo era dell'Árgolis. Così, mentre
Bilgames cerca di ottenere maggiori poteri a discapito di quelli di Inanna, Zeús mette suo figlio Hērakls a regnare su un territorio appartenente a sua moglie, di fatto usurpandoglielo. Adesso capiamo meglio la reazione di Hḗra, e anche perché la dea si
sia affrettata a provocare la nascita prematura di Eurysteús, così da dargli diritto, al posto di Hērakls, di salire al trono di Tíryns e Mikḗnē. Ma il confronto tra Inanna/Ištâr ed Hḗra ci consegna anche altre analogie, sebbene meno importanti. In Mesopotamia è Ištâr a richiedere che Gudanna, il toro celeste, venga scatenato contro la città di Uruk, che ne viene devastata. Nel mito greco, quando Hērakls cattura il toro cretese e lo trascina da Eurysteús, questi lo dedica proprio a Hḗra, la dea poliade dell'Árgolis, la quale, sdegnata, fa infuriare l'animale e lo manda a devastare la piana di Marathṓn, nell'Attikḗ. Il toro, in seguito, verrà catturato e ucciso da Thēseús. Il gesto irriverente di Enkidu, che scaglia la coscia del toro contro il volto di Ištâr, potrebbe avere una relazione con lo scocco di freccia che Hērakls vibra ad Hḗra nel corso dell'assedio di Pýlos: il colpo la ferisce al seno destro e, poiché le frecce di Hērakls erano intinte nel sangue dell'hýdra, le produce una ferita insanabile (Ilías [V: ]): ma
su quest'ultimo punto il terreno delle comparazioni si fa piuttosto fragile
e non insistiamo oltre. Detto tutto questo, il rapporto tra Hērakls ed Hḗra rivela dettagli piuttosto contraddittori. Il più esplicito è che l'eroe, che di nascita faceva Alkídēs, sia conosciuto con un nome teoforo legato a quello della sua acerrima nemesi: Hērakls, «gloria di Hḗra»,
per spiegare il quale sono stati spesi fiumi di inchiostro. Kerényi nota che gli artisti antichi decoravano i templi di Hḗra con immagini delle dodici «fatiche» (ad esempio a Paestum), segno che
dopotutto le imprese di Hērakls
erano gradite alla regina degli dèi. Né si può ignorare che fu la stessa Hḗra ad allattare il piccolo Hērakls. Secondo i mitografi, Alkménē, temendo la gelosia di Hḗra,
aveva esposto Hērakls neonato in un campo subito fuori le mura di Thbai. Poco dopo
erano passate di là, su consiglio di Zeús, Hḗra e Athēnâ. Raccogliendo quel
magnifico bimbo, Hḗra sconsideratamente gli
aveva porto il seno. Hērakls vi si
era aggrappato con tanta forza che la dea, gemendo di dolore, lo
aveva strappato da sé. Un getto di latte era arrivato nel firmamento
creando la striscia argentea della Via Lattea. Intanto, però, quel latte divino aveva reso Hērakls immortale (Diódōros Sikeliṓtēs: Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 9, ] | Hyginus: De Astronomia [II: 43]). Secondo un'altra versione,
tutto questo sarebbe avvenuto sull'Ólympos, nella sede stessa degli
dèi, come ci informa l'astronomo Eratosthénēs:
| | Non era possibile ai figli di Zeús avere parte agli onori del cielo, se non avevano succhiato il seno di Hḗra. Per questo si racconta che Hērms trasportò Hērakls sull'Ólympos, dopo la sua nascita, e lo attaccò al seno di Hḗra e quello succhiò. Quando se ne accorse, la dea lo respinse, e il latte in più, versato in questo modo, costituì il cerchio della Galaxías. | | Eratosthénēs: Katasterismoí [44] |
Da queste note trapelano molti importanti segnali. I mitografi greci stanno evidentemente cercando di adattare un antico mito, dove i rapporti tra la dea e l'eroe sembrano essere più quelli di una madre nei confronti del figlio, a un sistema più recente dove Hḗra ed Hērakls sono acerrimi nemici. A un livello più antico,
affiora qui l'ercole tirrenico, il dio che gli Etruschi chiamavano
Hercle Unial Clan, «figlio di Uni». Costei altro non era che la Iuno romana. Così si profila l'immagine, paradossale, di un antico «Hērakls» figlio di «Hḗra»? La questione non è tanto semplice: Hḗra è una dea di substrato, sicuramente preellenica che, nello sviluppo della mitologia greca, finì con il sostituire e l'occupare il ruolo dell'originaria paredra
e controparte femminile di Zeús, Diṓnē (la quale corrisponde etimologicamente a Iuno/Uni)
①▼. Si scorge dunque, in controluce, di una situazione originaria dove l'antico dio-tuono «Hērakls» era figlio del dio-cielo Zeús e della sua sposa Diṓnē? È un'ipotesi ragionevole,
sebbene non vi siano prove; la successiva sostituzione di Hḗra a Diṓnē, con il parallelo declassamento di Hērakls (anche in base alle riletture operate dal materiale che arrivava dal Medio Oriente) potrebbe aver provocato la situazione contraddittoria attestata in età classica: l'«eroe» Hērakls a cui veniva attribuito un culto divino, e la dea Hḗra, acerrima nemica dai tratti a volte stranamente «materni»
| | GILGAMEŠ ed INANNA/IŠTÂR | HĒRAKLS ed HḖRA | | 1 | Inanna/Ištâr è la dea poliade della città di Uruk. | Hḗra è particolarmente venerata nell'Argolís. | | 2a | Gilgameš cerca di accrescere il suo potere su Uruk a spese di quello di Inanna, la quale diviene sua implacabile
avversaria. | Zeús decreta che suo figlio Hērakls diventerà re di Tíryns, Mikḗnē e Mídeia, a spese di Hḗra, la quale reagisce e pone invece sul trono Eurysteús. | | 2b | Sdegnata da Gilgameš, Ištâr diviene sua implacabile
avversaria. | Tradita da Zeús con Alkménē, Hḗra diviene implacabile
avversaria di Hērakls. | | 3 | Su ordine di Inanna/Ištâr, Gudanna, il toro del cielo, irrompe infuriato nella città di Uruk, devastandola. L'animale viene ucciso da Gilgameš ed Enkidu. | Hḗra fa infuriare il toro di Krḗtē – che Hērakls ha catturato ed Eurysteús le ha dedicato – e lo manda a devastare la piana di Marathṓn. Il toro verrà catturato e ucciso da Thēseús. | | 4 | Dopo questi fatti, il consiglio divino decreta la morte di Enkidu: il lutto causerà la crisi attraverso la quale Gilgameš partirà per il suo viaggio alla ricerca della vita. | Hḗra fa impazzire Hērakls, il quale uccide i suoi figli. È questa la crisi decisiva per l'eroe, il quale si metterà agli ordini di Eurysteús che gli imporrà le dodici «fatiche», tra cui la ricerca dei pomi delle Hesperídes. |
Il gemello/compagno e la crisi esistenziale
La relazione tra Gilgameš ed Enkidu costituisce una difficoltà non facilmente superabile per quanto riguarda l'ipotesi di un'eventuale relazione con il mito di Hērakls. Certamente, non si può pretendere che il mito greco abbia adattato in toto ogni motivo dello schema del mito di Gilgameš; ma tentare di scoprire cosa sia accaduto a Enkidu potrebbe essere un interessante esercizio intellettuale. Gli studiosi hanno cercato di stabilire quale tipo di rapporto intercorresse tra Gilgameš ed Enkidu. I due personaggi sono presentati molto simili l'uno all'altro: quando Anu ordina ad Aruru di creare Enkidu, chiede che possa fungere da perfetto rivale di Gilgameš:
ai-ti a-ru-ru tab-ni[i LÚ(=amēla)]
⌜e⌝-nin-na bi-ni-i zi-kir-šú
ana u₄-um lìb-bi-šú lu-u ma-ḫ[ir]
liš-ta-an-na-nu-ma uruk liš-tap-š[iḫ] | Proprio tu, o Aruru, che hai creato [l'uomo],
crea ora la sua controparte:
che egli sia pari alla tempesta del suo cuore,
sì che essi contendano e che Uruk possa riposare | Ša naqba īmuru [I: -] |
Gilgameš ed Enkidu diventano inseparabili compagni. «L'amico mio, che amo sopra ogni cosa, che ha condiviso con me ogni sorta di avventure» [ib-ri šá a-ram-mu- šú dan-niš it-ti-ia ittallaku ka-lu mar-ṣa-a-ti] (Ša naqba īmuru [X: ]), così Gilgameš definisce Enkidu, e ancora: «l'ascia del mio fianco, la spada della mia cintura, lo scudo del mio petto, i miei ornamenti festivi, la mia cintura regale» (Ša naqba īmuru [VIII: -]). È una relazione di compagnonnage, quella tra i due sodali, come a volte si instaura tra un eroe e il suo compagno prediletto nell'epica universale, ma c'è anche una somiglianza fisica tra Gilgameš ed Enkidu, creati dagli dèi, per così dire, con la stessa creta: si riflettono l'un l'altro, speculari e simmetrici. Quando Enkidu arriva in città, la gente esclama: «Egli è simile nella figura a Gilgameš! In statura gli è inferiore ma le ossa sono più forti» [a-na-mi GIŠ ⌜ma⌝-ši-il pa-ID(=da)-tam la-nam [š]a-pi-il ⌜e-ṣe-em-tam⌝ [pu-u]k-ku-ul] (AB Šūtur eli šarrī [P: -]). E quando il lugal di Uruk si trova davanti Enkidu, ne riceve un'impressione assai esplicita: «per Gilgameš era stato posto un sostituto simile a un dio» [a-na GIŠ-gín-maš ki-ma DIIR(=ili) šá-ki-i[š-š]ú pu-ḫ[u]] (Ša naqba īmuru [II: ] | cfr. AB Šūtur eli šarrī [P: -]). Nella lotta, è Gilgameš a piegare il ginocchio, ma Enkidu lo riconosce re per volere degli dèi. Alcuni studiosi hanno anche avanzato l'ipotesi di una relazione omosessuale tra i due campioni, suggerita peraltro alla fine della tavola I, dove Ninsun interpreta il sogno di Gilgameš e, annunciandogli l'arrivo di Enkidu, ripete più
volte la frase «lo amerai come una donna, abbracciando e accarezzandolo» [⌜ta-ram-šu⌝-ma GIM(=kīma) DAM(=aššati) ta-ḫab-bu-bu UGU(=eli)-šú] (Ša naqba īmuru [I: = ]). Nell'epopea non ci sono altre indicazioni che facciano pensare a un risvolto sessuale nella relazione tra Gilgameš ed Enkidu, ma non conosciamo abbastanza le dinamiche dell'amicizia o dell'amore virile in epoca paleo-babilonese per dare una risposta a questo interrogativo. Viene anche detto che Gilgameš
vuole presentare Enkidu alla madre affinché lo riconosca come suo figlio; questo avviene nella tavola II, ma le lacunae del testo non permettono di capire bene cosa sia accaduto: il successivo disappunto di Enkidu fa pensare che la proposta sia stata respinta. Gilgameš non cessa tuttavia di chiamare Enkidu «fratello», oltre che «amico». Alcuni studiosi hanno ipotizzato un collegamento con il tema di Akhilleús e Patróklos nell'Ilías. Effettivamente abbiamo anche qui un rapporto intimo tra un eccellente guerriero e il suo giovane compagno, e uno straziante racconto del dolore dell'uno quando l'altro cade in combattimento. Il costume greco dell'efebato – dove un guerriero più vecchio ed esperto prendeva un ragazzo sotto la sua ala protettrice, utilizzandolo come compagno, scudiero e amante [erṓmenos] – spiega alcune delle divergenze tra la coppia omerica e quella mesopotamica, in particolare la differenza di età tra i due sodali, che nel mito greco è piuttosto marcata. Sebbene Enkidu sia stato creato da poco, quando incontra Gilgameš, i due manifestano pari sviluppo e simile forza: il loro rapporto – che pure vede in Gilgameš l'elemento dominante – non è mai sbilanciato come quello tra Akhilleús e Patróklos. Inoltre il parallelo tra la morte del sodale nello Ša naqba īmuru e quella nell'Ilías cede dal punto di vista funzionale. La morte di Enkidu costringe Gilgameš a mettere in discussione la propria esistenza: è la crisi che lo porterà ai confini del mondo alla ricerca della vita. Lo smarrimento universale di Gilgameš è ben lontano dal dolore di Akhilleús, il quale non si solleva di un palmo dal fatto che abbia semplicemente perso il proprio éphebos. Il dolore dell'eroe, nell'epopea omerica, rimane assai circoscritto e non si solleva mai al di sopra del formalismo letterario. La sua raison d'être è inoltre piuttosto diversa: serve a provocare in Akhilleús quell'«ira funesta» che porterà il principe Héktōr alla sua tragica morte.
Il rapporto tra Gilgameš ed Enkidu non ha nulla a che vedere con quello di Akhilleús e Patróklos.
Detto questo, è altrettanto arduo, nel ciclo di Hērakls, vedere l'eroe stringere una relazione tanto
critica con un compagno. Tra i vari sodali che lo accompagnano nelle sue imprese bisogna analizzarne due: Iphikls e Iólaos. Iphikls è il fratello gemello di Hērakls, partorito da Alkménē poche ore più tardi. Pur avendo la stessa madre, i due gemelli hanno padre differente: Hērakls è infatti figlio di Zeús, Iphikls di Amphitrýōn. Quando Hḗra spedisce i suoi serpenti nella stanza dove
dormono i due pargoli, è il piccolo Hērakls a ucciderli, non certo Iphikls:
e si dice che
è in quell'occasione che Amphitrýōn scopre quale dei figli sia suo e quale di Zeús. Nelle mitiche coppie gemellari, di solito i due gemelli hanno o acquistano una natura differente. Ciò che distingue Gilgameš ed Enkidu è che il primo è investito di melāmmu, «gloria regale», per volontà degli dèi, mentre il secondo viene creato per contrapporsi al primo unicamente sul piano fisico: sebbene lo vinca in una prova di forza, ne riconosce la superiorità regale. Nel caso di Hērakls e Iphikls, l'uno esprime i suoi geni divini con la capacità di compiere imprese sovrumane; l'altro non può che muoversi nel comune ambito della normale umanità. Lo iato tra i due gemelli è dunque in un quid presente nel membro principale e assente nel suo complementare: a distinguere Gilgameš da Enkidu è il melāmmu, a distinguere da Hērakls e Iphikls è la natura divina.
Ciò che manca al mito di Hērakls è l'episodio drammatico della morte del sodale. Alcune sbrigative fonti ci informano che Iphikls fu al fianco di Hērakls in alcune delle sue imprese e cadde nella battaglia contro Hippokóōn (Apollódōros: Bibliothḗkē [II: 7]) o contro i Molionídēs (Pausanías: Periḗgēsis [VIII: 14, ]), ma se in qualche
antemito si narrava del dolore di Hērakls per la morte del gemello, non ci è pervenuto.
②▼
Se Iphikls scompare, annullato dalle oscure necessità del mito, è però suo figlio Iólaos a trovarsi al fianco di Hērakls in alcune delle sue principali imprese. La sostituzione di Iphikls con il figlio è forse dovuta, ancora una volta, alla volontà di ricondurre la relazione tra i due sodali a un rapporto di efebato, il quale necessita l'affiancamento di un
guerriero esperto e maturo con un compagno più giovane, cosa ovviamente impossibile se i due sono gemelli. Possiamo dunque considerare Iphikls e Iólaos come un unico personaggio,
poi «ringiovanito» tramite sostituzione del padre con il figlio.
Il rapporto anche di natura sessuale tra Hērakls e Iólaos, l'erastḗs e l'erṓmenos, è di frequente sottolineato dai testi greci. Anche qui, però, non vi è alcuno schema che preveda una crisi scatenata dalla morte di Iólaos. Anzi, dei due, è proprio Hērakls a morire per primo. Secondo una tradizione, fu Iólaos ad accendere la pira funebre dello zio.
③▼
Le considerazioni fatte fin qui partono tuttavia dall'idea che il
mito del lutto di Gilgameš per la
morte di Enkidu sia un elemento antico
e fondamentale del ciclo mesopotamico del lugal di Uruk e che
se ne debba trovare una traccia nel mito ellenico (di Hērakls
o, come hanno proposto altri, di Akhilleús).
In realtà, nulla vieta che tale vicenda non possa essere
un'elaborazione letteraria relativamente recente. La crisi di
Gilgameš per la morte del compagno
è infatti centrale nello Ša naqba īmuru,
è attestata in alcune versioni medio-babilonesi: nella tavoletta di
Ur, nel frammento di Meîddô e in uno dei frammenti di Ḫattuša/Böğazköy
(MB [U | M | Böğ₁]);
era sicuramente conosciuta anche in Anatolia, visto che è attestata
nella versione ḫittita dell'epopea (Ḫ).
Inoltre la vicenda era conosciuta anche nelle versioni
antico-babilonesi, visto che nella tavoletta di Berlino/Londra,
Gilgameš parla di come la morte di
Enkidu abbia scatenato in lui la paura
della morte (AB [B/L: ii
'-' | iii: ]). Risaliamo così
almeno alla prima metà del Secondo millennio avanti Cristo, ed è
effettivamente un'epoca abbastanza antica perché la vicenda di
Gilgameš, arrivata in occidente
per tramite anatolico, abbia potuto influenzare i miti ellenici.
Tuttavia, se torniamo ancora un po' indietro, in epoca sumerica, la
vicenda della morte di Enkidu, attestata nel poema
Ud rea ud sudra rea (che
peraltro è argomento della tavola XII
dell'epopea ninivita), è profondamente diversa dalla versione
accadica. Enkidu scende nell'Arali
per recuperare il pukku e il mekku (qualunque cosa
siano) perduti da
Bilgames al «pianto di una fanciulla», ma viola
le leggi degli inferi e ne rimane prigioniero. In seguito,
Bilgames riesce a richiamare l'ombra
dell'amico dalle profondità del Kur, ed
Enkidu gli fornisce un desolante
panorama del destino degli uomini dopo la morte.
Sembra dunque che il mito della crisi scatenata in
Gilgameš dalla morte di
Enkidu sia stato elaborato in epoca
accadica. Possiamo dunque chiederci quale fosse la forma del mito su
cui sia stata modellata la vicenda di Hērakls:
si tratta di una versione già accadizzata del ciclo di
Gilgameš, risalente al Secondo
millennio avanti Cristo (e in questo caso, sì, potremmo aspettarci
di trovare un episodio critico della morte del compagno), o si
tratta di un mito anteriore, ancora più antico, sul quale sono state
modellate tanto la versione accadica del mito di
Gilgameš quanto il ciclo di
Hērakls? Se così è,
potremmo aspettarci di trovare una diversa versione della crisi che
spinge l'eroe alla ricerca dell'immortalità.
 | | Hērakls
uccide i suoi figli (✍ 1799) | |
Antonio Canova (1757-1822), olio su carta. |
Nel mito ellenico, infatti, la crisi definitiva, quella che abbatte le sicurezze di Hērakls e lo consegna nelle mani di Eurysteús, dando l'avvio al ciclo delle «fatiche»,
non consiste nella morte di Iphikls e/o Iólaos,
ma nell'orribile episodio dell'uccisione dei propri figli. Il legame tra l'infanticidio commesso da Hērakls e la servitù a cui
è condannato presso Eurysteús non ha
tuttavia una tradizione decisa. Nella tragedia di Euripídēs,
ad esempio, l'uccisione dei figli viene compiuta dopo il ritorno di Hērakls dal compimento delle «fatiche» (Euripídēs: Hērakls mainómenos; cfr. Hyginus: Fabulae [32]). Károly Kerényi considera tale tradizione più antica e autorevole (Kerény 1963), visto che in onore dei figli di Hērakls si celebravano a Thbai, ogni anno, dei giochi atletici e dei sacrifici (Píndaros: Ísthmia [4, -]; Pausanías: Periḗgēsis [IX: 11, ]). Gli studi folklorici ci insegnano, tuttavia, che molto spesso i miti vengono costruiti ad hoc per giustificare dei riti più antichi. La tragedia di Euripídēs
è un memorabile pezzo di letteratura: è tragica, cruenta,
dolente. Tuttavia troviamo più coerente la tradizione alternativa, secondo la quale il delitto non solo sarebbe avvenuto
prima delle «fatiche» dell'eroe, ma ne sarebbe stato la causa. È la versione di Apollódōros:
| ...[a Hērakls] accadde d'impazzire a causa della gelosia di Hḗra e di scagliare nel fuoco i propri figli, avuti da Mégara, insieme ai due figli di Iphikls. In seguito a ciò [...], recatosi a Delphoí, interrogò il dio sul luogo in cui avrebbe dovuto prendere dimora. Fu allora che la pythía per prima si rivolse a lui col nome di Hērakls (in precedenza veniva chiamato Alkídēs). Essa gli ingiunse di stabilirsi a Tíryns al servizio di Eurysteús per dodici anni, compiendo le dieci fatiche che gli sarebbero state imposte, e predisse che dopo averle portate a compimento sarebbe divenuto immortale. | | Apollódōros: Bibliothḗkē [II: 4, ] |
Nella versione di Diódōros Sikeliṓtēs, Hērakls riceve l'ordine da re Eurysteús di mettersi al suo servizio. Poco convinto, l'eroe si reca a Delphoí
dove però gli viene assicurato che è volontà degli dèi che si
sottometta alle dodici fatiche; ciò fatto, avrebbe ottenuto
l'immortalità. Hērakls viene
però colto dallo scoraggiamento, ritenendo indegno sottomettersi a una persona vile come Eurysteús:
| Dunque, trovandosi egli in grande impaccio, Hḗra gli mandò un furore; egli, inquieto nello spirito, cadde in uno stato di follia. La malattia progrediva e, uscito di senno, Hērakls cospirò per uccidere Iólaos, ma poiché quello fuggì e i figli che aveva avuto da Mégara stavano là vicino, li colpì col suo arco come se fossero suoi nemici. | | Diódōros Sikeliṓtēs: Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 11, ] |
Sia Apollódōros che Diódōros collegano la crisi di Hērakls al compimento delle dodici «fatiche», sebbene Diódōros ne capovolga i termini: è la prospettiva di dover servire il vile Eurysteús a provocare nell'eroe quello stordimento dello spirito che permetterà a Hḗra di indurlo alla follia.
Ciò nonostante, i due mitografi concordano su un fatto forse ancora più importante, sebbene non lo giustifichino in alcun modo: che sia proprio il compimento delle «fatiche» a meritare a Hērakls l'immortalità. Questa nota ci
suggerisce che siamo sulla pista giusta. Il secondo punto interessante è che, in entrambi i casi, la follia di Hērakls è rivolta contro la prole di Iphikls: in Apollódōros tra le vittime vi sono anche due figli di Iphikls; in Diódōros l'eroe vuole uccidere proprio Iólaos, il quale però riesce a fuggire.
È forse un indizio che, in una qualche versione tradita del mito, a venire ucciso
sia stato il fratello o il sodale dell'eroe, e che la sostituzione con il tema dell'uccisione
da parte di Hērakls dei propri figli sia dovuto alla sovrapposizione di una tradizione locale. Altro particolare interessante è che, concluse le «fatiche», Hērakls darà in sposa a Iólaos la sua ex moglie Mégara, poiché la semplice vista di lei
gli causava il doloroso ricordo dei figli che aveva ucciso. È piuttosto interessante questa «doppia» parentela, tanto di sangue quanto acquisita, tra Hērakls e Iólaos. Vorremmo saperne di più sul tentativo di Gilgameš di far adottare il suo «gemello» Enkidu dalla madre Ninsun, sebbene le lacunae dei testi non ci permettano di entrare
nel dettaglio.
Questo motivo potrebbe spiegare la strana parentela tra Sikander
e
Dārā nello
Šāhnāmè di Ferdowsī. I due sono fratelli, essendo figli dello šāhan-šāh Key Dārāb, sebbene con diversa madre. La guerra che
Sikander
muove all'Īrān crea una serie di ripercussioni che provocano
la morte di
Dārā in una congiura di palazzo.
Dārā fa in tempo a morire con la testa sulle ginocchia di
Sikander, ma intanto lo prega di prendere in moglie sua figlia
Rowšanak, nipote del macedone. La struttura, che l'epopea ninivita tiene collegata con una certa coerenza a uno stesso personaggio, Enkidu, nel mito greco
sembra ripartita in uno schema più complesso, dove il sodale (Iphikls e Iólaos)
ha tuttavia un'importanza meno decisiva nell'economia complessiva
della vicenda:
| | GILGAMEŠ |
| HĒRAKLS | | Gemello | Enkidu viene creato da Aruru a somiglianza di Gilgameš; gli è tuttavia inferiore nella funzione regale. |
≈ | Gemelli, Hērakls e Iphikls hanno stessa madre, Alkménē, ma padri diversi: Hērakls ha natura divina essendo figlio di Zeús, Iphikls ha natura umana essendo figlio di Amphitrýōn. | | Sodale | Enkidu è compagno di Gilgameš nelle sue imprese; in particolare la spedizione contro Ḫumbaba e l'uccisione del toro celeste Gudanna. |
≈ | Iólaos (figlio di Iphikls) è compagno di Hērakls in alcune sue imprese; in particolare nell'uccisione dell'hýdra di Lérnē. | | Amante | Il rapporto tra Gilgameš ed Enkidu viene a volte espresso in termini di intimità e tenerezza: ma rimane dubbio che si possa intendere in termini di una relazione omosessuale. |
? | Iólaos è l'erṓmenos di Hērakls. | | Parentela acquisita | Viene fatto un tentativo perché Ninsun adotti Enkidu (?) |
? | Iólaos prende in sposa l'ex moglie di Hērakls, Mégara. | | Crisi | La crisi esistenziale di Gilgameš viene scatenata dalla morte di Enkidu. |
≈ | La crisi esistenziale di Hērakls viene scatenata dall'uccisione dei suoi stessi figli. |
In conclusione, vi è sicuramente un comune
mito alla base tanto del ciclo di Gilgameš
tanto di quello di Hērakls.
Il mito in questione era incentrato su un eroe (un semidio? un
sovrano?) che si muoveva ai confini del mondo alla ricerca di un
modo per sconfiggere la morte: la crisi era stata scatenata
dall'azione, mortale e luttuosa, di una dea avversaria, che aveva
messo il nostro eroe di fronte a una sorta di ingiustizia
esistenziale. La natura della crisi non è ben specificata: un
delitto? la morte di un compagno? Nei prossimi capitoli
cercheremo di definire meglio l'ideologia dell'immortalità che
anima il nostro eroe e le tappe del suo percorso alla ricerca
della vita.
|
①▲
Nonostante fossero state identificate in età classica, Iuno ed Hḗra non sono personaggi omologhi. Vero: l'immagine che abbiamo della Iuno italica dipende in gran parte dal fatto che in epoca classica le è
stato praticamente sovrapposto il carattere e la mitologia dell'ingombrante Hḗra ellenica, tuttavia i nomi delle due dee ci indicano la loro diversa origine. Il nomen Iuno deriva da un antico *Diūno, equivalente femminile di *Diuspater > Iuppiter. La relazione etimologica tra Iuppiter e Iuno è la stessa che in Grecia sussisteva tra Zeús (< miceneo di-we/di-wo) e Diṓnē (< miceneo di-u-ja). Si tratta dei due esiti del dio-cielo, derivato dall'antico *Dyeus ph₂tēr indoeuropeo, pervenuta anticamente tanto in Grecia quanto in Italia, accompagnato da un suo equivalente femminile in qualità di paredra. Ma in Grecia, una complessa interazione con la mitologia di substrato, ha fatto sì che Diṓnē venisse sostituita da una divinità preellenica: Hḗra. Non sappiamo quale parte della mitologia dell'antica
*Diṓnē sia stata ereditata dalla figura classica di Hḗra: nel sistema mitologico a noi noto, Diṓnē è una titanide, ricordata tra le spose minori di Zeús. Parte dell'antico culto è sopravvissuto in epoca classica a Dōdṓnē, dove Zeús veniva ancora associato a Diṓnē. |
| |
|
②▲ L'unico compagno di cui Hērakls avverta la morte con una certa durezza, è Hýlai (o Hýlē), che però è presente solo in un episodio minore, appartenente al ciclo degli Argonaûtai. È proprio per andarlo a cercare che Hērakls abbandona la spedizione di Iásōn alla ricerca del vello d'oro. Tuttavia non ci sembra che questo esempio sia relativo al tema che stiamo trattando. |
| | |
|
③▲ Uno scolio alle Pýthia di Píndaros ci informa che Iólaos uscì dalla tomba per uccidere Eurysteús: episodio in cui si può forse riconoscere, da lontano, il mito della risalita di Enkidu dagli inferi nella tavola XII dello Ša naqba īmuru. Il contesto tuttavia è molto diverso e non è il caso di insistere
troppo su questo punto. |
|
|
| GILGAMEŠ ED HĒRAKLS: L'IDEOLOGIA DELL'IMMORTALITÀ
L'ipotesi che andiamo sostenendo, di un substrato comune al mito
di Gilgameš e a quello di Hērakls ha il suo punto di maggiore divergenza nel motivo della ricerca della vita. Sembra a prima vista una difficoltà insolubile visto il destino praticamente opposto a cui vanno incontro il re mesopotamico e l'eroe ellenico: gli dèi negano a Gilgameš la vita eterna, ma la concedono a Hērakls. Tale distacco è talmente esplicito e sensazionale, e anzi, talmente significativo nella definizione dei due personaggi, da avere in pratica reso irriconoscibile, agli occhi della maggior parte degli studiosi, il fatto che entrambi i campioni si muovano lungo i binari di uno schema comune. Poche voci si sono accorte che tra Gilgameš ed Hērakls le somiglianze erano assai più profonde e decisive di quanto non fossero i punti di distacco. Il fatto che, nello sviluppo e nella trasmissione dei miti, si possano verificare divergenze tanto contrastanti, non è una difficoltà per mitografi, ma piuttosto una ragione di interesse. Quando una civiltà eredita una tradizione di substrato o assimila un mito straniero, deve adattarne gli elementi al fine di incorporarli nei propri schemi ideologici. Tali adattamenti possono anche comportare, nei casi estremi, il completo rovesciamento del senso di un racconto, qualora i valori, la cultura, la teologia del sistema ricevente siano molto diversi rispetto a quelli del sistema di partenza. Tali alterazioni, prese singolarmente, possano rendere arduo il riconoscimento della similarità tra due miti: ma in genere esse non vengono trasmesse
in modo isolato, ma entro schemi narrativi piuttosto complessi, ed è appunto dalla comparazione di questi schemi che possiamo stabilire la presenza di omologie significative. Il confronto tra i singoli mitemi, una volta individuati gli schemi, ci permette di trarre conclusioni sulle ragioni delle alterazioni che li hanno interessati, a volte dei rovesciamenti, e quindi sulle ideologie che hanno provocato
l'alterazione. Nei capitoli precedenti abbiamo indicato delle affinità tra alcuni elementi tratti dal mito di Hērakls e quelli di Gilgameš. L'approccio invertito alla regalità e all'immortalità; il rapporto con la dea antagonista; la relazione con il gemello/sodale e la crisi esistenziale. Alcune delle affinità che abbiamo proposto appaiono, anche ai nostri occhi, segnate da una certa fragilità, e le avanziamo soltanto come ipotesi di lavoro per futuri studi. Ma gli episodi del ciclo di Hērakls in cui si può scorgere una sicura influenza del mito di Gilgameš sono
proprio quelli relativi alle sue spedizioni ai confini del mondo, nei quali si riconoscono, in controluce, i viaggi del lugal di Uruk alla ricerca della vita. Che l'itinerario di Hērakls venga compiuto su una cosmologia analoga a quella di Gilgameš, è un tratto banale. Tuttavia i due eroi risolvono le difficoltà escogitando analoghe soluzioni. Ad esempio, quando Gilgameš cerca un modo per attraversare il
tâmtu, il «mare», Šiduri lo avverte che solo il dio-sole è in grado di varcare quelle acque funeste: “L'unico che attraversa il mare è l'eroe Šamaš: al di fuori di Šamaš chi può mai attraversare il mare?” [e-bir tam-ti UTU(=šamaš) qu-ra-du-um-mu ba-lu UTU(=šamaš) e-bir tam-tim man-⌜nu⌝⌉] (Ša naqba īmuru [X: -]).
Analogamente, una volta arrivato dinanzi al potamós Ōkeanós, Hērakls lo attraversa a bordo della coppa d'oro di Hḗlios.
Inoltre, quando Gilgameš, nel mezzo della traversata, esaurisce i pali con cui spinge la barca, fa egli stesso da albero e utilizza il suo abito come fosse una vela. Alle prese con un analogo dilemma, venuti meno i venti e le correnti, Hērakls agisce nello stesso modo, così come ci assicura la rara tradizione riportata dallo scoliaste Servius Honoratus: «navigò verso [l'isola di] Gēryṓn, come abbiamo detto, su una nave di bronzo che per vela aveva la pelle di leone» [ad Geryonem autem, sicut iam supra dictum est, navi aenea navigavit tergo leonis velificans] (Servius: Scholia in Vergilii Aeneidem [VIII, ]). La storia dei krýsea mla, dei «frutti d'oro» che crescevano nel giardino delle Hesperídes, era narrata in uno dei perduti libri di Pherekýdēs (FGrHist [3 F 16a]). Secondo questo racconto, riferito in sintesi tanto da Apollódōros (Bibliothḗkē [II: 5, ]) quanto da Eratosthénēs (Katasterismoí [3]), questi frutti erano il dono di nozze che la dea-terra Gaîa aveva recato a Hḗra in occasione del suo matrimonio con Zeús, ed erano talmente belli che la dea dagli occhi bovini aveva ordinato di piantarli nel «giardino degli dèi» [then kpos]. E poiché le figlie di Átlas (le Hesperídes) avevano preso l'abitudine di rubare i preziosi frutti, Hḗra vi aveva posto a guardia il drákōn hespérios, Ládōn, al fine di proteggerli. Per tale ragione il luogo era meglio conosciuto come il kpos Hesperídōn, il «giardino delle Hesperídes». Il mitema degli alberi dai frutti d'oro o carichi di gemme è piuttosto vario e diffuso. Ne avevamo trovato una traccia nel corso di uno dei viaggi di
Bulūqiyā. Nella mitologia scandinava, la
dísa
Iðunn custodisce le epli ellilyf, le «mele contro la vecchiaia», anch'esse tutte d'oro, che proteggono dalla vecchiaia e dalla morte (Gylfaginning
[26];
Skírnismál [19]). Il «giardino degli dèi», posto accanto all'óros
Átlas, dove le Hesperídes vanno a cogliere i frutti dorati, corrisponde agli iṣû ilī, gli «alberi degli dèi», carichi di pietre preziose, che Gilgameš ammira una volta emerso dagli oscuri interstizi del monte Māšu (Ša naqba īmuru [IX: ]). Il primo è localizzato laddove il sole tramonta, il secondo dove il sole sorge. È indubbio che l'immagine di questo frutteto riecheggi il biblico giardino di ʿĒḏẹn, sebbene nell'epica ninivita risulti scisso dal motivo dell'albero della vita e dal suo sinuoso guardiano: Gilgameš, stanco e impolverato, si limita ad ammirare, stupito, i frutti che scintillano come pietre preziose. Possiamo certo parlare di un relitto mitologico rimasto incagliato all'interno dello Ša naqba īmuru, un residuo letterario, ormai del tutto privo di una giustificazione, che il compilatore dell'epopea (Sîn-lēqi-unninni?) ha evidentemente lasciato soltanto per il suo sense of wonder. Ovviamente, Ládōn, il serpente che protegge il kpos then, o Hesperídōn, è un parente stretto del serpente/nāḥāš che, in un ipotetico antigrafo del mito biblico, stava a guardia del ʿēṣ haḥayyîm, dell'«albero della vita» che spuntava al centro del gan ʿĒḏẹn. Ma tra tutti questi giardini e serpenti rischiamo di perdere la bussola: e non rimane che ricordarci del serpente che, nell'epopea ninivita, divora la šammu nikitti, la «pianta dell'irrequietezza», privando Gilgameš del dono inestimabile della gioventù (Ša naqba īmuru [IX]). Ma se Gilgameš non riesce a ottenere l'immortalità,
e se per questo nemmeno
Eskandar e
Bulūqiyā ottengono quanto hanno cercato nel corso dei loro lunghi viaggi,
perché Hērakls fa eccezione? Perché l'eroe ellenico è, tra tutti questi
inesausti esploratori dei confini del mondo, l'unico che alla fine pervenga a una vita immortale? La ragione l'abbiamo già sottolineata: gli Elleni
cercarono di adattare un antichissimo mito di substrato,
incentrato su un eroe che viaggia ai confini del mondo alla
ricerca della vita eterna (di cui il ciclo di Gilgameš
è un esito medio-orientale), a un personaggio simile nell'aspetto ma profondamente diverso come natura. Sebbene apparentemente trasformato in un eroe epico, Hērakls non aveva cessato di essere considerato una vera e propria divinità: il suo pacchetto mitologico prevedeva già un'apoteosi finale, e questo rendeva praticamente inutili le ragioni del suo viaggio alla ricerca dei krýsea mla nel lontano giardino d'occidente. Nella forma definitiva del racconto, questi dettagli erratici appaiono del tutto pretestuosi. È Eurysteús a chiedere i frutti dell'immortalità, con il segreto desiderio che Hērakls finisca per farsi ammazzare nel corso
di quel suo viaggio impossibile. E quando Hērakls, a dispetto di ogni pronostico, gli reca i krýsea mla, Eurysteús non sa che farsene.
Ha paura di offendere ulteriormente gli dèi, mangiando i frutti rubati dal loro
sacro giardino. Così li restituisce all'eroe. Ma Hērakls
li riconsegna alla dea Athēnâ, sua protettrice, che li riporta al
Kpos Hesperídōn. Hērakls non ha bisogno di mangiare i frutti della vita. La pýthia, a Delphoí, gli
ha profetizzato che, al termine dei dodici érga, sarebbe diventato immortale. Secondo l'ironica annotazione di Diódōros Sikeliṓtēs, Hērakls ne era talmente convinto che, nel tornare in
Hellás spingendo avanti le rossigne mandrie di Gēryṓn, accettava sacrifici dalle popolazioni presso cui transitava, ritenendo di aver già cominciato a ricevere l'immortalità (Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 24, ]). Concluse le «fatiche», dice sempre Diódōros, Hērakls «si mise ad attendere di ricevere l'immortalità, come [l'oracolo di] Apóllōn gli aveva profetizzato» (Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 26, ]). I mitografi sottolineano spesso il fatto che Hērakls sia destinato in ogni caso a diventare immortale. Secondo Eratosthénēs questo sarebbe avvenuto quando Hērakls neonato aveva poppato il latte alle mammelle di Hḗra. Un personaggio come Hērakls
avrà forse il fisique du rôle di Gilgameš, e
potrà sicuramente interpretarne la parte sul piano puramente fisico, ma certamente non è in grado di far propria la disperazione esistenziale del lugal sumerico. Ecco dunque che, pur seguendone le tracce, e arrivando vittorioso alla meta, perde completamente lo scopo e l'essenza originaria della propria ricerca. Possiamo apprezzare l'ingegnosità dei mitografi nel riattualizzare gli elementi del
ciclo di Gilgameš, o del suo
antemito. E gli elementi li ritroviamo quasi tutti: la dea
avversaria, il viaggio, la ricerca, la barca del sole, il giardino incantato, il serpente. Ma quando Šiduri, la taverniera che risiede sulla riva dell'oceano cosmico, ricorda a Gilgameš che la vita umana può avere un senso anche nella propria limitatezza e caducità, un briciolo di dubbio ancora ci assale. Gli studiosi si sono sempre interrogati sulla figura di Šiduri, che la versione accadica dell'epopea chiama semplicemente sābītu, la «taverniera», e la si è voluta paragonare a Kírkē o a Kalypsṓ. Ma Šiduri rifiuta la propria ospitalità a Gilgameš: spaventata, tenta di chiudergli in faccia la porta. Perché? Ragioniamo sui simboli. Šiduri, la taverniera, è un'immagine dell'enofora; colei che, nelle sue molte declinazioni mitiche, distilla la bevanda della sapienza, della regalità, dell'immortalità. Vero, nessuno di questi elementi viene mai esplicitato nei testi mesopotamici per definire la figura di Šiduri. Le nostre ipotesi sembrano ragionevoli, a meno di non lasciare inesplicata l'immagine di questa strana bierstube posta sulle rive dell'oceano cosmico, tra gli alberi degli dèi e le acque della morte. Sappiamo che Šiduri è una dea, in quanto il suo nome appare sempre contrassegnato dal determinativo «» che caratterizza i teonimi. Dietro il suo profilo possiamo forse scorgere, in controluce, figure come l'irlandese Étaín, la scandinava Iðunn, la greca Hḗbē:
enofore che offrono agli dèi il cibo e la bevanda
dell'immortalità. Hḗbē, in particolare, figlia di Zeús ed Hḗra, personificazione
della giovinezza, serviva il néktar e l'ambrosía alla mensa degli dèi. Ammettendo un legame, per quando debole, tra Hḗbē e Šiduri, e confrontando il diverso destino di Hērakls e Gilgameš, forse non dovremmo stupirci di accorgerci che proprio Hḗbē, la coppiera che elargisce agli dèi il cibo e la bevanda dell'immortalità, è destinata a divenire la giovane sposa di Hērakls, ormai immortale, sulla cima nevosa di Ólympos. Questo schema può parere quasi pretestuoso, tanto i mitemi appaiono distorti e capovolti nello schema greco rispetto a quello mesopotamico. Chi ci ha seguito fin qui potrà
tuttavia valutare la verosimiglianza della nostra ricostruzione:
| GILGAMEŠ | HĒRAKLS | | Dopo la morte di Enkidu, Gilgameš parte per i confini alla ricerca di un modo per sconfiggere la morte. | Dopo l'uccisione dei suoi figli, Hērakls entra al servizio di Eurysteús. | | Hērakls viene inviato da Eurysteús a cogliere i frutti dell'immortalità nel
Kpos Hesperídōn. | |
Giunto al limite orientale (settentrionale?) della terra, Gilgameš si fa aprire la porta del monte Māšu, per immettersi sul sentiero del sole e uscire dal mondo. | Giunto al limite occidentale della terra, Hērakls pone le colonne nello stretto tra Africa e Europa, delimitando la «porta» per uscire dal mondo. In alcune tradizioni egli crea lo stretto, scansando i monti, per passare oltre. | | Attraversato il monte Māšu, sulla sponda orientale del mondo, Gilgameš giunge nel frutteto dove crescono gli alberi degli dèi, dai frutti di pietre preziose e gemme. | Arriva in
Erýtheia, l'isola del tramonto. | | Il giardino degli dèi o delle Hesperídes, i cui alberi portano i frutti d'oro dell'immortalità, si troverebbe, secondo alcuni, oltre il monte Átlas. | | Gilgameš attraversa il mare esterno [tâmtu], che solo Šamaš può superare, sulla barca di Uršanabi. | Hērakls attraversa il fiume Ōkeanós, che nessuno ha mai superato, a bordo della coppa d'oro di Hḗlios | | Gilgameš funge lui stesso da albero utilizzando il proprio vestito come vela. | Hērakls utilizza come vela la sua pelle di leone. | | Arrivato nel Pû-nārāti, Gilgameš scende nel profondo dell'Apsū, dove coglie la šammu nikitti, la «pianta dell'irrequietezza». | Hērakls giunge nel
Kpos Hesperídōn, dove ottiene i frutti d'oro dell'immortalità. | | Un serpente divora la šammu nikitti. | Hērakls combatte e uccide il serpente Ládōn, il drákōn hespérios, che è a guardia del giardino. | | Gilgameš incontra Šiduri, la donna della vigna, la coppiera che mesce il vino sulla riva del mare. Ella lo avverte che non raggiungerà l'immortalità che cerca. | Dopo la sua apoteosi, Hērakls sposa Hḗbē, la coppiera degli dèi, colei che mesce il néktar e l'ambrosía che rendono immortali. | | Gilgameš non riesce a ottenere la vita eterna e deve soggiacere alla morte. | Hērakls ottiene l'immortalità ed entra nel consesso degli dèi. |
|
|
IN SCANDINAVIA: I VIAGGI DI ÞÓRR
La cosmologia germanica ci è conosciuta grazie alla letteratura
medievale in lingua norrena. Trattata tanto
nei carmi della
Ljóða Edda
(risalenti al periodo tra il IX e il
XII secolo), quanto nella
Prose Edda di Snorri Sturluson (composta tra il 1222
e il 1225), meriterebbe uno studio a parte, data la sua complessità.
Ma è purtroppo piuttosto frammentaria, affidata a citazioni slegate e non sempre coerenti
tra loro. Vi è anche il
sospetto che non fosse nemmeno ben compresa dagli ultimi interpreti
della tradizione scandinava, visto che, nella forma in cui ci è
stata trasmessa, sembra ridotta a una lista di conoscenze
antiquarie. Non viene mai detto dove sorgano e dove tramontino il
sole e la luna, come sia disegnata la loro traiettoria celeste, cosa
ci sia all'orizzonte. Niente di tutto ciò:
Sól e Máni, si limitano a
correre nel cielo sui loro carri, inseguiti da una coppia di lupi
celesti, chiamati Skǫll e
Hati, e questo è tutto quanto i testi
mitologici scandinavi ci raccontino in materia astronomica. Alcuni elementi cosmologici possono però
essere recuperati dai alcuni episodi del ciclo di
Þórr.
Nella mitologia scandinava, Þórr è il
dio-tuono, figlio di Óðinn e della
dea-terra
Jǫrð. Di imponente forza fisica e per di più facile alla furia [ásmóðr],
Þórr è dotato di un appetito gagliardo
ed è un formidabile bevitore. Il suo ruolo principale – parallelamente a quello
di Hērakls – è quello di muoversi ai confini del mondo per spacciare mostri
e malevoli
giganti [jǫtnar], ostili all'ordine istituito dagli dèi, gli
Æsir. Sua arma prediletta è il martello
Mjǫllnir, che riassume in sé tanto
l'idea del fulmine di Indra quanto quella della clava
di Hērakls. Pur mancando, nella
mitologia scandinava, il tema della ricerca della vita,
possiamo comunque riconoscere nel ciclo di
Þórr alcuni elementi dell'isomitema del
viaggio ai confini del mondo, e quindi diverse
avventure in comune con quelle degli eroi di cui abbiamo fin qui seguito le
imprese.
Spesso Þórr
vagabonda agli estremi estremi del mondo, nel corso delle sue avventure, permettendoci così di tracciare una mappa del kósmos
germanico. Questo comprendeva innanzitutto la nozione di una terra centrale,
sorta di oikouménē abitata dagli uomini, definita Miðgarðr, «recinto mediano», a cui corrispondevano
delle «terre»
periferiche, considerate irraggiungibili dai mortali. In molti passi eddici il complesso cosmologico è definito con la formula «nove
mondi» [heimar nío o jǫrðar nío], ma quali siano questi «mondi» e in quali direzioni
dello spazio vadano localizzati, non è molto chiaro. Le liste degli jǫrðar
nío, quelle che
troviamo nei libri di divulgazione e nei siti di cultura
nordica, non appartengono
alle fonti originali ma sono state compilate a tavolino da studiosi e appassionati mettendo insieme i nomi delle
varie regioni cosmiche citate nelle due Edda.
Ⓐ▼ Una di queste
liste «apocrife» potrebbe essere la seguente:
- Ásaheimr (il mondo degli
Æsir)
- Álfheimr (il mondo degli
Álfar)
- Jǫtunheimr (il mondo degli
Jǫtnar)
- Vanaheimr (il mondo dei
Vanir)
- Miðgarðr (il mondo degli uomini)
- Múspellsheimr (il mondo del
fuoco)
- Svartálfaheimr (il mondo dei
Døkkálfar e dei
Dvergar)
- Niflheimr (il mondo della nebbia)
- Hel/Niflhel (il mondo dei morti)
Questi mondi sarebbero disposti nelle varie
direzioni dello spazio, nonché impilati lungo un asse verticale. Piergiuseppe
Scardigli propone il seguente schema, in gran parte speculativo
(Scardigli 1982):
In un episodio narrato da Snorri nella
Prose Edda, ampiamente analizzato in una
pagina apposita Ⓑ▼,
Þórr e Loki
si mettono in viaggio a bordo del carro del dio, trainato dai caproni Tanngnjóstr e
Tranngrisnir. Giunti alla casa di un
fattore [búandi], come consueto
Þórr uccide i caproni e li imbandisce
per la cena, invitando a desinare anche il fattore e i suoi figli.
Purtroppo, il mattino dopo, quando Þórr
riunisce le ossa dei caproni e li resuscita, scopre che uno
dei due animali è azzoppato. Þórr è furibondo:
qualcuno, durante la cena, contravvenendo alle sue indicazioni, ha
inciso il femore dell'animale per succhiare il midollo. È stato
Þjálfi, l'agile figlio del
fattore. Per ricompensare l'áss del danno,
Þjálfi e sua sorella
Rǫskva si mettono al suo servizio e lo
accompagneranno per il resto del viaggio, che sarà compiuto a piedi.
(Gylfaginning [44]).
Ed è un viaggio i cui elementi non possono che suscitarci un
immediato déjà-vu.
Ma lasciamo la parola a Snorri:
| Lét hann þar eptir hafra
ok byrjaði ferðina austr í Jǫtunheima ok allt til hafsins, ok þá fór hann út
yfir hafit þat it djúpa. En er hann kom til lands, þá gekk hann upp ok með
honum Loki ok Þjálfi ok Rǫskva. |
Þórr si lasciò i caproni alle spalle e
cominciò il suo viaggio a est, verso lo
Jǫtunheimr e dritto fino al mare, del quale attraversò le
profondità. Giunto a terra, con lui approdarono
Loki, Þjalfi e
Rǫskva. |
| Snorri
Sturluson: Prose Edda >
Gylfaginning [45] |
 |
| Þórr e i suoi compagni attraversano il mare
(✍ 1875) |
| Lorenz Frølich (1820-1908).
Illustrazione (Oehlenschläger
1875-1877) |
Þórr
e i suoi compagni hanno dunque lasciato Miðgarðr
e si sono recati verso uno dei mondi esterni: in questo caso
Jǫtunheimr, il «mondo
degli
Jǫtnar», i giganti.
Dopo alcune divertenti avventure,
che Snorri ha abilmente cucito nella trama del racconto
(Gylfaginning [45]),
Þórr,
Loki, Þjalfi e
Rǫskva giungono in un posto chiamato
Útgarðr. Sebbene Snorri
descriva questo luogo come una fortezza, il toponimo ha un
significato cosmologico. Come Miðgarðr
è il «recinto mediano»,
Útgarðr è il «recinto
esterno». Saxo Grammaticus, che di questo mito riporta una variante evemerizzata,
definisce Utgarth- una «terra oltremondana» [extramundanum clima] (Historia Danorum [VIII: xv, 8]). Si profila
una concezione del mondo costituito da due regioni grosso modo
concentriche: Miðgarðr,
la terra abitata dagli uomini (oikouménē), che si trova al centro del kósmos, e
Útgarðr, la terra esterna, che ne
costituisce la periferia oltremondana. Tra
l'uno e l'altro si stende il mare [haf] di cui
Þórr e i suoi compagni hanno
«attraversato le profondità».
L'idea ricorda, in modo molto generale,
alcune delle strutture cosmologiche che abbiamo analizzato
fin qui. L'Imago mundi Babylonica,
ad esempio, distingueva tra un oikouménē centrale circolare
e una serie di otto nagi˒ānu esterni, l'uno
separato dagli altri dal circolo del fiume «amaro»
Marratu. La cosmologia iranica distingueva invece tra la terra
abitata centrale, aniraθa-,
e i sei karvąr periferici, separati dalle
distese interne dell'oceano cosmico Vourukaa.
La struttura del kósmos scandinavo, sebbene non venga mai
dettagliatamente spiegata nei testi pervenuti fino a noi, sembra
rientrare in
un modello di questo tipo, estremizzando tuttavia
l'opposizione geografica e ontologica tra centro e periferie.
Ma le sorprese non sono finite.
Giunti nello
Jǫtunheimr,
Þórr,
Loki, Þjalfi e
Rǫskva si
trovano ora dinanzi all'ingresso per
Útgarðr. Anche
questo passaggio per i confini del mondo, come gli altri che abbiamo
incontrato in precedenza, è custodito da una porta. È un cancello,
per l'esattezza. È chiuso, ma è talmente grande e imponente, che Þórr e i
suoi compagni non hanno difficoltà a strisciare, come pollicini, attraverso le sue sbarre:
| Þórr fór
fram á leið ok þeir félagar ok gekk fram til miðs dags. Þá sá þeir borg
standa á vǫllum nǫkkvorum ok settu hnakkann á bak sér aptr áðr þeir fengu
sét yfir upp, ganga til borgarinnar ok var grind fyrir borghliðinu ok lokin
aptr. Þórr gekk á grindina ok fekk eigi upp lokit, en er þeir þreyttu at
komask í borgina þá smugu þeir milli spalanna ok kómu svá inn... |
Þórr prese la sua strada coi compagni
e proseguì fino a mezzogiorno. Allora essi videro una rocca che sorgeva
in mezzo a una pianura e dovettero inarcare il collo fino alla
schiena prima di riuscire a scorgerne la sommità. Giunsero fino alla rocca,
davanti alle porte, che erano chiuse da un cancello.
Þórr andò al cancello ma non
riuscì ad aprirlo. Decisi a penetrare nella rocca, essi strisciarono fra le
sbarre e così riuscirono a passare... |
| Snorri
Sturluson: Prose Edda >
Gylfaginning [46] |
Il seguito della storia l'abbiamo già narrato
altrove Ⓒ▼ e abbiamo anche
analizzato l'incontro tra
Þórr e
Útgarðaloki, il «Loki dei
recinti esterni» (útgarða è infatti genitivo plurale),
dimostrando come possa essere considerato un equivalente nordico dell'incontro tra Hērakls
e Promētheús Ⓓ▼. Nel corso di questo episodio
(Gylfaginning [46-47]),
Þórr viene peraltro sottoposto a
tre interessanti sfide:
-
bere dal vítishorn, un corno che, segretamente, attinge al mare: nonostante il dio-tuono sia
irritato da non essere riuscito a seccarlo in un colpo, ha
abbassato considerevolmente il livello dell'acqua, provocando la
bassa marea;
-
sollevare un grosso gatto, che si
rivelerà essere Jǫrmungandr, il
serpente che circonda il mondo,
dissimulato da un sjónhverfingr, un inganno magico della
vista e dei sensi;
-
combattere contro la vecchia Elli,
la quale è tuttavia la vecchiaia [elli]
in persona, che nessun uomo può vincere.
Snorri utilizza la
prova (b), la sfida di sollevamento del gatto/Jǫrmungandr, per giustificare –
toppa assai poco raffinata – l'astio che
intercorre tra Þórr e il serpente.
Subito dopo, infatti, in un impeto di rivalsa per lo smacco subito, il dio del tuono
parte per andare a pescare
il Miðgarðrsormr dal fondo
dell'oceano
(Gylfaginning [48]).
Questo mito, rappresentato più volte
nell'iconografia antico-nordica e citato in diverse fonti
scaldiche, ha una formulazione
assai più interessante in un poema eddico, l'Hymiskviða,
sorta di ballata anteriore di circa un secolo all'Edda
di Snorri,
nella quale si possono indovinare degli elementi paralleli alla
vicenda del viaggio
di Þórr a
Útgarðr. All'episodio abbiamo dedicato
una pagina apposita. Ⓔ▼
Nell'Hymiskviða,
la ragione per cui
Þórr si mette in
viaggio, accompagnato
da Týr, è piuttosto diversa: deve procurarsi un paiolo
abbastanza capiente affinché il gigante marino
Ægir possa preparare birra [ǫl] per
tutti gli
Æsir. I due si recano allora dal gigante
Hymir – qui detto padre di
Týr –, nel tentativo di impadronirsi di uno smisurato
calderone appartenente a quest'ultimo. Poco sappiamo su questo Hymir,
nonostante l'Hymiskviða
ci faccia balenare l'esistenza di molti antichi miti, andati perduti. Il suo
nome potrebbe forse essere corradicale con il norreno himinn («cielo). Se
tale etimologia fosse dimostrata, potrebbe forse fornire un barlume di
significato a una battuta presente nel poema, dove
Týr spiega:
Il termine Élivágar indica
l'insieme complessivo dei fiumi cosmici che, nella cosmologia scandinava,
attraversavano tutti i livelli del kósmos, scendendo dal cielo,
solcando la terra e sprofondando negli inferi, la cui lunga lista di nomi è
elencata nei poemi sapienziali della
Ljóða Edda
(Grímnismál [26-29]),
ma anche in Snorri
(Gylfaginning [5]).
Vi riconosciamo un mitema attestato tanto in Īrān quanto in Grecia. Gli Élivágar sgorgavano da una sorta di
sorgente abissale, Hvergelmir, la
«caldaia gorgogliante», sorta di versione nordica dell'Apsū,
e dopo aver attraversato l'intero universo, tornavano a confluire in quell'abisso.
Alcuni degli Élivágar erano
velenosi: ed è
a questo veleno, recato a tutti gli angoli del cosmo, che la soteriologia
germanica attribuiva le ragioni della presenza del male nel mondo e della
malvagità insita in tutti gli esseri
(Gylfaginning [5]).
Ⓕ▼
L'Hymiskviða localizza dunque la
dimora di
Hymir a «oriente
degli Élivágar» [fyr austan
Élivága] e «ai confini del cielo», o più letteralmente: «alla fine del cielo» [at himins enda].
Quest'ultima espressione viene
altrove
utilizzata
per indicare il posto in cui sta appollaiata l'aquila
Hræsvelgr, che
produce tutti i venti che soffiano sulla terra
(Vafþrúðnismál
[37]), ma Snorri la usa anche per indicare il luogo dove il ponte
arcobaleno
Bifrǫst raggiunge la
cima di
Himinbjǫrg,
il «monte del cielo», obbligato punto di passaggio per accedere ad
Ásgarðr, la rocca degli
Æsir
(Gylfaginning [17 |
27]). In questo caso, entrambe le formule (fyr austan
Élivága e at himins enda) sembrano indicare l'orizzonte, il punto
dove la terra finisce e l'oceano cosmico diviene una nozione astronomica.
Hymir
potrebbe essere interpretato come una sorta di «guardiano» che sorveglia i confini
del mondo. Potremmo considerarlo un lontano parente boreale di
Átlas? Difficile a dirsi.
Prima di arrivare alla dimora dello
jǫtunn,
Þórr e
Týr si fermano alla casa di
Egill: e vi riconosciamo lo stesso
episodio della sosta di Þórr e
Loki a casa del fattore [búandi] nel racconto di Snorri
(Gylfaginning [44]) (seguirà anche l'episodio dell'azzoppamento del caprone, ma
più tardi, sulla via del ritorno). La scena è descritta in una sola
strofa:
Fóru drjúgum
dag þann fram
Ásgarði frá,
unz til Egils kvómu.
Hirði hann hafra
horngǫfgasta... |
Viaggiarono decisi
avanti tutto il giorno
dall'Ásgarðr,
finché giunsero da Egill;
al sicuro [Þórr] mise i caproni
dalle splendide corna... |
|
Ljóða Edda
>
Hymiskviða [7] |
La casa del búandi/Egill sembra essere
una «stazione» sulla via ai confini del mondo. Si potrebbe pensare alla
strana Bierstube di Šiduri, se motivi e
funzioni non fossero così irrimediabilmente differenti (e l'ostessa mesopotamica
assai più affascinante del ruvido fattore). L'Hymiskviða non spiega la ragione per
cui Þórr e
Týr parcheggino carro e caproni a casa di Egill,
prima di proseguire a piedi verso la dimora di Hymir.
L'impressione è che per Þórr sia impossibile
proseguire a bordo del carro. Come sappiamo da un'altra fonte, egli è
quotidianamente costretto a guadare una serie di fiumi quando si reca al
þing degli Æsir, in
quanto il ponte
Bifrǫst arderebbe sotto
le ruote del suo carro
(Grímnismál
[29]).
La sosta presso Egill è forse legata a
qualche ragione analoga: carro e caproni non possono guadare gli
Élivágar (o il haf) e arrivare at himins enda,
«alla fine del cielo» (Eysteinn 2006). La cosa è
piuttosto curiosa: mentre Gilgameš deve mendicare un
passaggio sulla barca di Uršanabi, ed Hērakls
deve farsi prestare l'aurea coppa di Hḗlios,
Þórr è costretto, al perfetto
contrario, a rinunciare a ogni mezzo di trasporto e attraversare
l'oceano cosmico a guado.
 |
| Þórr pesca il serpente di Miðgarðr
(✍ 1790) |
Johann Heinrich Füssli (1741-1825), dipinto
Royal Academy of Arts, London (Regno Unito) |
Sorvoliamo le pur divertenti avventure di
Þórr e
Týr a casa di Hymir. A
sera il dio-tuono mangia talmente tanto che, la mattina dopo, è
costretto a seguire il truce padrone di casa in una battuta di
pesca. Per procurarsi l'esca,
Þórr decapita il miglior toro della mandria di Hymir,
che Snorri chiama
Himinhrjótr
(Gylfaginning [48]
|
Hymiskviða
[17-19]). Questo nome (formato sulla radice
himin- «cielo») ci ricorda il «toro celeste»
Gudanna abbattuto da
Gilgameš. Inutile dire che lo jǫtunn è assai poco
soddisfatto della bella pensata di
Þórr. Poi i due mettono in mare il nǫkkvi
e
Þórr convince Hymir a
spingersi al largo. Lo
jǫtunn è piuttosto nervoso: sa che in mare aperto rischiano di
imbattersi nel serpente che circonda il mondo, Jǫrmungandr.
Così infatti avviene:
non appena
Þórr getta in mare l'esca, cioè la
testa del toro, il
Miðgarðrsormr abbocca.
Con sforzo immane,
Þórr solleva l'immenso serpente fino alla fiancata
del nǫkkvi e solleva il martello per ucciderlo. Ma Hymir,
terrorizzato, taglia la lenza e Jǫrmungandr
torna a sprofondare negli abissi. L'áss è infuriato. Nella versione di Snorri,
Þórr assesta un pugno
allo jǫtunn,
scagliandolo fuori dalla barca, quindi, avendo sfondato la chiglia
con i piedi, torna indietro
guadando ancora una volta l'oceano. Nell'Hymiskviða
i due tornano invece a riva a colpi di remi:, entrambi di
malumore, sebbene per ragioni diverse. Lo scontro di
Þórr con il
serpente è ormai rimandato al giorno di
ragnarǫk (Vǫluspa
[56] |
Gylfaginning [51]).
Quella sera, nel corso di una movimentata cena a casa di Hymir,
Þórr spacca il calice dello jǫtunn,
reputato infrangibile, contro la fronte del padrone di casa, poi
sradica il suo enorme calderone e, capovolgendoselo sul capo (con i
manici che gli tintinnano alle caviglie), si dà alla fuga. Ma
Hymir gli è presto alle calcagna,
seguito da una masnada di jǫtnar. Per
Þórr è un invito a nozze: posa il
calderone, agguanta il martello Mjǫllnir e li
massacra. Il calderone
viene infine portato alla dimora di Ægir
– il dio del mare, il birraio degli dèi –, che può così distillare ǫl
per tutti gli
Æsir.
Se mettiamo in parallelo
le due vicende – il
viaggio di
Þórr a
Útgarðr, narrato da Snorri in
Gylfaginning [44-47], e la spedizione di
Þórr presso Hymir, narrata nell'Hymiskviða
(e in lectio brevis in
Gylfaginning [48]) – possiamo riconoscervi degli
elementi simili, alcuni dei quali direttamente confrontabili tra
loro. Le due vicende potrebbero essere dei collages narrativi
effettuati giustapponendo episodi tratti da un mito unitario, ancora
più antico, forse il racconto di un periplo ai confini del mondo,
simile a quello di Hērakls.
Ma vediamo innanzitutto di costruire, intorno a
questo percorso, una cosmologia coerente. Secondo Snorri, una volta lasciate le
sponde del Miðgarðr, Þórr
e i suoi compagni attraversano a nuoto il «mare» [haf], e
giungono a
Útgarðr, l'extramundanum clima alla periferia del
mondo. Snorri non entra in dettagli cosmologici, tutto intento com'è a narrarci la storia delle
sfide lanciate da
Útgarðaloki a Þórr.
Ovvero: (a) bere da un vítishorn che attinge
al mare; (b) sollevare un gatto, che è in
realtà il serpente Jǫrmungandr;
(c) combattere contro la vecchia Elli,
che è la vecchiaia in persona.
Piuttosto interessante, la sfida del sollevamento
del gatto, ovvero di Jǫrmungandr.
Se il serpente giace negli abissi del mare, come possiamo trovarlo
nella fortezza di
Útgarðaloki? Ci troviamo immersi in un clima di sjónhverfingar,
inganni magici dei sensi, è vero. Ed è evidente che la scena, senza
che
Þórr, se ne accorga, si svolge nel mare o in prossimità
di esso. Ma quale mare? Difficile si tratti di quello stesso
haf che Þórr e
i suoi compagni avevano attraversato a nuoto per giungere in Útgarðr,
altrimenti avrebbero già incontrato il serpente nel corso
della traversata (proprio come accadrà a
Þórr
e a Hymir
quando, nell'Hymiskviða,
si spingeranno troppo al largo). I meccanismi dell'epica di solito
procedono dal lontano al più lontano, dal grande al grandissimo, dal
forte al fortissimo. Quindi, nonostante abbia attraversato il haf
e sia arrivato a Útgarðr,
Þórr non può tornare
indietro, ma deve spingersi ancora più al largo per trovare Jǫrmungandr.
Dunque
Útgarðr non si trova semplicemente
oltre il mare, ma in mezzo al mare, e che l'oceano cosmico –
dove giace Jǫrmungandr – si estende
subito oltre.
Tale topografia, ipotetica in
Gylfaginning [44-47], è parzialmente confermata in
Hymiskviða.
La dimora di
Hymir si trova oltre i fiumi
Élivágar, in una terra posta at himins enda, «alla
fine del cielo», e noi vi riconosciamo ancora una volta, per
associazione semantica, la «terra oltremondana» [extramundanum clima]
di Saxo Grammaticus (Historia Danorum [VIII: xv, 8]).
E quando Þórr e
Hymir salpano col nǫkkvi, e il dio-tuono trascina lo jǫtunn più al largo di quanto
questi non
fosse solito arrivare nelle sue battute di pesca, inevitabilmente i due
si imbattono nel serpente Jǫrmungandr.
Ci sembra che il mare su cui si inoltrano
Þórr e
Hymir nell'Hymiskviða
sia profondamente diverso dal haf attraversato a nuoto da
Þórr in
Gylfaginning [45]. Non è un mare che, per quanto
ampio e difficile da attraversare, si limita a separare il nostro
mondo dalle regioni oltremondane. Al contrario. È un oceano che ha
una sola sponda. Un oceano che si estende senza limiti, fino a
confondersi con il cielo. Possiamo
chiamarlo úthaf, il «mare esterno», utilizzando un raro
termine che la letteratura norrena ha escogitato (guarda caso!) per
la Alexander saga [118].
| |
Gylfaginning [44-47] |
Hymiskviða |
|
Oikouménē |
Miðgarðr |
Miðgarðr |
|
Mare interno |
haf |
Élivágar |
|
Extramundanum clima |
Útgarðr |
at himins enda |
|
«Guardiano» |
Útgarðaloki |
Hymir |
|
Oceano cosmico |
?
Jǫrmungandr |
[úthaf]
Jǫrmungandr |
Naturalmente presumiamo che i due testi (Gylfaginning
[44-47] e
Hymiskviða) siano costruiti
attorno a una cosmologia comune, cosa di cui non possiamo
essere certi. La situazione descritta trova tuttavia un
riscontro alla luce delle altre cosmologie da noi
analizzate. L'oceano che circonda il mondo risulta diviso in due sezioni: un
«mare» [haf] che bagna il Miðgarðr,
oltre il quale si trovano le terre oltremondane,
ovvero Útgarðr; e al di là, un
«mare esterno» [úthaf], dimora del serpente
Jǫrmungandr, che si estende fino al
firmamento.
Nel mito scandinavo manca tuttavia il tema più
importante: quello della ricerca della vita. Ammettendo che il mondo
germanico abbia adattato una versione del nostro mito analoga a quelle
fin qui esplorate, la totale scomparsa del tema potrebbe avere una
semplice spiegazione: Þórr, essendo un dio, non ha alcun
bisogno di ottenere l'immortalità. Infatti gli
Æsir
possedevano già il loro frutteto dorato con le epli ellilyf,
le «mele contro la vecchiaia», custodite dalla dísa Iðunn.
Dovevano stare attenti, piuttosto, a non
farsele rubare, quelle mele. Altrimenti sarebbero stati guai seri.
Ⓖ▼
Dunque il nostro tema è scomparso senza lasciare
traccia? In realtà ci sarebbero un paio di elementi, incagliati in
questo complesso di leggende, che potrebbero avere un rapporto con
il mito della ricerca della vita. Il
primo è il furto del caldaio di Hymir,
indispensabile affinché il dio del mare
Ægir possa distillare birra [ǫl]
per tutti gli dèi. Nel mondo celtico, le Túatha Dé Danann, gli dèi
dei Gaeli d'Irlanda, consumavano birra e idromele per mantenersi
sempre giovani, esenti dal disfacimento, dalla malattia e dalla
morte. Colui che aveva organizzato il «banchetto della vecchiaia»
era il dio del mare
Manannán mac Lir, il nocchiero del mito
gaelico, figlio del dio dell'oceano Lér.
È interessante notare che Ægir, detto
Hlér, è probabilmente
una versione scandinavizzata del celtico Lér. Vi è
dunque la possibilità che il nostro tema si celi proprio nel mito
del furto del calderone? Lo proponiamo come progetto per future
analisi. Al riguardo si veda anche la variante testimoniata dal ciclo irlandese dei Clanna
Tuireann, di cui parleremo tra poco
[infra]▼.
Un altro episodio interessante è costituito
dall'ultima delle tre sfide
sostenute da Þórr a
Útgarðr: un incontro di lotta
contro
Elli,
la stessa vecchiaia. Lasciamo la parola a Snorri:
| Þá svarar Útgarðaloki ok litask
um á bekkina ok mælti: “Eigi sé ek þann mann hér inni er eigi mun lítilræði
í þykkja at fásk við þik”. Ok enn mælti hann: “Sjám fyrst. Kalli mér hingat
kerlinguna fóstru mína, Elli, ok fáisk Þórr við hana ef hann vill. Fellt hefir
hon þá menn er mér hafa litizk eigi ósterkligri en Þórr er” |
Útgarðaloki guardò fra le panche e
commentò:
“Non vedo qui chi non
possa ritenere cosa da nulla un combattimento con te”. Disse ancora: “Ma
vediamo; chiamate Elli, la mia vecchia levatrice, e
Þórr combatta con lei, se vuole. Ella ha abbattuto uomini che non mi sono sembrati meno forti di quanto sia
Þórr”. |
| Því næst gekk í hǫllina kerling
ein gǫmul. Þá mælti Útgarðaloki at hon skal taka fang við Ásaþór. Ekki er
langt um at gera. Svá fór fang þat at því harðara er Þórr knúðisk at fanginu,
því fastara stóð hon. Þá tók kerling at leita til bragða, ok varð Þórr þá
lauss á fótum, ok váru þær sviptingar allharðar ok eigi lengi áðr en Þórr fell á
kné ǫðrum fǿti. |
Entrò quindi nella sala una vecchia donna.
Útgarðaloki le disse che doveva
battersi con Ásaþórr. Non c'è bisogno di
dilungarsi: nello scontro, quanta più forza usava
Þórr, tanto più ella resisteva. Poi la vecchia
cominciò a reagire, Þórr perse
l'equilibrio e la lotta si fece violenta. Dopo non molto
Þórr cadde su un ginocchio. |
| Þá gekk til Útgarðaloki, bað þau
hætta fanginu ok sagði svá at Þórr mundi eigi þurfa at bjóða fleirum
mǫnnum fang í hans hǫll. |
Si fece allora avanti
Útgarðaloki; impose loro di cessare lo scontro e disse
che Þórr non avrebbe più dovuto sforzarsi
di combattere contro altri uomini della sua hǫll. |
| Snorri
Sturluson: Prose Edda >
Gylfaginning [46] |
 |
| Þórr contro Elli (✍
1930) |
| Charles E. Brock,
illustrazione (Keary ~ Keary 1930) |
Þórr
è assai amareggiato, ritenendo di non aver fatto una bella figura. Solo più tardi scoprirà
di essere stato ingannato. Il mattino dopo, infatti,
Útgarðaloki gli confessa di
averlo preso per il naso grazie ai suoi sjónhverfingar, e gli dice, tra
l'altro: “È
stato un grande prodigio la lotta che hai sostenuto tanto a lungo,
senza cedere se non con un ginocchio, quando hai combattuto contro
Elli, poiché nessuno è mai riuscito e mai riuscirà
a non crollare quando giunge la vecchiaia, se diviene abbastanza anziano da
incontrarla” [En hitt var ok mikit undr um fangit er þú stótt
svá lengi við ok felt eigi meir en á kné ǫðrum fǿti er þú fekzk við
Elli, fyrir því at engi hefir sá
orðit ok engi mun verða ef svá gamall er at elli bíðr, at eigi
komi ellin ǫllum til falls]
(Gylfaginning [47]).
Questa prova è anche la più enigmatica. Se Þórr è immortale,
ed eternamente giovane (grazie alle mele di
Iðunn), per quale motivo viene, seppure a fatica, vinto dalla
vecchiaia? Si potrebbe pensare che l'episodio celi un motivo più antico,
dove il protagonista era un'emanazione eroica di Þórr,
una figura simile al
Thorkillus di Saxo Grammaticus: trasparente versione mortale del dio-tuono scandinavo.
D'altra parte le mitologie indoeuropee presentano molti esempi di
eroi dotati delle caratteristiche funzionali del dio-tuono, ma
distinti da esso. Ricordiamo gli iranici
Θraētaona e
Kǝrǝsāspa, l'indiano Bhīma,
forse lo stesso Hērakls.
Il mito della lotta di Þórr
con
Elli potrebbe avere una relazione
con l'episodio in cui Hērakls
si batte contro Thánatos, la morte, per impedirle di
trascinare negli inferi la coraggiosa
principessa Álkēstis, decisa a morire
al posto dell'amato sposo Ádmētos.
Nella versione che ne dà Euripídēs in una delle sue più belle tragedie, è lo
stesso Hērakls a rivelare
al pubblico le sue intenzioni:
| |
“Andrò laggiù. Farò la posta a
Thánatos, il re dei morti, col suo manto bruno. Lo
troverò, m'immagino, vicino a quella tomba, intento a bere il sangue delle
vittime. Fuori dell'agguato scatterò: se l'agguanto e lo cingo nel giro delle
braccia, non lo libera nessuno dalla stretta dolorosa dei fianchi. A meno che
non molli prima a me la donna”. |
|
Euripídēs: Álkēstis |
Sebbene elaborati in maniera molto
diversa, differenti per finalità e anche per esito, Snorri ed
Euripídēs ci mostrano un isomitema in cui due campioni omologhi – Hērakls
e Þórr – impegnano in
una lotta corpo a corpo degli avversari che si rivelano essere
delle astrazioni personificate, rappresentazioni allegoriche della
caducità e della mortalità umane.
La nostra conclusione è che, sebbene il
ciclo di Þórr abbia
elaborato i temi in maniera molto differente, conservi al suo
interno, ormai quasi irriconoscibili, alcuni elementi del nostro
antico Ur-Myth. In un qualche esito
anteriore del mito germanico, un eroe – forse il futuro dio
«Þūnraz/Þórr»,
o forse un campione a lui legato
per fisionomia – si reca ai confini del mondo per procurarsi
giovinezza e immortalità. Due tappe sul percorso del nostro eroe
avrebbero potuto essere Utgarðaloki
e Hymir: rispettivamente, il
prometeo incatenato e il guardiano dell'orizzonte. In tal caso, il
furto del calderone di Hymir potrebbe
essere il risultato di una trasposizione del tema originario, dove
si cercava di ottenere non tanto il recipiente, quanto il suo contenuto,
la birra che rende immortali. Può darsi che il serpente Jǫrmungandr
fosse preposto a custodia
di questo tesoro.
Vero: la nostra ricostruzione è
solo una fantasia fragile e ipotetica. Non insistiamo oltre.
Qualunque sia stata la storia originale, è impossibile tentare di
ricostruirla. I temi che abbiamo rilevato nel ciclo di Þórr, però, sembrano proprio quelli
corretti. Se così è, lo
stato di deterioramento in cui il nostro mito è pervenuto ai due
testimoni germanici è indice che i suoi elementi risalgono a una
notevole antichità.
|
|
IN SCANDINAVIA: IL REGNO DI
GUTHMUNDUS Se le
Edda
poco altro aggiungono sul nostro tema, è lo storico danese Saxo
Grammaticus (vissuto tra l'xi
e il xii secolo) che
riporta una serie di dati interessanti e assai ben integrati tra
loro, nel suo Gesta Danorum,
dove narra, tra l'altro, dei viaggi oltremondani di un navigatore
chiamato Thorkillus, le cui spedizioni
ai confini della terra sembrano essere dellel riscritture in chiave
eroica di alcuni miti che l'Edda
attribuisce a Þórr.
D'altra parte, come gli studiosi hanno sottolineato,
Thorkillus è un'evidente ipostasi
eroica del dio Þórr,
cosa che si evince anche dal fatto che il suo nome,
latinizzazione del norreno Þórkell, incorpora il teonimo del
dio-tuono. Ma abbiamo già incontrato
Thorkillus : il suo viaggio ai confini del mondo e il suo
incontro con Utgarthilokus, un
gigante-dio incatenato in una lontanissima caverna, presenta ovvi
riferimenti all'incontro di Þórr
con Utgarðaloki, ma – cosa ancora più
interessante – può essere messo agevolmente in parallelo con il mito
dell'incontro di Hērakls
con Promētheús incatenato. Se
Thorkillus è un'estrema ipostasi
nordica del nostro inesausto esploratore dei confini del mondo (Hērakls,
Gilgameš,
Eskandar...), ci possiamo attendere che nel suo mito siano
confluiti elementi del tema della ricerca dell'immortalità, di cui
stiamo trattando in questa pagina.
Ⓐ▼
Saxo Grammaticus narra che, all'inizio della sua carriera, il
marinaio Thorkillus entrò agli ordini
del re danese Gormo, il quale si era
invaghito delle ricchezze ammassate da
Geruthus , un re dei giganti che dimorava ai confini del
mondo. Non sarebbe stato in realtà un viaggio facile, perché la
dimora di Geruthus si trovava in un
luogo «quasi inaccessibile per dei mortali». La descrizione che ne
dà Saxo non ci sorprende affatto:
| Ambitorem namque terrarum Oceanum navigandum, solem postponendum ac sidera,
sub Chao peregrinandum ac demum in loca lucis expertia iugibusque tenebris
obnoxia transeundum expertorum assertione constabat. |
Secondo quanto affermavano gli esperti di
quella rotta, si doveva attraversare l'oceano che circonda la terra, lasciandosi
alle spalle sole e stelle, viaggiare nel regno del caos e infine passare in
luoghi esclusi dalla luce e immersi nell'oscurità perenne. |
| Saxo
Grammaticus:
Gesta Danorum [viii,
xiv, 1] |
Gormo e
Thorkillus si mettono in mare, insieme
a trecento uomini. Partono dal Hálogaland, il porto più
settentrionale della Norvegia e, puntando le prue a est, solcano il
mar glaciale Artico fino a raggiungere il Bjarmaland. Questo luogo –
estrema propaggine nord-orientale delle spedizioni vichinghe – si
trovava sulla costa settentrionale dell'odierna Russia, oltre la
penisola di Kola. In Saxo diviene tuttavia un luogo mitologico,
avvolto da una notte perenne, e abitato da orribili mostri e
giganti.
(Gesta Danorum [viii,
xiv, 2-6]). Arrivano infine
in una terra selvaggia, percorsa da fiumi fragorosi e spumeggianti,
e qui arriva loro incontro un essere gigantesco: è
Guthmundus, fratello di
Geruthus, il quale invita i danesi
nella sua dimora. Lungo la strada arrivano a un ponte d'oro che
scavalca un fiume: i danesi vogliono attraversarlo ma
Guthmundus li invita alla prudenza, e
li informa che «quel fiume era il limite che la natura aveva creato
per separare il mondo degli uomini da quello non umano e che non era
concesso ai mortali di spingere i passi al di là» (Gesta Danorum [viii,
xiv, 7]). Condotti infine
danesi nella sua reggia, Guthmundus
imbandisce un ricco banchetto e offre loro la compagnia delle sue
splendide figlie. Ma Thorkillus avverte i suoi uomini di non
accettare né cibo né donne: chi avrebbe condiviso quel cibo avrebbe
perso la propria memoria e sarebbe stato costretto a passare il
resto della sua vita insieme a quei turpi esseri (Gesta Danorum [viii,
xiv, 8-9]).
Sebbene molti dettagli non risaltino cme
dovrebbero nel testo di Saxo, altri testi ci vengono in aiuto nel
nostro sforzo di definire la natura del regno di
Guthmundus. Di un re
Guðmundr, sovrano di un'iperborea terra
felice, narrano infatti diverse saghe e þáttr di argomento
leggendario. Nella redazione lunga della Hervarar
saga ok Heiðreks, ad esempio, leggiamo quanto segue:
| Svá er sagt, at í fyrndinni
var kallat Jötunheimar norðr í Finnmörk, [...]. Guðmundr hét konúngr í
Jötunheimum; hann var blótmaðr mikill; bær hans hét á Grund, en héraðit á
Glasisvöllum; hann var vitr ok ríkr; hann ok menn hans lifðu marga mannsaldra,
ok því trúa menn, at í hans ríki sé Ódáinsakr, en hverr, er þar kemr, hverfr af
sótt ok elli, ok má eigi deyja. Eptir dauða Guðmundar blótuðu menn hann, ok
kölluðu hann goð sitt. |
Si tramanda che anticamente la regione a nord del Finnland fosse chiamata
Jǫtunheimr [...]. Nello
Jǫtunheimr viveva allora
un re di nome Guðmundr, un pagano dalle ferme
convinzioni. Risiedeva in una città chiamata Grund, mentre la regione aveva nome
Glæsisvellir. Era un re forte e saggio. Insieme ai
suoi sudditi, vivevano numerosi stranieri, poiché i pagani credevano che nel suo
regno si trovasse il [campo di] Ódáinsakr e che,
chiunque riuscisse a giungervi, scampasse alla malattia e alla vecchiaia, e non
morisse. Dopo la morte di Guðmundr, i suoi
celebrarono un sacrificio e lo proclamarono loro dio... |
| Hervarar
saga ok Heiðreks [1] |
Glæsisvellir, la
«pianura splendente», reminescente della Glesaria di Plinius,
e Ódáinsakr, il «campo degli immortali»
(da ó-, prefisso negativo, e dáinn, «morto») sono due
nomi della terra d'immortalità che è meta degli eroi del tema che
stiamo qui analizzando. Guðmundr è
quindi il signore del felice oltremondo, il guardiano dei passaggi
che conducono al di là dello spazio. Pur con molta prudenza,
potremmo associarlo ad Átlas, e le sue
figlie alle Hesperídes. Nel
racconto di Saxo, tuttavia, l'incontro dei danesi con
Guthmundus viene svolto nei termini di
una tentazione da superare: Thorkillus
e i suoi uomini devono resistere all'allettamento del cibo imbandito
e alle grazie delle bellissime fanciulle che si offrono loro, se
vogliono conservare la memoria e la propria integrità.
Che nelle fonti il regno di Guðmundr
appaia collocato oltre il Bjarmaland (e quindi in direzione nord-est) non deve indurci in errore: si tratta di
interpretazioni eseguite a posteriori da Saxo Grammaticus e dagli altri autori,
nel momento in cui le mitologia veniva rielaborata storicamente. L'antica cosmologia nordica, di cui è rimasta traccia
nelle ballate e nelle saghe, era assai più complessa. Secondo l'interpretazione
di Liestøl e Moe, il mar glaciale Artico era immaginato racchiuso in un vasto
golfo che dalla Norvegia si congiungeva alla Groenlandia. La leggendaria terra
oltreboreale, al di là del mar Artico, il luogo dove gli eroi delle saghe, delle
ballate e delle fiabe andavano a conquistare tesori, abbattere mostri e
conquistare fanciulle, era conosciuto con molti nomi. Hafsbotn nella
Landnámabók e nelle fornaldarsǫgur,
Norðrbotn [Sinus septentrionalis] nella
Historia Norwegiae,
Trollebotten o Trollabotnar nelle
ballate, o semplicemente Botnar, dove il termine botn indicava il
«fondo» di un fiordo o di una valle; cfr. inglese bottom
(Liestøl ~ Moe 1920-1924; Taglianetti 2016). Ma non
bisogna lasciarsi indurre in errore. Ma ritenere, come fanno Liestøl e Moe, che
queste regioni cosmologiche possano essere identificate con la Groenlandia (la
quale fu scoperta solo nel 1000), significa commettere lo stesso errore di
metodo di chi ha cercato di localizzare il giardino di ʿĒḏẹn in qualche oasi del
Medio Oriente, o ha ritenuto che Eskandar, salpato
dalla Spagna, fosse giunto in America.
Per posizionare questi luoghi non dobbiamo
rivolgerci alla geografia, bensì alla cosmologia. La terra
d'immortalità di Guthmundus/Guðmundr,
così come la fiabesca Hafsbotn/Trollebotten,
vanno poste più a nord dell'asse terrestre. Questa
definizone, paradossale nella geografia reale, è accettabilissima
nella cosmologia mitica. Una volta oltrepassata la terra
dell'oscurità (che dallo Ša naqba īmuru
in poi sappiamo gettata dalla montagna cosmica, attorno alla quale
ruota il firmamento), il sole che illumina queste regioni
oltreboreali è il sole dei morti
①▼. Luca
Taglianetti ricorda che nella ballata Jomfrua Ingebjørg
il toponimo Trollebotten indica l'inferno
(Taglianetti 2016). Nella descrizione di Saxo, il
mitema della terra d'immortalità si confonde alla nozione, comune ai
miti scandinavi e finnici, del Tartarus septentrionalis e
quello di non accettare il cibo dei morti è una ben nota accortezza
di tutti gli eroi che si accingono in questi viaggi cosmologici.
Ma torniamo al racconto di Saxo. Visti inutili i
suoi sforzi di ingannare i danesi, Guthmundus
dà loro il permesso di oltrepassare il fiume.
Thorkillus e i suoi giungono così a una città lugubre e
desolata, circondata da una palizzata: teste umane infilzate sulle
picche e cani feroci che ne vigilano l'ingresso. Solo con difficoltà
riescono a varcarne le porte. All'interno è un groviglio di
ricchezze ineguagliabili abbandonate in mezzo al più orribile
sudiciume, mentre spettri esangui li guatano dai loro seggi. Al
centro della sala si presenta loro un'immagine grottesca:
| Procedentes perfractam
scopuli partem nec procul in editiore quodam suggestu senem pertuso corpore
discissae rupis plagae adversum residere conspiciunt. Praeterea feminas tres
corporeis oneratas strumis ac veluti dorsi firmitate defectas iunctos occupasse
discubitus. Cupientes cognoscere socios Thorkillus, qui probe rerum causas
noverat, docet Thor divum, gigantea quondam insolentia lacessitum, per
obluctantis Geruthi praecordia torridam egisse chalybem eademque ulterius lapsa
convulsi montis latera pertudisse; feminas vero vi fulminum tactas infracti
corporis damno eiusdem numinis attentati poenas pependisse firmabat. |
Avanzando nella sala, scorgono una fenditura nella roccia e non molto distante,
seduto su una piattaforma sopraelevata di fronte alla rupe spaccata, un vecchio
con il corpo squarciato. Lì vicino vedono anche tre donne, con il corpo
ricoperto di scrofole, che sembravano senza forza nella spina dorsale. I suoi
compagni bruciavano dalla voglia di sapere, perciò
Thorkillus, che conosceva bene la ragione di quelle cose, raccontò loro
che il dio Thor era stato una volta sfidato
dall'arroganza dei giganti e, mentre lottava contro
Geruthus, gli aveva cacciato nelle viscere una verga di ferro
incandescente che, attraversandogli il corpo e scivolando più in basso, era
arrivata a spaccare i fianchi della montagna, squarciandola. Disse che le donne
erano state colpite dai potenti fulmini di Thor e
avevano pagato con il corpo spezzato la colpa di avere provocato la divinità. |
| Saxo
Grammaticus: Gesta Danorum [viii,
xiv, 15] |
Saxo si riferisce qui al mito della lotta di
Þórr contro il gigante Geirrøðr
e le sue sgradevoli figlie Gjálp e
Greip, narrato dallo scaldo
Eilífr Goðrúnarson nell'arduo poema
Þórsdrápa (x
sec.) e, in maniera più lineare, da Snorri Sturluson in
Skáldskaparmál [26]
Ⓑ▼.
Ciò che colpisce nel racconto di Saxo, tuttavia, è il fatto che l'immagine del
sovrano morto, assiso in trono, lo avevamo già trovato nella fiaba araba di
Bulūqiyā: si ricorderà che
l'eroe, nel corso del suo viaggio verso la lontana terra d'immortalità, arriva in una
caverna dove trova un uomo morto su un trono: è re Sulaymān;
subito dopo, Bulūqiyā viene
aggredito da una serpente che sputa fiamme. È interessante notare
che anche i danesi, non appena cominciano a rubare i tesori ammassati nella
reggia di
Geruthus, verranno attaccati da un serpente. Anche nello
Šāhnāmè
di Ferdowsī, Eskandar,
nel corso della sua ricerca, trova il cadavere di Sulaymān
ancora assiso sul suo trono. Quale sia il significato di questo motivo, e come
sia pervenuto dal Medio Oriente alla Scandinavia, è difficile dirlo. Nel
racconto di Saxo, dopo aver combattuto contro spettri semimorti e
orrigili streghe, Thorkillus e i suoi
uomini tornano da Guthmundus e decidono
di riprendere la via del ritorno. Ma un uomo del seguito di
Thorkillus, l'eroico
Buki, piegato dalla passione per una
fanciulla, decide di rimanere nel paese di
Guthmundus. Mentre accompagna il re alla partenza, tuttavia,
fa per guadare il fiume con il suo carro ma, travolto dalle acque
vorticose, muore annegato. Immaginiamo che
Buki assolva qui, in qualche modo, il
ruolo dell'eroe principale del nostro tema. I dati sono però
piuttosto frammentari e non permettono un'analisi comparatistica più
rigorosa. ②▼
|
①▲
Nel
Kalevala finnico
compare
Pohjola, la lontana e
oscura «terra del nord», dove si recano gli eroi del
poema per chiedere la mano delle sue meravigliose
fanciulle. Sebbene Pohjola
non sia mai caratterizzata come una landa d'immortalità,
essa è il luogo dov'è custodito il
sampo, misterioso strumento di
inesauribile ricchezza e fertilità. Nei runolaulut
del ciclo di Lemminkäinen,
compare la nozione parallela di
Päivölä, la «terra del sole», raggiungibile solo
dopo un lunghissimo e pericoloso viaggio iperboreo, i
cui elementi sono stati messi in correlazione con quelli
del regno di Geruthus in
Saxo Grammaticus (le picche con le teste umane
infilzate, i cani che ne sorvegliano i cancelli, etc.).
Gli studiosi, equiparando il percorso di
Lemminkäinen a un viaggio
sciamanico, tendono a collocare
Päivölä nelle regioni celesti. Tuttavia la
comparazione con il complesso cosmologico di cui
trattiamo in questo pagine, anche tenendo conto della
natura oscura degli scenari attraversati da
Lemminkäinen, giustificano
l'ipotesi che questa «terra del sole» sia in realtà la
regione oltreboreale che il sole illumina nel suo
percorso notturno: è di nuovo la nozione del Tartarus
septentrionalis. Non ha quindi sbagliato Elias
Lönnrot che, nella compilazione del
Kalevala,
ha sostituito per ragioni di economia letteraria
Päivölä con
Pohjola. |
| |
|
②▲
Diverse narrazioni mettono in scena il personaggio di
una figlia di Guðmundr. Si
vedano la Bósa saga,
o il Helga þáttr Þórissonar,
dove però i contesti escludono qualsiasi riferimento al
tema che stiamo trattando. Nondimeno, un'analisi di
questi testi e, in particolare, della
Bósa saga, con le
sue interessanti affinità con il
Kalevala
potrebbe portare a interessanti conclusioni.
La proponiamo per esercizio ai nostri lettori... |
|
|
MAPPE DI VIAGGIO: LE MONTAGNE
CHE SOSTENGONO IL CIELO Narrate le grandi avventure, messi i protagonisti in locandina, tolte di mezzo le necessarie premesse, è ora di tracciare il nostro itinerario per i confini del mondo, tappa dopo tappa, e
localizzare il giardino meraviglioso dove fiorisce l'albero della vita, dove sgorga l'acqua dell'immortalità. Le nostre guide saranno, ancora una volta, Gilgameš, Hērakls, Eskandar e Bulūqiyā, inesausti esploratori dei confini del mondo, e oltre.
La prima tappa del viaggio compiuto dal nostro eroe, quale che sia il suo nome,
consiste in una montagna stagliata ai confini del mondo. Essa ha, in tutti i casi, un
valore cosmologico: segna il limite estremo della terra, funge da
«porta» per il sorgere e il tramonto del sole, sostiene il cielo. Nei
suoi pressi vi è una regione di tenebre. Oltre di essa si stende
l'oceano cosmico. Ed è nei pressi di questa montagna che sgorga l'acqua
della vita o si trova il giardino dove fiorisce l'albero dell'immortalità.
- (α) Gilgameš arriva allo
šadû Māšu. La direzione
non è specificata: ma è dalla porta [bābu] sul
fianco della montagna che ogni giorno il
sole sorge e tramonta. Varcato l'ingresso, Gilgameš
si immette sul ḫarran šamši, il «sentiero del
sole», e avanza nella totale oscurità per dodici bēru.
Quando arriva dall'altra parte, trova gli iṣû ilī,
gli «alberi degli dèi», e davanti a lui si stende il mare [tâmtu],
ovvero l'oceano cosmico.
- (β) Hērakls si muove,
nelle varianti del suo ciclo, tanto verso occidente tanto
verso oriente. A
oriente arriva all'óros Kaúkasos, il monte dell'alba,
dove è incatenato Promētheús; a
occidente arriva all'óros Átlas, il monte del tramonto,
regno di Átlas, oltre il quale c'è
il Kpos Hesperídōn. (β₁) Secondo la
variante «polare», Hērakls
trova Átlas nell'estremo
settentrione, dove il gigante/montagna funge da asse celeste, ed
è qui che si trova il Kpos Hesperídōn.
- (γ) La fiaba di Bulūqiyā non fornisce una direzione precisa: l'eroe
lascia la terraferma e si mette in cammino sui «sette mari».
Dopo aver attraversato vaste distese marine ed essere transitato per isole
lontane, attraversa una regione di
tenebre e arriva al ǧabal al-Qāf.
- (δ) Al-Iskandar/Eskandar
compie una serie di viaggi ai confini del mondo, raggiungendo
tanto l'estremo oriente, tanto l'estremo occidente. Dopo aver
attraversato la terra delle tenebre (aẓ-Ẓulumat), arriva al ǧabal
al-Qāf, dove sorgono le
città di smeraldo di Ǧābarsā e
Ǧābalqā,
ed è testimone del sorgere e del tramontare del sole. (δ₁) In
Neẓāmī,
si associa un ulteriore viaggio verso il polo settentrionale. Attraversate le tenebre
(Ẓolmat), Eskandar
arriva alla montagna che funge da asse del mondo, ed è qui che
sgorga l'acqua della vita.
- (ε) Þórr compie una serie di
viaggi ai confini del mondo, solitamente verso oriente,
direzione in cui sono localizzati il mondo dei giganti
Jǫtunheimr, la terra «ai confini
del cielo» dove dimora Hymir, o il
«recinto esterno» Útgarðr. I tratti
astronomici, purtroppo, non sono mai evidenziati. (ε₁)
Himinbjǫrg, la «montagna del
cielo», servita dal ponte Bifrǫst,
è il luogo di passaggio dalla terra all'Ásgarðr,
la fortezza celeste dove vivono gli dèi.
In tutti i miti citati, la montagna può assumere tre modelli differenti:
- portae mundi - due montagne: un monte dell'alba a est, un
monte del tramonto a ovest;
- cingulus mundi - una montagna anulare che circonda la
terra sul confine esterno;
- axis mundi - una montagna localizzata all'estremo
settentrione,
che funge da perno per il polo celeste.
Tali modelli non sono esclusivi dell'uno o dell'altro
sistema mitico. Essi possono sovrapporsi in un sistema cosmologico
coerente (Īrān zoroastriano); possono apparire come possibilità
alternative nelle varianti del medesimo mito (Grecia, Īrān
islāmico); oppure presentarsi come possibili interpretazioni in un
sistema non meglio specificato (Mesopotamia).
Mesopotamia
Quando Gilgameš arriva allo šadû Māšu, i filologi gettano la spugna e i cosmologi si arrendono. Il testo dello Ša naqba īmuru, anche per via delle lacunae
e delle difficoltà di interpretazione, non permette di definire la
precisa localizzazione del Māšu. Che il viaggio di Gilgameš
lo abbia condotto a est lo si deduce
quasi unicamente dal fatto che Ziudsura, l'equivalente sumerico di Ūtnapištī, era stato reso immortale e traslato «in una regione al di là del mare, a Dilmun, dove si leva Utu» [kur-bal kur dilmun-na ki utu éd-šè mu-un-tìl-eš] («Poema di Ziudsura» [V: ]).
Tra il poema sumerico del diluvio e lo Ša naqba īmuru
vi è una distanza temporale di quasi due millenni. Ipotizzando,
tuttavia, che la localizzazione del Pû-nārāti
sia rimasta quella dell'antica Dilmun, la conclusione comunemente accettata
dagli studiosi è che Gilgameš
sia arrivato allo šadû Māšu
muovendosi in direzione est (e qui pesa
anche,
bisogna ammetterlo, il ricordo del gan ʿĒḏẹn
piantato «a oriente»). Ci troviamo dunque di fronte al modello delle portae mundi?
È possibile. Altri testi, come abbiamo visto, citano lo Šadû Ḫašur e lo Šadû Budugḫudug, il monte dell'alba e il monte del tramonto, l'uno a oriente e l'altro a occidente della terra (SB [Hh XXII]; TCL [XV: 7, ]).
E questa è una possibile attestazione dell'esistenza del modello delle portae mundi.
Purtroppo lo Ša naqba īmuru non
permette di sciogliere l'ambiguità. La localizzazione dello šadû
Māšu
– lo ripetiamo per chiarezza – è affidata a due versi del poema ninivita. Nel primo, mutilo, Gilgameš ammira il Māšu «che giornalmente guarda il sorg[ere del sole...]» [šá umišama inaṣaru a[ṣê šamši...]] [IX: ], apparentemente suggerendo una localizzazione orientale
della montagna. Ma poche righe sotto è scritto che gli aqrab-amēlû,
gli uomini-scorpione, le solerti sentinelle del
Māšu, «stanno
a guardia del sole, al tramonto del sole e al sorgere del sole» [ana a-ṣe-〈e〉 UTU(=šamši) u e-reb UTU(=šamši) i-na-aṣ-ṣa-ru UTU(=šamši)-ma] [IX: ], inducendo gli studiosi, sebbene a malincuore, a emendare il verso
[IX: ] in šá umišama inaṣaru a[ṣê šamši u ereb šamši], «che giornalmente guarda il sorg[ere del sole e il tramonto del sole]».
Chiedersi come faccia il sole a sorgere e tramontare dalla stessa
porta può essere una domanda scomoda. Una possibilità risolutiva,
sebbene raramente proposta dagli studiosi, è che lo šadû
Māšu sia un'unica montagna e si trovi a nord e che
funga da asse celeste; che non risponda al modello delle portae mundi ma a quello dell'axis
mundi. Ciò spiegherebbe perché gli aqrab-amēlû stanno a
guardia del sole tanto al tramonto quanto al suo sorgere
[IX: ], ma anche perché, nel momento in cui
Gilgameš è al nono bēru del suo buio percorso lungo il
ḫarran šamši, avverta il «vento
del nord» [iltānu] soffiare sul suo viso. Il modello axis mundi è sicuramente meno
intuitivo, ma dopo aver analizzato la cosmologia iranica, con il suo
monte Tērag-ī-Harborz che funge da asse per la
rivoluzione del sole intorno la terra, e dopo aver seguito l'Eskandar
di Neẓāmī a Ẓolmat,
sotto la scura montagna polare, l'idea appare assai meno peregrina. Ci si può chiedere
se il KUR delle varianti sumeriche non sia un esempio arcaico di questo mitema.
Nell'Imago mundi Babylonica, all'altezza di uno dei nagi˒ānu settentrionali, compariva un BÀD.GULA, un «grande muro [...] dove
Šamaš non è visto», che potrebbe essere un
altro esito mesopotamico del modello dell'axis mundi. Il tal
caso, la distanza di sei bēru, fornita dall'Imago mundi, se intesa in senso temporale, potrebbe indicare le dodici ore che il sole impiega a percorrere
l'altro lato della montagna.
Ma l'idea di un «grande muro», se presa nel più elementare senso semantico, ricorda piuttosto il cingulus mundi, sebbene tale
modello non sia altrimenti attestato nei testi sumeri o accadici. In sintesi, le possibili interpretazioni dei testi mesopotamici
ci consegnano un'ampia possibilità di opzioni, che però sono valide
unicamente come interpretazioni alternative degli oronimi che compaiono
nei singoli testi:
| |
Portae mundi |
Axis mundi |
Cingulus mundi |
| Ša naqba īmuru |
šadû
Māšu (?) |
šadû
Māšu (?) |
|
En-e kur
lu tillaše
Ia lulu uluḫḫa sudsud |
|
KUR (?) |
|
SB [Hh XXII]
TCL [XV: 7, ] |
Šadû Ḫašur
Šadû Budugḫudug |
|
|
| Imago
mundi Babylonica |
|
BÀD.GULA (?) |
BÀD.GULA (?) |
Egitto
Non appaia un arbitrio se ci spostiamo un momento in Egitto,
territorio culturale che abbiamo appena accennato in questo studio. Sebbene
la letteratura della terra dei faraoni non abbia conservato, a nostra
conoscenza, alcun racconto incentrato su una disperata ricerca della
vita eterna, questo tema era onnipresente in tutti i miti escatologici e
aveva continuo riscontro nel riti funerari di questo popolo ossessionato
dalla morte e dalla possibilità di una vita oltremondana. Il lettore che
ci ha seguito fin qui, d'altra parte, riconderà come un riscontro con la
simbologia egizia ci è stato precedentemente utile nel delineare il
motivo della «gemellarità» del monte dell'alba e del tramonto. Abbiamo
visto come le due cime dello šadû, ben evidenti in alcuni sigilli
antico-babilonesi che raffigurano il sorgere e il calare del dio-sole
Utu/Šamaš (immagini:
[ME, 89110]✦ e
[ME,
89115]✦), abbiano un puntuale riscontro
nella scrittura geroglifica, dove la parola ḏew [ḏw],
«monte», era rappresentata da un rilievo concavo, e la parola ẚḫet
[ꜣḫt], «orizzonte», era rappresentata dal sole
sospeso sulla concavità (immagine:
[ḏew e ẚḫet]✦) (Betrò 1995).
Gli egittologi hanno analizzato la complessa simbologia del monte a
due cime raffigurato nei geroglifici ḏw e ꜣḫt.
A un livello prettamente geografico, le due cime alluderebbero alle catene montuose che si trovano a est e a ovest della valle del Nilo
e che segnavano i confini dell'Egitto, chiamate rispettivamente
Bẚū [bꜣw] e
Mẚnū [mꜣnw]. Il sole, Reʿ [rʿ]
nel suo aspetto principale, sorgeva dietro la catena orientale,
Bẚū, e tramontava dietro quella
occidentale, Mẚnū.
 | |
ker. Papiro egizio | |
Immagine simbolica del dio ker,
raffigurato come due leoni maculati ai lati del geroglifico 3ḫt,
«orizzonte», dove il sole è sospeso sulla concavità di una
montagna bicuspide. |
A guardia dell'orizzonte stava il dio ker
[ꜣkr], il quale aveva il compito di aprire le porte del
mattino e della sera, in modo che Reʿ
potesse passare
nel suo sorgere e nel suo tramontare. Tali porte erano anche i
varchi tra il nostro mondo e il regno dei morti, la
Dūẚt [dwꜣt]. Perciò, ker,
dio dell'orizzonte, era anche il dio del «passaggio» tra il giorno e la
notte e, di conseguenza, tra la vita e la morte. Non lo si rappresentava
in forma antropomorfa, ma veniva
simbolizzato dal geroglifico ꜣḫt affiancato da due leoni
che guardavano in direzioni opposte. I due felini –
forse una varietà maculata dell'ormai estinto leone di Barberia – si
chiamavano Sef [sf]e
Dūẚū [dwꜣw], «ieri» e
«domani».
S'imporrebbe qui un trattato sulle concezioni simboliche sul percorso
del sole, tanto diurno, quanto notturno, nella mitologia egizia. Di
come, sorgendo, «fecondasse» la dea-cielo Nūt,
viaggiasse nel corso del giorno lungo il suo corpo, inarcato attraverso
la volta celeste, e quindi, a sera, dopo aver attraversato l'orizzonte,
entrasse nella sua bocca. E di come, il suo viaggio notturno compiuto,
da ovest a est, all'interno del corpo di Nūt,
si riflettesse in un percorso ipoctonio, attraverso la
Dūẚt. E infine di come, la mattina
successiva, il dio-sole rinascesse a nuova vita, «partorito» a oriente
dalla dea-cielo (Meeks
~ Meeks 1993 | Tosi 2004 | Zecchi 2004). La natura contorta e
spesso contraddittoria di tali simbolismi non deve però lasciarci
sviare: le eccessive stratificazioni simboliche della mitologia egizia
costituiscono idiosincrasie peculiari, non necessariamente
estendibili ad altri sistemi mitologici. Se abbiamo lanciato uno sguardo
curioso lungo le rive del Nilo è solo per sottolineare, con un esempio
forse eccessivo, come la cosmologia del mito segua a volte percorsi
assai poco aristotelici.
Non sarà sfuggito, ad esempio, il fatto che ker
sta a guardia delle porte del sole tanto a oriente quanto a occidente. Il
suo nome significa «colui che s'incurva» e, quale dio dell'orizzonte, è
presente al passaggio del sole sia presso la porta del monte
Bẚū, a est, sia presso quella del monte
Mẚnū, a ovest. In altre parole, condivide la
strana caratteristica degli aqrab-amēlû, gli
uomini-scorpione, che stanno a guardia alle porte dello šadû
Māšu tanto al tramonto tanto all'alba. Ma non bisogna pensare a
una sorta di ubiquità da parte di ker,
né sono gli uomini-scorpione che si spostano da est a ovest. Nei
geroglifici ḏw «monte» e ꜣḫt «orizzonte»,
la montagna a due cime rappresenta tanto il monte
dell'alba tanto il monte del tramonto. Nella logica del pensiero mitico, il
monte a est e quello a ovest sono in realtà una sola montagna.
Le due cime, raffigurate l'una accanto all'altra, ne rappresentano la
natura duplice. E ker, dio
dell'orizzonte, ne è il guardiano dell'unica porta, che è situata
sia
a est sia a ovest. Inoltre, a un livello prettamente simbolico,
il geroglifico ꜣḫt, «orizzonte», rappresenterebbe
anche la collina primordiale (ḳꜣꜣ wnw) che venne
spaccata in due quando tūm-Reʿ comparve
come luce, per la prima volta, all'inizio del mondo.
Estendendo il medesimo ordine di idee ai sigilli antico-babilonesi, la montagna a due cime
attraverso la quale il dio-sole Utu/Šamaš
sorge
[ME, 89110]✦ e tramonta
[ME,
89115]✦ è sia la montagna dell'alba sia quella del tramonto, le cui nozioni si fondono in un rilievo duplice,
annullando di fatto l'orizzonte. La porta che
Gilgameš vede incastonata nello šadû
Māšu vale tanto per l'alba quanto per il tramonto.
La simbologia egizia può aiutarci a penetrare in questa logica che
trasforma la geografia e l'astronomia in un campo astratto, costituito esso stesso di geroglifici, e sicuramente lontanissimo dal nostro modo
di percepire il mondo. Ma non vogliamo insistere troppo su questa linea.
Sarebbe improprio – e davvero troppo facile – proporre una simbologia
tanto «fumosa» come chiave di interpretazione delle sofisticate
concezioni astronomiche dei popoli della Mesopotamia, che erano frutto di lunghe
e attente osservazioni. Nella nostra pretesa di
razionalità abbiamo bisogno di schemi più rigorosi e concreti.
Grecia
Nella mitologia ellenica troviamo attestato sia il
modello delle portae mundi sia quello dell'axis mundi. I due
modelli, però, non compaiono mai insieme e non si sovrappongono. In
oltre tre millenni di elucubrazioni teologiche, gli Egiziani erano
riusciti a sovraccaricare i loro simboli di un gran numero di
significati divergenti, deformandone le semantiche fino a farci stare
dentro di tutto. Al contrario, i Greci erano troppo razionali per non
avvertire una contraddizione, logica prima che cosmologica, tra
due modelli tanto diversi come le portae mundi e l'axis mundi.
Ragion per cui, pur conservandoli entrambi, li concepirono come alternativi
tra loro. Entrambi i modelli sopravvissero nel ciclo di Hērakls,
ma vennero considerati delle varianti inconciliabili.
La geografia ellenica identificava la montagna del tramonto col
massiccio dell'Atlante e la montagna dell'alba, forse, con la catena del
Caucaso. La faccenda presenta complesse
stratificazioni che dobbiamo evidenziare prima di procedere.
Che il titán Átlas avesse il proprio regno in Libýē, all'estremità
occidentale dell'oikouménē, dinanzi al fiume Ōkeanós,
ce ne dà conferma la maggior parte delle fonti classiche, soprattutto
di epoca ellenistica e imperiale. Essa ha le sue attestazioni
principali in Pherekýdēs (FGrHist [3 F
16a]), Diódōros Sikeliṓtēs
(Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 27]),
Apollṓnios Rhódios (Tá Argonautiká [IV: -]),
Hyginus (De Astronomia
[II: 30]) e anche in Nónnos Panopolítēs, che parla di un
«libico Átlas» [Líbus Átlas]
(Dionysiaká [XVIII:
]). Naturalmente in tutti questi casi si parla del titán
Átlas, non dell'óros Átlas, sebbene
si dia per scontato che la montagna abbia preso nome dal gigante che vi
dimorava. Nella maggior parte di queste fonti, il
monte è associato al giardino delle Hesperídes,
ma il dato cosmologico è assente. Fa eccezione Publius Ovidius
Naso, il quale, trattando il mito non come dato geografico,
bensì come fabula, non ha timore di attingere ai suoi
elementi più arcaici:
Iapetionides Atlas fuit, ultima tellus
rege sub hoc et pontus erat, qui Solis anhelis
aequora subdit equis et fessos excipit axes.. |
Átlas, figlio di Iapetós
regnava sull'estremo lembo della terra
e sulle distese marine che accolgono nel loro grembo
i cavalli ansimanti e il cocchio stanco del sole... | | Publius Ovidius Naso: Metamorphoseon [IV: -] |
Ovidius definisce cosmologicamente il regno di Átlas
come il luogo, situato «sull'estremo lembo della terra», dove scende a
immergersi, al tramonto, il «cocchio stanco del sole». In questa terra,
che il poeta augusteo chiama Hesperia, «sugli alberi, fronde lucenti, d'oro sfavillante,
/ coprivano rami d'oro, frutti d'oro» [arboreae frondes auro radiante nitentes
/ ex auro ramos, ex auro poma tegebant.] [IV: -].
Infine, Ovidius pietrifica il titán Átlas,
trasfigurandolo nel monte omonimo, e così completa lo scenario: Quantus erat, mons factus Atlas; nam barba comaeque
in silvals abeunt, iuga sunt umerique manusque,
quod caput ante fuit, summo est in monte cacumen,
ossa lepis fiunt: tum partes auctus in omnes
crevis in inmsum (sic, di, statuistis) et omne
cum tot sideribus caelum requievit in illo. | Grande quant'era, Átlas diventò un monte. La barba e i capelli
passarono infatti in selve, le spalle e le mani sono balze,
quello che prima era
il capo è il più alto cocuzzolo della montagna,
le ossa divennero sasso. Poi, gonfiandosi dappertutto,
crebbe smisuratamente in altezza (così decideste, o dèi), e tutto
il cielo con le sue tante stelle poggiò su di lui. | | Publius Ovidius Naso: Metamorphoseon [IV: -] |
«...e tutto il cielo con le sue tante stelle poggiò su di lui». E
questa, come sappiamo, è un'importante caratteristica delle montagne cosmiche: anche
riguardo alle vette del Māšu si diceva che
«sulle loro cime grava la volta celeste»
(Ša naqba īmuru [IX: ]).
E il ǧabal al-Qāf in Arabia e il monte Harā Bǝrǝzaitī/Harborz/Alborz
in Īrān hanno la medesima funzione di sostenere il cielo e unirlo alla
terra. Che il massiccio del Caucaso potesse essere considerato,
in una qualche remota cosmografia greca, l'analoga montagna dell'alba,
non è altrettanto certo. Le fonti non sono esplicite al riguardo:
nondimeno ci trasmettono degli interessanti segnali. Il Caucaso era considerato il più remoto punto orientale della geografia arcaica
e soprattutto era il luogo dove era stato incatenato Prometheus. È Strábōn a collegare esplicitamente le due nozioni: «I Greci hanno chiamato questi monti
Kaúkasos [...]. Lì si svolge il racconto mitico di Promētheús e del suo incatenamento: ma questo perché, allora, il
Kaúkasos era l'estremo limite orientale conosciuto» (Geōgraphiká [XI, 5, ]).
La concezione del mondo tracciata dal geografo Hekataîos Milḗsios
(550-476 a.C.), sebbene si collochi ormai in età classica e contempli località esotiche come l'Assyría, la Mēdía, la Persía e
l'Indía, nondimeno continua a disporre
il Kaúkasos verso l'estremità orientale della terra
(Períodos
Gs).
 | |
Mappa mundi secondo Hekataîos
Milḗsios |
Può essere interessante seguire gli spostamenti di Hērakls
su una mappa di questo tipo. Vediamo infatti l'eroe toccare
le estremità del disco terrestre (oikouménē) in tutti e quattro i
punti cardinali:
- occidente: a Erýtheia,
per il furto del bestiame di Gēryṓn
(o all'óros Átlas in Libýē per i frutti d'oro nel
giardino delle Hesperídes);
- meridione: in Aithiopía o in Arabía, per imbarcarsi
sulla coppa di Hḗlios nel corso
dell'undicesimo érgon;
- oriente: sull'óros Kaúkasos, per liberare Promētheús;
- settentrione: verso l'óros Átlas nella terra degli
Hyperbóreoi per i rubare frutti nel
giardino delle Hesperídes.
Infatti Apollódōros, nel corso dell'undicesimo érgon, fa imbarcare Hērakls
sulla coppa del sole sul lato sud-orientale di Ōkeanós per
poi farlo sbarcare
nel Kaúkasos. In epoca arcaica si riteneva che il Kaspía
thálassa (il mar Caspio) fosse un golfo
aperto a est, o a nord-est, sul potamós Ōkeanós. Aiskhýlos si riallaccia a questa visione
geografica quando, nella sua tragedia, invia dapprima le Ōkeanídes a consolare Promētheús,
incatenato per ordine di Zeús, e poi lo stesso Ōkeanós
per convincere il titán ribelle a riconoscere la sovranità del re dell'Ólympos
(Promētheús desmṓtēs).
Se il Kaúkasos fosse stato correttamente situato al centro del
continente eurasiatico, difficilmente avremmo visto le Ōkeanídes,
e ancor più difficilmente Ōkeanós –
che nel mito non si muove mai dalla sua sede intorno alla terra –,
intrattenersi con Promētheús.
Ma nella concezione geografica arcaica, il titán incatenato tra le
asperrime rocce del Kaúkasos non era così lontano dai flutti
di Ōkeanós.
Apollṓnios Rhódios (❀ III sec. a.C.) che,
pur vivendo in piena epoca ellenistica, ambienta il suo poema in una
geografia mitica, scrive che «il regno di Aîa, in Kolkhís, si stende
agli estremi confini di mare e di terra» (Tá
Argonautiká [I: ]). Detto, questo, ciò che ancora ci
manca è un collegamento esplicito tra il massiccio caucasico e il
sorgere del sole. Forse non è significativo il fatto che il mitico
re di Kolkhís, Aiḗtēs, fosse
considerato figlio di Hḗlios, e che il
nome del suo regno, Aîa, sembri derivare da quello della dea dell'autora
Éōs. Più importante, al riguardo, è
però una nota dello stesso Apollṓnios, il quale fa dire a un suo
personaggio che «la Libýē è tanto lontana dal regno di Kolkhís
quanto vediamo lontani l'oriente e il tramonto»
(Tá Argonautiká [I: -]),
stabilendo finalmente una proporzione ideale in cui la Libia sta al
tramontare del sole come il Caucaso sta al suo sorgere.
 |
|
Atlas e Promētheús
(✍
±530 a.C.) |
Kylix laconico, da Cerveteri
Musei Vaticani, Roma (Italia) |
Queste note suggeriscono la presenza, in una fase remota del mito greco,
del modello cosmologico delle portae mundi: due montagne, l'óros
Kaúkasos
e l'óros Átlas, situate sulle sponde del fiume Ōkeanós,
l'una nell'estremo oriente della terra, l'altra nell'estremo occidente, le quali
sorreggono il cielo e si stagliano dinanzi al sole, rispettivamente nel suo sorgere e nel
suo tramontare.
Ciascuna delle due montagne è legata inoltre a un titán
condannato a scontarvi un'atroce punizione. Prometheus
e Átlas,
i due figli di Iapetós, sono infatti segnati da un
destino convergente: relegati alle opposte estremità del mondo, sono
immobilizzati nelle rispettive sedi: l'uno nel Kaúkasos, incatenato a
una colonna, o direttamente alle
rocce di una montagna, sospeso tra il cielo e la terra; il
secondo condannato a fungere egli stesso da colonna tra la terra e
il cielo. Il primo torturato da un'aquila [aetós kaukasíos], il secondo
affiancato da un serpente [drákōn hespérios]. Dei
due, Promētheús mantiene una certa sua individualità
rispetto all'ambiente orografico in cui è collocato (ma
in proposito rimandiamo ai miti caucasici su Amirani/Abrskil
Ⓐ▼),
mentre Átlas è venuto a identificarsi fisicamente con il massiccio di cui
porta il nome.
Ma c'è un altro fil rouge che accumuna i due
titânes: entrambi vengono visitati da Hērakls nel corso del suo viaggio verso il
Kpos Hesperídōn.
L'eroe libera Promētheús, ma non Átlas. Inoltre uccide sia il drákōn hespérios
sia l'aetós kaukasíos. Il fatto che Hērakls
visiti entrambi i figli di Iapetós non è solo un'indicazione delle valenze di
simmetria e specularità che associano e oppongono Promētheús ed Átlas,
ma anche un'ulteriore traccia che i due Iapetonídēs simboleggiano
gli opposti confini del mondo, e l'aver raggiunto sia l'uno che
l'altro definisce il personaggio di Hērakls
in termini dei suoi spostamenti ai confini della terra.
Il gioco di simmetrie tra Promētheús ed Átlas
ci dice che, in una certa fase del mito greco, i mitografi hanno speculato sull'analogo destino a cui sono andati
incontro i due Iapetonídēs. È incerto tuttavia che sia mai esistito,
in epoca antica, un modello equilibrato e coerente. È assai più probabile, a nostro avviso, che i due personaggi si
siano, per così dire, «incastrati» nelle rispettive posizioni in una
fase in cui le conoscenze geografiche degli Elleni erano progredite al
punto tale che il Kaúkasos aveva cessato di essere l'estremità orientale del
mondo, e quindi il sistema non è mai arrivato alla sua perfetta simmetria
geografica.
Se ci spostiamo indietro nel tempo, agli albori della letteratura
greca, scopriamo che Hēsíodos non
identifica Átlas con una montagna, bensì lo
proietta «ai confini della terra, davanti alle Hesperídes dalla voce sonora»
(Theogonía [-]),
dopo aver disposto queste ultime «al di
là del famoso Ōkeanós»
(Theogonía []). Dunque, per Hēsíodos,
l'occidente in cui è collocato Átlas
non era la Libýē, ma un luogo indefinito, remoto, situato oltre l'oceano cosmico.
Un occidente che non apparteneva all'oikouménē ma al kósmos.
E prima ancora di Hēsíodos, in quella che è la
prima apparizione
letteraria di Átlas, lo stesso
Hómēros ci fornisce un suggerimento
importantissimo:
Átlantos thygátēr oloóphronos, hós te
thalássēs
pásēs bénthea oîden, ékhei dé te kíonas
autòs
makrás, haì gaîán te kaì ouranòn amphìs
ékhousi. |
...Átlas, dal cuore perverso, il quale del mare
tutti conosce gli abissi, regge le grandi colonne,
che terra e cielo sostengono da una parte e dall'altra... |
|
Hómēros: Odýsseia
[I: -] |
I classicisti, analizzando questo passo omerico sulla base
di ciò che hanno appreso dalle fonti successive, ma anche
secondo
logica, si sono limitati a evidenziare che: (a)
Hómēros è ambiguo sull'esatta
posizione di Átlas e non
dice se il titán fosse collocato a oriente o a
occidente; che (b) Átlas viene detto esperto di tutti gli abissi
marini [thalássēs pásēs bénthea], i quali
sono ovviamente quelli del potamós Ōkeanós
che circonda la terra; e che (c) il titán non
sostiene direttamente la volta celeste ma lo fa tramite delle «grandi
colonne» [kíonas makrás], le quali sostengono il cielo e
la terra. L'esatto significato del verso ha fatto
dannare i filologi. L'avverbio amphís viene di
solito inteso come «da tutte e due le parti», nel senso che
le colonne sosterrebbero da un lato il cielo e dall'altro la
terra, ma ha anche il significato di «intorno», e in tal
caso la frase potrebbe indicare la presenza di una
successione di colonne, o di montagne, che sostengono il cielo
tutto intorno alla terra. Avremmo in tal caso un
cingulus mundi, simile al ǧabal
al-Qāf, oppure un sistema
di portae
mundi opposte ma coincidenti, affine ai monti egiziani dell'alba e del
tramonto.
Quanto abbiamo precedentemente sottolineato riguardo al dio egiziano ker,
che presiede tanto ai monti dell'alba tanto a
quelli del tramonto, e sugli aqrab-amēlû, che
presso lo šadû
Māšu osservano il sole tanto nel suo sorgere
tanto nel suo tramontare, potrebbe gettare una nuova
luce su questi versi omerici. Se valesse per Hómēros
una cosmologia affine a quella egiziana, avremmo un Átlas
non limitato al solo occidente ma, come ker,
identificato con l'intero orizzonte. Il fatto che, secondo Hómēros,
Átlas «del mare tutti conosce gli
abissi», potrebbe essere una preziosa indicazione che il titán
fosse considerato presente nell'intero circolo del potamós
Ōkeanós, e quindi tutto intorno al
mondo.
Átlas – se abbiamo ben
interpretato Hómēros –
era forse un'antica divinità dell'orizzonte: il titán
a guardia delle portae mundi, situato presso le
colonne/montagne che sostengono il cielo da ogni lato, e di cui troviamo
forse un antemito nella figura di
Upelluri, il torpido atlante abissale della
mitologia ḫittita. Promētheús,
come abbiamo sottolineato in uno studio precedente, è
invece l'esito ellenico del tricefalo incatenato, di probabile
origine indoeuropea, i cui omologhi più noti sono
Viśvarūpa in India,
Aži Dahāka in Īrān e Loki in
Scandinavia Ⓑ▼. La convergenza di queste due figure, l'uno relegato a
sorreggere il cielo sull'orizzonte, l'altro destinato a
venire incatenato tra le montagne che sostengono il cielo, deve aver
comportato un complesso scambio di attributi e valenze. Alla
fine di questo processo, i due personaggi, trasformati in
fratelli, hanno finito per venire rielaborati secondo sorti
simmetriche, dividendosi in parte il ruolo: l'uno (Promētheús)
imprigionato tra cielo e terra, al limite orientale del
mondo, l'altro (Átlas)
condannato a sostenere il cielo sulle proprie spalle, al
limite occidentale del mondo.
Ma...
Ma accanto al modello delle portae mundi (a cui aggiungiamo
l'ipotesi del cingulus mundi), il mito ellenico
conosce anche il modello dell'axis mundi, attestato ancora una
volta nel ciclo eracleo, nell'ambito del quale, anzi, viene presentato come una
variante alternativa. È presente in Apollódōros,
il quale spedisce Hērakls
nell'estremo settentrione del mondo: ed è appunto qui che l'eroe incontra Átlas
e penetra nel Kpos Hesperídōn (Bibliothḗkē [II: 5]).
Le ragioni per cui i mitografi abbiano rimosso
Átlas dalla sua sede originaria,
l'estremo occidente, e l'abbiano spostato nel settentrione del mondo,
potrebbe essere dovuto a considerazioni di carattere astronomico. Poiché il cielo ruota attorno a un asse inclinato in direzione nord, la posizione più logica perché Átlas possa fungere non solo da sostegno celeste, ma anche da axis mundi,
da perno per la rotazione del firmamento, è appunto a nord.
E nonostante la complessa rilocalizzazione astronomica dell'antico titán, la sua natura orografica, insieme gigante e montagna, rimane valida, come attesta il perplesso Apollódōros, il quale scrive che i frutti delle Hesperídes «non si trovavano, come alcuni hanno detto, in Libýē, ma sul [monte] Átlas tra gli Hyperbóreoi...» (Bibliothḗkē [II: 5]).
Questa posizione «polare» di Átlas
è apprezzata soprattutto dagli astronomi. Dà un nuovo significato al drákōn hespérios, Ládōn,
catasterizzato nella costellazione che i Greci conoscevano
come Ópheōs, il «serpente» (→ Draco, il «dragone»),
secondo quanto attesta Eratosthénēs
(Katasterismoí [3]).
Tale costellazione, situata vicino a quella di Hercules, doveva
infatti conservare la memoria della lotta che Hērakls aveva ingaggiato contro Ládōn per impadronirsi dei frutti.
| Si racconta che [il
«serpente»] era il guardiano dei frutti d'oro e fu ucciso da Hērakls. Hḗra gli dette un posto fra le stelle, lei che lo aveva messo a proteggere i frutti presso, presso le Hesperídes. [...] È prova decisiva di questa identificazione il fatto che gli sta accanto l'immagine di Hērakls: con questa disposizione delle figure Zeús voleva conservare nel modo più efficace la lotta tra di loro. | Eratosthénēs: Katasterismoí [3] |
 |
|
Draco e Hercules |
|
Posizioni degli asterismi oggi
conosciuti come Draco e Hercules.
Nell'antichità, il polo celeste era collocato presso α Draconis.
La costellazione Hercules è di costituzione piuttosto
recente: gli astronomi greci si riferiscono ad essa tramite
diverse lezioni. Immagine creata con il programma
Stellarium. |
Tale interpretazione sembra tuttavia un'invenzione di Eratosthénēs,
stando a quanto afferma Hyginus (De Astronomia [II, 3]).
Uno dei principali curatori dei Katasterismoí, il classicista tedesco Karl Robert
(1850-1922), aveva emendato il testo, riportato dai manoscritti nella lezione epì ts hespéras, «a occidente», in taîs Hesperísi, «presso le Hesperídes» (Robert 1878), e la maggior parte dei curatori ha seguito il
suo suggerimento. Non è
certo una correzione innocua, viste le ricadute cosmologiche che comporta... e non
solo riguardo alla localizzazione del
Kpos Hesperídōn
(Santoni 2009), ma un filologo competente non propone
correzioni ai
testi senza validissime ragioni. Eratosthénēs
è stato uno dei maggiori astronomi dell'antichità: aveva
certamente ben presenti
tutte le implicazioni dovute alla posizione del mitico Átlas in relazione all'asse celeste e, nell'indicare
la costellazione Ópheōs (→ Draco),
dirotta esplicitamente l'attenzione a nord.
Tra il Quarto e il Terzo millennio avanti Cristo, la stella principale di questa costellazione, α Draconis (oggi Thuban, dall'arabo ṯuʿbān «basilisco»), si trovava presso il polo celeste ed era utilizzata come stella polare. Nel testo di Eratosthénēs, sia che accettiamo sia che scartiamo la correzione di Karl Robert, sono
già presenti tutte le ragioni astronomiche della traslazione di Átlas da occidente a settentrione e quindi della ridefinizione
dell'intera macchina celeste.
| |
Cingulus mundi |
Portae mundi |
Axis mundi |
| Hómēros |
aut: Átlas
sorregge le grandi colonne disposte intorno al
mondo. |
aut: Átlas
sorregge le colonne che sostengono il cielo e la
terra. |
|
| Hēsíodos |
|
Átlas
sorregge il cielo a occidente del kósmos,
oltre il fiume Ōkeanós. |
|
Pherekýdēs
Diódōros Sikeliṓtēs
Apollṓnios Rhódios
Hyginus
Nónnos Panopolítēs |
|
Átlas
risiede a occidente dell'oikouméne,
presso l'óros Átlas. |
|
|
Ovidius
|
|
Átlas,
trasformato nell'óros Átlas,
sorregge il cielo a occidente dell'oikouméne. |
|
|
Apollódōros
Eratosthénēs
(?)
Hyginus
(?) |
|
|
Átlas
sorregge il cielo nell'estremo settentrione del
mondo, fungendo da supporto per il polo celeste. |
Sembrerebbe logico presumere una progressione storica dei tre modelli (cingulus,
portae, axis mundi)
presso gli antichi Elleni, ma di nuovo dobbiamo chiederci se non stiamo
inconsciamente retro-proiettando un nostro preconcetto
sullo sviluppo positivo del pensiero. In realtà potrebbero esservi ottime
ragioni per sostenere che il modello dell'axis mundi
possa essere altrettanto antico di quello delle portae o del
cingulus mundi. Immaginare che i tre
modelli rappresentino un'evoluzione del pensiero, significa sottovalutare di gran lunga le
competenze astronomiche degli antichi. Non c'è mai stato un
momento storico in cui qualcuno si è accorto che il sole non sorge
mai nello stesso punto dell'orizzonte, o che il cielo ruota intorno
a un asse fissato nel polo celeste. Tali conoscenze sono presenti
nell'esperienza umana fin dalla preistoria. Portae,
cingulus e axis mundi non sono modelli alternativi, ma
coesistono e, in certa misura, si integrano tra loro. È nostra opinione che tali sistemi
abbiano cominciato a essere
avvertiti come
contraddittori soltanto quando sono stati applicati all'astronomia
strumenti logici sempre più raffinati, o quando la mitologia, in
epoca classica, ha cominciato a essere letta come silloge di fatti
inquadrabili storicamente e geograficamente.
Īrān zoroastriano e Islām
Se in Mesopotamia o in Grecia i
monti dell'alba e del tramonto si trovavano ancora alle estremità
dell'oikouméne, nel modello delle portae mundi, in India e in Īrān vengono sospinti oltre il cerchio dell'oceano, laddove la terra sfuma nel kósmos,
e prevale il modello del cingulus mundi. Nella cosmologia indiana, attestata nei Purāṇa, la catena dei monti è detta Lokāloka («mondo-non-mondo») in quanto percorre il confine esterno della terra (qui costituita da una serie di sette dvīpa,
continenti anulari, tra loro concentrici, di cui la parte del mondo abitata dagli uomini corrisponde al lato meridionale del continente più interno, il Jambudvīpa), separandola dall'oscuro spazio esterno. Ma se il modello indiano si presenta in forma eccessivamente astratta e concettualizzata, assai più interessante, e vicino ai nostri scopi, è quello iranico.
Nell'Avestā la montagna
che circonda il mondo ha nome Harā Bǝrǝzaitī. In questa fase, la tradizione appare ancora fluida ma sono già presenti tutti gli elementi che verranno fissati in seguito dal canone zoroastriano. Il monte Harā ha innanzitutto la funzione di montagna dell'alba: ogni mattina il sorge passa al di sopra della sua vetta (Yašt Mihr [10: ]), sebbene lo yazatā Miθra lo preceda scavalcando l'immensa barriera montuosa per scendere dal mondo celeste sulla terra: | miθrǝm vouru-gaoyaoitīm
[...] ǰaγaurvåŋhǝm ýō paoiryō mainyavō ýazatō tarō harąm āsnaoiti paurva-naēmā amǝahe hū ýa aurva-aspahe... | Sacrifichiamo a Miθra, signore degli ampi pascoli [...], instancabile e sempre vigile, che è il primo yazatā del mondo celeste a superare il monte Harā [Bǝrǝzaitī], prima del sorgere del sole immortale, dai veloci destrieri... | Yašt Mihr [10: -] |
La mitologia zoroastriana, anche nella sua fase più antica, offre uno spazio importante all'orografia cosmica. | miθrǝm vouru-gaoyaoitīm
[...] ǰaγaurvåŋhǝm ýahmāi maēθanǝm frāθwǝrǝsa ýō daδvå ahurō mazdå upairi harąm bǝrǝzaitīm pouru-fraorvaēsyąm bāmyąm ýaθra nōi xapa nōi tǝmå nōi aotō ātō nōi garǝmō nōi axtiš pouru-mahrkō nōi āhitiš daēvō-dāta naēδa dunmąn uzǰasaiti haraiθyō paiti barǝzayå | Sacrifichiamo a Miθra, signore degli ampi pascoli [...], instancabile e sempre vigile, per il quale il creatore, Ahura Mazdā, ha costruito una dimora sullo Harā Bǝrǝzaitī, la luminosa montagna attorno alla quale ruotano molte stelle, dove non c'è notte né buio, né vento freddo né vento caldo, né malattia mortale e nessuna impurità fatta dai daēvā; le nubi stesse non posso raggiungere lo
Haraitī Barǝzā. | Yašt Mihr [10: -] |
In un altro yašt, dedicato alla
Terra, si elencano le varie montagne man mano che spuntano dal suolo, l'una dopo l'altra: esse si moltiplicano e circondano il mondo a oriente e a occidente. È un passo davvero suggestivo, di cui riportiamo la prima parte, essendo il seguito un interminabile catalogo di vette: | paoiryō gairiš hąm-hišta spitama zaraθuštra paiti āya zǝmā haraiti barš hā hama pāirisāite frāpayå dahuš ā upaoaŋhvåsca, bityō zǝrǝδazō gairiš pārǝṇtarǝm arǝδō manuahe hāmō hasci pāirisāite frāpayå dahuš ā upaoaŋhvåsca. | La prima montagna che è sorta dalla terra, o Spitāma Zaraθuštra, è stata lo Haraitī Barǝzā. La montagna si estende lungo le spiagge della terra bagnata dal mare verso oriente. La seconda montagna è stata il monte Zǝrǝδo, all'esterno del monte Manuā. Anche questa montagna si estende lungo le spiagge della terra bagnata dal mare verso oriente. | | ahma haca garayō fraoxyąn uiδå uidarǝnō ǝrǝzifyasca fraorǝpō xštvō ǝrǝzurō haptaθō būmyō aštǝmō raoδitō naomō mazivå dasǝmō aṇtarǝ-dahuš aēvaṇdasō ǝrǝziō dvadasō aiti-gaēsō… | Da lì sono sorti il monte Uiδau, il monte Uidarǝnā, il monte Ǝrǝzifyā e il monte Fraorǝpā. Il sesto a sorgere è il monte Ǝrǝzurā. Il settimo è il monte Būmyā. L'ottavo è il monte Raoδitā. Il nono è il monte Mazivau. Il decimo è il monte Aṇtarǝ-dahu. L'undicesimo è il monte Ǝrǝzisā. Il dodicesimo è il monte Vaiti-gaēsā... | Yašt Zamyad [19: -] |
Lo yašt continua a elencare la nascita di una lunga serie di monti e conclude affermando che, in tutto, si siano formate duemila duecento quarantaquattro montagne. Il senso etico del processo di orogenesi viene definito solo nel successivo periodo medio-persiano. Nella letteratura
sāsānide, lo spuntare dei monti diviene una disperata reazione al trionfo delle forze ahrimaniche: mentre la druǰ prende forza sulla terra, questa si ribella e tenta di ricongiungersi al cielo, emanando le montagne in una sorta di possente abbraccio tra terra e cielo. Il testo, molto interessante, è riportato sia nel «grande» Bundahišn [9: -], sia nella sua versione «indiana», il Zand-āgāhīh Bundahišn [12: -]. È un passo piuttosto lungo ma abbastanza raro da indurci a presentarlo ai nostri lettori: | gōwēd pad dēn kū fradom, [harborz. pas hamāg kōf] frāz rust hēnd pad haštdah sāl, harborz tā bowandagīh hašt sad sāl hamē rust. dō sad sāl ō star-pāyag ud dō sad sāl ō māh-pāyag ud dō sad sāl ō xwaršēd pāyag ud dō sad sāl ō a-sar-rōšn. | Sulla natura delle montagne si parla nelle scritture: la prima montagna a spuntare fu Harborz, che venne fuori in diciotto anni. E Harborz continuò a crescere per ottocento anni: in duecento giunse al pāyag delle stelle, in [altri] duecento al pāyag della luna, in [altri] duecento al pāyag del sole, in [altri] duecento raggiunse la luce infinita. | | čiyōn abārīg kōfān az harborz rust hēnd, pad marag dō hazār ud dō sad ud čehel ud čahār kōf, [ī] ast hugar ī buland, tērag
ī harborz, čagād ī dāiti, ud arzūr pušt, usindām kōf, kōf ī abarsēn kē kōf [ī] pārs gōwēnd. kōf ī zǝrǝza kē hast {ast} kōf ī manuš, kōf ī iriz, kōf ī kāf, kōf ī wadges, kōf ī ušdāštār, kōf ī arzūr-būm, kōf ī rōyišnōmand, kōf ī padišxwārgar, kē mahist andar xwārīh, kōf ī čīn xwānēnd, kōf ī rēwand, kōf ī dār-spēd, bagīr [kōf], kōf ī was-škeft, kōf ī syāōmand, kōf ī wafrōmand, kōf ī spandyād, kōf ī kadrwasp, kōf ī asnāwand, kōigrās kōf, [ī] sēzdah kōf andar ān ī Kang-diz kē gōwēnd kū āsānīhōmand ud rāmišn-dādār, weh, ud xwurdag kōf; u-šān gōkān gōwēm. | Poi sorsero e altre montagne fuori da Harborz, in numero di duemila duecento e quarantaquattro montagne, ed esse sono: l'imponente Hugar, il Tērag-ī-Harborz, il Čagād-ī-Dāiti e la cresta di Arzūr, il monte Usindām, il monte Abarsēn detto anche monte di Pārs, il monte
Zǝrǝza che è anche il monte Manuš, il monte Iriz, il monte Kāf, il monte
Wadges, il monte Ušdāštār, il monte Arzūr-būm, il monte Rōyišnōmand, il monte Padišxwārgar, che è il più grande in Xwārī, la montagna chiamata Čīn, il monte Rēwand, il monte Dārspēd il monte Bagīr, il monte Was-škeft, il monte Syāōmand, il monte Wafrōmand, il monte Spandyād, il monte Kadrwasp, il monte Asnāwand, il monte Kōigrās, il monte Sēzdah, che è nel Kangdiz, che dicono che fu di conforto e delizia al buon creatore, e le cime più piccole. Ma ora citerò [le montagne] una seconda volta. | | harborz kōf pērāmōn ī ēn zamīg ō asmān paywast ēstēd. tērag ī harborz ān kē[-š] star, māh, xwaršēd padiš andar šawēnd, ud padiš abāz āyēnd. hugar ī buland, ān kē āb ī ardwisūr aziš frōd jahēd hazār mard bālāy. usindām kōf, ān kē az xwēn-āhan, az gōhr ī asmān, mayān ī zrēh frāxwkard, kē-š āb [ī] az hugar padiš frōd rēzēd. čagād ī dāitī, ān ī mayān ī gēhān, sad mard bālāy, kē-š činwad puhl padiš ēstēd, ruwān pad ān gyāg āmārēnd. [harborz kōf] arzur grīwag čagād-ē pad dar ī dušox, kē-š hamwār dēwān dwārišnīh ānōh kunēnd. ēn-iz gōwēd kū jud az harborz abarsēn kōf meh ast; abarsēn kōf kōf ī pārs xwānēnd. u-š bun pad sagestān, u-š sar pad čīnestān. kōf ī manuš [meh] ān kōf kē-š manuščihr padiš zād. abārīg kōf[īhā] frahist az awēšān rust hēnd. | Harborz è tutto intorno alla terra ed è connesso al cielo. Il Tērag-ī-Harborz è quel [monte] attorno il quale ruotano le stelle, la luna e il sole, e dietro il quale ritornano di nuovo. L'imponente Hugar è da dove le acque di Ardwisūr scendono dalle altezza di un migliaio di uomini. Il monte Usindām è fatto di rubino, della sostanza del cielo, ed è nel mezzo dell'oceano Frāxwkard, così che le sue acque, che scendono dal Hugar, si riversano in esso. Il Čagād-ī-Dāiti [il «picco del giudizio»] è al centro del mondo, alto un centinaio di uomini, su cui è fissato il ponte Činwad: in quel luogo vengono giudicate le anime. La cresta di Arzūr è sopra le porte degli inferi, dove si tengono le assemblee dei dēwān. E si dice anche che, con l'eccezione del Harborz, il monte Abarsēn sia il più imponente, l'Abarsēn, detto anche la montagna di Pārs, che inizia nel Sagestān e finisce nel Čīnestān. [Anche] il monte Manuš è grande, ed è il monte su cui è nato Manuščihr. | Zand-āgāhīh Bundahišn [12: -] |
È difficile tirar fuori una geografia razionale da tali cataloghi orografici, nei quali montagne mitiche e montagne reali si mescolano e si confondono senza soluzione di continuità. Lo stesso Harā Bǝrǝzaitī (medio persiano
Harborz), portato dal mondo
mitico a quello reale, verrà poi identificato con l'imponente catena dell'Elborz, che separa il mar Caspio dall'altopiano iraniano. Tanto dagli yašt avestici quanto il Bundahišn presentano
però una situazione piuttosto complessa, dove al cingulus mundi si associa anche il mitema dell'axis mundi, della montagna centrale attorno alla quale ruotano il sole e tutti gli altri luminari. Il monte centrale è perlopiù chiamato Taēra nell'Avestā; nel Bundahišn è definito Tērag-ī-Harborz,
ovvero «Tērag del Harborz». Ed è sorprendente che l'orografia iranica consideri il monte al centro del mondo come parte della
medesima catena che circonda la terra dall'esterno, ma i testi zoroastriani sono chiari al riguardo: tutte le montagne sono tra loro collegate da un groviglio di radici sotterranee che ne fanno, in pratica, una sola montagna.
| Il monte Harborz circonda il mondo; il monte Tērag è al centro del mondo. Il sole, girando come una corona intorno al mondo, ritorna, puro, oltre il monte Harborz, intorno a Tērag. Come qualcuno ha detto: il Tērag-ī-Harborz, dietro cui roteano il mio sole, la luna e le stelle.” | Bundahišn [5B: -] |
Il fatto che ogni giorno il sole sorga e tramonti in un
punto diverso, ha portato i cosmografi persiani a moltiplicare il
numero di portae sui due lati del kōf ī
Harborz. Queste sono chiamate rōzan,
«giorni», e trasformano il Harborz in
una sorta di immenso calendario orografico: «In Harborz, vi sono centottanta rōzan a est e centottanta a ovest: il sole entra attraverso un rōz e esce da un rōz
ogni giorno» (Bundahišn [5B: ]).
La cosmografia persiana annulla dunque la differenza tra il
cingulus mundi e l'axis mundi: l'uno fa parte dell'altro,
così «come il dito è in mezzo all'anello», secondo la bella metafora
di aṭ-Ṭabarī
e al-Balʿamī (cfr. Taʾrīḫ ar-rusul wa al-mulūk [VI]).
Questa visione sembra comprendere e annullare la contraddizione,
palese nel mito greco, tra un Átlas
proiettato sull'orizzonte e un Átlas
che funge da polo celeste. Se poi pensiamo che il titán Átlas
è in realtà l'óros Átlas, cioè la personificazione di un
elemento cosmologico, raffigurato come montagna, ritroviamo la
polisemantica del kōf ī Harborz,
che è tanto cingulus mundi quanto axis mundi. Le
portae mundi, più che un modello a sé stante, divengono, in
questo modello generale, un elemento che connette il tutto in un
sistema astronomicamente più integrato.
Nella concezione araba, dove il kōf ī
Harborz diviene il ǧabal
Qāf, sembra scomparire l'idea dell'axis
mundi. In realtà non c'è più bisogno di effettuare una
distinzione tra i tre modelli, in quanto
al-Qāf assume su di sé l'intero sistema.
Quando al-Iskandar, nelle versioni
arabe della leggenda, giunge al ǧabal
Qāf, perviene regolarmente in una regione d'oscurità,
aẓ-Ẓulumat: la montagna è talmente alta che, nei suoi
pressi, il mondo è immerso in una notte senza luna e senza stelle.
Quando Neẓāmī conduce Eskandar
alla ricerca dell'acqua della vita, a settentrione, lo fa arrivare
ai piedi di un'enorme montagna immersa nelle tenebre, ed essa non è soltanto il kōf ī
Tērag-ī-Harborz, ma anche il kōf ī
Čagād-ī-Dāiti, il «picco del giudizio»,
sul quale vengono giudicate le anime, il quale, leggiamo in
Zand-āgāhīh Bundahišn [12: ],
si trova al centro del mondo
ed è il punto su cui è fissato il ponte Činwad.
Questo ponte avrebbe suggerito, in epoca islāmica, il ponte
escatologico Ṣirāṭ che, nello yawm ad-dīn,
i risorti dovranno percorrere per arrivare all'aldilà e che sotto i
piedi dei malvagi diviene sottilissimo, facendoli precipitare nel Ǧahannam. Neẓāmī si
ricorderà di questo motivo quando farà avanzare
Eskandar su un sentiero sottile come un
capello, tra due masse incombenti di oscurità.
Il mondo arabo-islāmico, inoltre, aderendo al dettato qurʾānico della «sorgente del sole» [ʿayn aš-šamsi],
secondo la quale l'astro emerge la mattina da una pozza d'acqua
fetida a oriente e s'immerge la sera in una pozza d'acqua
altrettanto fetida a occidente, avrebbe potuto tranquillamente
eliminare le portae mundi. Invece, la cosmologia islāmica
continua a essere fortemente orientata in direzione est ↔ ovest, che è
quella presente in tutte le varianti dei viaggi di
al-Iskandar. E le porte solari non solo
non sono state eliminate, ma hanno avuto uno sviluppo sorprendente,
trasformate in due città di meraviglioso smeraldo, Ǧābarsā e Ǧābalqā,
l'una a est e l'altra a ovest.
| |
Cingulus mundi |
Axis mundi |
Portae mundi |
| Avestā |
Harā Bǝrǝzaitī |
Taēra
Dāiti |
|
|
Bundahišn |
kōf ī
Harborz |
kōf ī
Čagād-ī-Dāiti
kōf ī
Tērag-ī-Harborz |
180 rōzan |
| Letteratura araba |
ǧabal
al-Qāf |
(ǧabal al-Qāf) |
Ǧābarsā e Ǧābalqā |
Scandinavia
Nella letteratura in lingua norrena è attestata
Himinbjǫrg,
la «montagna
del cielo», sebbene le due Edda
non ci diano spiegazioni che ci consentano di inserirla
esplicitamente nel tema degli axis mundi. Sappiamo che era
considerata il punto di passaggio dalla terra e al cielo, dal mondo
degli uomini ad Ásgarðr, la rocca degli
Æsir.
| Þar er enn sá
staðr er Himinbjǫrg heita. Sá
stendr á himins enda við
brúarsporð, þar er Bifrǫst kemr
til himins. |
C'è anche
quel luogo chiamato
Himinbjǫrg, che
si trova alla fine del cielo, sulla soglia del ponte, là dove
Bifrǫst giunge nel firmamento. |
| Snorri
Sturluson: Prose Edda >
Gylfaginning [17] |
Sul monte aveva la residenza Heimdallr,
il dio-sentinella (Grímnismál
[13] |
Lokasenna [13]). Perfettamente insonne e dai sensi acutissimi,
egli stava eternamente guardia all'estremità del Bilrǫst
o Bifrǫst, sorta di
ponte cosmico identificato, nella letteratura posteriore, con
l'arcobaleno.
| Hann býr þar
er heita Himinbjǫrg við Bifrǫst.
Hann er vǫrðr guða ok settr þar
við himins enda at gæta brúarinnar
fyrir bergrisum. |
[Heimdallr]
abita in quel posto chiamato
Himinbjǫrg, presso
Bifrǫst. Egli è il guardiano degli
dèi: risiede lassù, alla fine del cielo, per vegliare sul ponte l'arrivo dei
giganti di montagna. |
| Snorri
Sturluson: Prose Edda >
Gylfaginning [27] |
Heimdallr ha con sé il
Gjallarhorn, il «corno risonante», con
il quale darà il segnale della battaglia escatologica, nel giorno di
ragnarǫk, risvegliando nel salone di
Valhǫll tutti i guerrieri caduti a battaglia nel corso della
storia (Gylfaginning [27]).
E viene subito in mente il malʾak con il corno incontrato da Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid
(Aṣ-Ṣaʿb Ḏu ʾl-Qarnayn): ci si
può chiedere perché proprio a questi guardiani alla fine dello
spazio venga dato il compito di segnalare la fine del tempo.
Sebbene il [monte] Himinbjǫrg
non abbia alcuna connessione con eventuali miti di ricerca
dell'immortalità, ci troviamo probabilmente di fronte a una versione
nordica del mitema iranico del kōf ī
Tērag-ī-Harborz, il monte
attorno al quale girano il sole, la luna, i pianeti e le stelle, o del kōf ī
Čagād-ī-Dāiti,
il picco del giudizio, dove verranno giudicate le anime dei morti, e alla cui cima è fissato il ponte Činwad.
Se ci è permesso condensare queste note in un periplo
comune, la prima tappa del percorso compiuto da tutti i nostri
inesausti esploratori dei confini della terra (Gilgameš, Hērakls, Eskandar e Bulūqiyā),
nella loro affannosa ricerca della vita, consiste nell'uscire dal
mondo e raggiungere il limite dove l'oikouméne sfuma nel
kósmos. Le antiche cosmologie ci
dicono che cielo e terra sono connessi da un sistema di montagne...
sistema che, pur nella sua complessità, si mostra stranamente
unitario. La montagna cosmica circonda la terra tutto intorno
all'orizzonte, dischiude delle porte a est e a ovest per far passare
il sole e funge essa stessa da perno per la rotazione del cielo e
degli astri. In definitiva, il cielo è una montagna, e noi
viviamo al suo interno, come dentro una luminosa caverna di smeraldo
che ruota sopra la nostra testa. L'azzurro del cielo ne è il
riflesso sulla sua volta, e la notte è la sua ombra allorché il sole
si trova dall'altro lato di essa.
Per arrivare al regno degli dèi, al mondo imperituro, è dunque
necessario uscire dalla terra, ovvero uscire dal cielo.
Per far questo è necessario seguire il sole nel suo cammino e
imboccare le porte, incastonate sul fianco della montagna, che
conducono fuori di essa. Oppure – e simbolicamente è la stessa cosa
– arrivare all'axis mundi che collega la terra il cielo,
perché anch'esso, in un certo senso, è la montagna che separa la
terra dal cielo.
E dunque:
| |
GILGAMEŠ |
HĒRAKLS |
BULŪQIYĀ |
AL-ISKANDAR |
ESKANDAR |
| I |
Arriva allo šadû Māšu,
il monte da dove il sole sorge e tramonta. |
Tocca tanto l'óros
Kaúkasos nel lontano oriente, quanto l'óros Átlas nel
lontano occidente. |
Arriva al ǧabal
al-Qāf. |
Arriva al ǧabal
al-Qāf sia da oriente sia
da occidente, arrivando alla «sorgente del sole» [ʿayn aš-šamsi]. |
Si spinge tanto nell'estremo
oriente quanto nell'estremo occidente, arrivando alla «sorgente
del sole» [ʿayn aš-šamsi]. |
| II |
Al monte stanno gli aqrab-amēlû,
gli uomini-scorpione. |
I monti sono presieduti
rispettivamente da Promētheús ed
Átlas. |
|
Le estremità orientale ed
occidentale sono presiedute dalle città di Ǧābarsā e Ǧābalqā. |
|
| III |
Si immette lungo il ḫarran šamši,
il «sentiero del sole», e avanza nella totale oscurità per
dodici bēru |
|
Attraversa una regione di
tenebre, aẓ-Ẓulumat,
creata dall'ombra di al-Qāf. |
Attraversa una regione di
tenebre, aẓ-Ẓulumat,
creata dall'ombra di al-Qāf. |
Attraversa una regione di
tenebre, Ẓolmat, creata dall'ombra
della montagna boreale. |
| IV |
Sente sul viso il vento del nord,
ed esce dalle viscere della montagna nel frutteto degli «alberi
degli dèi» (iṣû ilī). |
Giunge all'estremo settentrione,
dove, sotto il polo boreale, Átlas
funge da asse celeste, ed è qui che si trova il
Kpos Hesperídōn. |
|
|
Giunge all'estremo settentrione,
dove, sotto il polo boreale, una montagna funge da asse celeste,
ed è qui che sgorga l'acqua della vita. |
| |
MAPPE DI VIAGGIO:
LE USCITE DAL MONDO La seconda tappa del viaggio del nostro
eroe consiste nel passaggio attraverso una «porta» situata sul
fianco della montagna, apertura che conduce oltre i confini del
mondo.
- (α) Gilgameš trova una porta sul monte
Māšu. Contratta con gli aqrab-amēlû
il passaggio attraverso di essa: percorre il ḫarran šamši,
il «sentiero del sole», e giunto dalla parte opposta, trova gli
iṣû ilī, gli alberi degli dèi, carichi di
frutti di pietre preziose e gemme. All'esterno si estende il
tâmtu,
il «mare» che circonda il mondo.
- (β) Superato l'óros Átlas in Libýē,
Hērakls apre/chiude lo stretto per entrare nel fiume
Ōkeanós e dispone due colonne ai suoi lati.
(β₁) Secondo un'altra versione, chiude lo stretto per impedire ai
mostri marini di entrare nel Mediterraneo.
- (γ) Dopo aver attraversato i sette mari, e aver
visitato isole paradisiache, Bulūqiyā
trova la grande porta sulle pendici del ǧabal
al-Qāf e contratta il
passaggio con i malāʾika preposti ad essa.
- (δ) Nel mito di Ḏū ʾl-Qarnayn/al-Iskandar, il motivo
delle porte ai confini del mondo appare piuttosto indebolito.
Nel corso dei suoi viaggi l'eroe arriva in luoghi paradisiaci
dove il tema degli alberi coperti di gemme è solo un
leit-motiv letterario ormai scisso dal contesto (nella
variante di Neẓāmī, Eskandar arriva a Iram ḏāt al-ʿimād,
la città di Šaddād ibn ʿĀd,
nei cui giardini vi sono alberi d'oro con frutti d'oro). Quando l'eroe arriva al ǧabal
al-Qāf, le portae mundi
appaiono sostituite dalle città di Ǧābarsā e Ǧābalqā.
(δ₁) La variante del mito della chiusura della porta è sviluppata nel
mito del sadd al-Iskandar, la barriera destinata
a tenere confinati all'esterno del mondo i popoli escatologici di Yaʾǧūǧ e Maʾǧūǧ.
- (ε) Dopo aver attraversato il haf, «mare», ed essere
giunti nella terra oltremondana di Útgarðr,
Þórr e i suoi compagni si trovano
di fronte a un immenso cancello, e lo oltrepassano strisciando
in mezzo alle sue sbarre.
Nello Ša naqba īmuru, Gilgameš,
giunto di fronte allo šadû Māšu, deve contrattare con i suoi guardiani – gli aqrab-amelu – il permesso di transitare attraverso la porta [bābu] aperta sul monte.
Si tratta presumibilmente della porta attraverso cui passa Šamaš nel suo sorgere e/o
tramontare [IX: | ]. Una volta entrato, Gilgameš cammina nelle tenebre più assolute per dodici bēru, lungo il ḫarran šamši, il «sentiero del sole», finché avverte sul viso il
«vento del nord» [iltānu] e, uscito nella luce del giorno, arriva al giardino dove crescono gli iṣû ilī, gli «alberi degli dèi»,
dai cui rami pendono pietre preziose e gemme. A questo punto Gilgameš si trova dinanzi
il tâmtu, il «mare» che circonda il mondo (è il Marratu, il «fiume» amaro del
Imago mundi Babylonica) (Ša naqba īmuru [IX]). Anche Bulūqiyā
trova la grande porta scolpita sulle pendici del ǧabal
Qāf, oltre il quale si trova il Baḥr al-muḥīṭ, l'oceano onniavvolgente della cosmologia
islāmica.
Il frutteto degli iṣû ilī, nell'epopea di Gilgameš, si trova ai confini del mondo, tra il Māšu,
la montagna dove il sole sorge e/o tramonta, e il
Marratu. Nel mito ellenico il
Kpos Hesperídōn ha una localizzazione analoga:
si trova ai confini occidentali del mondo, tra l'óros Átlas,
il monte che si erge dinanzi al tramonto del sole, e il fiume Ōkeanós
(o presso l'óros Átlas, inteso come monte che funge da perno per la
rotazione del cielo). In Grecia, tuttavia, il luogo dove si trova il favoloso giardino delle Hesperídes è definito
etimologicamente in relazione all'ovest e al tramonto del sole (da éspera, «occidente», «sera»).
Una relazione ancora più diretta è fornita da Hēsíodos
nella sua
Theogonía,
a patto però di considerare
Átlas nella sua
personificazione titanica. In questo passo di dice infatti che il giorno [Hēméra] e la notte [Nýx] si alternano attraverso una porta di bronzo situata
sull'orizzonte, proprio dove Átlas, figlio di Iapetós, regge la volta del cielo:
Tn prósth' Iapetoîo páis échei ouranòn eurỳn
hestēṑs kephal te kaì akamátēısi chéressin
astemphéōs, hóthi Nýx te kaì Hēmérē âsson ioûsai
allḗlas proséeipon, ameibómenai mégan oudòn
chálkeon; hḕ mèn ésō katabḗsetai, hḕ dè thýraze ... | Di fronte ad essa [la dimora di Nýx], il figlio di Iapetós
regge saldo con il capo e le braccia infaticabili la volta del cielo
là dove Nýx ed Hēméra si avvicinano
e si salutano, varcando alterni la porta di bronzo,
l'uno per entrare e l'altra per uscire... | | Hēsíodos: Theogonía [-] |
Si potrebbe ribattere, però, che nel ciclo di Hērakls
non vediamo mai l'eroe passare esplicitamente attraverso una
porta mundi. Sì, lo vediamo arrivare sia ai monti dell'alba sia
a quelli del tramonto, ma mai transitare esplicitamente attraverso
una porta, né, come Gilgameš,
contrattare il passaggio ai suoi eventuali guardiani. Ma è proprio
vero? O non sarà che questo motivo ha soltanto cambiato aspetto
divenendo più o meno irriconoscibile?
Ed è infatti proprio così! La «porta» che conduce all'esterno dello spazio viene stabilita dallo stesso eroe nel momento in cui arriva alle estreme propaggini occidentali dell'oikouménē.
Arrivato dinanzi alle acque del potamós Ōkeanós, infatti, l'eroe pone due «colonne» nel punto più ravvicinato dello stretto che conduce al Mediterraneo: una sulla sponda libica, ad Ábila (od. Sibtah/Ceuta, nell'attuale exclave spagnola sulla costa africana), l'altra sulla sponda iberica, a Kálpē (od.
Gibilterra). «Giunto a Tártēssos, [Hērakls] innalzò come segno del suo passaggio due colonne, una di fronte all'altra, ai confini tra Eurṓpē e Libýē» (Apollódōros: Bibliothḗkē [II: 5]).
Non crediamo sia eccessivo confrontare queste colonne con quelle
presenti sul sigillo antico-babilonese, dove le montagne attraverso
cui il dio-sole
Utu/Šamaš sorge sono a sua volta
incastonate tra due colonne, a formare una sorta di porta priva di
architrave (immagine:
[ME, 89110]✦).
 | |
Le colonne di Hērakls |
Monumento a Ceuta/Sibtah (exclave spagnola in Marocco).
Fotografia di J. Sarría (particolare). |
Strábōn riferisce di alcune spedizioni effettuate anticamente dagli abitanti di Týros, su suggerimento di un oracolo, per fondare una colonia oltre le Hērákleioi stlai: sebbene fossero sbarcati in vari luoghi e isolotti dentro e fuori lo stretto, i
fenici non trovarono un luogo adatto a impiantarvi una colonia e, dopo
essere arrivati su un'isola sacra a Hērakls,
gli tributarono un sacrificio e tornarono indietro. Solo alla terza spedizione venne fondata Gádeira (od. Cádiz,
Spagna) (Geōgraphiká [III: 5, ]). Strábōn è abbastanza sospettoso riguardo questa vicenda, che definisce una «favola fenicia», ma intanto ci suggerisce un'origine semitica della leggenda. Egli fornisce molte possibili localizzazioni geografiche delle Hērákleioi stlai, identificando Gádeira con Eirýthia (Geōgraphiká [III: 5, -]), ma ci troviamo ormai in un'epoca in cui i miti pretendevano
spiegazioni razionali. Le Hērákleioi stlai finirono per venire identificate tout-court con le due colonne di bronzo che sorgevano
nel tempio di Hērakls a Gádeira, sulle quali era incisa un'iscrizione che registrava il costo di costruzione del tempio stesso (cfr. Strábōn: Geōgraphiká [III: 5, ] | Plinius: Naturalis historia [II: 242]). Ma le due colonne di bronzo celebrano quelle mitiche: Hērakls
era venerato in tutta la regione fin dall'epoca dei Fenici, i quali lo identificavano
nel loro Melkqart. Pare che anticamente le stlai fossero anche attribuite a Krónos o a Briáreōs (Eustáthios Thessaloníkēs: commenta in Dionýsios Periēgētḗs: Oikouménēs periḗgēsēs [64-68]; Claúdios Ailianós: Poikílē historía [V: 3]). Anche Strábōn parla di un tempio sacro a Krónos in un'isoletta di fronte a Gádeira (Geōgraphiká [III: 5,
]). La presenza di Krónos è significativa, in questa sede, come infatti vedremo tra poco. Gilgameš e Bulūqiyā devono ottenere il permesso di passare dai guardiani delle
portae mundi. A Hērakls basta la sua proverbiale forza. Che anche le Hērákleioi stlai fossero viste come un portale, quindi come un «passaggio» che fosse necessario aprire per imboccare l'uscita dal mondo, è testimoniato da un'importante variante del mito dove Europa e Africa erano inizialmente uniti in un istmo, che lo stesso Hērakls avrebbe
spaccato creando in tal modo lo stretto. Così riferiscono, tra gli altri, Diódōros Sikeliṓtēs (Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 18, ]), Seneca (Hercules furens [-]), Plinius (Naturalis historia [III: 4]), Pomponius Mela (De situ orbis [I: 27]) e altri. Seneca, nella sua tragedia Hercules furens, offre una visione quasi apocalittica dell'impresa dell'eroe. Hērakls, pervenuto nella terra di Hesperia, all'estremo ovest del mondo, si sarebbe trovato di fronte a una catena continua di montagne. Allora si sarebbe aperto lui stesso un varco, spalancando i monti dall'una e dall'altra parte dello stretto, lasciando irrompere le acque di Ōkeanós all'interno del bacino mediterraneo.
Inter remotos gentis Hesperiae greges
pastro triformis litoris Tartessii
peremtus, acta est praeda ab occasu ultimo;
notum Cithaeron pavit Oceano pecus.
Penetrare iussus solis aestivi plagas
ed adusta medius regna quae torret dies,
utrimque montes solvit abrupto obiice,
et iam ruenti fecit Oceano viam. | Fra i greggi remoti della gente di Hesperia
il pastore triforme della spiaggia tartessia
fu ucciso e fu fatto bottino dall'estremo limite d'occidente:
il Cithaeron
nutrì un gregge noto all'Oceanus.
Avuto l'ordine di giungere fino alle regioni del sole estivo
e ai regni che arde il mezzogiorno
da entrambe le parti [Hercules]
aprì i monti e, spezzato ogni impedimento,
fece una larga via all'Oceanus che precipitava. | | Lucius Annaeus Seneca: Hercules furens [-] |
La versione di Diódōros Sikeliṓtēs è particolarmente interessante:
| Hērakls, infatti, giunto ai capi estremi dei continenti di Libýē ed Eurṓpē,
situati dinanzi a Ōkeanós, decise
di porvi queste due colonne a ricordo della propria spedizione. Dal
momento che desiderava compiere un'opera sempiterna, affermano che
egli arginò entrambi questi capi per lungo tratto. E perciò, mentre
prima essi erano separati da una grande distanza, egli restrinse
quel braccio di mare affinché, resolo poco profondo e stretto, fosse
impedito ai grandi mostri marini di passare da Ōkeanós
al mare interno e, contemporaneamente, data la grandiosità di quelle
opere, la celebrità del loro costruttore perdurasse eterna. Ma
alcuni affermano che, al contrario, essendo uniti i due continenti,
egli vi tagliò un passaggio e aprendo quel braccio di mare fece sì
che Ōkeanós si mescolasse al nostro mare. | | Diódōros Sikeliṓtēs: Bibliothḗkē Historikḗ [IV: 18, ] |
In questo passo affiorano tanto il mitema dell'apertura della «porta» tra i monti, per spostarsi all'esterno della terra, sia quello del pericolo legato a tale apertura. La rara variante di Diódōros, dove Hērakls
avvicina i due capi dello stretto in modo da impedire il passaggio ai «grandi mostri marini» confinati fuori dallo spazio, potrebbe illuminare il capovolgimento presente nel mito arabo-persiano, dove Ḏū ʾl-Qarnayn/al-Iskandar salda
tra i monti una barriera di ferro, la sadd al-Iskandar, affinché i popoli escatologici di Yaʾǧūǧ e Maʾǧūǧ rimangano confinati all'esterno
della terra. Si riteneva, in epoca classica, che Hērakls e Diónysos avessero posto colonne anche durante i loro viaggi a
oriente. Stando a quanto ci riferisce Strábōn, nel corso della sua spedizione in India, Mégas Aléxandros cercò invano le colonne lasciate dai suoi mitici predecessori, e non trovandole, o credendo di localizzarle in questo o quel posto, pose a sua volta altari e colonne nei punti più lontani che riuscì a raggiungere (Geōgraphiká [III: 5, -]). L'annotazione di Strábōn ci informa non soltanto di una possibile tradizione «orientale» delle Hērákleioi stlai, ma anche che, in epoca tardo-classica, il mito di Aléxandros andava sovrapponendosi a quello di Hērakls.
Se la nostra teoria è corretta, e se nella cosmografia arcaica il limite orientale della terra
era posto nell'óros Kaúkasos,
si potrebbe inferire la presenza di un mito (non tramandato) secondo il quale Hērakls
avesse posto le sue stlai orientali nel massiccio
caucasico (aprendo o chiudendo un passaggio, analogamente alle
versioni del mito sulle stlai occidentali). Questa
ipotesi potrebbe fornire un antemito alla notizia di Flavius Iosephus secondo la quale re Aléxandros avrebbe sbarrato
le portae Caspiae, cioè il passaggio tra l'Hyrcania e la Media, con delle porte di ferro (Bellum Iudaicum [VII: 7, ]).
In seguito, gli arabi, ereditando il mito delle stlai orientali nella
sua versione «alessandrina», e dandogli forma canonica attraverso il racconto qur˒ānico, finirono per localizzare la barriera sigillata da Ḏū ʾl-Qarnayn/al-Iskandar
nel Caucaso. Non stupisce che il ḫalīfah ʿUmar ibn al-Ḫattāb abbia voluto identificare la proverbiale Bāb al-abwab nelle imponenti fortificazioni di Derbent,
presso le portae Caspiae. E poiché il Caucaso si trova a nord
dell'Arabia, non stupisce nemmeno che gli autori persiani, quali Ferdowsī nello Šāhnāmè e Neẓāmī nell'Eskandarnāmè, finiranno per trasferire la forgia della mitica barriera in un settentrione vago e indefinito.
Curiosamente, questo motivo è sopravvissuto anche nel mito
germanico.
Þórr e i suoi compagni, dopo
essere arrivati ai confini del
Miðgarðr (cioè l'oikouménē),
si pongono davanti al haf, il mare che circonda la terra
abitata. Lo attraversano a nuoto e quindi, arrivati nella terra
oltremondana (lo Jǫtunheimr), giungono ai cancelli di
Utgarðr, il recinto
esterno. E qui, le portae mundi sono presentate da Snorri come
un cancello sbarrato. Ma
Þórr e i suoi compagni, pur non
riuscendo ad aprirle, passano ugualmente attraverso le sbarre:
|
...ganga til borgarinnar ok var grind fyrir
borghliðinu ok lokin aptr. Þórr gekk á
grindina ok fekk eigi upp lokit, en er þeir
þreyttu at komask í borgina þá smugu þeir
milli spalanna ok kómu svá inn, sá þá hǫll
mikla ok gengu þannig. |
...Giunsero fino alla rocca, davanti alle porte, che erano chiuse da un
cancello.
Þórr andò al cancello ma non riuscì ad aprirlo. Decisi a penetrare
nella rocca, essi strisciarono fra le sbarre e così riuscirono a passare. |
|
Snorri Sturluson: Prose Edda
> Gylfaginning [46] |
E così, incredibilmente, in una scena apparentemente insignificante del mito
nordico, e che sarebbe passata
del tutto inosservata, se non fosse rimasta incagliata nel giusto contesto,
sentiamo echeggiare il passaggio di Gilgameš
attraverso la porte del monte Mâšu e
ritroviamo Hēraklês stagliato sul limitare
delle sue imponenti colonne.
| |
GILGAMEŠ |
HĒRAKLS |
BULŪQIYĀ |
ḎŪ ʾL-QARNAYN
AL-ISKANDAR
ESKANDAR |
ÞÓRR |
| Ia |
Arrivato allo šadû Māšu,
contratta con gli aqrab-amēlû il passaggio
attraverso la sua porta [bābu]. |
Pone due colonne [Hērákleioi stlai]
nello stretto tra Africa ed Europa, che viene aperto e spaccato
per poter uscire sul fiume Ōkeanós. |
Arrivato al ǧabal
al-Qāf, contratta con gli
angeli il passaggio attraverso la sua porta. |
|
Arrivato a
Útgarðr, nella terra esterna al
mondo,
Þórr ne trova i cancelli chiusi:
ma passa attraverso le sbarre. |
| Ib |
|
Aut
Avvicina i due
capi dello stretto per impedire ai mostri di
Ōkeanós
di entrare nel Mediterraneo. |
|
Salda tra i monti una barriera di ferro,
la sadd al-Iskandar, affinché i popoli escatologici di Yaʾǧūǧ e Maʾǧūǧ
rimangano confinati all'esterno |
|
| II |
Oltre lo šadû Māšu
si trovano gli iṣû ilī, gli alberi degli dèi,
carichi di frutti di pietre preziose e gemme. |
Vicino all'óros
Átlas si trova il
Kpos Hesperídōn,
il giardino degli dèi, con i suoi frutti d'oro. |
Visita molte isole paradisiache,
dove gli alberi sono carichi di frutti simili a gemme. |
Arriva a Iram ḏāt al-ʿimād,
la città di Šaddād ibn ʿĀd,
nei cui giardini vi sono alberi d'oro con frutti d'oro (in
Neẓāmī). |
|
| III |
All'esterno si estende il
tâmtu,
il «mare» che circonda il mondo. |
Oltre l'óros
Átlas si stende il fiume Ōkeanós
che circonda il mondo. |
Oltre il ǧabal
al-Qāf, si stende il
Baḥr al-muḥīṭ,
l'oceano onniavvolgente. |
All'esterno si stende il
Baḥr al-muḥīṭ/Baḥr-i-Oqiyānūs,
l'oceano onniavvolgente. |
Útgarðr
si trova oltre il haf, il «mare» che circonda
Miðgarðr. Oltre di essa si estende il úthaf, il
«mare esterno». |
|
|
I SEGNALI STRADALI: LEONI E TORI, AQUILE E SERPENTI
Visto che siamo sulla strada, una prima traccia per arrivare alle porte del gan ʿĒḏẹn
potrebbero darcela, forse, quei severi guardiani che Yǝhwāh lōhîm
aveva messo davanti ai cancelli del meraviglioso giardino, in modo da
impedire il regressus ad paradisum ad Āḏām
e Ḥawwāh e ai loro
discendenti.
“Ora dunque, che egli non stenda la mano e non
colga anche dell'albero della vita e ne mangi e viva in eterno...”
[wǝ˓attāh pẹn-yišlaḥ yāḏô, wǝlāqaḥ gam mē˓ēṣ haḥayyîm, wǝ˒āḵal wāḥay lǝ˓ōlām]
(Bǝrēʾšîṯ [3: ]),
aveva decretato Yǝhwāh
allorché aveva esiliato l'uomo dal gan
ʿĒḏẹn
e l'aveva mandato nel caduco mondo del tempo a condurre la sua breve esistenza di fatica e
di dolore.
| Wayārẹš ẹṯ-hā˒āḏām; wayyaškēn miqqẹḏẹm lǝan-˓ēḏẹn ẹṯ-hakkǝruḇîm, wǝ˒ēṯ lahaṭ haḥẹrẹḇ hammiṯhappẹḵẹṯ, lišmōr ẹṯ-dẹrẹḵ ˓ēṣ haḥayyîm. | [Yǝhwāh] cacciò dunque l'uomo e pose a oriente del giardino di ʿĒḏẹn i
kǝrûḇîm e la fiamma della spada guizzante per custodire l'accesso all'albero della vita. | | Bǝrēʾšîṯ [3: ] |
 | |
Lamassu (883-859 a.C.) |
Scultura neoassira, regno di Aššurnāṣirapli
II.
Scavata a Nimrud/Kalhu, ‘Irāq
(313.7 cm)
Metropolitan Museum of Art, New York (USA). |
Il nostro immaginario corre
subito all'iconografia dei due angeli, accigliati e biancovestiti, di fronte ai cancelli del gan ʿĒḏẹn,
la spada fiammeggiante stretta nei pugni. Tuttavia quest'immagine è
solo un'incrostazione posteriore, costruita sul passaggio
biblico e non illustrativa dello stesso. Il redattore del
Bǝrēʾšîṯ
aveva una concezione ben diversa dei kǝrûḇîm,
derivata con ogni probabilità dalle profezie di Yǝḥẹzqêl,
vissuto due secoli prima, al tempo della deportazione a
Babilonia.
Costui aveva derivato queste creature dalla demonologia
babilonese, dove il kuribu era un essere soprannaturale,
sorta di šēdu, «genio», a volte raffigurato in forma di robusto toro alato
con testa umana, ornata da una barba finemente arricciolata e sormontata da una
maestosa tiara. Le immagini scolpite di tali esseri, definiti
lamassu, venivano disposte dinanzi alle porte, con funzione di custodia o
apotropaica. Ma nel coacervo di elegie, invettive, lamenti e
accese visioni che è il repertorio profetico di Yǝḥẹzqêl,
i kǝrûḇîm si stagliano con
una strana, virulenta energia.
“Tu eri il modello della perfezione,
ripieno di sapienza e di bellezza meravigliosa: abitavi nel
ʿĒḏẹn, il
giardino di lōhîm”
dice ăḏōnāy Yǝhwāh
al re di Ṣôr [Týros]: “Il giorno in cui fosti creato, ti
stabilii quale kǝrûḇ protettore, ti posi sul qōḏẹš
bǝhar, il «monte santo» di lōhîm,
e incedevi fra pietre fiammanti. Perfetto tu eri nelle tue vie
dal giorno in cui fosti creato, finché spuntò in te l'iniquità.
[...] Ma io ti scacciai dal monte di lōhîm
e ti feci perire, o kǝrûḇ protettore, in mezzo alle
pietre fiammanti” (Yǝḥẹzqêl
[28: -]). Non cercheremo di dare un senso a questa
invettiva, che è tra i tanti loci obscuri dei libri
profetici della Bibbia, se non per notare che è stata
probabilmente una delle fonti del
redattore del Bǝrēʾšîṯ.
Ma se ci interessa sapere quale aspetto avessero originariamente i
kǝrûḇîm, ne troviamo una vivida descrizione proprio
nell'incipit del libro di Yǝḥẹzqêl, ed è
senza alcun dubbio una delle visioni più inquietanti della
Bibbia:
| |
Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal
settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco,
che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come
un balenare di elettro incandescente. Al centro apparve
la figura di quattro ḥayyôṯ [«esseri viventi»], dei quali questo
era l'aspetto: avevano sembianza umana e avevano
ciascuno quattro facce e quattro ali. Le loro gambe
erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi erano come
gli zoccoli dei piedi d'un vitello, splendenti come
lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati, avevano
mani d'uomo; tutti e quattro avevano le medesime
sembianze e le proprie ali, e queste ali erano unite
l'una all'altra. Mentre avanzavano, non si volgevano
indietro, ma ciascuno andava diritto avanti a sé. | | |
Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva
fattezze d'uomo; poi fattezze di leone a destra,
fattezze di toro a sinistra e, ognuno dei quattro,
fattezze d'aquila. Le loro ali erano spiegate verso
l'alto; ciascuno aveva due ali che si toccavano e
due che coprivano il corpo. Ciascuno si muoveva
davanti a sé; andavano là dove lo spirito li
dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro.
[...] | | |
Al di sopra delle teste degli ḥayyôṯ vi era
una specie di firmamento, simile ad un cristallo
splendente, disteso sopra le loro teste, e sotto il
firmamento vi erano le loro ali distese, l'una di
contro all'altra; ciascuno ne aveva due che gli
coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io
udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi
acque, come il tuono dell'onnipotente, come il
fragore della tempesta, come il tumulto d'un
accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano
le ali... | |
Yǝḥẹzqêl
[1: - ... -] |
 | |
Visione di Yəḥẹzqêl | |
I kǝrûḇîm
nell'illustrazione di un autore contemporaneo |
La descrizione di questi
ḥayyôṯ («esseri viventi», identificati con
i
kǝrûḇîm in Yǝḥẹzqêl
[10]), come anche quella
degli ôannîm, i
bizzarri malʾāḵîm simili a ruote costellate di occhi,
non ha mai smesso di interessare biblisti, esoteristi e
psicologi (e categorie ancor più alternative…). E ci
chiediamo che effetto poteva aver fatto, sui poveri Āḏām
e Ḥawwāh, nel caso
avessero voluto tentare il ritorno al gan
ʿĒḏẹn,
trovarsi la strada sbarrata da esseri simili.
Ma non lasciamoci distrarre e analizziamo
bene queste creature. Di forma umana, con zampe
bovine, quattro ali e quattro mani. E soprattutto con quattro
teste: umana, di toro, di leone e d'aquila. I medesimi tetramorfi che accompagnano i ritratti degli
Evangelisti. Il lettore sta provando un senso di déjà vu: dove abbiamo già incontrato questi
animali?
Ma dovunque! Nella leggenda
di Bulūqiyā, il
giovane eroe,
durante il suo viaggio,
arriva presso un albero maestoso e imponente, e ci
sono quattro malāʾika inginocchiati ai suoi piedi: il primo ha
forme umane, il secondo di leone, il terzo di uccello, il
quarto di toro. Più tardi, quando egli arriva dinanzi alle
porte del ǧabal Qāf,
i due esseri che la custodiscono sono l'uno simile a un
leone, l'altro a un toro. Sembrerebbe che questi teriomorfi siano
legati in qualche modo alle portae mundi, ai passaggi
per uscire dal mondo. In uno
dei sigilli antico-babilonesi precedentemente esaminati,
dove
Utu/Šamaš
tramonta tra i due picchi gemelli, compaiono ancora una volta
un leone, un'aquila e un piccolo toro (immagine:
[ME, 89115]✦). Due leoni sono
presenti tanto in un secondo sigillo, sulle colonne ai lati della
porta solare (immagine:
[ME, 89110]✦), ma anche nella
figurazione egizia di ker,
il dio guardiano dell'orizzonte, posti ai lati della
montagna/porta solare (immagine:
[ker]✦).
Tori e leoni sono animali assai
significativi tanto nel ciclo di Gilgameš
quanto in quello di Hērakls.
Nello Ša naqba īmuru, Gilgameš
ed Enkidu uccidono dapprima
Gudanna, il toro del cielo, poi Gilgameš
combatte dei leoni e afferma di vestirsi della loro pelle.
Due delle fatiche di Hērakls
riguardavano appunto l'uccisione del leone di Neméa, dalla
cui pelle l'eroe trae il suo mantello, e la
cattura del toro di Krḗtē. Che valore dare a
questi animali? Perché li vediamo ritornare con tanta
tenacia?
L'aquila sembra invece un po'
più rara in questo tipo di rappresentazioni. È assente nel mito di Gilgameš
(possiamo ignorare il racconto greco di Claudius Aelianus,
dove il neonato Gílgamos,
scagliato dall'alto di una torre, viene salvato da
un'aquila (Perì zṓıōn idiótētos [12, ])).
Il rapace compare invece nel ciclo di Hērakls in un punto assai significativo:
è infatti l'aquila che tormenta Promētheús
e che l'eroe
abbatte. Ma l'aetós kaukasíos rimanda al suo
contraltare, il drákōn hespérios, il serpente
che fa la guardia ai
krýsea mla, gli aurei frutti dell'immortalità, nel
giardino delle Hesperídes.
Come già abbiamo più volte notato, i due animali presentano
tutta una serie di simmetrie: ciascuno è definito dal luogo in cui è collocato o, se vogliamo, dalla
direzione in cui è proiettato: il rapace è kaukasíos,
«caucasico», il serpente è hespérios, «occidentale».
Il primo è legato all'óros Kaúkasos, il monte ai
confini orientali del mondo, il secondo è legato all'estremo
occidente, dove si erge l'óros Átlas. Poiché i due monti sono rispettivamente la porta mundi
orientale e occidentale, aquila e serpente potrebbero
essere i rispettivi guardiani dell'orizzonte nelle due
direzioni.
Se però l'aquila è uno dei teriomorfi
presenti nell'immagine dei kǝrûḇîm,
non possiamo dire lo stesso del serpente. Questo potrebbe
non essere tuttavia un problema: non ci
si può aspettare di trovare un serpente
nell'iconografia di una creatura angelica, tanto più che il nāḥāš
si trova già all'interno del gan ʿĒḏẹn,
almeno nel Bǝrēʾšîṯ.
Il problema è però assai più sottile, visto che, a quanto
abbiamo asserito nella nostra ricerca, le montagne dell'alba
e del tramonto sono fuse tra loro
nell'immagine dell'axis mundi. Tale considerazione toglierebbe,
almeno in teoria, questi due guardiani dai loro siti a est
e a ovest per collocarli lungo l'asse celeste.
È qui, in effetti, in una lontana terra
iperborea, che Hērakls
trova (e uccide) Ládon, il drákōn hespérios,
nella variante «boreale» dell'undicesimo érgon, per
strappargli i frutti d'oro. E Gilgameš
viene beffato dal serpente, che gli divora la šammu nikitti,
la «pianta dell'irrequietezza», dopo essere risalito in
superficie dal suo tuffo «verticale» nelle profondità
abissali dell'Apsū. Se l'aquila
sembra d'un tratto scomparsa, il serpente assume una strana
posizione assiale. E di nuovo, è nel suo regno sotterraneo
che Bulūqiyā cattura
Yamlīḫā,
la regina dei serpenti, la quale lo beffa a sua volta non
rivelandogli, potendo farlo, quale sia l'erba che rende
immortali.
Riassumendo:
| |
Bǝrēʾšîṯ |
Ša naqba īmuru |
Ciclo di Hērakls |
Racconto di Bulūqiyā | | Leone |
Un volto dei kǝrûḇîm |
Dei leoni vengono messi in fuga da Gilgameš |
Uccide il leone di Neméa |
Uno dei guardiani della porta del ǧabal
al-Qāf
ha aspetto di leone | | Toro |
Un volto dei kǝrûḇîm | Gilgameš ed Enkidu uccidono
Gudanna, il toro del cielo |
Cattura il toro di Krḗtē |
Uno dei guardiani della porta del ǧabal
al-Qāf
ha aspetto di toro | | Aquila |
Un volto dei kǝrûḇîm | |
Uccide l'aetós kaukasíos |
Vede malāʾika con teste di leone, toro, aquila e umana | |
Serpente | Il nāḥāš
a guardia dell'albero della vita |
Divora la šammu nikitti, la «pianta
dell'irrequietezza» |
Uccide il drákōn hespérios, Ládōn,
a guardia del Kpos Hesperídōn. |
Yamlīḫā, la regina dei
serpenti, gli cela la natura della pianta
dell'immortalità. |
Tori e leoni, aquile e serpenti, ci hanno
accompagnato in questi viaggi ai confini della terra,
indicandoci la strada nei punti cruciali del percorso, o
ergendosi come guardiani alle porte che
conducono all'esterno del mondo. Ma non è il momento di tentare
un'identificazione di questi teriomorfi. Abbiamo appena superato
le montagne che sorreggono il cielo e valicato le
portae mundi. C'è ancora parecchia strada prima di arrivare
al giardino della vita. |
MAPPE DI VIAGGIO: LA
CONFLUENZA DEI FIUMI Superate le montagne che sorreggono il cielo, valicate le
portae mundi, l'eroe è ormai giunto al limite dell'oikouménē,
della terra abitata dagli uomini, e trova davanti a sé l'oceano che circonda il mondo. Un mare
sterminato e difficile, che nessun mortale, a memoria d'uomo, ha mai
attraversato.
- (α) Nello Ša naqba īmuru,
Gilgameš si trova di fronte un
«mare» [tâmtu] che soltanto il dio-sole Šamaš
è in grado di valicare e lo attraversa sulla barca di
Uršanabi. Al centro di esso ci sono
le mê mūti, le «acque della morte»: egli avanza
sospingendo l'imbarcazione con delle pertiche; quando termina le
pertiche, usa il suo
vestito come vela, facendo egli stesso da albero.
- (β) Hērakls attraversa il
fiume
Ōkeanós per ben due volte, a bordo
della coppa d'oro del dio-sole Hḗlios.
Nel primo viaggio si reca a Eirýthia,
per rubare il bestiame di Gēryṓn;
nel secondo, arriva al giardino delle
Hesperídes. Quando vengono meno il vento e le correnti,
anch'egli utilizza la pelle di leone come vela.
- (γ) Dopo aver attraversato a piedi i «sette mari» e aver
varcato la porta del ǧabal
al-Qāf, Bulūqiyā
si trova di fronte al Baḥr al-muḥīṭ,
l'oceano onniavvolgente che si trova sotto il trono di
Allāh
e alimenta tutte le acque del mondo.
- (δ) Al-Iskandar/Eskandar
si mette in mare sia nel corso della sua spedizione a oriente, sia in
quella a occidente. Nella versione di
Neẓāmī,
Eskandar giunge dapprima a una
terra d'oltremare, traversata la quale, si trova di fronte a un
oceano invalicabile, dove il sole si tuffa nel
tramonto. È il baḥr-i-oqiyānūs, versione arabizzata dell'antica concezione iranica del
Vourukaa. Non può tuttavia proseguire a causa del
baḥr-i-mard, la «distesa della morte».
- (ε) Sebbene i testi non siano molto chiari, una volta
arrivato nella terra at himins enda «alla fine del
cielo», posta oltre gli Élivágar,
Þórr si trova di fronte un nuovo
oceano: l'útháf, il «mare esterno» che circonda il mondo,
nel quale giace il serpente Jǫrmungandr.
Il più antico eroe, a nostra memoria, a trovarsi di fronte
all'oceano cosmico è Gilgameš. Sebbene
lo Ša naqba īmuru lo
definisca semplicemente tâmtu, «mare», esso corrisponde al Marratu, il «fiume amaro» che circonda
la terra abitata nell'Imago mundi Babylonica.
Il lugal di Uruk deve superare questa barriera. Le parole con cui Šiduri
lo mette in guardia
esprimono perfettamente le difficoltà e i rischi di una tale impresa:
ul ib-ši GIŠ-gím-maš né-bé-ru ma-ti-ma
u ma-am-ma šá ul-tu u₄-um ṣa-at {KUR} la ib-bi-ru tam-ta
e-bir tam-ti UTU(=šamaš) qu-ra-du-um-mu
ba-lu UTU(=šamaš) e-bir tam-tim man-⌜nu⌝⌉
pa-áš-qat né-ber-tum šup-šu-qat ú-ru-uḫ-šá
ù bi-ra-a A(=mê) mu-ti šá pa-na-as-sa par-ku
a-ḫum-ma GIŠ-gím-maš te-te-bir tam-ta
a-na A(=mê) mu-ú-ti ki-i tak-tal-du te-ep-pu-uš mi-na | “O Gilgameš, non c'è mai stato un traghetto
e nessuno degli antichi ha mai attraversato il mare [tâmtu];
l'unico che attraversa il mare è l'eroe Šamaš:
al di fuori di Šamaš chi può mai attraversare il mare?
La traversata è difficile, la via piena di insidie;
e in mezzo vi sono le acque della morte che impediscono il passaggio.
Come puoi tu, quindi, Gilgameš, attraversare il mare?
E una volta che hai raggiunto le acque della morte, cosa farai?” | | Ša naqba īmuru [X: -] |
Nonostante tutto, Gilgameš, il tenace Gilgameš, riuscirà ad attraversare il Marratu, imbarcandosi sul traghetto di Uršanabi. Mai perfettamente spiegato, questo personaggio sembra essere il nocchiero di Ūtanapištî: forse corrisponde al pilota dell'arca di Xísuthros che,
nella Babyloniaká di Bḗrōssos (apud Aléxandros Polyḯstōr), sarebbe stato reso immortale insieme al suo padrone e ai congiunti
di quest'ultimo. Il suo nome, in una tarda lista bilingue di antroponimi, viene interpretato secondo l'equazione, probabilmente artificiosa, di ur-šánabi = amēl-É.A, cioè «Uršanabi = l'uomo di Ea» (VR [44: iii, ]), suggerendo la sua familiarità con le acque abissali dell'Apsū, dimora di Enki/Ea.
Nel mito greco, il Marratu
è rappresentato dal potamós Ōkeanós, il grande circuito liquido che circonda il mondo. In Hēsíodos, Ōkeanós è il primogenito dei Titânes
(Theogonía [])
ma, a differenza degli altri suoi fratelli che, pur tradendo una natura elementale, presentano tratti antropomorfi, Ōkeanós è un
ente cosmologico, del tutto identificato con l'oceano che circonda il mondo. I suoi flutti tumultuosi scorrono intorno alla terra, rifluendo su sé stessi in un circolo
ininterrotto, e delimitano i confini dello spazio, i limiti del nulla. Ma Ōkeanós non
scorre in solitudine: mescola infatti le sue acque con quelle della sua sorella-sposa Tēthýs, in una sorprendente
interpraetatio graeca della formula accadica pû-nārāti,
«confluenza dei fiumi».
Genitori dei tremila dèi fluviali, i Potamoí, e delle altrettante Ōkeanínes
(Theogonía [-]), Ōkeanós e Tēthýs sono le sorgenti donde scaturiscono le acque che scorrevano sulla terra e il luogo ultimo ove esse tornano a defluire. Essi penetrano all'interno delle terre attraverso le acque dei mari e dei fiumi, garantendo, grazie al dualismo insito nell'opposizione di maschio e femmina, la pluralità e la complessità della vita. (Vernant 1989¹)
Ⓐ▼ Solo Šamaš può attraversare il
tâmtu, spiega Šiduri a
Gilgameš.
Un'osservazione assai sensata. Ed Hērakls,
quasi avesse udito lui le parole di Šiduri, bersaglia
il dio-sole Hḗlios con le sue frecce, obbligandolo a prestargli la sua coppa d'oro.
A bordo di essa, l'eroe ellenico può affrontare le onde oceaniche. Ma perché solo il dio-sole è in grado di attraversare il Marratu
o Ōkeanós?
Semplice. Siamo al di là delle montagne dell'alba o del tramonto, sull'altro lato delle «porte solari». Trovandosi oltre l'alba e oltre il tramonto, Gilgameš ed Hērakls si
sono spinti in uno scenario che non appartiene più alla terra, ma al corso
degli astri. Essi stanno passando dall'oikouménē al kósmos
e le acque su cui stanno navigando fanno parte del percorso notturno
del sole. Ecco giustificata l'osservazione di Šiduri.
Un frammento di Stesíkhoros (vii-vi sec. a.C.) ci spiega che,
nella sua coppa d'oro, Hḗlios navigava nelle «sacre e buie profondità della notte» per raggiungere, dopo il tramonto, la sua famiglia.
| E allora forte figlio di Hypérion [Hḗlios] entrava in una coppa d'oro massiccio, in modo che potesse attraversare Ōkeanós e raggiungere le sacre e buie profondità della notte, e sua madre [Theía] e la sua sposa e i cari figli; mentre il figlio di Zeús [Hērakls], che dentro quella coppa ha raggiunto Erýtheia
per poi ritornare indietro alla terraferma, ora la restituisce a Hḗlios,
ed a piedi entra nel bosco, ombreggiato di allori. | | Stesíkhoros: Phragmenta [X17] |
Un frammento di Mímnermos (❀ 630-600 a.C.) è ancora più esplicito. Ci
narra che, dopo aver solcato il cielo nella sua orbita diurna, da oriente a occidente, Hḗlios
si accoccolava nella sua coppa d'oro e dormiva saporitamente, mentre
la corrente di Ōkeanós lo
riconduceva di nuovo a oriente:
| Il destino di Hḗlios è quello del sole: faticare ogni giorno. Non c'è mai tregua per lui e per i suoi cavalli, dal momento che Ēṓs dalle dita rosate lascia Ōkeanós e s'innalza nel cielo. Un bel letto concavo, alato, forgiato dalle mani di Hḗphaistos in oro prezioso, lo trasporta tra le onde, sulla superficie dell'acqua, mentre dorme profondamente, dalla dimora delle Hesperídes alla terra degli Aithíopes, dove il suo rapido carro e i cavalli attendono fino alle prime luci dell'alba. Là, il figlio di Hypérion [Hḗlios] monta il suo altro veicolo. | | Mímnermos: Phragmenta [12] |
Un'immagine affascinante, questa di Hḗlios, che fugge i destrieri della notte correndo intorno al mondo sulla sua
aurea navicella (Aiskhýlos: Hēlíades [ph. 33],
Athḗnaios: Deipnosophistaí [XI: 39, ]), mentre le correnti di Ōkeanós lo riconducono al suo palazzo, a oriente, dove lo attendono un carro e cavalli freschi perché egli li monti e riprenda il suo quotidiano viaggio attraverso il cielo. In Apollódōros
(Bibliothḗkē [II: 5]), Hērakls utilizza
due volte la coppa del sole come imbarcazione:
-
nel decimo érgon, sul lato occidentale di Ōkeanós, dall'Ibēría verso Eirýthia, per rubare il bestiame di Gēryṓn;
-
nell'undicesimo érgon, sul lato orientale, dalle coste di Aithiopía verso il giardino delle Hesperídes.
Nel primo caso, Hērakls si muove
dalla terra abitata verso l'esterno, cioè perpendicolarmente al flusso di Ōkeanós; nel secondo caso, asseconda la corrente,
costeggiando la terra abitata. Questo secondo percorso sembra
suggerire che il
potamós Ōkeanós fluisca
intorno alla terra in senso antiorario,
contrario a quello che dovrebbe essere il normale senso di marcia del sole.
Riteniamo che questo dettaglio sia una trascuratezza astronomica di Apollódōros.
Se dopo il tramonto, il sole seguisse la logica continuazione
della sua rotta diurna, Ōkeanós
dovrebbe trasportarlo da occidente in senso orario, lungo il lato
della terra opposto al polo
settentrionale. Ma concentriamoci sul termine accadico Pû-nārāti,
la «confluenza dei fiumi» o più letteralmente la «bocca dei fiumi». Lo Ša naqba īmuru definisce con questo termine il luogo dove è stato traslato Ūtanapištî,
senza specificare se si tratti di una terra posto oltre il mondo o,
come il nome porterebbe piuttosto a intendere, di un epiteto dello
stesso mare esterno. L'idea generale
sembra essere quella di una località situata nel punto dove
confluiscono tutte le acque del mondo. Tale concetto può essere
inteso in due modi: uno mitico/cosmologico e uno geografico/idrografico. -
Mitico/cosmologico:
il riferimento è alla rappresentazione assiro-babilonese dell'oceano
cosmico, costituito dalla confluenza di Apsū e Tiāmat, rispettivamente personificazione delle acque dolci e delle acque salate.
Stando al mito cosmogonico attestato in Enūma elîš, con il trionfo di Marduk, Tiāmat viene uccisa e, dal suo corpo
spaccato in due parti, vengono tratte le acque celesti e quelle
terrestri; Apsū verrà respinto ai confini
della terra e rimarrà quale abisso delle acque dolci
sotterranee Ⓑ▼. Nel contesto di tale cosmologia, il Pû-nārāti, la «confluenza dei fiumi», è il luogo,
situato ai confini del mondo, dove si mescolano le acque di Tiāmat e Apsū: le acque salate dei mari della terra e le acque dolci dell'abisso sotterraneo. Gilgameš deve arrivare al Pû-nārāti prima di potersi aprire un varco verso l'Apsū. È infatti nel profondo di questo abisso acquatico che si
cala per strappare la šammu nikitti, la «pianta
dell'irrequietezza».
- Geografico/idrografico: tutti i fiumi e i mari della terra confluiscono nel Marratu, che è dunque il luogo dove tutte le acque, percorse le loro
vie, tornano a mescolarsi. Si noti che i Babilonesi e gli Assiri identificavano con
l'espressione pû-nārāti la città di Eridu, la più meridionale della Mesopotamia, che si affacciava sul
golfo Persico, là dove le acque dolci del Tigri e dell'Eufrate si confondevano con quelle salate del mare
①▼. Eridu era anche la città sacra al dio Enki:
una scelta sensata, visto il legame di Enki/Ea con l'Apsū.
Tali considerazione valgono anche per gli altri
schemi mitici che abbiamo analizzato. Nel mito greco, il potamós Ōkeanós,
«origine e fine di tutte le cose», era anch'esso considerato la
sorgente di tutte le acque che scorrevano sul mondo e Ōkeanós e Tēthýs mescolano le loro acque in maniera analoga a Tiāmat e Apsū. Ma abbiamo già parlato altrove del groviglio di affinità e omologie tra il modello greco e quello accadico
Ⓒ▼. Simili mitemi erano presenti anche nella cosmologia antico-iranica, la quale
presta notevole attenzione all'aspetto idrografico. Anche qui l'oceano cosmico Vourukaa/Frāxwkard/Warkaš è
costituito dalla confluenza di tutte le acque fluviali dell'universo, incarnate
dalla yazatā Arǝdvī Sūra Anāhita, che scorrono dal cielo alla terra, giungendo in tutti i sette karšvąr. Così
leggiamo in un passo dell'Avestā:
| Masitąm dūrāṯ frasrūtąm ýā asti avavaiti masō ýaθa īspå imå āpō ýå zǝmā paiti fratačiñti ýā amavaiti fratačaiti hukairyāṯ hača barǝzaŋhaṯ aoi zrayō ouru-kaṣ̌ǝm. | [Arǝdvī Sūra Anāhita], con una massa [d'acqua] che si sente da lontano, che da sola è uguale per volume a tutte le acque che scorrono sulla terra, che scende precipitosa giù con potenti rivoli dalla cima dello Hukairya fino al mare Vourukaa. | | Ýaozǝñti īspe karanō zrayā ouru-kaaya ā īspō maiδyō ýaozaiti ýaṯ hīš aoi fratačaiti ýaṯ hīš aoi fražgaraiti arǝdvī sūra anāhita, ýeŋ́he hazaŋrǝm airyanąm hazaŋrǝm apaγžāranąm, kasčiṯča aēṣ̌ąm airyanąm kasčiṯča aēṣ̌ąm apaγžāranąm čaθβarǝ-satǝm ayarǝ-baranąm hvaspāi naire barǝmnāi. | Tutti i golfi nel Vourukaa sono agitati quando essa precipita, da tutto il centro del mare si alzano zampilli quando Arǝdvī Sūra Anāhita vi si getta veloce dentro, quando ella vi si tuffa schiumeggiante, ella, di cui sono migliaia i fiumi tributari e migliaia gli sbocchi emissari, e ognuno come s'immette o scorre via, è come facesse una galoppata lunga quaranta giorni percorsi da un cavaliere provetto. | | Aiŋ́håsča mē aēvaŋhå āpō apaγžārō ījasāiti īspāiš aoi karṣ̌vąn ýāiš hapta... | Il principale emissario e sbocco di quest'unica acqua va lontanissimo, dividendosi in tutti i sette karšvąr... | | Avestā > Yasna [14: -] |
Di questi fiumi, i
due principali sembrano essere il Raŋhā e il Vaŋhuī Dāityā (medio persiano Arang e Wehrōd). I testi medio-persiani li presentano uniti tra loro da vincoli di amicizia e amore: ciascuno dei due prega Ahura Mazdā, a nome dell'altro, affinché
l'uno possa portare felicità a tutte le creature, l'altro possa
elargire a tutti l'immortalità. Ma per colpa delle forze ahrimaniche, essi
sono strappati dall'oceano Vourukaa,
nei quali mescolavano le loro acque, e scendono, immensi, da settentrione. A questo punto si dividono: il Raŋhā scorre lungo la costa occidentale della terra abitata
e il Vaŋhuī Dāityā lungo
quella orientale. Riunitisi infine a sud, rifluiscono purificati nell'oceano Vourukaa (Bundahišn [4B, - | 9, -]). Queste note dànno un'idea
del senso dell'espressione «confluenza dei fiumi», ricorrente in questo
tema mitico, che porterà all'enigmatica maǧmaʿa al-baḥrayni, la «confluenza dei due mari»,
attestata in al-Qur˒ān [xviii: ] e nella storia di Bulūqiyā. La šammu nikitti, la «pianta
dell'irrequietezza», che Gilgameš coglie sul fondo dell'Apsū, richiama probabilmente i due alberi rigogliosi che crescono nell'oceano Vourukaa: l'albero Gaokǝrǝna (pahlevico
Gōkarn), sul quale fruttifica il bianco haoma (pahlevico hōm-ī-sped), l'elixir
vitae distillato da Ahura Mazdāh per sconfiggere la vecchiaia, far risorgere i morti e rendere immortali i viventi,
alla fine dei tempi, nel Frasōkǝrǝti (pehlevico Frašgird); e il wan ī was-tōhmag, l'albero imperituro e dalle molte semenze, che guarisce ogni male.
Le acque della morte
Un tema assai interessante, in
questo scenario idro-cosmologico, è la presenza di un flusso
mortale che, in qualche modo, scorre nell'oceano cosmico pur
tenendosene in qualche modo distinto, formando una sorta di regione
o corrente pericolosissima a chi la attraversi.
La sua più antica rappresentazione sono ovviamente le mê mūti, le «acque della morte»
dello Ša naqba īmuru, che
scorrono nel bel mezzo del tâmtu e rendono difficoltosa la traversata di Gilgameš.
Esse possono essere direttamente confrontate con le gelide acque del
potamós Stýx,
i cui flutti scorrono per nove decimi nelle profondità della terra,
fino a sprofondare nel Tártaros, ma un decimo contribuisce alla corrente di Ōkeanós.
Ebbene, dice Hēsíodos, se uno degli dèi immortali attinge all'acqua di Stýx con un calice d'oro e la beve giurando il falso, per un anno intero cade senza respiro: e questa è la cosa più simile alla morte che possa capitare a un
immortale. Al termine dell'anno, una volta uscito dal coma, lo spergiuro non può più avvicinarsi per nove anni alle mense degli dèi, non può gustare il néktar e l'ambrosía e partecipare alle assemblee divine. (Theogonía [-]).
Ritroviamo il tema nella forma dello yamā saryā,
il «mare fetido» del Neṣḥānā d-leh d-ʾAleksandrōs
aramaico. Ma esso è presente anche nel racconto di Neẓāmī,
dove Eskandar, una volta giunto
ai confini del mondo, viene distolto
dalla sua intenzione di avventurarsi sul baḥr-i-oqiyānūs,
a causa del rischio di incappare sul baḥr-i-mard, la
«distesa della morte». Il mitema del mare velenoso è
diffuso nei miti di tutto il mondo, in particolare nelle
leggende marinare.
Al tema delle correnti avvelenate dei flutti cosmici
accenna tanto la cosmologia iranica, dove ha un significato etico (Bundahišn [7,
, | 19, ]), ma anche la mitologia
nordica,
dove nelle acque dei fiumi cosmici Élivágar
scorrevano correnti velenose.
Ed è
a questo veleno, recato a tutti gli angoli del cosmo, che la soteriologia
scandinava attribuiva le ragioni della presenza del male nel mondo e
della malvagità in tutti gli esseri, soprattutto negli jǫtnar e nelle
creature primordiali
(Gylfaginning [5]). Ⓓ▼
Ór Élivágum
stukku eitrdropar
ok óx unz varð ór jǫtunn,
þar órar ættir
komu allar saman,
því er þat allt eða atalt”.. |
Dagli
Élivágar
scaturì in gocce il veleno
e crebbe finché nacque un gigante.
Da là le nostre stirpi
vennero tutte insieme,
per cui sempre feroci saranno”. |
|
Gylfaginning [5: {8}] =
Vafþrúðnismál [31] |
Ma seguendo le tumultuose correnti dei dei fiumi cosmici i quali, in Īrān, in Grecia e in Scandinavia, erompono e confluiscono dall'oceano cosmico,
scorrendo dal cielo alla terra, dalla terra agli inferi e unendo tra loro tutti i livelli dell'essere,
rischiamo di uscire dal nostro argomento. Ne tratteremo in uno
studio a parte.
Riassumendo:
| MESOPOTAMIA |
GRECIA |
ĪRĀN PREISLĀMICO |
ARABIA / ISLĀM |
SCANDINAVIA |
| Il Marratu è il fiume amaro che circonda la terra all'esterno. |
Ōkeanós è il fiume cosmico che fluisce intorno alla terra. |
Vourukaa è l'oceano cosmico che circonda il mondo. |
Il Baḥr al-muḥīṭ
è l'oceano onniavvolgente che circonda il mondo. |
L'háf è l'oceano
che circonda il Miðgarðr. |
| L'oceano cosmico primordiale
è formato dalla confluenza delle acque dolci maschili di Apsū
e delle acque salate femminili di Tiāmat. |
Nelle acque cosmiche si confondono la corrente di Ōkeanós e della sua sorella-sposa Tēthýs. |
I fiumi Raŋhā e il Vaŋhuī Dāityā fondono con amore le loro acque nel Vourukaa. |
L'oceano esterno è definito maǧmaʿa al-baḥrayni, «confluenza dei due mari». |
Élivágar si chiama l'insieme dei
fiumi che scorrono attraverso tutti i livelli del cosmo. |
| Apsū e Tiāmat vengono strappati l'una all'altra. Marduk uccide Tiāmat e produce con il suo corpo le acque celesti e marine. |
Ōkeanós e Tēthýs sono separati da un dissidio e divorziano. |
Le forze ahrimaniche obbligano il Raŋhā e il Vaŋhuī Dāityā a separarsi nel loro fluire intorno al mondo. |
|
|
| Tutti i mari interni, i fiumi e le acque che scorrono sulla terra, provengono e tornano a rifluire nel
tâmtu/Marratu, nel
Pû-nārāti, «confluenza dei fiumi». |
Ōkeanós e Tēthýs sono i genitori delle tremila divinità fluviali
(Potamoí) e delle altrettante
Ōkeanínes. |
I diciottomila fiumi derivano dal Raŋhā e dal Vaŋhuī Dāityā. |
Il Baḥr al-muḥīṭ, l'oceano onniavvolgente che si trova sotto il trono di Allāh,
alimenta tutte le acque del mondo |
Gli
Élivágar sgorgano e
rifluiscono nella sorgente di
Hvergelmir, l'abisso acqueo posto nel profondo
dell'universo. |
| Apsū è la sorgente ultima di tutte le acque che scorrono sul mondo
e il posto dove tornano a rifluire. |
Tutti i mari interni, i fiumi e le acque che scorrono sulla terra provengono e ritornano nella corrente di Ōkeanós. |
Tutte le acque fluviali, incarnate nella yazatā Arǝdvī Sūra Anāhita, scorrono dal cielo alla terra e rifluiscono nel Vourukaa. |
| Al centro del Marratu scorrono le mê mūti, le «acque della morte». |
La
fatale corrente di Stýx si mescola a quella di Ōkeanós. |
Alcuni fiumi che arrivano al Vourukaa
sono stati avvelenati dalle forze ahrimaniche. |
Nel
baḥr-i-oqiyānūs scorre
il baḥr-i-mard, la «distesa della morte». |
Alcuni fiumi che
compongono gli Élivágar
sono saturi di veleno. |
| Oltre il
tâmtu/Marratu vi sono Dilmun e Pû-nārāti,
le terre lontane dal mondo degli uomini, dove risiede
l'eroe diluviale (Ziudsura, Atraḫasîs e Ūtnapištî),
reso immortale per volere degli dèi. |
Oltre la corrente di Ōkeanós vi sono le Makárōn Nsoi,
le «isole dei beati» lontane dal mondo degli uomini,
dove gli eroi prescelti dagli dèi vivono una vita
immortale. | Oltre il fiume Vourukaa
vi sono i karvąr, terre lontane dal mondo degli
uomini. | In un'isola nel Baḥr al-muḥīṭ,
lontano dal mondo degli uomini, Bulūqiyā incontra
l'immortale al-Ḫiḍr. |
|
| Sul fondo dell'Apsū cresce la šammu nikitti, la «pianta
dell'irrequietezza», che permette ai vecchi di tornare giovani. |
Seguendo la corrente di Ōkeanós
si arriva ai krýsea mla, i «frutti d'oro»
dell'immortalità, che crescono nel giardino delle Hesperídes |
Nella parte più profonda del Vourukaa crescere l'albero Gaokǝrǝna,
da cui fruttifica il bianco haoma, liquore
d'immortalità. | La māʾ al-ḥayāt,
l'«acqua della vita» sgorga nelle terre presso o oltre
il Baḥr al-muḥīṭ. |
|
| |
| |
Il frassino
Yggdrasill dirige le sue
tre radici alle sorgenti di
Hvergelmir, Mímisbrunnr
(la fonte della conoscenza) e
Urðarbrunnr (la fonte del destino). |
|
①▲ Oggi il Tigri e l'Eufrate si riuniscono formando un unico fiume, lo Šaṭṭ al-ʿArab, che procede per circa 190 chilometri prima di formare un
delta che sfocia nel golfo Persico. Ma la pianura alluvionale si è formata nel corso dei secoli a causa del fango e del limo trasportati a valle dai due fiumi, tanto che dall'antichità il mare si è ritirato per almeno 280 chilometri. All'epoca dei Sumeri, il Tigri e l'Eufrate entravano nel
golfo Persico con due distinte foci, distanti circa 150 chilometri, e la città di Eridu si trovava tra l'una e l'altra. Non è dunque facile trarre un senso dall'espressione Pû-nārāti, e qualche filologo, perplesso e disperato, è arrivato addirittura a supporre che i Sumeri non avessero mai saputo in quale direzione scorressero le acque e credessero che nel
golfo Persico i due fiumi avessero la loro sorgente! Alcuni hanno addirittura proposto di tradurre Pû-nārāti con «sorgente», invece di «foce», ma senza chiarire il significato dell'espressione. |
|
|
MAPPE DI VIAGGIO: ISOLE OLTRE LO SPAZIO Varcato il mare/oceano, dice il nostro schema, l'eroe giunge in una terra lontanissima e disabitata. Il lettore che ci ha seguito fin qui sa bene, ormai, che la presenza di queste «terre d'oltreoceano» sembra essere un elemento costante
di certe cosmologie. Una versione molto antica è certamente costituita dagli otto nagi˒ānu
che
l'Imago mundi Babylonica ci mostra irradiarsi, a stella, al di fuori della terra abitata (oikouménē) e separati da questo dal cerchio del fiume «amaro» Marratu.
 | |
L'Imago mundi Babylonica (✍
VI sec. a.C.) | | British
Museum, Londra (Regno Unito) |
Purtroppo le iscrizioni dell'Imago mundi Babylonica sono lacunose e spesso inintellegibili. Poche confuse notizie arrivano a noi da questo documento risalente, forse, all'inizio del Primo millennio avanti
Cristo. Al terzo nagû un uccello non può completare il suo tragitto, forse a causa di asperità e deserti; il quinto nagû è caratterizzato da un'impenetrabile foresta
(o da piogge e inondazioni); il sesto nagû sembra essere un territorio montuoso; nel settimo nagû corre libero del bestiame cornuto; nell'ottavo nagû c'è la porta da dove il sole sorge all'alba [verso]. A questi si unisce un altro luogo,
a nord, dove una grande muraglia copre il sole [verso]. È davvero un peccato non saperne di più. Questo schema è il medesimo attestato nella cosmologia iranica, dove l'oceano esterno Vourukaa/Frāxwkard/Warkaš separa la terra abitata, aniraθa-/Xwanirah/Ḵonīras, dai sei karvąr/kešwar periferici; e in India, dove ogni idea diviene sottile metafora teologica,
e i dvīpa hanno la forma di anelli concentrici separati
da oceani. E non si potrà mai insistere a sufficienza su un punto
fondamentale: questi continenti esterni non sono entità geografiche ma cosmologiche. Una loro caratteristica è che siano del tutto irraggiungibili dai comuni mortali. «Nessuno può attraversare il mare» è un leit-motiv che abbiamo
udito molto spesso. Risuona ancora nelle nostre orecchie l'avvertimento di Šiduri a Gilgameš:
“al di fuori di Šamaš chi può mai
attraversare il tâmtu?” (Ša naqba īmuru [X: ]). Ma anche i testi zoroastriani ci avevano messo in guardia che non si può compiere la fatidica traversata senza affidarsi a una guida soprannaturale: «Non è possibile andare da un kešwar a un altro kešwar, se non con la guida e l'illuminazione degli yazatā» (Bundahišn [5B: ]). Anche Hērakls, per traversare il fiume Ōkeanós, deve ottenere un passaggio sull'aurea coppa di Hḗlios:
nessuno ha mai compiuto quell'impresa prima di lui e solo un traghetto cosmologico può trasportare l'eroe oltre il mondo degli uomini. Un'altra caratteristica di questi «continenti cosmici» è che, rarissimamente, gli dèi permettono a qualche essere umano di accedervi e dimorarvi. Traslato, per volontà divina, nelle terre d'oltreoceano, il prescelto scompare definitivamente dal consorzio umano.
Ma è anche strappato dalle leggi che reggono la conditione humaine: dalla dura necessità del lavoro e dal comune destino di malattia, vecchiaia e morte. Chi dimora nei
«continenti cosmici» conduce un'immortale vita di letizia e abbondanza. Conosciamo molti nomi di fortunati mortali che siano andati incontro a questo destino, a partire dai noè mesopotamici. Un confronto con i testi del diluvio, in particolare con il «Poema di Ziudsura» e con l'Enûma ilû awîlum, ci permette di asserire che il noè sumerico
Ziudsura, o il suo equivalente antico-babilonese Atraḫasîs, resi immortali, vennero traslati in un nagû. Un confronto con lo Ša naqba īmuru ci rivela che è proprio in un nagû che si reca Gilgameš, dopo aver attraversato il mare a bordo del traghetto di Uršanabi, per trovare l'indolente Ūtnapištî. Dunque Dilmun e il Pû-nārāti fanno parte della cosmologia dei nagi˒ānu. Anche le destinazioni extramondane raggiunte da Hērakls,
una volta varcato il potamós Ōkeanós a bordo della coppa solare, fanno parte di questa classe di destinazioni. L'isola di Erýtheia, la «rossa», posta proprio di fronte al tramonto del sole, e il favoloso giardino delle Hesperídes, le nýmphai dell'occidente, situato proprio sotto lo sguardo vigile di Átlas (Theogonía [- | - | -]), si confondono con la nozione delle Makárōn Nsoi, le «isole dei beati»,
felici terre di immortalità poste anch'esse nel lontano occidente. Qui, sotto il governo di Krónos,
gli dèi hanno destinato alla vita eterna alcuni tra più meritevoli
eroi, dopo averli traslati – proprio come
Ziudsura, Atraḫasîs e Ūtnapištî – lontani dal mondo degli uomini:
toîs dè dích' anthrṓpōn bíoton kaì ḗthe' opássas
Zeùs Kronídēs katénasse patḕr es peírata gaíēs.
tēloû ap' athanátōn: toîsin Krónos embasileúei.
kaì toì mèn naíousin akēdéa thymòn échontes
en makárōn nḗsoisi par' Ōkeanòn bathydínēn,
ólbioi hḗrōes, toîsin meliēdéa karpòn
trìs éteos thállonta phérei zeídōros ároura. | ...altri [eroi] il padre Zeús Kronídēs li pose ai confini della terra,
lontano dagli uomini, dando loro una dimora e i mezzi per vivere:
lontano dagli immortali, essi hanno Krónos per re.
Essi abitano, con il cuore lontano da affanni,
nelle Makárōn Nsoi, presso Ōkeanós dai gorghi profondi:
felici eroi, per i quali il suolo fecondo produce
un raccolto fiorente e abbondante per tre volte l'anno. | | Hēsíodos: Érga kaì hēmérai [-] |
Dilmun e il Pû-nārāti, il giardino delle Hesperídes, Erýtheia e le Makárōn Nsoi,
la lontana isola di al-Ḫiḍr,
sono solo alcune di queste terre extramondane, «sospese» nell'oceano cosmico che circonda il mondo. Esse sono l'unico luogo, fuori dal tempo e dallo spazio, dove il mondo è rimasto com'era prima della caduta, dove l'albero dell'immortalità concede ancora i suoi frutti o dove sgorga l'acqua della vita. Giustamente gli Elleni ponevano le Makárōn Nsoi sotto il dominio di Krónos, l'antico sovrano dell'età aurea. Abbiamo visto, nel mito esiodeo, che tagliando il fallo proteso di Ouranós e scindendo per sempre Ouranós da Gaîa, il dio-cielo dalla dea-terra, Krónos aveva rotto l'immutabile eternità dei primordi e aveva dato inizio al tempo. In epoca tarda, Krónos era stato interpretato anche come chrónos, il «tempo». La perfezione degli inizi era cristallizzata in un eterno stato di immutabilità: ma il tempo aveva per corollario il mutamento, e questo è a sua volta inscindibile dal disfacimento, dalla vecchiaia, dalla morte.
Ⓐ▼①▼
Queste terre d'oltreoceano, che il mito ellenico posta sotto gli auspici di Krónos, sono dunque immagine mitica di un «luogo»
esterno non sono allo spazio, ma anche al tempo, estraneo del mutamento e del disfacimento, e quindi del male e della morte. È il luogo dove il leone non mangia l'agnello e dove scorrono fiumi di latte e miele. È il luogo dove il vecchio non dice
“sono vecchio” e la vecchia non dice “sono vecchia”, dove la fanciulla non si bagna nel fiume e dove l'aedo non canta le sue canzoni. È l'irraggiungibile giardino di ʿĒḏẹn dov'era stato traslato Ḥănōḵ nel mito ebraico, così come al-Ḫīḍr/Ḵeżr in quello
islāmico e Ziudsura/Atraḫasīs/Ūtnapištî nelle varie versioni del racconto mesopotamico del diluvio. È il luogo dove gli eroi del mito ellenico vivono un'esistenza non diversa da quella degli dèi.
 | |
L'isola della vita (✍
1888) | | Arnold Böcklin
(1827-1901) |
È curioso che la stretta relazione semantica tra il kpos Hesperídōn (il «giardino d'occidente») e il gan-bǝʿĒḏẹn miqqẹḏẹm (il «giardino a Ēḏẹn in oriente») (Bǝrēʾšîṯ [2: ]) non sia stato sottolineata
con maggior forza dagli studiosi, quasi che classicisti e biblisti
si vergognassero di mettere in correlazione il mondo classico con
quello ebraico, il paganesimo con il monoteismo abramitico. Sulla localizzazione di Ēḏẹn abbiamo assai meno informazioni di quanto non sia per i suoi omologhi mesopotamici o ellenici. Miqqẹḏẹm, «a oriente», è una nozione assai vaga, e per di più parzialmente contraddetta dal fatto che, dopo la cacciata dell'uomo dal gan ʿĒḏẹn, i
kǝrûḇîm sono stati posti «a oriente» del giardino, per sorvegliarne l'ingresso (Bǝrēʾšîṯ [3: ]). Se il giardino si trova già oriente, che senso ha mettere guardiani a oriente di esso? Né i libri canonici, né quelli apocrifi, forniscono dati precisi sulla localizzazione di ʿĒḏẹn. In alcuni testi sapienziali, come il Mäṣǝḥäfä Henok, il «libro di Ḥănôḵ» in gǝʿǝz, il giardino viene collocato
addirittura nel terzo cielo e il suo accesso stabilito in un complesso sistema di porte celesti. Trasformato in un elemento escatologico, diviene una tappa nel processo delle anime dei giusti... ma ciò fa parte delle speculazioni apocalittiche ed esula dal nostro discorso. Queste terre extramondane, dove il tempo è fermo e l'immortalità è ancora possibile, appartengono non al dominio della geografia, ma piuttosto dell'astronomia, in quella sua antica forma ancora in parte indistinguibile dalla metafisica: nagi˒ānu, karvąr/kešwar e dvīpa sono territori dell'aldilà.
Ⓐ▲
Studi: [La
separazione del cielo e della terra]►
|
①▲ È
interessante notare che, nella mitologia scandinava, se al
centro vi è il Miðgarðr, il mondo
che gli dèi hanno creato e affidato agli uomini, man mano che ci
si inoltra verso la periferia l'ordine lascia il posto a un
ambiente sempre più selvaggio e ostile. Più che terre
meravigliose dove si conservava l'età dell'oro, ai confini del
mondo i vichinghi vedevano il perdurare di una sorta caos
primordiale. Questa visione era forse condizionata dall'ambiente
in cui vivevano gli Scandinavi: gli insediamenti, rari e
distanti gli uni dagli altri, erano stabiliti nelle regioni
meridionali della Svezia e sulle coste della Norvegia. Il
nord-est era un territorio inospitale, gelido e selvaggio. Gli
esseri che si immaginava vivessero in questi luoghi remoti erano
incarnazioni di elementi primordiali, forze che si opponevano
all'ordine imposto dagli dèi ed erano state respinte ai confini
del mondo:
troll,
draugar,
jǫtnar, hrimþursi. Non c'è da stupirsi se veniva usato, a indicare il mondo della
manifestazione umana, un termine come
Miðgarðr, «recinto mediano». In questa parola non vi
era solo una nozione di
centralità, ma anche di luogo
raccolto a difesa. Nel termine
garðr, «recinto», ma anche «fortezza», è contenuta la
connotazione di una fortificazione atta a proteggere un
villaggio o un centro urbano. Il mito narrato nelle
Edda afferma che gli dèi, allorché uccisero
il primordiale gigante
Ymir e crearono il
mondo usando il suo corpo come materia prima, utilizzarono le ciglia
del gigante per innalzare attorno alla terra degli uomini un
bastione, atto a contenere e proteggere gli esseri umani dalle creature che abitavano ai confini del mondo.
(Gylfaginning [8]). |
|
|
|
|
UNO SGUARDO ATTRAVERSO UNA COPPA DI CICUTA
Ora che finalmente, come promesso, abbiamo attraversato l'oceano
cosmico e abbiamo raggiunto il gan ʿĒḏẹn,
Dilmun e il
Pû-nārāti, il
Kpos Hesperídōn, Erýtheia e le Makárōn Nsoi,
e l'isola di al-Ḫīḍr/Ḵeżr,
dobbiamo cercare di fare il punto della situazione, prima di perdere
definitivamente la bussola. Non lasciamoci distrarre da questi
severi guardiani in forma di leoni, aquile, tori e serpenti. Dove ci hanno condotto, infine,
Gilgameš,
Hērakls ed
Eskander? Siamo su un'isola cosmica sospesa tra
due correnti del grande fiume Ōkeanós:
alle nostre spalle, i mari che circondano il mondo: laggiù, da
qualche parte, vi è l'oikouménē, la terra abitata dagli uomini. Ma
davanti a noi, cosa c'è? Dove ci troviamo? E dove stiamo andando?
Ma proviamo a far nostri, per un attimo, il disperato coraggio di Gilgameš,
la tenacia di Hērakls, il
candore di Balūqiyā e
soprattutto l'hýbris di Eskandar
e il suo inesausto desiderio di mettere alla prova i confini dell'umana
conoscenza. Aver raggiunto queste felici isole di immortalità
non ci basta. Vogliamo aguzzare lo sguardo, capire, guardare davanti a noi e cercare di capire cosa vi sia un passo oltre. Ed
ecco, d'un tratto il panorama si fa sfocato. Gli antichissimi
miti, che ci hanno sostenuto fin qui, cominciano a farsi inconsistenti. Più che ai confini del mondo sembra essere arrivati ai confini dell'immaginazione.
Nell'Imago mundi Babylonica
non sembra esservi nulla oltre il profilo a stella costituito dagli
aguzzi nagi˒ānu,
ma forse è soltanto un limite nella rappresentabilità della mappa.
Sappiamo che Gilgameš, oltre
il
Pû-nārāti, trova soltanto le
acque cosmiche abissali dell'Apsū,
nelle quali si immerge per cogliere la šammu nikitti, la
«pianta dell'irrequietezza». Nel
mito ellenico le cose si fanno un po' più chiare, ma non troppo. Sappiamo che
l'isola di Erýtheia
e le Makárōn Nsoi si
stagliano sui flutti del potamós Ōkeanós;
e stessa cosa possiamo inferire del Kpos Hesperídōn nella variante iperborea,
dato che Hērakls
lo raggiunge affidandosi alla corrente oceanica sulla coppa del sole. E sebbene Hērakls
non sia andato a controllare con i suoi occhi, anzi, al contrario,
abbia subito alzato i tacchi e sia tornato indietro, una volta
conclusa la missione, ci sembra ragionevole presumere che al di là
di Erýtheia e delle Makárōn Nsoi,
così come oltre il Kpos Hesperídōn, non vi siano che le correnti sempre più fredde
e oscure del grande fiume che circonda il mondo.
La stessa cosa si può dire del Vourukaa/Frāxwkard/Warkaš,
il grande oceano
del mito iranico: esso separa la terra abitata, aniraθa-/Xwanirah/Ḵonīras, dai sei karvąr/kešwar
che giacciono all'esterno del mondo. Oltre questi ultimi è possibile che l'oceano cosmico
si stenda indisturbato verso lo spazio. Alcune
rappresentazioni del kósmos iranico pongono il cingulus
mundi costituito dal monte Harā Bǝrǝzaitī/Harborz/Alborz
a chiudere all'esterno il grande oceano, come a circonscrivere l'intero
universo, ma su questo punto i testi non sono chiari.
Sicuramente la cosmologia arabo-islāmica dispone il ǧabal
al-Qāf tra i «sette mari», che lambiscono le terre note
agli uomini, e il Baḥr al-muḥīṭ,
l'oceano onniavvolgente
che si trova all'esterno del mondo... Anche l'Eskandar
persiano, nell'Iskandarnāmè, una
volta raggiunto e attraversato il continente oltre il mare, trova un
nuovo oceano impenetrabile, che Neẓāmī
chiama baḥr-i-oqiyānūs.
Sembra dunque di capire che, oltre le isole cosmiche, l'oceano
esterno prosegua senza limiti e senza confini. Come si può
interpretare questo fatto? E soprattutto: può illuminarci in qualche
modo sui luoghi dove siamo arrivati, sulla natura del gan ʿĒḏẹn,
di
Dilmun e del
Pû-nārāti, del
Kpos Hesperídōn, di Erýtheia e
delle Makárōn Nsoi, e
dell'isola di al-Ḫīḍr/Ḵeżr? Ma se
il mito tace, non ci resta che rivolgerci alla filosofia antica, che
del linguaggio mitico aveva fatto un suo valido strumento.
Ebbene, abbiamo la fortuna di poter beneficiare, al riguardo, di un
discorso davvero illuminante, ed è l'ultimo discorso che ascolteremo
dalla bocca di Sōkrátēs.
Dobbiamo sbrigarci, però. Sōkrátēs è in carcere,
attende la morte conversando con i suoi amici e discepoli. Il
testamento filosofico è stato fatto, il calice è vuoto, Xanthíppē è
in lacrime. E Sōkrátēs, Sōkrátēs si è lasciato alle spalle il mondo e ora attende quieto la
morte. Il suo spirito già vaga per sfere iperuranie, distaccato dalle
cose del mondo, che anzi, osserva da una prospettiva inconsueta. Il racconto che ci lascia ci consentirà di allargare la
nostra visione dal ristretto orizzonte delle carte geografiche, su
cui tanti si sono ostinati a cercare la «confluenza dei fiumi», al
kósmos intero, vero palcoscenico di tutta la mitologia. Naturalmente è Plátōn
a riferire delle ultime ore del grande filosofo: Sōkrátēs inizia a parlare:
| |
Io anzitutto mi sono persuaso di questo. Che se
la terra è collocata nel mezzo dell'universo ed è sferica,
ella non ha bisogno, per non cadere, né di aria né di alcun
altro appoggio di tal genere, essendo sufficiente a
sostenerla il fatto che l'universo è tutto uguale da ogni
parte a sé stesso e che la terra è per sé stessa
perfettamente equilibrata. Infatti, una cosa equilibrata,
posta nel bel mezzo di un'altra che sia eguale a sé stessa,
non potrà mai inclinarsi da nessuna parte; e, trovandosi
sempre in una condizione di perfetta eguaglianza, rimarrà
ferma al suo posto senza veruna indicazione.
| |
Plátōn: Phaídōn [108e-109a]
|
Il pensiero del grande filosofo prelude qui alla
fisica dinamica e al principio cosmologico. Ma che la terra fosse
sospesa al centro di un universo simmetrico in tutte le direzioni non
era una concezione nuova, né scientifica, ma solo una delle tante
idee che venivano ad affiancarsi a quelle già fornite in
precedenza dalla speculazione mitologica, certamente più
sottile e ragionata di visioni che volevano la terra poggiata sul
dorso di una balena o sorretta da un angelo, ma in fondo non
qualitativamente diversa da quelle. Ma abbiamo appena iniziato,
ché Sōkrátēs subito prosegue il racconto:
| |
Credo che la terra sia qualche cosa
di molto grande, e che noi, dal Phásis [nel Kaúkasos] alle colonne di Hērakls
ne abitiamo
soltanto una sua piccola parte; e abitiamo intorno al mar
Mediterraneo come formiche o rane intorno a uno stagno, e
altrove altra gente abita in luoghi simili a questo. Vi sono
molte cavità intorno alla Terra, diverse di forma e
di grandezza, nelle quali confluiscono insieme l'acqua e la
nebbia e l'aria. Ma la Vera Terra si libra pura nel cielo
puro dove sono le stelle, il quale è chiamato
etere. L'acqua e la nebbia e l'aria sono appunto un
sedimento di questo etere, e insieme si riversano
continuamente nelle cavità della terra. | | | Ora, noi che abitiamo in queste
cavità, non ce ne accorgiamo, e crediamo di abitare
sopra la terra. Allo stesso modo di chi, abitando nelle
profondità del mare, ritenesse di vivere sulla
superficie della terra, e credesse la superficie del mare
che lo sovrasta, attraverso la quale lui vede il sole e le
stelle, essere il cielo. Questo crede l'abitante del mare,
non essendo mai giunto al di sopra della superficie
dell'acqua e non avendo mai osservato queste regioni in cui
noi abitiamo, più pure e più belle di quelle
dove lui ha trascorso la sua intera vita. | | | Ebbene, anche a noi, credo,
è capitato precisamente lo stesso: ché
crediamo di abitare sulla superficie del mondo, mentre
invece abitiamo in una sua cavità. E l'aria la
chiamiamo cielo perché ci pare che attraverso questa,
quasi fosse cielo, noi vediamo muoversi le stelle. Ed
è la stessa cosa: anche noi non siamo capaci
di passare attraverso l'aria fino alla sua sommità.
Infatti, se uno, messe le ali, riuscisse a spingersi volando
fin sopra l'estremo lembo dell'atmosfera, colui vedrebbe,
levando il capo oltre la superficie dell'aria, vedrebbe le
cose di lassù. E se la natura sua fosse capace di
sostenere tale visione, egli riconoscerebbe che quello
è il vero cielo, quella la vera luce, quella la vera terra [alēthḗs
g]. [...]. | | | La
terra, per chi la guardi
dall'alto, ha l'aspetto delle nostre palle di cuoio a dodici
pezzi, iridescente. [...]. Crescono ivi alberi e fiori di
meravigliosi colori. E parimenti le montagne e le rocce sono
levigate e trasparenti, diaspri e smeraldi di vivace
splendore. [...]. E vi sono lassù molti esseri
viventi, piante e animali di specie diverse, e anche uomini.
Molti di questi abitano nell'entroterra, altri ancora come
noi sulle rive del mare d'aria, altri in isole non lontane
dal continente e circondate tutt'intorno dall'aria.
Ciò che per noi è l'acqua, infatti,
lassù è l'aria; ciò che per noi
è l'aria, lassù è l'etere. E le
stagioni lassù hanno tal temperanza che non vi sono
ammalati, e gli uomini non solo vivono più a lungo di
noi, ma anche, per la finezza della vista, dell'udito,
dell'intelligenza e di tutte le altre facoltà, sono
alla stessa distanza da noi che la purezza dell'aria dalla
purezza dell'acqua, e la purezza dell'etere da quella
dell'aria. E inoltre vi sono lassù boschi sacri agli
dèi e templi dove gli dèi abitano realmente; e
vi sono oracoli e divinazioni che permettono contatti
diretti con gli dèi. E gli uomini di lassù
vedono il sole, la luna e le stelle come sono realmente, e
così essi godono di ogni beatitudine.
| |
Plátōn: Phaídōn [108e-111c]
|
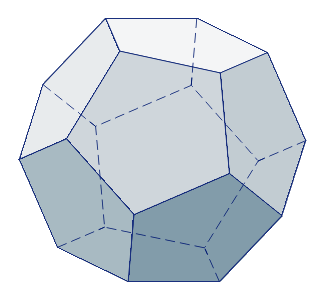 Al lettore abituato alle consuete rappresentazioni geografiche della
terra, queste
immagini di Sōkrátēs parranno assai strane. È evidente che
l'acqua del mare sia contenuta nelle «cavità» della terra, un
po' meno evidente che anche l'aria sia immaginata trattenuta in «cavità» più grandi.
La visione cosmologica che qui
traspare è di un mondo in cui, procedendo dalla terra verso
l'alto, gli elementi si fanno più sottili e imperituri. L'acqua
è più densa dell'aria, l'aria è più densa
dell'etere, solo l'etere è pura e cristallina sostanza.
La «vera terra», alēthḗs
g, dunque, per Sōkrátēs, si trovava oltre il confine
dell'aria, nello spazio cosmico. Al lettore abituato alle consuete rappresentazioni geografiche della
terra, queste
immagini di Sōkrátēs parranno assai strane. È evidente che
l'acqua del mare sia contenuta nelle «cavità» della terra, un
po' meno evidente che anche l'aria sia immaginata trattenuta in «cavità» più grandi.
La visione cosmologica che qui
traspare è di un mondo in cui, procedendo dalla terra verso
l'alto, gli elementi si fanno più sottili e imperituri. L'acqua
è più densa dell'aria, l'aria è più densa
dell'etere, solo l'etere è pura e cristallina sostanza.
La «vera terra», alēthḗs
g, dunque, per Sōkrátēs, si trovava oltre il confine
dell'aria, nello spazio cosmico.
È evidente che questa alēthḗs g sognata da Sōkrátēs vada
identificata con il kósmos
pitagorico, l'immane struttura metafisica che implica in sé
l'ordine eterno dei pianeti e delle stelle. È indicativo il
fatto che l'universo, visto da fuori, abbia qui «l'aspetto delle nostre palle di cuoio a dodici pezzi». Si tratta del dodecaedro, la
«sfera dai dodici
pentagoni», che nell'antica numerologia veniva riferita all'insieme
del kósmos. Plátōn narra che
dopo che il dēmiourgós ebbe usato i primi quattro solidi regolari
per costruire gli elementi, gli rimase il dodecaedro, che usò
come struttura per «formare il tutto» [epì tò pân]
(Tímaios [55c]).
Ploútarkhos spiega:
| |
È forse vera l'opinione di
coloro che pensano che [Plátōn] abbia attribuito il
dodecaedro alla forma sferica, allorché dice che il
dio si era servito di esso nel decorare la natura del tutto?
Infatti, per il gran numero delle basi e l'ottusità
degli angoli, evitando ogni «rettitudine», [il dodecaedro]
è flessibile; e se teso all'intorno, come le palle
fatte di dodici pezzi di cuoio, diventa circolare e
capiente. Ha inoltre venti angoli solidi, ciascuno dei quali
è contenuto da tre piani ottusi, e ciascuno di essi
contiene un angolo retto più una quinta parte
[108°]. Ed è connesso insieme da dodici
pentagoni equiangoli ed equilateri, ciascuno dei quali
consiste di trenta dei primi triangoli scaleni.
Perciò sembra assomigliare sia allo zoodiaco che
all'anno, essendo diviso nello stesso numero di parti di
quelli. | |
Ploútarkhos: Platonicae
Quaestiones [V: 1, c]
|
Il rapporto tra il dodecadro e il kósmos è dunque sia spaziale che
temporale. Il dodecaedro tende alla sfera, simbolo di perfezione. Ha
dodici facce, così come il cielo si estende all'intorno per
dodici segni zodiacali, e ogni faccia consiste di trenta triangoli
scaleni, così come ogni segno zodiacale si estende su una
fascia di 30°. Inoltre, 30 × 12 dà 360, che è sia
il numero di giorni in un anno, sia il numero di gradi in un cerchio.
Abbiamo detto altrove, parlando del mito egiziano citato da
Ploútarkhos
(De Iside et Osiride [2]), che gli antichi consideravano inappropriato che l'anno
solare avesse 365 giorni e non 360, come invece sembrava più equilibrato, ragione per cui i cinque giorni
in più venivano disposti quali giorni epagomeni e considerati fuori
dal tempo. Ⓐ▼
Naturalmente non tutti gli studiosi si sono lanciati convincere da
questa visione geometrica del kósmos. L'obiezione principale è
che Plátōn e Ploútarkhos
abbiano confuso il dodecaedro col dodecagono, in quanto lo zodiaco si
estende lungo un cerchio e non in una sfera. Il dodecaedro viene usato contemporaneamente come
rappresentazione spaziale e temporale. Sappiamo che i per Pitagorici soltanto i
numeri erano importanti, come ha messo sufficientemente in chiaro Aristotélēs (Metà
ta physiká
[985b]). Ed è per questo che anche Johannes
Kepler, che fu insieme l'ultimo dei pitagorici e il primo degli
astronomi moderni, non ha alcuna difficoltà a confrontarsi con
Plátōn e Ploútarkhos, se è vero che scrive:
«Il dodecaedro viene attribuito al
corpo celeste, siccome che esso possiede appunto tante facce
quanti sono i segni dello zodiaco. Si può provare
che, tra le restanti figure, esso ha la maggiore
capacità, proprio come il cielo abbraccia ogni
cosa» (Harmonicae
Mundi).
Proseguire lungo questa strada ci porterebbe a perderci in uno
straordinario universo di idee in cui la geometria, figlia del connubio tra
astronomia e filosofia, è il linguaggio che studia l'ordine supremo
del kósmos. Dobbiamo sforzarci di seguire il nostro percorso e notare, ancora
una volta, come questo mondo dodecaedrale Sōkrátēs lo descrive perfetto,
immutabile, privo del decadimento e della morte. È naturalmente il mitema del
giardino meraviglioso (il gan ʿĒḏẹn,
Dilmun e il
Pû-nārāti, il
Kpos Hesperídōn, Erýtheia e le
Makárōn Nsoi, e l'isola di al-Ḫīḍr/Ḵeżr...),
che nella filosofia greca è stato inaspettatamente respinto dalla terra al
cielo, dalla terra alla «vera terra», e ora ce lo troviamo sospeso nello spazio.
Ma è un'innovazione filosofica, o si tratta dell'ultima rielaborazione di un
mito antichissimo? Sōkrátēs sta utilizzando un linguaggio tradizionale per esprimere
sue personali idee cosmologiche, o ha semplicemente restituito al mito il suo
autentico significato?
Certamente non dobbiamo confondere il kósmos pitagorico con
lo spazio interplanetario. Bisogna sempre interpretare il mito secondo una
cosmologia che non era scientifica, né pretendeva di esserlo. Tra
«cielo» e «terra» non c'era soltanto una questione di direzione spaziale, ma
anche e soprattutto una distinzione metafisica. Il giardino meraviglioso
è sospeso in una perfezione utopica, e i suoi abitanti non conoscono la fatica, la
malattia e la morte, perché è irrimediabilmente scisso dal nostro mondo
sublunare. Come l'acqua è più grossolana dell'aria e
l'aria è più grossolana dell'etere, ecco che man mano
che ci allontaniamo dalla terra per avanzare nelle sfere cosmiche,
più troviamo conservata la perfezione atemporale dei primordi.
L'eternità appartiene al cosmo, ai pianeti e alle stelle.
Non siamo più in un ordine di idee
terrestre, ma cosmico.
Dunque,
per dirla con le parole di Sōkrátēs, attraversando le porte dello šadû Māšu
e seguendo il sentiero del sole fino al tâmtu,
Gilgameš ha
abbandonato le cavità terrestri per affacciarsi a un nuovo ordine di realtà. Stessa
cosa possiamo dire Hērakls, che dopo
aver spalancato le montagne sullo stretto tra Eurṓpē e Libýē è
uscito dalla terra abitata dagli uomini e ha trovato davanti a
sé i flutti di Ōkeanós.
L'oceano cosmico non circonda semplicemente la terra come un
anello, ma la avvolge tutto intorno, come il cielo. Gli epiteti del potamós Ōkeanós
nei testi sono «profondo-fluente», «rifluente su sé stesso»,
«instancabile», immagini che suggeriscono silenzio, regolarità,
profondità, quiete, rotazione: tutti elementi del cielo
stellato.
Ed ecco perché nello Ša naqba īmuru si
insiste sul fatto che solo
il dio-sole Šamaš sia
in grado di attraversare il tâmtu; ed ecco perché nel mito greco Hērakls
utilizza la coppa d'oro del dio-sole
Hḗlios per intraprendere un'analoga navigazione. Il
giardino meraviglioso non si trova sulla terra, ma lassù, da
qualche parte, tra le stelle.
|
|
UNA PROSPETTIVA
ASTRONOMICA
Il pensiero corre ormai alla possibilità
di implicazioni astronomiche, idea spesso avanzata tanto per
il ciclo di Gilgameš, tanto per
quello di Hērakls,
sicché è difficile aggiungere qualcosa di nuovo in questo
campo. In seguito alle primissime ricostruzioni dello Ša naqba īmuru, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, Gilgameš era stato interpretato come un eroe solare; si puntualizzava che le tavolette della redazione ninivita
fossero dodici, proprio come i segni dello zodiaco, e molti
importanti studiosi (Hugo Winckler (1863-1913), Heinrich Zimmern
(1862-1931), Otto Weber (1902-1966)) leggevano il ciclo del lugal
urukita come un'allegoria del sole che, nel corso dell'anno, si muove lungo l'eclittica. A quell'epoca andavano di moda le interpretazioni astrali
e forse si è un po' esagerato con simili letture, ma è fuor di dubbio che molti episodi della leggenda di Gilgameš
sembrano riferirsi ai segni zodiacali.
Ma in quanto a implicazioni astronomiche, Hērakls
non è da meno. Le attinenze zodiacali di alcune delle sue
«fatiche» sono spesso esplicitamente attestate e
confermate dagli astronomi classici. Il granchio che
artigliò la caviglia di Hērakls
durante la lotta contro l'hýdra di Lérnē,
sarebbe stato poi posto da Hḗra
tra le stelle e sarebbe divenuto la costellazione del Cancer. Il centauro Kheírōn, tormentato da una ferita insanabile, prodotta dalla freccia di Hērakls, donò la propria immortalità a uno dei due
Dióskouroi, e morì diventando il
Sagittarius (secondo altri il Centaurus). E la lotta di Hērakls contro il dio fluviale
Akhelos, il quale poi gli regalerà
la cornucopiae in cambio del corno che l'eroe gli aveva strappato, rimanda
alla simbologia di Aquarius.
Se vi aggiungiamo l'uccisione del leone di Neméa e la
cattura del toro di Krḗtē, catasterizzati
rispettivamente nelle costellazioni di Leo
e Taurus, possiamo concludere che ben cinque segni
zodiacali su dodici sono legati al ciclo eracleo. Ma vi sono
anche diversi asterismi non zodiacali che rimandano,
direttamente o indirettamente a svariati miti di Hērakls
(Draco, Hydra, Sagitta, Aquila, Eridanus, etc.),
compresa una costellazione che, seppure elaborata in epoca tarda e con
molti ripensamenti, è stata dedicata all'eroe stesso (Hercules).
Bisogna ammettere, tuttavia, che
sia nel mito di Gilgameš
sia in quello di Hērakls non è possibile forzare le analogie fino a comprendere l'intero giro dello zodiaco.
Se vi fosse davvero un archetipo comune alla base dei due cicli, le sue origini risalirebbero troppo indietro nel tempo perché sia
possibile trovare confronti precisi e puntuali con un sistema
astronomico tanto più recente. L'idea che lo
zodiaco, così come oggi lo conosciamo, risalga a epoche
antichissime, non è corretta. Non ci sono evidenze che i greci possedessero uno zodiaco completo fino al
vi secolo avanti Cristo, prima che gli astronomi
Méthōn (v sec. a.C.) e Euktḗmōn (±460-±390
a.C.) formalizzassero i dodici segni nel loro calendario
solare. L'odierna sfera celeste si è sviluppata solo a
partire dai lavori di Eúdoxos
Knídios (408-355 a.C.) sulle costellazioni. Dei tempi precedenti poco sappiamo: Hómēros cita sei costellazioni e la stella Sirio,
gli stessi asterismi più o meno citati da Hēsíodos nelle
Érga kaì Hēmérai. È probabile che i Greci abbiano assunto lo schema zodiacale dalla Mesopotamia intorno al
vi secolo avanti Cristo, sostituendo
la costellazione del LÚ.ḪU.GÁ,
l'«operaio salariato», con Aries. In seguito i romani reintrodussero la
Libra, già
presente nello schema babilonese, le cui stelle erano però
state inserite dai Greci nell'asterismo di Scorpio, di
cui costituivano le chele.
Il sistema zodiacale in dodici segni, che da Babilonia si era diffuso
tanto in Oriente quanto in Occidente, era
stato stabilito dai sacerdoti caldei non prima dell'viii-vii
secolo avanti Cristo. Il più antico compendio babilonese di
astronomia pervenuto fino a noi, il
APIN
(«Stella aratro») può essere fatto risalire, per talune
concezioni, al 1300 a.C.
Esso elenca sedici segni zodiacali. Ecco la lista delle costellazioni in sumerico e,
tra parentesi quadre, in accadico.
-
LÚ.ḪU.GÁ [Agru] - L'«operaio
salariato». In epoca tarda, l'erronea lettura della parola sumerica
LÚ «uomo» con il suo omofono
LU «ariete», dovrebbe aver portato
alla rappresentazione greca di questo segno come «ariete». Di qui, la tarda interpretazione degli astrologi babilonesi che associarono questa costellazione al dio
Dumuzi, il divino pastore del mito mesopotamico.
→ Aries
-
MUL.MUL [Zappu]
- Le «stelle» [la «criniera»]. → È l'ammasso delle
Pleiades, vicino a Taurus.
-
GU₄.AN.NA [Alû
/ Is lê] - Il
«toro del cielo» [la «mascella del toro»]. → α Tauri
(Aldebaran) e le Hyades.
-
SIPA.ZI.AN.NA
[Šitaddaru/Šidallu] - Il
«pastore fedele di An/Anu». →
Orion.
-
ŠU.GI
[Šību] - Il
«vecchio». → Perseus
-
GÀM o ZUBI
[Gamlu] - La
«scimitarra» o il «ricurvo». → Auriga.
-
MAŠ.TAB.BA.GAL.GAL [Māšu
/ Tūʾāmū rabûtu] - I
«grandi gemelli». Questa costellazione, che nell'astronomia mesopotamica si confrontava con MAŠ.TAB.BA.TUR.TUR
[Tūʾāmū seḫûtu], i «piccoli
gemelli», rappresentava gli dèi
Maslamteaea e
Lugalgirra. → α e β
Geminorum e le stelle a nord e sud di esse.
-
AL.LUL [Alluttu] - Il
«granchio», anche detto il «trono di
An/Anu». →
Cancer
-
UR.GU.LA
[Urgulû] - Il
«leone». → Leo
-
AB.SÍN
[Absinnu/Šerʾu] - Letteralmente, il «solco». Nelle rappresentazioni questo segno viene reso con una donna che tiene in mano una spiga d'orzo (Spica è ancora oggi il nome
della stella α Virginis).
→ Virgo
-
ZI.BA.AN.NA
o GIS.ÉRIN [Zibānītu] - La
«bilancia», più esattamente un tipo di bilancia a due braccia
[zibana]. Per i Greci
era le «chele dello Scorpione», ma i Romani reintrodussero la figura della
«bilancia». → Libra e parte di Virgo
-
GÍR.TAB [Zuqaqīpu] - Lo
«scorpione». In Mesopotamia simbolo di fertilità e
prosperità. → Scorpio
-
PA.BÍL.SAG -
Divinità mesopotamica,
generalmente raffigurata con arco e freccia, forse da
identificare con il dio Ninurta.
→ Sagittarius e forse θ Ophiuchi
-
SUḪUR.MÁŠ(.KU₆) [Suḫurmāššu] - Il
«capro-pesce». → Capricornus
-
GU.LA
[Ṣinundu/Rammanu] - Il «grande», probabilmente da
identificare con il dio Enki/Ea,
signore
dell'abisso acqueo. → Aquarius
-
KUN
o ZIB.ME [Zibbātu] - Le
«code». Rappresentato come un pesce e una rondine le cui
code si toccano. Esso è formato da:
16a. ŠÍM.MAḪ
[Šinūnūtu] - La «rondine». → Le sue ali sono ζ, θ, ε Pegasi e α Equulei; la sua coda
corrisponde alla parte occidentale di Pisces.
16b. A.NU.NI.TU₄
[Anunītu] - Il «pesce» (cfr. la dea
Anunītum). → La parte nordorientale
di Pisces più parte di Andromeda.
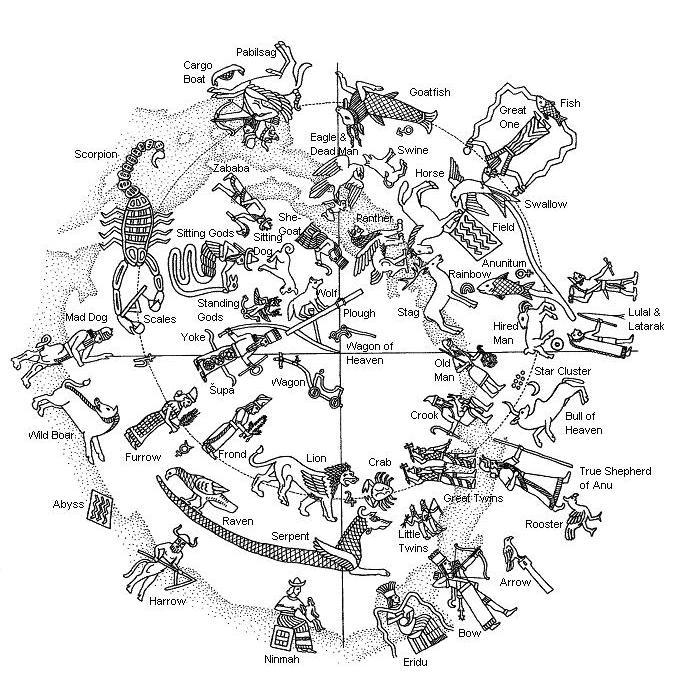 | |
Costellazioni babilonesi | |
Mappa celeste di
epoca babilonese (circa 1000 a.C.). L'eclittica
è rappresentata dal cerchio tratteggiato: la
fascia sfumata corrisponde alla Via Lattea.
Ricostruzione effettuata da Gavin White
(White 2008). |
Le analisi «zodiacali» del mito di
Gilgameš
sono un classico negli studi mitologici, sebbene i risultati
siano piuttosto fragili. Conosciamo
l'iconografia di alcune costellazioni mesopotamiche, grazie
alle immagini scolpite sulle pietre di confine [kudurru],
ma nessun Eratosthénēs
babilonese ci ha mai narrato nel dettaglio i miti legati
agli asterismi che apparivano nei
cieli del Medio Oriente. Detto questo, far coincidere il percorso di Gilgameš
con l'elenco di costellazioni sopra riportate non è impossibile. Anzi, è fin
troppo facile, con un po' di fantasia, indovinare o
inventarsi delle affinità. Il problema è stabilire quanto
siano fondate.
 |
|
Orion e Taurus |
|
Posizioni degli asterismi oggi
conosciuti come Orion e Taurus. Alcuni ritengono che, in
epoca sumerica, essi rappresentassero Gilgameš
alle prese con Gudanna.
Simulazione con il programma Stellarium. |
Si è ipotizzato, ad esempio, che
l'apparizione di Ištâr sulle mura
di Uruk abbia la sua rappresentazione celeste nella
costellazione di AB.SÍN
(il «solco» → Virgo); che LÚ.ḪU.GÁ
(l'«operaio» → Aries) raffiguri
Enkidu; che i due picchi
del monte Māšu
siano catasterizzati in ZI.BA.AN.NA
(→ Libra) o in MAŠ.TAB.BA.GAL.GAL
(i «grandi gemelli» → Gemini). Quest'ultima
lettura, basata sul fatto che māšu in accadico
vuol dire «gemello», non tiene conto che i «grandi
gemelli» rappresentavano gli dèi
Maslamteaea
e
Lugalgirra. Secondo altri,
invece,
la costellazione dei «grandi gemelli» avrebbe raffigurato
Gilgameš ed Enkidu.
Suggestiva l'idea secondo la quale il gruppo formato da SIPA.ZI.AN.NA
(→ Orion) e GU₄.AN.NA
(→
Taurus) avrebbe rappresentato, in epoca sumerica, Gilgameš
alle prese con il toro celeste Gudanna.
Alcune di queste ipotesi sembrano avere qualche grado di
verosimiglianza. Esistono studi – che non citeremo – dove
ogni singolo segno dello zodiaco trova puntuale riferimento
nello Ša naqba īmuru.
Detto questo, ci sono pochi
dubbi che GU₄.AN.NA,
il «toro del cielo», rappresenti Gudanna, il toro celeste ucciso
da Gilgameš ed
Enkidu nella tavola
VI dello Ša naqba īmuru
e nel poema Šul meka šul meka.
Maggiore incertezza sussiste sul fatto che UR.GU.LA,
il «leone», abbia qualche riferimento alla scena in cui
Gilgameš attacca e
disperde dei leoni, nella tavola IX
dello Ša naqba īmuru.
Se l'episodio sembra poco significativo
nell'economia del poema ninivita dipende probabilmente dalle
numerose
lacunae, che ci impediscono una corretta comprensione
del testo, ma il fatto che l'episodio sia presente anche nella
versione ḫittita è forse indicativo di una sua
originaria importanza.
Molto più fragile, a nostro avviso, l'identificazione di GÍR.TAB,
lo «scorpione», con gli aqrab-amēlû incontrati da
Gilgameš sempre nella
tavola IX. Una possibile indicazione a
favore della natura astronomica di questi esseri potrebbe essere inferita dal fatto che
essi erano attestati anche tra le schiere mostruose di
Tiāmat nell'Enūma Elîš.
 |
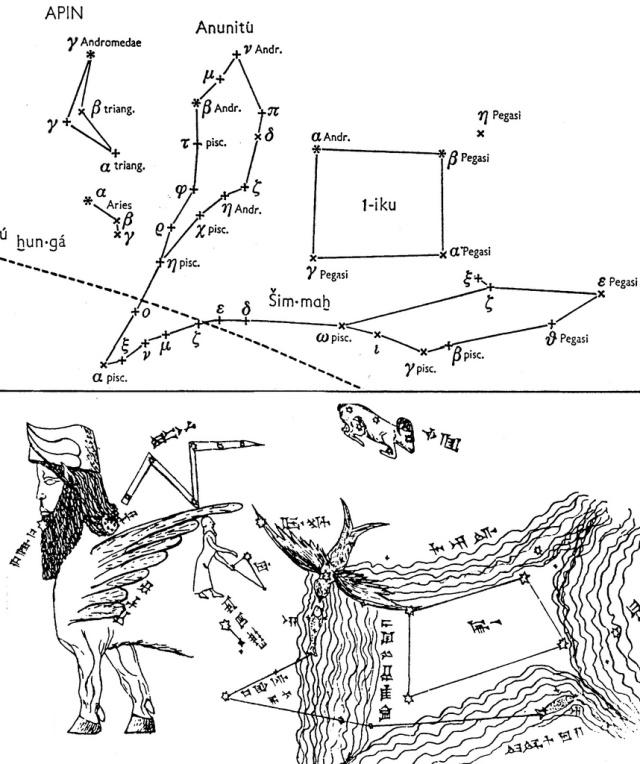 |
|
Il «quadrato» di Pegasus |
|
Rielaborazione di una carta
stellare babilonese (invertita specularmente) e una moderna |
Interessante il complesso degli asterismi che gravitano intorno a GU.LA
(→ Aquarius), di solito
identificato con il dio Enki/Ea.
L'identificazione è avvalorata dalla vicinanza con SUḪUR.MAŠ
(→ Capricornus):
il suḫurmaššu o «capro-pesce» era
infatti un animale mitologico
tradizionalmente
associato a Enki/Ea.
Negli esercizi di comparazione tra lo
zodiaco e lo Ša naqba īmuru,
si è ipotizzato che GU.LA
possa rappresentare il racconto del diluvio nella tavola
XI dell'epopea ninivita: è infatti
Enki/Ea
ad avvertire Ūtnapištî
dell'incombere del cataclisma. In tal caso, la costellazione KUN.MEŠ
(le «code» → Pisces), nella sua curiosa rappresentazione medio-orientale di un pesce e
di una rondine, potrebbe rappresentare tanto l'erompere
delle acque
diluviali, tanto l'episodio in cui Ūtnapištî
fa uscire dall'arca tre uccelli, una colomba, un corvo e una rondine, per vedere se
finiscano col trovare un lembo di terra su cui posarsi.
La
vicina costellazione 1.IKU (il
«campo»), ovvero il «quadrato» di Pegasus, (α,
β, γ Pegasi e α Andromedae), potrebbe
rappresentare la stessa arca di Ūtnapištî,
che in Ša naqba īmuru [XI:
] viene detta essere un cubo dalla base
ampia un ikū (misura di superficie di
3600 o 8100 m², a seconda se si intenda composta da cubiti
lunghi o corti). E qui non si può fare a meno di notare
l'interessante presenza, vicino a 1.IKU,
del piccolo asterismo TIR.AN.NA
(Har-ri-ru, l'«arcobaleno» → 18, 31 e 32 Andromedae?),
con i suoi ovvi collegamenti al racconto biblico del diluvio.
Se tutto ciò ha un senso – e ne
dubitiamo noi per primi –
possiamo avanzare l'ipotesi di un percorso di Gilgameš
attraverso quattro asterismi: Taurus, Leo, Scorpio,
Aquarius. Poiché abbiamo barato, eliminando altre
possibili identificazione e accettando il fragile
Scorpio, non è certo un caso che queste quattro
costellazioni si trovino, lungo l'eclittica, a 90° l'una
dall'altra. Se ci spostiamo al tardo neolitico, intorno al
6000 a.C., che è anche il periodo a ridosso delle prime
urbanizzazioni del Medio Oriente, queste costellazioni
segnavano i punti solstiziali ed equinoziali, e grosso modo
la situazione non cambia molto fino al 3000 a.C.:
-
GU₄.AN.NA
(→
Taurus), equinozio di
primavera;
-
UR.GU.LA (→
Leo), solstizio d'estate;
-
GÍR.TAB
(→ Scorpio), equinozio d'autunno;
-
GU.LA (→ Aquarius), solstizio d'inverno.
Le 71 tra stelle e pianeti elencati nel
APIN
erano
ordinati nei quattro segmenti in cui veniva suddivisa la sfera
celeste. Il segmento superiore riguardava le stelle
circumpolari boreali; gli altri tre erano chiamati «sentieri» ed erano
compresi, approssimativamente, tra il 40° grado nord e il
40° grado sud: il «sentiero di Enlil»
comprendeva il Tropico del Cancro (17° N), il
«sentiero di Anu» l'equatore
celeste, il «sentiero di Ea» il
tropico del Capricorno (17° S). L'eclittica, inclinata di 23°27'
rispetto all'equatore celeste, attraversa tutti e tre i «sentieri». Ciò vuol dire che il
sole, nel suo moto apparente attraverso i segni zodiacali, traccia un percorso che lo porta
a scendere e salire attraverso i «sentieri». (Si tenga
comunque conto che la ripartizione di stelle e asterismi tra i tre «sentieri» effettuata dal APIN,
potrebbe non essere valida per epoche precedenti il Secondo
millennio a.C., a causa del
fenomeno della precessione degli equinozi.)
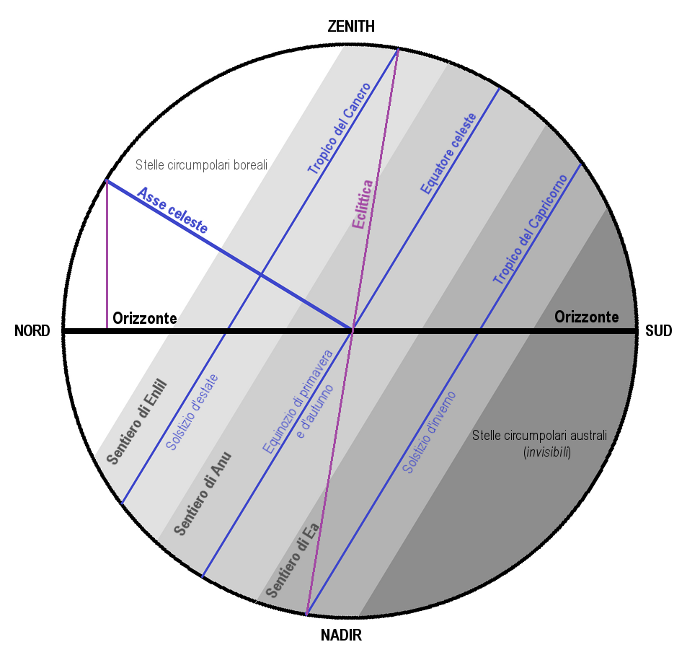 | |
Cosmografia babilonese | |
Sezione della
sfera celeste lungo l'asse nord-sud, calcolata
alla latitudine di Uruk (circa 31° N). I tre
«sentieri», che dividono in tre fasce le stelle circum-equatoriali,
occupano un'ampiezza di circa 40° dall'una e
dall'altra parte dell'equatore celeste. L'intersezione del Tropico del
Cancro, dell'equatore celeste e del Tropico del
Capricorno con la linea dell'orizzonte mostra i punti il sole
sorge rispettivamente
nel solstizio d'estate,
negli equinozi di primavera e d'autunno,
e
nel solstizio d'inverno. Le linee in blu
dei due tropici e dell'equatore celeste rappresentano il percorso diurno del sole nelle
rispettive date solstiziali ed equinoziali.
L'eclittica, in viola, rappresenta invece il
percorso del sole attraverso lo
zodiaco nel corso dell'anno. Si noti che,
mentre le stelle del cielo circumpolare boreale
(in bianco) sono ben conosciute, quelle australi
erano quasi del tutto ignote in epoca antica: la
parte inferiore della sfera celeste (in grigio
scuro), rappresenta forse l'abzu/Apsū,
l'abisso acqueo dimora di
Enki/Ea. |
Il mare/oceano che Gilgameš
e Hērakls
si trovano davanti, e che solo il dio-sole può
attraversare, rappresenta forse il percorso zodiacale del
sole. Quando i due eroi
s'imbarcano per attraversarlo, l'uno sul traghetto
di Uršanabi e l'altro
sulla coppa d'oro di Hḗlios,
stanno per lasciare il piano dell'orizzonte terrestre per
entrare in quello segnato dall'eclittica. I punti di
passaggio dalla terra al cielo, contrassegnati dalle nostre portae mundi, potrebbero essere i segni zodiacali che si
affacciano sul filo dell'orizzonte nel momento della loro
levata eliaca. Alla data del 4000 a.C., Taurus e Scorpio/Libra
sono i «guardiani» delle porte equinoziali, le
cui costellazioni si affacciano a oriente, all'alba
dell'equinozio di primavera o di autunno: ed è necessario affrontarli, o
contrattare con essi, se si vuole varcare le portae, prendere il «treno
zodiacale» e passare dall'oikouméne al kósmos.
Tali considerazioni potrebbero spiegare la lotta di Gilgameš
e Hērakls
con il toro, oppure l'incontro di Gilgameš
con gli aqrab-amēlû dinanzi allo šadû Māšu.
La formula, però, è insoddisfacente: l'eclittica interseca
l'orizzonte a est solo nell'equinozio di primavera e in
quello di autunno. Negli altri giorni dell'anno
l'intersezione si sposta verso il Tropico del Cancro (in
estate) o verso il Tropico del Capricorno (in inverno). Alla
data del 4000 a.C., il sole si trova in Leo nel
solstizio d'estate e in Aquarius nel solstizio
d'inverno. Il
fatto che sia Gilgameš sia Hērakls
affrontino tanto il toro tanto il leone, suggerirebbe un
percorso che è, in qualche modo, già zodiacale.
Inoltre non c'è alcuna ragione perché il passaggio dall'oikouméne al kósmos
avvenga solo nei solstizi o negli equinozi: in ogni giorno
dell'anno c'è
sempre un segno zodiacale che si leva all'alba
insieme al
sole
Ma possiamo sforzarci di essere un po'
più rigorosi. Come si evince anche dal nostro schema, il
percorso annuale del sole lungo l'eclittica, tra il Tropico
del Cancro e il Tropico del Capricorno, lo porta a
percorrere tutti e tre i «sentieri», salendo al di sopra
dell'equatore celeste nel semestre tra l'equinozio di
primavera e quello d'autunno e scendendo sotto l'equatore
celeste nel semestre tra l'equinozio d'autunno e quello di
primavera). Se equipariamo l'equatore celeste alla
superficie di un «oceano cosmico» – proiezione e
continuazione sulla sfera celeste dell'oceano che circonda
del mondo –, questo movimento del sole può essere visto come
un'immersione invernale dell'astro nelle profondità
abissali, seguito da un'emersione estiva. È interessante
notare che la maggior parte delle costellazioni «acquatiche»
(Pisces, Aquarius, Hydra, Argo,
Eridanus, Cetus...) si trovavano, prima del Secondo millennio a.C.,
e la maggior parte si trova ancora, sul lato meridionale
dell'equatore celeste.
L'equatore celeste interseca l'eclittica
in due punti, i quali variano nel corso della precessione
degli equinozi. Tali punti potrebbero fornirci un possibile
criterio di datazione del mito che stiamo trattando in queste pagine.
Sfortunatamente non possiamo far altro che ruotare il cielo
fino a trovare una data ad hoc al fine di sostenere
il nostro modello. Il procedimento è di scarso valore
scientifico: lo proponiamo soltanto come esperimento e scegliamo – arbitrariamente – la data del 3000 a.C. Sul
finire del Quarto millennio, infatti, l'equatore celeste e
l'eclittica si intersecano in
Taurus e Scorpio, in concomitanza
con le porte equinoziali.
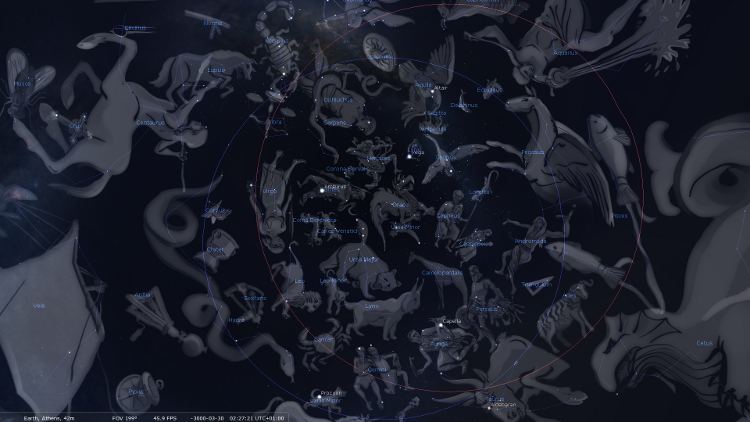 | |
Intersezione tra equatore celeste ed eclittica | |
La data prescelta
è il 3000 a.C. Equatore celeste (il cerchio
azzurro) ed eclittica (il cerchio rosso) si
intersecano in Scorpio e Taurus,
che in questa data segnano, grosso modo,
anche la posizione del sole nell'equinozio
d'autunno e di primavera. Il solstizio d'estate
è in Leo e quello d'inverno in
Aquarius. Il polo celeste, in questa data, è
in Draco. Si noti che l'equatore celeste
passa attraverso le costellazioni di Hydra
e di Aquila. |
E qui non dobbiamo dimenticare
il «viaggio verticale» compiuto da
Gilgameš nel fondo dell'Apsū
alla ricerca della šammu nikitti, la «pianta
dell'irrequietezza». Questo tratto del viaggio potrebbe
essere messo in correlazione con l'asterismo GU.LA
(il «grande» → Aquarius). Identificato
con il dio Enki/Ea,
GU.LA segnava,
nell'epoca indicata, il solstizio d'inverno, rappresentando
il punto più basso del percorso del sole al di sotto
dell'equatore celeste. Nel nostro schema
[vedi]✦ è il
punto dove l'eclittica tocca il Tropico del Capricorno, nel
lato inferiore del «sentiero di Ea».
A sud di esso vi sono solo le ignote stelle dell'emisfero
australe: l'Apsū.
GU.LA
sembra dunque essere un passaggio obbligato per giungere
nell'abisso di acqua dolce che si stende nel lato inferiore
del kósmos. Sembrerebbe di capire – se sia
valido un ragionamento metanarrativo – che il racconto del diluvio fatto da Ūtnapištî
a Gilgameš, rappresentando
l'arrivo in GU.LA, sia propedeutico alla discesa dell'eroe
nell'Apsū.
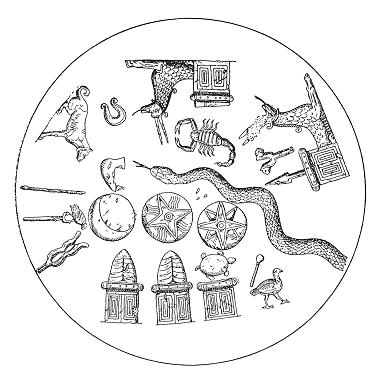 |
|
Raffigurazione astronomica (±
1100 a.C.) |
|
Raffigurazione astronomica da
un kudurru babilonese. È riconoscibile mul dMUS, il «serpente»,
attorniato dai simboli astrali di
Šamaš,
Sīn,
Ištâr, Anu,
Enlil ed
Ea, da GÍR.TAB (→ Scorpio) e dal mušḫuššu (il drago di
Marduk).(Pettinato
1998) |
|
|
 |
|
Raffigurazione astronomica |
|
Raffigurazione astronomica da
una pietra cilindrica proveniente da Susa. Al centro è MUS, il «serpente», circondato dai simboli di
Šamaš,
Sīn,
Ištâr,
Anu,
Enlil, Ea,
Ninḫursaĝ e
Marduk. Si riconoscono il
mušḫuššu e il suḫurmaššu o
«capro-pesce», animali mitologici legati a
Marduk ed a
Ea.
(Pettinato 1998) |
D'altra parte, come abbiamo visto, il
«viaggio verticale» sembra legato a due teriomorfi non
presenti dello zodiaco tradizionale: l'aquila e il serpente.
Nella mitologia della Mesopotamia, l'aquila
trasporta Etana
verso il cielo, mentre il serpente ruba la šammu nikitti
a Gilgameš al suo ritorno dall'Apsū.
Se il nostro ragionamento ha senso, dovremmo
aspettarci di trovare degli asterismi che ricordano
un'aquila e un serpente ai due estremi dell'asse terrestre.
Così non è. La costellazione TI₈
(l'«aquila» →
Aquila) si trovava in realtà lungo l'equatore celeste,
nel «sentiero di Anu».
Alla latitudine della Mesopotamia, la si poteva vedere, in
certe stagioni, alzarsi dall'orizzonte e arrivare fin quasi allo zenith,
suggerendo forse il volo del maestoso rapace. Ma detto
questo, TI₈
è inadatta a rappresentare un punto «polare»
boreale.
L'altro teriomorfo possiamo
probabilmente identificarlo nella costellazione
MUS (il «serpente» → Hydra). Di frequente rappresentato ai piedi di UR.GU.LA (→
Leo), MUS era
anch'essa una
costellazione del «sentiero di
Anu», posta sull'equatore
celeste. Se questo rappresenta in cielo la superficie
dell'oceano cosmico, nel 3000
a.C. MUS
sembrava «nuotare» sulla superficie dell'acqua,
il che spiega anche il nome classico della costellazione, Hydra, il
«serpente acquatico». L'ampiezza di questo asterismo è
sorprendente: oggi occupa 100° in larghezza, quasi un terzo
della circonferenza del cielo, e in epoca mesopotamica, a
giudicare dall'iconografia, non era meno ampia. MUS
è una delle costellazioni più frequentemente rappresentate
nei kudurru e nell'iconografia. Molto
spesso il serpente è raffigurato in lunghezza, secondo la
naturale immagine dell'asterismo, e a volte è sovrastato
dall'immagine di UR.GU.LA,
il «leone», che gli «cammina» sul dorso. La cosa curiosa, è
che in altri casi MUS,
posto in posizione centrale, viene raffigurato attorcigliato
a spirale: il suo significato perimetrico
non è incompatibile con una sua percezione quale elemento
polare.
Non paghi di
aver scoperto le origini astronomiche di
ʿpop,
Vṛtra e
Jǫrmungandr, tutte immagini di serpenti cosmici
che trattengono le acque oceaniche intorno
all'orizzonte, dobbiamo però notare che, diversi gradi
a sud di MUS, si trova Canopo (α
Carinae), la seconda stella più luminosa del cielo dopo Sirio. Trovandosi
tanto a sud, Canopo non può essere mai osservata dalle
latitudini più settentrionali di 37° nord: questo ne faceva,
nell'antichità, la stella meridionale per eccellenza. In Mesopotamia faceva parte di un asterismo chiamato NUN,
«Eridu». Non è un caso che la città più
meridionale della terra di Sumer, situata alla confluenza
dei fiumi Tigri ed Eufrate nel golfo Persico, e
naturalmente sacra al dio Enki/Ea,
avesse lo stesso nome della costellazione più meridionale
del cielo, posta sul «sentiero di Ea». Se dunque il percorso
di Gilgameš tra le
costellazioni ha un senso, è a NUN/Canopo
che dovremo trovare il Pû Nārāti, la
«confluenza dei fiumi». Ed è solo da qui che l'eroe può
essersi tuffato nell'Apsū,
tra le invisibili stelle circumpolari australi, per cogliere
la šammu nikitti. Può darsi che sia stato appunto
sulla strada del ritorno, verso l'equatore celeste, che
MUS gli abbia divorato la pianta.
 | |
Hydra e Canopo | |
L'immagine
rappresenta Hydra, il «serpente d'acqua»
posto sull'equatore celeste, sotto il quale si
trova Canopo (α Carinae),
la stella più meridionale conosciuta agli
antichi. Sebbene l'astronomia greca assegni
Canopo al complesso asterismo della nave
Árgos (oggi divisa in tre costellazioni
distinte: Vela, Puppis e Carina), in
Mesopotamia questa stella era associata ad Eridu,
la città sacra al dio Enki/Ea,
posta alla confluenza dei fiumi Tigri ed Eufrate
nel golfo Persico. Un'altra via «fluviale» verso
le stelle dell'emisfero sud è visibile sulla
destra: la costellazione dell'Eridanus si
stacca dal piede di Orion per calare
verso il polo meridionale. |
Nel 3000 a.C. l'equatore celeste passava
attraverso quattro costellazioni:
-
GU₄.AN.NA
(→
Taurus)
-
MUS
(→ Hydra)
-
GÍR.TAB
(→ Scorpio)
-
TI₈
(→ Aquila)
Questa composizione di quattro
costellazioni è piuttosto interessante, innanzitutto perché
ci pone ancora una volta di fronte al binomio di Aquila e Hydra,
cioè aquila e serpente
[equatore celeste]✦. I due animali che il mito greco
situa a oriente e a occidente, rispettivamente presso Promētheús
e presso Átlas, sembrano
legati all'equatore celeste. Se l'idea originaria è
che i due titánes, identificati con le rispettive
montagne (l'óros Kaukásios e l'óros Átlas),
sostenessero in qualche modo la volta celeste, il punto
ideale per reggere la grande macchina del cielo non è
l'eclittica, col suo moto obliquo, ma appunto l'equatore
celeste.
Ma allora che dire del viaggio di Hērakls
verso il giardino delle Hesperídes?
Il kpos, secondo Apollódōros, si trovava a settentrione,
dove
Átlas sorreggeva il cielo. L'axis
mundi è rappresentato nel nostro schema
[vedi]✦ dalla linea viola che, dal
polo celeste, cade perpendicolarmente al suolo, e si può
notare come tale linea segni, in pratica, l'estremo nord del disco
terrestre. È
quello il perno del cielo, il punto ideale dove collocare
tanto lo
šadû Māšu quanto
Átlas (e forse anche
Himinbjǫrg). Se è da questo punto che
il cingulus mundi
si
estende verso est e verso ovest, viene a sparire la
contraddizione che identifica la montagna centrale e quella
perimetrale.
Tuttavia rimane il
sospetto che, in una versione antica del mito,
anche il viaggio di Hērakls
sia stato verticale, diretto cioè verso l'abisso inferiore. Come
abbiamo già notato, il percorso che l'eroe effettua sul
fiume Ōkeanós, a bordo
dell'aurea coppa di Hḗlios,
si muoverebbe, secondo Apollódōros, in senso
antiorario, cioè in direzione opposta alla normale rotta del
sole. Imbarcatosi sul lato orientale del mondo, Hērakls
avrebbe dovuto spostarsi verso sud, non verso nord. Se la
nostra ricostruzione è valida, Ládōn, il drákōn hespérios,
non può essere la costellazione di Draco, nel
cielo boreale, ma Hydra, il guardiano dell'equatore
celeste. A questo punto potrebbe essere ragionevole
sostenere che il mito della
lotta di Hērakls
contro l'hýdra di Lérnē sia un rimasuglio dello
scontro dell'eroe contro il drákōn hespérios,
qui visto nella sua antica immagine indoeuropea di serpente
cosmico che trattiene le acque oceaniche, in parte
identificandosi con esse. Lo «spostamento» delle catasterizzazioni da Hydra a Draco, con tutta
la rilettura degli asterismi circostanti, potrebbe essere
avvenuta in un'epoca posteriore: l'identificazione di Hērakls
con la costellazione conosciuta oggi come Hercules è
infatti tarda e oggetto di ampi dissensi da parte degli
stessi astronomi greci (Santoni 2009).
①▼
L'episodio dove Hērakls
giunge al fiume Ēridanós per farsi rivelare da Nēreús
la strada da seguire per arrivare al Kpos Hesperídōn,
potrebbe essersi svolto anch'essa tra le stelle: la costellazione
che oggi porta il nome di Eridanus (secondo
la lettura di Áratos; Erathosténēs proponeva di
identificarla infatti con il Nilo) si stacca dal piede di
Orion e scende verso l'emisfero sud. La sua ultima e
più luminosa stella, α Eridani, ovvero Achernar
(dall'arabo āḫir an-nahr, la «fine del fiume») è
a
pochi gradi di distanza da Canopo. Non ci stupiremmo se il
Kpos Hesperídōn
sia da quelle parti.
Al lettore non sarà neppure sfuggito che abbiamo forse trovato una
spiegazione dei nostri teriomorfi. Toro,
leone, scorpione e acquario contrassegnano l'eclittica;
aquila e serpente l'equatore celeste. Leone e serpente
potrebbero forse essere considerati intercambiabili, vista
la loro stretta associazione
②▼. Se il nostro
ragionamento è valido, potremmo aver trovato uno schema
comune che si può applicare ai kǝrûḇîm
e ai sigilli antico-babilonesi, che offre una possibile
spiegazione al mito di Promētheús
e di Átlas, e anche di alcuni
episodi dell'epopea di Gilgameš, delle fatiche di Hērakls
e di un paio di imprese di Þórr.
Le analogie astronomiche
qui proposte, e lo
ammettiamo noi per primi, non sono molto rigorose e, dove lo
sembrano, è solo perché abbiamo applicato un effetto
selezione scegliendo ad hoc le epoche precessionali e
le costellazioni più indicate ai nostri scopi. Un metodo
scientificamente poco valido. L'ipotesi, o per meglio dire
la «sensazione», che vi sia un'ideologia
astronomica dietro il mito di Gilgameš
ed Hērakls alla
ricerca della vita, è probabilmente corretta, ma in
tal caso affonda in un'antichità talmente remota che
difficilmente possiamo trovare corrispondenze puntuali e
precise con gli asterismi a noi noti. Le
più antiche costellazioni a cui possiamo giungere sono
quelle di epoca ellenica e babilonese: difficilmente
possiamo risalire in epoche anteriori al 1200 a.C., sebbene
sia probabile che
alcuni asterismi possano essere incredibilmente più
antichi. Ma quanto? Difficile dirlo: vi sono
costellazioni che sembrano diffuse presso civiltà molto lontane tra loro. Il dinomio aquila ~ serpente
caratterizza il concetto di albero cosmico tanto nel mito
sumerico (l'albero ḫuluppu difeso da Gilgameš
nel poema
Ud rea ud sudra rea), quanto in
Īrān, in Siberia, in Scandinavia (il frassino
cosmico Yggdrasill, con il
serpente Níðhǫggr che ne rode
le radici e un'aquila senza nome appollaiata tra i rami), e addirittura in America
Centrale (gli Aztechi, nel corso della loro migrazione,
seppero di essere arrivati al centro del mondo quando videro
un un'aquila che si era posata su un cactus con un serpente
tra gli artigli: lì fu fondata Tenōchtitlan). Se l'esito americano non è una fortunata
coincidenza, possiamo star certi di trovarci di fronte ad
asterismi, o almeno a simbolismi, che affondano le loro
radici nella preistoria dell'uomo.
③▼
Studi più dettagliati hanno avanzato proposte
assai più complesse e complete della nostra, e rimandiamo all'affascinante
Hamlet's Mill di Giorgio De
Santillana ed Hertha Von Dechend: un lavoro epocale, che non ha mai
smesso di stimolare l'immaginazione di tutti gli appassionati di
mitologia quanto di astronomia (De Santillana
~ Von Dechend 1969).
La cosa migliore, per quanto ci riguarda, è
sospendere il giudizio. Abbiamo raggiunto i nostri limiti di
competenza. Nei capitoli successivi,
analizzeremo altri esiti del mito della ricerca dell'immortalità,
pescati dalla Cina all'Irlanda, per cercare di capire,
nebulosamente, quanto indietro
nel tempo sia necessario spingerci per trovare i bandoli di questa
millenaria matassa.
|
②▲ Si potrebbe
anche proporre uno scambio tra scorpione e
serpente basandosi sull'interessante
costellazione di Ophiuchus, il
«serpentario». Sebbene non sia contemplata tra i
segni dello zodiaco, questo asterismo – la cui
immagine tradizionale è un uomo alle prese con
un serpente – si trova lungo l'eclittica,
accanto a Scorpio. Il mito alla base di
questa costellazione, a cui Erathosténēs accenna
soltanto (Katasterismoí
[6]), è sviluppato da Hyginus: mentre
cerca di riportare in vita
Glaûkos, figlio di
Mínōs, affogato in un otre pieno di
miele, Asklēpiós
vede un serpente resuscitarne un altro con una
speciale erba, e usa quella stessa erba per
resuscitare Glaûkos
(De Astronomia [II:
14, ]). Così il serpente diviene simbolo
di Asklēpiós e viene catasterizzato in cielo insieme a lui. È
indubbio che tale mito sia immerso nel campo che
stiamo indagando, ed è forte la tentazione di
vedere nel serpente di Ophiuchus il
rettile che divora l'erba di Gilgameš
e questa costellazione una delle tappe zodiacali
del percorso dell'eroe. Tuttavia, non sembra che
un simile asterismo fosse attestato in
Mesopotamia. Nell'area di Ophiuchus
compaiono costellazioni piuttosto diverse, quali
ZA-BA₄-BA₄ («Zababa», dio di Kiš) e
DINGIR.TUS.A («l'uomo seduto»). |
| |
|
①▲ La bella costellazione
oggi dedicata a Hercules è stata oggetto,
presso gli autori classici, di tante
identificazioni diverse:
Thēseús, Thámyris,
Orpheús,
Ixíōn,
Promētheús,
Átlas,
Tántalos
(Santoni 2009).
Áratos definisce la costellazione Toû en
gónasin, «l'inginocchiato»: si limita a
riconoscere la figura di un uomo accasciato, in
preda a uno sforzo, con le braccia alzate e un
piede sulla costelazione di Ópheōs (→
Draco) e afferma che nessuno sa dire con
certezza chi sia questo personaggio
(Phainómena
[63-66]). È Erathosténēs a identificare
questa costellazione con
Hērakls (Katasterismoí
[4]), suscitando tuttavia i dubbi di
Hyginus (De Astronomia
[II: 6]), il quale ci ricorda che
Aiskhylos, nel perduto
Promētheùs Lyómenos, sosteneva che si
trattasse di Hērakls
nell'atto di combattere contro i Lígues
(phr. Radt [199]).
L'identificazione della costellazione con
Hērakls in lotta
contro il drákōn hespérios, attorcigliato
attorno all'albero dai frutti d'oro, si trova
solo nei tardi manoscritti dei
Phainómena
di Áratos. |
| | |
|
③▲ Una possibilità
molto interessante consiste nel considerare
la stessa Via Lattea come il fiume
dell'acqua della vita. Nel mito greco, la
traccia della Galaxías, come
sappiamo, si era formata grazie al latte di
Hḗra che era
schizzato tra le stelle: e pare che Hērakls
fosse divenuto immortale quando venne
allattato dalla dea. Se questa
interpretazione ha un senso, la sorgente
della māʾ al-ḥayāt,
l'«acqua della vita», che
al-Iskandar
cerca di raggiungere, potrebbe trovarsi agli
incroci della Via Lattea con l'eclittica e/o
l'equatore celeste: da un lato troviamo
Gemini, Orion e Taurus;
all'altro capo troviamo Scorpio (Ophiuchus)
e, a poca distanza, Aquila. Al
riguardo, il lettore curioso troverà molti
studi interessanti e affascinanti. |
|
|
| IN CINA ALLA RICERCA DELL'IMMORTALITÀ I motivi che abbiamo or ora descritto,
il mito di un luogo posto sito ai confini del kósmos, dove sia custodito il segreto dell'immortalità, il viaggio di un eroe fino a quel luogo misterioso dove confluiscono tutte le acque, alla ricerca della
vita eterna, sembrano motivi di un mito antichissimo che sembra essersi irradiato,
da qualche antichità portentosa, affiorando in Mesopotamia,
quindi in Grecia. E da qui, attraverso il mondo antico, riaffiorando
nei racconto islāmici su al-Iskandar/Eskandar.
Che questo mito abbia avuto la sua prima formulazione in Mesopotamia, è una teoria limitata dal nostro non poter risalire ancora più indietro. Quasi nulla è pervenuto a noi del tempo in cui la scrittura non permetteva di tramandare il pensiero. Eppure nelle migliaia di anni che precedettero
i Sumeri e gli Egiziani, vi furono popoli che
raccontarono i loro sogni, che innalzarono mondi concettuali
e trasmisero la loro tradizione alle generazioni successive. Il fatto
di ritrovare un esito del medesimo mito in Cina, ovviamente
espresso in maniera peculiare allo spirito e al genio dell'oriente, non ci autorizza a pensare che tali miti giunsero
fin laggiù dalla dalla Mesopotamia, forse per il tramite dell'India proto-dravidica, perché forse le origini di questi pensieri, di questi concetti, vanno
probabilmente cercati in popolazioni ancora più antiche, in quelle migrazioni preistoriche da oriente a occidente che solo oggi genetisti e antropologi cominciano nebulosamente a definire. Nulla di cui stupirsi, dunque, se
anche la Cina venne percorsa dalla febbre dell'immortalità. Il taoismo, il movimento filosofico-religioso di cui
Lǎozǐ fu il tradizionale iniziatore, cercò per secoli una formula per l'immortalità attraverso la ricerca dell'armonia primordiale tra uomo e cosmo. L'indecifrabile parola
dào, attorno a cui roteava questo sistema di simboli, era la «via» del raggiungimento di tale armonia, che in termini mitici potrebbe essere configurata come un ritorno allo stadio iniziale di edenica perfezione.
Xiān era il nome generico indicante quei saggi taoisti che erano riusciti a raggiungere l'immortalità tramite il continuo perfezionamento
e la ricerca di un'armonia tra
yīn e yáng, ma anche, col lento trasformarsi del taoismo, tramite pratiche ascetiche, magiche, alchimistiche. Gli
xiān rientravano, insieme a spiriti, geni e dèi
(tutti raccolti nella vaga espressione shén), tra le numerosissime divinità che il
pántheon taoista accoglieva dalle tradizioni più disparate. Erano considerati liberi dalle molteplici costrizioni del nostro mondo: i loro corpi si libravano nello spazio, viaggiavano su draghi e gru, volavano con ali o su nuvole portatili.
Le montagne dei
xiān
 |
|
Pénglái
shān |
|
Yuán Jiāng (attivo tra il 1680 e
il 1730), dipinto.
Gùgōng Bówùyùan, Běijīng (Cina) |
Degli
xiān si diceva – e non ci stupisce – vivessero su alcune remote isole,
o
shān, «montagne», nel Dōnghǎi, il mare orientale.
Queste isole/montagne erano l'ultima propaggine del kósmos:
oltre di esse si spalancava il
Dáhè, «grande varco»
(Shānhǎi Jīng [VIX: 1]),
anche detto Guīxū, «abisso senza ritorno»
(Lièzǐ [V:
3-4]), una versione estremo-orientale dell'Apsū,
definita come il luogo dove tutte le acque terrestri
confluivano nella Via Lattea. Queste isole/montagne si
chiamavano Dàiyǘ,
Yüánjiào, Fānghú,
Yíngzhōu e Pénglái
shān, ed erano abitate da una razza di saggi
immortali, troppi numerosi per essere contati. Essi vivevano
laggiù in palazzi d'oro sostenuti da colonne di giada, e
avevano a disposizione elixires vitae che impedivano la morte, e
alberi dai frutti di giada o di perla che conferivano
l'immortalità a chiunque li assaggiasse. «Laggiù vivono
shénrén [«semidèi»] dalle carni fresche come il ghiaccio
e la pelle bianca come la neve. Hanno l'eleganza squisita
delle vergini. Non consumano cereali, ma respirano vento e
bevono rugiada. Si fanno trasportare dall'aria e dalle nubi,
trascinare da lóng [«draghi»] volanti, e volano al di
là dei quattro mari...» (Zhuāngzǐ
[I]). Così li descrive, ammirato e invidioso, il
filosofo taoista Zhuāng Zhōu
(369-286 a.C.), e rincara, echeggiando il
Bhagavadgītā, «Un
diluvio che si alzasse fino ai cieli non li annegherebbe, né
li brucerebbe una siccità che liquefacesse metalli e pietre,
e arrostisse pianure e montagne» (Zhuāngzǐ
[I]). (Granet 1934)
Le cinque isole/montagne, tuttavia, non si trovavano mai
nello stesso posto: non essendo fissate al fondo del
mare, se ne andavano alla deriva nel Dōnghǎi, trascinate
dalle maree e sospinte dalle correnti. Si dice che, stanchi di quell'esistenza vagabonda, gli
xiān si recarono dal dio supremo, il «dominatore
dall'alto» Shàngdì, e gli chiesero di
intervenire. Questi ordinò a uno shén di nome Yü Jiang di cercare quindici tartarughe giganti in modo che a turno sostenessero sulle loro teste le cinque
montagne. Se non
che, un jùrén, un gigante, pescando, lanciò la lenza lontano, oltre la curva dove il cielo incontra il mare, agganciò sei di queste tartarughe, e, dopo averle rovesciate, le trascinò a riva con l'idea
di farsi una scorpacciata. Così le isole Dàiyǘ e
Yüánjiào shān andarono distrutte. Quando gli
xiān, sconvolti dal cataclisma, si rivolsero a Shàngdì, questi
rimpicciolì tutti i jùrén perché non combinassero più disastri; in quanto alle isole
superstiti, Pénglái, Fānghú e
Yíngzhōu shān, esse rimasero da quel giorno sempre
fissate al loro posto sul dorso delle tartarughe.
(Lièzǐ)
Giungere nelle isole/montagne degli
xiān non era facile, e
non solo a causa della loro distanza nel grande oceano, ma
anche perché venti contrari spingevano lontano le navi degli
uomini. Ciò nonostante, le cronache cinesi registrano molte
spedizioni organizzate da vari sovrani e imperatori nel
tentativo di raggiungere queste terre, allo scopo di ottenere
l'elixir vitae, in tal modo
perpetuando, a migliaia di anni e di chilometri di distanza,
l'archetipo di Gilgameš.
Il grande storico Sīmǎ Qiān (145/135-86 a.C.) riferisce:
«Ai tempi di Qí Wēi wáng (♔ 356-320 a.C.), Qí
Xuān wáng (♔ 319-301 a.C.) e Yān Zhào wáng
(♔ 311-279 a.C.), furono inviate spedizioni alle tre divine
isole di Pénglái, Fānghú e
Yíngzhōu. Si diceva si
trovassero nel golfo di Bóhǎi, non molto lontano oltre i
limiti abitati dall'uomo. Sfortunatamente nessuno riuscì ad
arrivarci: si alzarono venti contrari e spinsero indietro le
navi» (Shǐjì). Tali
difficoltà non scoraggiarono di certo Qín
Shǐ huángdì (♔ 220-210 a.C.), il megalomane
autocrate unificatore del Zhōngguó, il quale, dopo essere
divenuto signore di tutto lo spazio, ambiva – in una sorta
di hýbris iskandariana – a divenire anche padrone del
tempo. Ossessionato dal desiderio di raggiungere
l'immortalità, nel 219 a.C. il huángdì mandò il suo
cortigiano Xú Fú a Pénglái
shān, insieme a tremila fanciulli, maschi e femmine, per
farsi consegnare l'elixir vitae dal mitico
xiān Ānqī Shēng. Xú Fú
navigò per anni nel Dōnghǎi e, al suo ritorno, raccontò a Qín
Shǐ huángdì che un enorme mostro marino gli
aveva bloccato la via per la montagna dei beati. Il huángdì
gli affidò un gruppo di arcieri per abbattere il mostro. Xú
Fú partì di nuovo con la sua flotta e non fece più ritorno
(Shǐjì). Secondo Sīmǎ Qiān, Xú Fú
sarebbe sbarcato in una terra tranquilla e fertile, di
«basse pianure e ampie paludi», dove si sarebbe stabilito
come sovrano, e successivi storici questionano se non fosse
arrivato in Giappone, scambiando il Fujiyama per il
leggendario monte Pénglái.
Il Kūnlún
shān e il paradiso d'occidente
Ma i miti sinici conoscevano un altro giardino d'immortalità, il quale veniva posto sull'inaccessibile vetta
del Kūnlún, in quello che
nella geografia tradizionale cinese – che ha il suo canone
nello Shānhǎi Jīng,
il «Classico dei monti e dei mari» (IV-II
sec. a.C.) – era l'estremo lembo occidentale della terra.
Sebbene vagamente identificabile con l'omonima catena del
Turkestān cinese, il Kūnlún
shān della cosmografia cinese, presenta tratti che ci permettono di
ricondurlo al mitema, a noi ben conosciuto, dell'axis
mundi. L'erudito Guō Pú (276-324), nel suo commentario
allo Shānhǎi Jīng,
afferma che il Kūnlún
si trovasse a ridosso del polo occidentale e lo
definisce l'asse centrale tra la terra e il cielo. Anche
Sīmǎ Qiān ne dà una descrizione che non lascia adito a
dubbi: «Il Kūnlún è alto più di
2500 lǐ ed è il luogo in cui il sole e la luna, in
modo alternato, si occultano e risplendono»
(Shǐjì). Il mitografo
taoista Wáng Jiā († 390) aggiunge: «Il
Kūnlún è nel territorio di Kūnlíng e svetta al di
sopra del sole e della luna. Ha nove ripiani,
ognuno dei quali dista 10.000 lǐ dal precedente»
(Shíyíjì). Se i nove ripiani [jiǔcéng]
rappresentano i nove cieli (i pianeti, il sole, la
luna e le stelle fisse), siamo ancora
una volta in un ambito cosmografico. Uno shén chiamato Lù Wú, con
corpo di tigre, volto umano e nove code, controlla le nove
suddivisioni del Kūnlún e,
da quel privilegiato osservatorio del corso degli astri, regola l'avvicendarsi delle
stagioni (Shānhǎi Jīng [II:
17]).
Non hanno torto gli studiosi a confrontare il mitema del
Kūnlún con l'immagine indiana del monte Meru:
ma dobbiamo uscire dal tristo preconcetto che basti
ricondurre un elemento alla tradizione indù (o greca) per
risolverlo in via definitiva. Quale montagna centrale che
funge da perno per la rotazione del cielo, il
Kūnlún rassomiglia
altrettanto allo šadû Māšu
dell'epopea di Gilgameš,
«che giornalmente guarda il s[sorgere del sole e il tramontare del sole]»
(Ša naqba īmuru [IX: ]),
ma è pure affine al Tērag-ī-Harborz,
in quanto funge da axis mundi occultando
e rivelando il sole e la luna. In quanto alla
sua posizione geografica, il Kūnlún
shān presenta la strana dicotomia interpretativa che
avevamo trovato, in Grecia, per l'óros
Átlas: una localizzazione
definita in relazione al tramonto del sole, e quindi
occidentale, ma anche assiale. In Grecia le due
interpretazioni erano alternative; in Cina
coesistono invece in un'unica raffigurazione. Con
soluzione salomonica, lo Shānhǎi Jīng
[XI: 2] colloca il Kūnlún
shān a nordovest. In questa strana
localizzazione vi è pure una ragione mitologica: il
kósmos cinese, originariamente fissato agli otto angoli,
era stato infatti danneggiato dal mostro
Gònggōng, il
quale, in un impeto di rabbia, si era scagliato contro il
Bùzhōu shān, il pilastro
che sorreggeva il cielo a nord-ovest, non lontano dallo
stesso Kūnlún
(Chǔcí > Tiānwèn).
Quando il monte era crollato, il cielo si era inclinato verso
nord-ovest, e la terra, piegatasi in direzione sud-est, aveva causato
una catastrofica esondazione di tutte le acque continentali.
Lo Shānhǎi Jīng
annovera il Kūnlún shān tra i paesi occidentali «all'interno del
mare» [hǎinèi], cioè entro il disco della terra
abitata, e
fornisce molti dettagli pittoreschi su questa montagna e sui suoi abitanti. Il monte copre ottocento lǐ
quadrati e ha un'altezza di diecimila rén. Ha
otto lati e angoli, erti tra inaccessibili strapiombi, e
sulle sue pendici abitano cento shén. Vi si accede da nove porte,
sorvegliate da Kāimíng, un
guardiano con l'aspetto di un'enorme tigre, con nove teste umane,
sempre rivolte a est. Una serie di fiumi sgorga dagli angoli
del monte, circondandolo con le loro correnti
impenetrabili: il Chì, il
Hé, lo
Yáng, lo
Héi, il
Qīng e il
Ruò. Questi formano a sud del Kūnlún un gorgo profondo
trecento rén. (Shānhǎi Jīng
[XI: 4]). Sia lo Shānhǎi Jīng
sia altri testi forniscono sfavillanti descrizioni della
flora che cresce nei frutteti del Kūnlún shān,
ma è una botanica di cui ormai siamo esperti:
- il Zhū shù,
albero che,
come dice il nome, è carico di perle,
- lo Yǜ shù, il
Wényǜ shù e lo
Yěqí shù, i cui
frutti sono fatti di vari tipi di giada [yǜ];
- il Bì shù, di
giada azzurra;
- il Bōgān shù, di
cristallo di rocca (?);
- il Xuan shù,
i cui pomi brillano di pietre semipreziose;
- e il Bùsǐ shù, «l'albero del non morire».
Vi sono poi il chángshēngshù, l'«albero dell'immortalità» (o «della
longevità», omofono indicato con diverso
ideogramma), ma anche il misterioso shèngmù,
traducibile con «albero della santità» o «della conoscenza»
(Shānhǎi
Jīng [XI: 4] |
Lièzǐ
[V: 4] | Huáinánzǐ [IV: 3] | Wénxuǎn Zhǔ [XV:
14]) (Fracasso 1996).
Ciò che inaspettatamente ritroviamo, dunque, nelle estreme
propaggini nord-occidentali della Cina, è il monte delle erbe di
Yamlīḫā, la regina dei
serpenti della fiaba di Bulūqiyā.
Ma i modi per pervenire all'ambita condizione di xiān,
nella tradizione cinese, si moltiplicano e si riflettono tra
loro in un vertiginoso gioco di specchi:
| |
A ovest del [Kūnlún] crescono
gli [alberi] Zhū shù,
Yǜ shù,
Xuan shù e
Bùsǐ shù. A est crescono lo
Shātáng shù e il
Bōgān shù. A sud vi è il
Jiang shù. A nord vi sono il
Bì shù e lo
Yáo shù
[...]. Là scorre il [fiume] Dān
hé, e se uno beve le sue acque diviene immortale. Se uno
raggiunge il Liángfēng [«vento
freddo»], il primo livello del Kūnlún,
diviene immortale. Se uno arriva al Xuánpǔ
[«giardino pensile»], il secondo livello del Kūnlún,
diviene uno shén che controlla il vento e la pioggia. Se
uno raggiunge il terzo livello, sulla cima del Kūnlún,
ha raggiunto il cielo. | |
Liú Ān:
Huáinánzǐ [IV: 3] |
Pare che il
Kūnlún shān fosse inizialmente
considerato la residenza celeste di
Huángdì, il «dominatore giallo». Si narra che Zhōu Mù wáng (♔ 976-922
a.C. o 956-918 a.C.), quinto re della dinastia Zhōu, arrivò sul
Kūnlún per vedere il
palazzo del mitico sovrano:
| |
Il giorno dopo [Mù wáng e il suo seguito] salirono sulla
sommità del
Kūnlún per vedere il
palazzo di
Huángdì e vi costruirono un tumulo per memoria delle
future generazioni. Poi il re fu ospite di
Xīwángmǔ, la «regina
madre dell'occidente», che gli offrì un banchetto sulla riva
dello Yǜ Hú, il «lago di giada». La
regina cantò per lui e il re rispose al canto, ma le sue parole
furono tristi, mentre il suo sguardo era rivolto a occidente,
dove il sole tramonta dopo aver camminato ogni giorno per
diecimila lǐ... | |
Liè Yǔkòu: Lièzǐ
|
La presenza di
Huángdì in questo luogo è altamente significativa: il
«dominatore giallo» era il primo dei cinque dì, uno
dei remoti sovrani predinastici ricordato dalle tradizioni
cinesi. Importante eroe culturale e iniziatore di varie
tecniche, condivideva con Ziudsura, Atraḫasîs e Ūtnapištî,
e naturalmente con gli eroi ellenici trasferiti nelle
Makáron Nḗsoi, la
caratteristica di essere stato traslato dalla terra degli
uomini e condotto in un luogo edenico, ai confini del mondo,
per condurre un'esistenza immortale. Il fatto di trovare il
palazzo di
Huángdì sul monte
Kūnlún ci informa che
siamo sulla pista giusta.
 |
|
Xīwángmǔ |
|
Zhao Zōngfú (?-?), acquarello. |
Tuttavia la tradizione vuole che il
Kūnlún shān
fosse la dimora della dea
Xīwángmǔ, la «regina madre dell'occidente»:
ed è proprio a lei che Zhōu Mù wáng si rivolge per
avere l'immortalità nella rielaborazione romanzesca
delle sue avventure, il
Mù tiānzǐ zhuàn (IV
sec. a.C.). Xīwángmǔ è una
delle più antiche divinità cinesi: il nome xīmǔ,
«madre d'occidente», è attestato sulle incisioni oracolari
dell'epoca Shāng (1500-1000 a.C.); ma è solo in seguito alla
diffusione del taoismo che la dea assume un'importanza
sempre maggiore nel pántheon e nel folklore cinesi.
Xīwángmǔ era raffigurata con l'aspetto di una stupenda signora con una corona di giada sul capo, ma poteva anche trasformarsi in una divinità
terrifica, e allora nella sua bocca gentile
si snudavano zanne di tigre e dal culetto le spuntava una lunga coda di leopardo. Era nel suo aspetto
ferino che ella inviava malattie e pestilenze sull'umanità per punirla dei misfatti di cui si rendeva colpevole.
Xīwángmǔ aveva la sua dimora
nel lato yīn (settentrionale) del
Kūnlún shān, in un palazzo di giada dal perimetro di mille
lǐ. Era nel giardino di questo palazzo che scorreva il fiume di cinabro, le cui acque liberavano dalla morte chiunque le bevesse, e crescevano i peschi dell'immortalità, i quali fiorivano
solo una volta ogni mille anni. La dea era molto gelosa di quegli alberi e ne concedeva i frutti assai di rado. L'esistenza che
Xīwángmǔ conduceva nel suo remoto paradiso era perfetta:
una vita di piaceri e di delizie, nella più totale calma e serenità. Ella conosceva alla perfezione tutte le tecniche amatorie ed era circondata da una schiera di giovani amanti che, dopo ogni rapporto
sessuale, si indebolivano e invecchiavano, mentre ella
diventava sempre più giovane e fresca. Di tanto in tanto
la dea non disdegnava di concedere le sue grazie a qualche
fortunato mortale, mostrandogli quanto fosse bello far
l'amore con una creatura divina. Si dice che Hàn Wǔ dì (156-87 a.C.),
settimo imperatore della dinastia Hàn, ricevesse la visita della dea ogni anno, in occasione
di particolari celebrazioni, e festeggiasse la ricorrenza in celeste compagnia.
L'impressione – correttissima – è che la cultura cinese
avesse messo in pratica il tema della
ricerca dell'immortalità, non limitandolo alla mitologia.
Non solo i saggi taoisti indugiavano in pratiche alchemiche
e ascetiche al fine di ottenere santità, immortalità e
trascendenza, ma la medicina e la farmacopea cinesi
cercavano sempre nuove tecniche per ottenere la
longevità. Si cercava di conservare le caratteristiche, i
tratti, lo spirito dell'infanzia e della gioventù. Si praticavano esercizi di
respirazione al fine di raffinare il soffio vitale [qì]. Chi poteva permetterselo, si accoppiava con
ragazze giovanissime, cercando di raffinare l'energia
virile: sebbene con gran poco godimento, visto che la
ritenzione del seme era ritenuta indispensabile per
prolungare la vita. Scrive mestamente
Lǐ Bái (705-762), il
grande poeta della dinastia Táng:
| |
Il Huáng Hé corre all'oceano dell'est,
il sole scende verso il mare dell'ovest.
Come il tempo l'acqua fugge per sempre,
non arrestano mai la loro corsa.
Con la giovinezza scompare la primavera,
l'autunno giunge coi miei capelli bianchi.
La vita umana è più corta di quella d'un pino.
che meraviglia allora...
se la bellezza fugge e fugge la forza?
Perché non posso inforcare un lóng celeste
per respirare essenza di luna e di sole
e divenire immortale? |
Lǐ Bái |
Ma detto questo, nello strato più antico della mitologia
cinese troviamo il racconto della spedizione di un eroe verso il
Kūnlún, alla ricerca del segreto dell'immortalità,
ed è un viaggio analogo a quello di Hērakls
e di Gilgameš...
Yì: la leggenda dell'arciere
Un antico accenno della vicenda di
Yì si trova nel
Huáinánzǐ (II sec. a.C.),
un classico della filosofia risalente alla [dinastia] Hàn
cháo. Il sunto è laconico e affannato:
| |
Durante il regno del dominatore Yáo
dì, dieci soli apparvero contemporaneamente nel cielo: il
grano e l'erba si disseccarono e la gente non aveva nulla da
mangiare. [I mostri] Yayú,
Záochǐ,
Jiǔyīng, Dàfēng,
Fēngxī e
Xiūshé causavano danni alla gente. Allora Yáo
mandò
Yì a eliminare
Záochǐ nella pianura di Shòuhuá, a
uccidere Jiǔyīng nelle acque del
Xiōngshuǐ hé, e catturare Dàfēng
nella [palude] Qīngqiū zhǎo. Egli colpì con le
frecce i dieci soli sopra e uccise Yayú
al di sotto. Egli uccise Xiūshé nel
[lago] Dòngtíng hú e prese Fēngxī
prigioniero nella [foresta] Sāng lín. | |
Huáinánzǐ [Běnjīng] |
Nelle antiche cronache storiche – ma lo sappiamo – i
primordi della civilizzazione cinese furono segnati da una
serie di mitici sovrani (sān huáng wǔ dì, i
«tre augusti e i cinque dominatori»). Yáo dì
fu il primo sovrano considerato «storico» dall'ortodossia
cinese. Avrebbe regnato, secondo Sīmǎ Qiān, dal 2145 al 2043
a.C. (Shǐjì). Il confucianesimo lo considerava l'uomo più saggio e compassionevole mai esistito. Conduceva vita semplicissima, senza lussi, e tutti i suoi sforzi erano tesi al benessere dei suoi sudditi. Stando allo
Shū Jīng (il «Classico
dei documenti») fu lui ad istituire il calendario. Nelle cronache, il regno di
Yáo fu funestato da due grandi catastrofi: l'una d'acqua, l'altra di fuoco. Quella d'acqua
si era verificata quando
Gònggōng aveva fatto
crollare il Bùzhōu shān,
il pilastro di nord-ovest, e tutte le acque dello Zhōngguó
erano straripate, provocando una catastrofica inondazione. Quella di fuoco
era avvenuta allorché dieci soli erano comparsi contemporaneamente nel cielo rischiando di ardere il mondo.
Nella cosmovisione
cinese, infatti, esistevano dieci soli e dodici lune. Di tutti era padre il dio
Dìjùn
①▼. Ma, mentre le dodici lune erano figlie dalla dea
Chángxī, i soli lo erano della dea
Xīhé. Questi avevano l'aspetto di fiori splendenti, la cui anima,
racchiusa all'interno, aveva la forma di un corvo a tre zampe
(sānzúwū o
jīnwū).
Il luogo dove i soli sorgevano si trovava nel Dōnghǎi, il mare
orientale, non lontano dalle isole degli xiān. Qui,
in un posto chiamato Tānggǔ
(«vallata delle acque bollenti»), in cima al monte
Nièyáoyūndī, sorgeva un immenso
albero, il Fúsāng («gelso che
sostiene»), alto trecento lǐ, ai cui cui rami i dieci
soli si posavano per asciugarsi non appena usciti dal loro
bagno mattutino nei nove guadi [jiǔjīn] dell'oceano: nove
soli sui rami inferiori e uno in cima
(Shānhǎi Jīng [IX: 3-3 |
VIX: 1 |
5]). Poi quello che stava in cima, saliva sul carro
dorato della madre Xīhé e, dopo
aver varcato una delle numerose porte solari che si aprivano
tra le montagne che sorgevano ai confini del mondo, percorreva
il suo tragitto giornaliero. A turno, uno al giorno, i soli percorrevano il cielo, illuminando
la terra.
Analogamente, nell'estremo occidente,
a ridosso del Kūnlún shān,
sui monti Héngshí,
Jiǔyin e
Huīyě shān, vi era il Ruò
mù, albero dai rossi fiori baluginanti, sui cui rami si
calava il sole di turno dopo aver traversato il cielo nel
suo percorso quotidiano. A questo punto,
Xīhé lasciava salire il sole su un carro trainato da nove
lóng rosso-fuoco e lo riconduceva nel Dōnghǎi. Un giorno
– narra la nostra leggenda – i dieci soli, decisero di non attendere la madre e di uscire nel cielo tutti insieme. Elusa la sorveglianza di
Xīhé, essi si arrampicarono sul
Fúsāng, che cominciò a fumare per l'eccessivo calore.
Se l'albero fosse morto, cielo e terra sarebbero stati
separati per sempre. Poi i dieci soli balzarono nel cielo e
irradiarono così tanta luce e tanto calore che l'aria si
fece violenta e irrespirabile. Le messi andarono a fuoco, i
fiumi si disseccarono, gli animali presero a morire come
mosche e gli uomini non riuscivano più nemmeno a tenere gli
occhi aperti. Se
i dieci soli avessero continuato a giocare tutti insieme nel
cielo, l'intero universo sarebbe bruciato. Il
dominatore Yáo pregò gli dèi che salvassero la terra e il genere umano dalla catastrofe.
 |
|
Yì abbatte i soli |
|
Autore non identificato, illustrazione
(particolare). |
Dìjùn, che non era sordo ai lamenti che si levavano dagli uomini e alle preghiere di
Yáo dì, convocò l'immortale arciere
Yì e gli ordinò andare ad ammonire i dieci soli affinché il loro eccessivo calore non bruciasse l'universo, e allo scopo gli diede un arco rosso e una faretra con dieci bianche frecce.
Yì obbedì e, sceso dal
cielo sulla terra, si recò sul Dōnghǎi, giungendo
in vista del
Fúsāng. L'aria stessa ardeva per
l'eccessivo calore: Yì tuttavia era immortale e minacciò i soli di tornarsene al loro posto. Ma poiché essi non gli davano ascolto e continuavano a giocare e rincorrersi nel cielo,
Yì comprese che non poteva attendere più a lungo, se non voleva che la terra
venisse distrutta. Allora brandì il suo arco e scoccò una freccia. Un sole
venne trafitto e cadde in mare, trasformandosi in un corvo a tre zampe. Ma rimanevano ancora nove soli.
Yì scoccò le sue frecce, una dopo l'altra, e i
jīnwū cominciarono a cadere dal cielo,
mentre pian piano il mare si faceva rovente. Fortuna volle che il previdente
Yáo dì avesse tolto una freccia dalla faretra di
Yì, che in tal modo risparmiò un unico sole,
lasciandolo a percorrere giornalmente, con fatica maggiore,
il percorso celeste suddiviso prima tra i dieci fratelli. La
dea
Xīhé fu l'unica a piangere i suoi figli, pur riconoscendo che essi avevano disobbedito e
messo in pericolo l'intero universo. Ma quando
Yì tornò in cielo, trovò le porte sbarrate.
Dìjùn, il padre dei dieci soli, era furibondo:
lo aveva mandato sulla terra ad ammonire i suoi figli scapestrati, non certo a ucciderli!
Espulse l'arciere dal cielo,
gli tolse l'immortalità e lo costrinse a vivere sulla terra come
un comune essere umano.
Yì fece buon viso a cattivo
gioco. Entrato al servizio del dominatore
Yáo,
si diede da fare per ristabilire l'ordine che le
due catastrofi avevano destabilizzato. Con le sue infallibili frecce,
Yì vinse tribù barbare e nemiche, ricacciandole oltre i confini
dello Zhōngguó. Oltre a ciò, provvide a eliminare
alcune delle terribili creature che a quel tempo imperversavano
nel regno di
Yáo dì:
- Yàyǔ, un mostro con
testa di drago e corpo di leopardo;
-
Zuòchǐ, un orco denti
lunghissimi, e affilati
come pugnali;
-
Jiǔyīng, un mostro con nove teste;
- Dàfēng, un enorme
uccello rapace;
- Fēngxī, un
cinghiale possente e feroce;
- Xiūshé, un
gigantesco serpente acquatico.
Yì combatté inoltre contro
Hé Bó, il «conte del fiume», uno
shén che faceva affogare le persone
nelle acque limacciose del Huáng Hé, e lo vinse accecandolo
all'occhio sinistro con la sua freccia. Quindi mosse contro Fēng
Bò, il «conte del vento», che, con l'aspetto di un toro monocolo dotato di
una lunga coda di serpente, suscitava tempeste
devastando i campi e abbattendo le case.
Yì lo andò a cercare nella sua
dimora, in una grotta sul Tài shān e, dopo averlo
ferito a un ginocchio, lo obbligò a comportarsi
correttamente.
Grazie a queste imprese, il mondo divenne un
posto abitabile e le tribù del Zhōngguó cominciarono a comunicare
le une con le altre (Huáinánzǐ
[8]). Yì si conquistò fama d'eroe e
meritò un posto
d'onore accanto al seggio del dominatore
Yáo. Ma il divino arciere era
lungi dal sentirsi soddisfatto, avendo perduto il rango di
shén e, ridotto alla condizione di mortale,
sentendosi condannato alla vecchiaia e alla morte. Pare che
a disperarsi fosse soprattutto la sua sposa, la bella
Cháng'é, che ogni giorno si
lamentava di aver perduto le meraviglie del cielo in cambio di una misera
casetta sulla terra, e peggio ancora, non poteva sopportare
l'idea che sarebbe presto avvizzita, che sarebbe diventata
vecchia e brutta, e sarebbe morta.
Al riguardo, esistono tradizioni divergenti, ma su
una cosa concorda la maggior parte delle fonti: un giorno
Yì intraprese un viaggio lungo
e pericoloso verso il
Kūnlún shān, con la speranza di
ottenere da
Xīwángmǔ l'elixir vitae.
(Huáinánzǐ [6]) Le montagne che circondavano il
Kūnlún erano perennemente avvolte da un turbinio di fuoco così terribile da liquefare rame e ferro, ma il coraggioso arciere riuscì ad aprirsi una via tra le fiamme. Le pendici del monte erano circondate da
fiumi ribollenti e impetuosi, l'ultimo dei quali, il nero
Ruò hé, scorreva in maniera
talmente tumultuosa che, se un uccello perdeva una piuma, non appena questa toccava la superficie dell'acqua veniva immediatamente inghiottita dalla furia dei flutti. Ma neanche questo riuscì a fermare
Yì, che attraversò il fiume nuotando con tutte le sue forze.
E nonostante il Kūnlún
fosse altissimo, pieno di precipizi e dirupi scoscesi,
Yì lo scalò fino a raggiungere
la cima. Giunto alla muraglia con nove parte,
Yì ne oltrepassò il tigresco guardiano
Kāimíng e finalmente si
trovò nel meraviglioso giardino d'occidente. Entrato nella
dimora dove
Xīwángmǔ lo attendeva,
Yì si inchinò e raccontò alla dea le ragioni del suo viaggio.
La shén, benigna, consegnò all'arciere una fiaschetta
nella quale era contenuto il filtro
della vita eterna, ottenuto dal succo delle pesche dell'immortalità, i
cui alberi fiorivano una volta ogni mille anni. Poiché di
elixir non ve n'era molto,
Xīwángmǔ si raccomandò con
Yì che lui e sua moglie facessero attenzione a come berlo.
L'elixir poteva concedere immortalità e trascendenza ad una sola persona, ma poiché essi dovevano dividerlo in due, avrebbero ottenuto l'immortalità ma non la trascendenza. E comunque, non dovevano berlo prima del giorno di luna nuova.
Yì tornò a casa e mostrò a
Cháng'é la fiaschetta con l'elixir vitae che
Xīwángmǔ gli aveva concesso e le spiegò
che, dividendoselo, essi avrebbero avuto sì, l'immortalità, ma avrebbero dovuto trascorrerla nel mondo sublunare.
Cháng'é, non soddisfatta di dover trascorrere una vita immortale sulla terra, un giorno che il marito era a caccia, bevve l'intero
elixir.
Subito il suo corpo si fece traslucido ed ella si staccò dal suolo e ascese galleggiando verso il cielo. Non era ancora luna nuova e una meravigliosa falce
lunare si arcuava nel cielo stellato. Attirata dalla luna, la donna
vi trovò un ambiente freddo e deserto; c'era solo un albero
cosparso di bianchi fiori profumati e un piccolo coniglio
candido che, con un pestello, frantumava delle erbe senza mai fermarsi.
Cháng'é guardò in basso, verso la terra. C'era chi lavorava nei campi, chi seminava e chi mieteva,
e tutti sembravano felici. Sentendosi assalire da una profonda nostalgia,
Cháng'é si appoggiò all'albero
fiorito e divenne la dea regolatrice del moto delle dodici
lune, che salivano a turno nel cielo, rimanendovi un mese. In quanto a
Yì, l'arciere, dovette restare sulla terra, condannato alla vecchiaia e alla
morte. Il suo
discepolo, Féng Méng, a cui egli aveva insegnato a tirar d'arco, era roso dall'invidia per la grande abilità
con l'arco del suo maestro. Con gli anni, d'altra parte, il carattere di
Yì peggiorava, e pretendeva sempre di più dai suoi
servi. Così Féng Méng fomentò il
loro risentimento e i servi gli tesero un'imboscata lungo uno dei suoi sentieri di caccia. Quando
Yì passò, Féng Méng lo colpì alla nuca con un
randello di pesco, uccidendolo sul colpo. Secondo alcuni, lo spirito di
Yì andò a raggiungere le anime degli uomini degli inferi, e divenne capo del mondo degli spettri.
Altri dicono, invece, che abbia raggiunto il sole. Comunque
sia, per merito dei suoi molti servigi, gli venne mai
dimenticato dagli uomini.
| |
|
①▲
Dìjùn era
probabilmente una divinità celeste dell'antica [tribù] Yīn dài,
fondatrice della
[dinastia] Shāng cháo. Ricordato quasi soltanto nello
Shānhǎi Jīng;
Dìjùn sarebbe stato
in seguito sostituito da
Shàngdì, il
«dominatore dall'alto», o Tiāndì,
il «dominatore celeste»,
divinità suprema della [tribù] Xià dài, fondatrice
dell'omonima [dinastia] dinastia
Xià cháo. |
|
| |
YÌ, HĒRAKLS E GILGAMEŠ: IPOTESI DI UN
MITO
EURASIATICO Nonostante
Yì (Hòu Yì, Yí Yì, Rén Yì),
il divino arciere, sia uno degli eroi più popolari della mitologia
cinese, non esiste un testo epico coerente incentrato su di lui. Il
suo ciclo viene ricostruito mettendo insieme brevi citazioni sparse
in almeno quindici secoli di letteratura cinese. Le fonti principali
sono il suggestivo poema Tiānwèn
[-] («Domande al cielo»), carme sapienziale
composto unicamente di domande di argomento mitologico,
contenuto nell'antica antologia poetica Chǔcí
(«Canti di Chu»), attribuita al poeta e
funzionario Qū Yuán (±343-278 a.C.), vissuto durante il periodo
Zhànguó
(«Stati combattenti»), e alcune sparse citazioni contenute
nello
Huáinánzǐ (il
«Libro di Huáinán»), una raccolta di saggi filosofici,
politici, astronomici, geografici, storici e religiosi,
collazionati da Liú Ān
(±179–122 a.C.), qīnwáng della [dinastia] Hàn cháo.
La popolarità di
Yì è tuttavia testimoniata,
oltre che dalla longeva tradizione letteraria, anche dalla
sua persistenza nel folklore: tradizioni orali incentrate su
di lui sono state raccolte fino a un'epoca relativamente
recente, soprattutto tra le popolazioni rurali e le minoranze
linguistiche della Cina (Yang ~ An
2005).
Qualsiasi
tentativo di tirar fuori una materia coerente, viene inoltre complicata dal
fatto che la figura di
Yì, il mitico arciere
vissuto all'epoca di Yào dì,
sembra sovrapporsi a quella di un certo Hòu Yì di Yǒuqióng, un
tirannico usurpatore vissuto qualche secolo più tardi, all'epoca di Xiāng wáng, quinto sovrano della semimitica [dinastia] Xià
cháo (collocata tradizionalmente nella prima metà del
II millennio a.C.). Il
Huáinánzǐ e il
Tiānwèn
sembrano confondere i due personaggi, attribuendo all'uno le
imprese dell'altro e viceversa, tanto che, fin
dall'antichità, gli esegeti hanno cercato di distinguerli. Gāo Yóu
e Wáng Yì, due eruditi vissuti durante la tarda [dinastia] Hàn
cháo (♔ ±I-II sec.), nei loro commentari
alle due opere summenzionate, hanno ipotizzato l'esistenza di uno
Yì «buono» e di uno
Yì «cattivo». Nel suo commento
allo Shānhǎi Jīng, Guō Pú, vissuto sotto la Jìn cháo (♔ 265-420),
presume che
lo
Yì «cattivo» potrebbe aver assunto il
nome dello
Yì «buono», il quale era
ricordato come un grande eroe. Identica cosa ha sostenuto l'erudito
Hóng Xīngzǔ, vissuto sotto la Sòng cháo (♔ 960-1276), nel suo
commentario al Chǔcí: «Il
dominatore Jùn impiegò la grande
abilità di
Yì con l'arco per risolvere i
problemi del mondo. [...] Tempo dopo, Hòu Yì di Yǒuqióng assunse il
nome di
Yì a causa della grande
fama di arciere di costui». Nel dizionario Shuōwén
Jiězì (✍ fine II sec.) si suggerisce che yì
potesse essere un titolo generico che, nei tempi antichi, veniva
assegnato agli arcieri. (Mori² 1991)
Tra gli studiosi moderni, il sinologo Marcel
Granet (1884-1940) ha sostenuto che lo
Yì celebrato nei miti fosse una sintesi
di due distinti personaggi storici, seguito in questo da Wolfram Eberhard
(1909-1989), mentre per Jiāng Màifū i personaggi confluiti nella
figura del mitico arciere sarebbero stati addirittura tre
(Granet 1926 | Eberhard 1968 | Jiāng
1976). Per lo scrittore e giornalista
Máo Dùn (pseudonimo di Shěn Déhóng, 1896-1981) il personaggio
di
Yì andrebbe visto come
evemerizzazione di un'arcaica divinità yí, cioè «barbara»
(Máo 1981). Secondo il giapponese Mori
Mikisaburō, invece,
Yì sarebbe stato l'eroe di una
tribù di cacciatori stanziati tra le montagne dello Shāndōng;
dopo essere stati assorbiti dai barbari orientali Dōngyí, verso la fine del
III millennio, alla figura inizialmente
positiva dell'eroe si sarebbe sovrapposta una rilettura in chiave
eversiva, visto come malvagio usurpatore (Mori¹
1941). Una teoria affine, proposta da Shirakawa Shizuka,
vuole che
Yì sia stato, al contrario, un
capo o un dio degli stessi Dōngyí, poi andato incontro a varie fasi
di alterazioni nel corso del tempo (Shirakawa
1975). Mori Masako sostiene, al perfetto contrario, che
Yì fosse un personaggio del
tutto
mitico e che i dati relativi alle sue varie incarnazioni letterarie
possano essere usati per tentare una ricostruzione della saga
originale. A tal fine la studiosa giapponese si è avvalsa di una
serie di brillanti comparazioni con l'epopea di Gilgameš
(Mori² 1991).
Anche la somiglianza tra Hērakls
e
Yì è stata ampiamente notata e analizzata, sebbene gli studiosi si siano limitati a
confrontare il tema degli érga: la
carriera di entrambi gli eroi è costellata dall'eliminazione di una
serie di esseri e animali mostruosi. La comparazione
però è stata sempre limitata al piano analogico: l'ipotesi
di una relazione tra i due personaggi non è
stata mai avanzata seriamente. D'altra parte, non essendo mai stata evidenziata la presenza del motivo della ricerca
dell'immortalità alla base del ciclo di Hērakls,
questo secondo tema – che avrebbe rafforzato non poco la
comparazione tra i due personaggi – è per lo più sfuggito agli
studiosi. Il presente saggio offre il
primo tentativo di una comparazione a largo spettro tra Hērakls, Gilgameš
e Yì: e dimostreremo che, paradossalmente, Hērakls
e Yì sembrano presentare
tra loro più tratti in comune di quanti non abbiano con Gilgameš.
Yì: la tipologia del guerriero con l'arco
Per prima cosa cerchiamo di inquadrare
Yì e definirne, per così dire, il character
design. La figura del divino arciere sembra lontana dall'archetipo «regale» di Gilgameš
e, soprattutto, da quello «muscolare» di Hērakls,
che sappiamo essere l'esito ellenico – mutatis mutandis
– del dio-tuono indoeuropeo. Traiamo una necessaria premessa da una brillante osservazione che Oscar Stig
Wikander (1908-1983) mosse a proposito degli eroi del
Mahābhārata,
secondo cui il prototipo del guerriero presentava,
nell'India vedica, due aspetti assai diversi tra di
loro: quello incarnato da Bhīma,
campione solitario, bestiale e istintivo, dotato di enorme
vigore fisico, le cui armi principali erano le braccia,
prolungate all'occorrenza da una sorta di clava; e quello
incarnato da Arjūna, guerriero
civilizzato, da battaglia, stratega intelligente e leader
naturale, dotato di armi di arco e lancia
(Wikander 1947). Tale
osservazione è stata ampliata e sistematizzata da Georges
Dumézil (1898-1986) nelle sue analisi sulla
tripartizione funzionale degli indoeuropei. La distinzione
tra il «tipo»
Bhīma e il «tipo» Arjūna
è stata ampliata ed estesa da Dumézil ad altri sistemi
mitologici. Egli, ad esempio, vedeva la distinzione
tipologica tra guerriero brutale ed eroe seducente
nell'opposizione che Kǝrǝsāspa
e Θraētaona in Īrān, tra Hērakls
e Akhilleús in Grecia, tra
Þórr e
Óðinn in Scandinavia (Dumézil 1958
| Dumézil 1968). Ora, pur senza togliere nulla al
lavoro di Dumézil (i cui personaggi sono
esplicativi delle diverse tipologie guerriere, ma non
costituiscono delle coppie funzionali), ambiamo essere più
precisi e cercare delle precise associazioni tra guerrieri
con clava e quelli con arco. Per esempio:
| |
India |
Grecia |
Scandinavia |
Cina |
| Guerriero con clava |
Bhīma |
Hērakls |
Þórr |
Féng Méng
(?) |
|
Guerriero con arco |
Arjūna |
Ullr |
Yì |
Notiamo subito che il contrasto tra clava e arco viene a perdersi,
ad esempio, nel caso di Hērakls,
che se la cava bene con entrambe le armi: sebbene sia
solitamente armato di clava, è con
l'arco che uccide l'aetós kaukasíos
e gli uccelli del lago Stymphalídes, ma anche i suoi stessi
figli. Anche nel caso di
Þórr, la cui clava è
opportunamente sostituita dal martello
Mjǫllnir, la dicotomia viene ad attenuarsi, visto che l'abilità con l'arco e
con le frecce è l'unico tratto che definisce il suo figliastro
Ullr, il quale potrebbe essere
una sorta di proiezione ingentilita di
Þórr. Ed è davvero un peccato
non saperne di più su
Ullr (una dicotomia
Þórr e
Óðinn può essere esclusa, in quanto quest'ultimo non
usa mai l'arco). Nel caso di
Yì, la sua abilità con l'arco è proprio una delle
principali definizioni del personaggio, ricordata in una
gran quantità di testi (Lúnyǔ |
Xúnzǐ | Guǎnzǐ | Zhuāngzǐ
[XXIII] | Hánfēizǐ).
Gli vengono addirittura attribuite delle caratteristiche di eroe
culturale: «Anticamente Yì
costruì il primo arco» (Mòzǐ
[IX] | Lǚshìchūnqiū
[XVII: 9]). L'arco e le
frecce, apprendiamo ancora nello Shānhǎi
Jīng,
erano stati conferiti a Yì
dallo stesso Dìjùn, il dio che
poi lo avrebbe esiliato dal cielo, allo scopo preciso di
portare ordine nel «paese sottostante» [xiàguó], cioè
sulla terra:
| |
Dìjùn conferì a
Yì un arco vermiglio con frecce
dalle piume bianche per proteggere il paese sottostante.
Yì fu il primo a soccorrere il
paese sottostante nelle cento difficoltà. | |
Shānhǎijīng [XVIII:
7] |
Invece l'uso
di una clava, o per l'esattezza di un táobǎng,
sorta di randello in legno di pesco, da parte di Féng Méng,
è
limitata all'episodio dell'uccisione di
Yì: forse un motivo non
abbastanza decisivo per classificarlo come guerriero di tipo
«tipo»
Bhīma, tanto più che Féng Méng
è detto essere un
grande arciere, pari allo stesso
Yì o di poco inferiore. Ma
forse proprio questa ragione rende ancora più significativo
il fatto che, per uccidere il proprio maestro, Féng Méng
non abbia usato un arco, ma, appunto,
un randello.
 |
|
Yì abbatte i soli |
|
Monumento dedicato al mitico arciere Yì
in Chángzhì (Cina), opportunamente fotografato nel corso di
una eclisse parziale di sole. |
Il nostro schema ha anche un altro difetto, che gli
indoeuropeisti non ci perdoneranno: quello di usare schemi
validi per il mondo indoeuropeo per interpretare un
personaggio tratto dalla mitologia cinese. Quel che
sosteniamo, tuttavia, non è un'omologia forte dei
personaggi, ma soltanto un calco,
dovuto a influenze storiche o a comuni eredità eurasiatiche.
D'altra parte, l'ipotesi di una possibile influenza della figura di
Arjūna, alla base di quella di
Yì, è stata sostenuta più volte. Un caso
emblematico – sotto diversi aspetti – è il mito dove
Yì abbatte i soli ribelli a colpi di freccia. Esso è
diffuso, in un gran numero di varianti, tra molti gruppi
etnici in Cina, Indocina, Mongolia e Siberia. Il numero dei
soli varia a seconda delle versioni: può essere due, tre,
sette, nove, dieci o dodici; il mitico arciere li abbatte
tutti, tranne uno. (Yang ~ An
2005). Gli antropologi spiegano questo mito come la
spiegazione di un rito inscenato in caso di eclissi: molti
antichi popoli asiatici e altaici scoccavano frecce in
direzione del sole per spaventare il
mostro celeste che, nella loro concezione, minacciava di
divorare l'astro, trascinando il mondo nelle tenebre.
Il mito cinese è stato anche messo in correlazione con un
episodio del Mahābhārata,
in cui
Arjūna uccide con un colpo di
freccia il fratellastro Karṇa,
figlio e avatāra del dio-sole
Sūrya. Stranamente, però, sembra sfuggito il motivo di Hērakls
che bersaglia di frecce il dio-sole
Hḗlios al fine di farsi prestare la coppa aurea che
gli permetterà di attraversare il potamós
Ōkeanós.
La crisi esistenziale e la servitù
La biografia generica del nostro eroe prevede, a un certo
punto della storia, una sorta di crisi esistenziale che lo
metta di fronte alla prospettiva della propria mortalità. La
crisi viene scatenata da un evento tragico, traumatico, orchestrato per volontà divina. L'evento
può produrre una situazione in cui l'eroe finisce per
servire un sovrano in una serie di imprese ardite e
pericolose, atte a ripristinare l'ordine cosmico. Vedremo
ora come, in questo schema, i miti di Hērakls
e di Yì siano direttamente
confrontabili, mentre il ciclo di Gilgameš,
almeno nella versione ninivita, se ne distacchi
parzialmente.
Nei tre miti considerati, la crisi è un lutto (Gilgameš),
un delitto (Yì) o entrambe
le cose (Hērakls).
Nel caso degli ultimi due miti, il delitto ha alla sua base una
volontà o una richiesta divina: Hērakls,
reso folle da Hḗra,
massacra i suoi stessi figli e due suoi nipoti, figli di
Iolaos (Apollódōros:
Bibliothḗkē [II:
4, ]
| Euripídēs: Hērakls mainómenos;
etc.). A Yì viene invece
esplicitamente richiesto dal dio Dìjùn
di ricondurre alla ragione i figli di lui, i dieci soli, che
sono usciti tutti insieme nel cielo e rischiano di bruciare
la terra. Ma, spinto dall'emergenza,
Yì eccede i limiti che gli sono stati imposti e
abbatte nove dei dieci soli. Entrambi gli eroi eccedono
nella rispettiva tipologia funzionale: Hērakls nella propria hýbris, Yì nella propria
eccellenza di arciere. Il risultato, in entrambi i casi, è
il massacro di giovani innocenti: nel mito ellenico gli
stessi figli di Hērakls,
in quello cinese i figli di Dìjùn.
Un'altra interessante interessante corrispondenza tra il
crimine di Yì e quello di Hērakls
è l'arma del delitto. L'eroe greco, infatti, utilizza
proprio
l'arco per uccidere i suoi bambini. Questo in
Diódōros Sikeliṓtēs, dove Hērakls
«li colpì con il suo arco come fossero suoi nemici»
(Bibliothḗkē Historikḗ
[IV: 11]), e in Euripídēs, dove l'arco viene
usato su due dei tre figli e sulla moglie
Megára; il terzo figlio si
getta ai piedi dell'eroe e viene ucciso con un colpo di
clava: ma si tratta di una variante
drammatica introdotta dallo stesso Euripídēs
(Hērakls
mainómenos).
È interessante notare che
l'arco viene utilizzato da Hērakls
in pochissimo altre occasioni. Ad esempio, per minacciare il dio-sole Hḗlios, al fine di farsi consegnare la coppa d'oro,
e
per uccidere l'aetós kaukasíos
e sterminare gli uccelli del lago Stymphalídes. Sia che miri al sole,
sia che colpisca degli uccelli, tutti i rari episodi in cui Hērakls
fa uso dell'arco mostrano delle corrispondenze con il
mito di
Yì. Si
aggiunga che in
Apollódōros, Hērakls
uccide i suoi figli e i due figli di
Iphikls
gettandoli nel fuoco (Bibliothḗkē
[II: 4, ]), variante in cui
possiamo riconoscere agilmente, ancora una volta, un tema
igneo. Ecco uno schema non proprio rigoroso:
| HĒRAKLS |
YÌ |
|
Bersaglia di frecce il dio-sole
Hḗlios al fine di farsi prestare la coppa aurea |
Uccide a colpi di freccia i nove soli, figli del dio Dìjùn. |
|
Uccide i propri figli a colpi di freccia. |
|
Uccide i propri figli gettandoli nel fuoco. |
I soli rischiano di ardere e la terra. Una volta caduti in mare,
ne rendono l'acqua rovente. |
|
Uccide a colpi di freccia l'aetós kaukasíos
e gli uccelli del lago Stymphalídes |
I soli, colpiti dalle frecce, si rivelano essere dei corvi a tre
zampe (sānzúwū o
jīnwū). |
La più significativa differenza tra il crimine di Hērakls
e quello di
Yì è che il mito ellenico non fornisce
giustificazioni né allevia in alcun modo la responsabilità
dell'eroe. L'uccisione dei propri figli, da parte di Hērakls,
rimane immotivata e gratuita (come ben sottolinea Euripídēs
in quell'esemplare pezzo di letteratura che è l'Hērakls
mainómenos). Il delitto di Yì
viene invece giustificato e motivato dalla necessità di
contrastare la fatale noncuranza dei dieci soli, la loro
incapacità di comprendere quale catastrofe stanno causando
alla terra e al genere umano con il loro irresponsabile
comportamento. Così, la condanna inflitta a Yì
– la cacciata dal cielo e la perdita del rango di shén
– viene presentata come una punizione eccessivamente severa. Il dettaglio
fondamentale è che Yì diviene
conscio dell'ingiustizia connaturata al suo (nuovo)
status di
mortale.
Che la condanna sia avvertita come ingiusta sembra una
costante di tutti e tre i miti. Nel racconto di Gilgameš,
l'eroe non è direttamente coinvolto nella morte di
Enkidu, che viene decisa a
freddo dagli dèi come punizione per l'uccisione di Gudanna. Il
«delitto» di cui si macchia l'eroe, nel mito mesopotamico, è
proprio l'abbattimento del toro celeste
(a cui possiamo aggiungere anche l'uccisione di
Ḫumbaba): la morte di Enkidu
espia anche e soprattutto la colpa di
Gilgameš. Sia
Gilgameš che
Yì avvertono
l'ingiustizia connaturata all'inevitabilità dlela propria morte in contrasto con i diritti
inerenti alla loro natura divina: Gilgameš
è per due terzi dio, Yì è
stato un dio; eppure entrambi dovranno soggiacere al
fato dei mortali, che non sentono di dover condividere. Nel caso
di Hērakls, abbiamo
già spiegato come la natura del personaggio (un dio-tuono a
cui veniva tributato un culto importante sebbene
fosse stato declassato nel mito a eroe),
impediscono un riconoscimento tragico della sua condition
humaine,
che comunque è percepita come transitoria e destinata a essere
superato tramite l'apoteosi. Nel mito greco, l'ingiustizia è stata
riletta come perdita della regalità a cui
Zeús lo aveva destinato.
Quale punizione per il delitto commesso, sia Hērakls
che Yì sono condannati a
soggiacere in servitù a un sovrano e compiere, per
lui, una serie di imprese ai limiti delle capacità umane. Hērakls
deve espiare l'uccisione dei suoi figli servendo re Eurysteús
per dodici anni, e questi lo spedirà in giro per il
mondo per compiere i suoi proverbiali érga.
Yì, una volta esiliato sulla
terra per aver ucciso i figli di Dìjùn, sebbene non sia ridotto in
servitù, si mette agli ordini del dominatore
Yào, il quale lo manda a
sgominare i mostri che, dopo la grande inondazione,
devastano il Zhōngguó.
| |
GILGAMEŠ
|
HĒRAKLS |
YÌ |
Mandante
(causa divina) |
La dea
Ištâr scatena
Gudanna. |
Hḗra
fa impazzire Hērakls. |
Dìjùn ordina a Yì
di ricondurre alla ragione i dieci soli. |
| Delitto |
Gilgameš
ed Enkidu uccidono
Ḫumbaba e
Gudanna. |
Hērakls
massacra i propri figli e quelli di
Iphikls. |
Yì
uccide nove dei dieci soli, figli di
Dìjùn. |
| Castigo |
L'assemblea degli dèi
decide la morte di Enkidu. |
|
Yì
viene cacciato dal cielo e privato dell'immortalità. |
| Servitù |
|
Hērakls deve
servire re Eurysteús per
dodici anni. |
Yì
si mette agli ordini del dominatore
Yào. |
Conseguenze
psicologiche |
Gilgameš
diviene conscio della propria mortalità. |
|
Yì
diviene conscio della propria mortalità. |
| Ingiustizia |
Essendo per due terzi dio e per un terzo
uomo, Gilgameš avverte la
propria mortalità come un'ingiustizia. |
Hērakls
avverte l'essere stato messo agli ordini di Eurysteús
come una profonda ingiustizia. |
Essendo stato un dio,
Yì avverte la propria
mortalità come una profonda ingiustizia. |
Il ciclo delle «fatiche»
Come abbiamo detto, Hērakls
e Yì sono stati spesso
associati dagli studiosi in quanto entrambi coinvolti in una serie di scontri con mostri pericolosi e
micidiali. Meno ovvio, ma altrettanto presente, il fatto che
entrambi gli eroi compiano lo loro «fatiche» sotto gli
ordini di un sovrano: l'insapido e vile Eurysteús
per l'uno, il saggio e virtuoso Yào
dì per l'altro. Detto ciò, non è affatto facile
trovare una qualche associazione tra le «fatiche» di
Hērakls e quelle
di Yì: la tradizione greca e
quella cinese contemplano infatti dei bestiari completamente
diversi.
Per quanto riguarda le possibili analogie con il ciclo di
Gilgameš, la professoressa Mori
Masako tenta di mettere in correlazioni la lotta di Gilgameš ed
Enkidu contro
Ḫumbaba con quella di Yì
contro
Jiǔyīng. Sfortunatamente sappiamo pochissimo su
quest'ultimo personaggio; Gāo Yóu,
nel commentario al
Huáinánzǐ, lo
descrive semplicemente come un mostro «d'acqua e di fuoco».
Per tale ragione la Mori ritiene di poterlo associare a
Ḫumbaba, «il cui grido è il diluvio,
il cui soffio è fuoco, il cui respiro è morte...»
(Ša naqba īmuru [II: -])
(Mori² 1991). A nostro
avviso abbiamo davvero troppi pochi dati per stabilire un
parallelismo rigoroso tra
Ḫumbaba e
Jiǔyīng.
Più solidamente costruita, a nostro avviso, la relazione
che la Mori stabilisce tra l'uccisione del cinghiale
Fēngxī,
compiuta da Yì, e quella del
toro Gudanna, compiuta
da Gilgameš ed
Enkidu. La studiosa equipara
brillantemente il mito greco e quello cinese su due punti:
- entrambe le bestie manifestano una situazione di
carestia: Fēngxú devasta i
campi e si nutre dei cereali piantati dagli uomini,
Gudanna prosciuga le acque
e porta anni di siccità sulla città di Uruk;
- dopo l'uccisione di Gudanna,
Gilgameš ed
Enkidu ne consacrano il
cuore a Šamaš e versano
olio nelle sue corna per
Lugalbanda, ma gli dèi non accolgono l'offerta e
decretano la morte di Enkidu;
analogamente, dopo aver abbattuto
Fēngxú, Yì offre un
sacrificio a Tiāndì, ma il
«dominatore del cielo» rifiuta la sua offerta. (Mori² 1991)
馮珧利決
封豨是射
何獻蒸肉之膏
而后帝不若 | féng yáo lì jué
fēng xī shì shè
hé xiàn zhēng ròu zhī gāo
ér hòu dì bù ruò | Con
l'arco di perla e l'anello di giada al pollice
[Yì] scoccò la freccia a
Fēngxú:
Perché il sacrificio succulento
dispiacque a [Tiān]dì? |
|
Chǔcí [III]
> Tiānwèn [69-70] |
Gli stessi due punti, a ben guardare, sussistono anche
nel mito ellenico: il toro di Krḗtē, catturato da
Hērakls, viene
dedicato a Hḗra, ma la dea,
sdegnata, fa impazzire l'animale, che infuria per anni nella
piana di Marathṓnē. Invece, ciò che indebolisce
l'equiparazione
tra l'eroe cinese e quello mesopotamico, è che l'uccisione
di Gudanna rimane una sorta di
unicum nel ciclo di Gilgameš
e non viene inquadrata in un sistema di «fatiche»,
come sono quelle di Hērakls
e di Yì. Inoltre,
Gilgameš agisce per sua propria
hýbris e non per ordine di un altro sovrano.
Dobbiamo tuttavia sforzarci di esaminare gli schemi più
che i singoli miti. Ciò che accomuna le tradizioni di
Hērakls e
Gilgameš è che, in entrambi i
miti, lo schema comprende una precisa ricorrenza dove l'eroe
combatte sia contro un toro sia contro un
leone (o dei leoni); ma né tori né leoni compaiono tra le
bestie abbattute da Yì, sebbene il cinghiale abbia le medesime funzionalità del
toro celeste e di quello di Krḗtē. C'è una ragione in
questa sostituzione di mostruosi animali o possiamo
ricondurla in qualche modo a un isomitema?
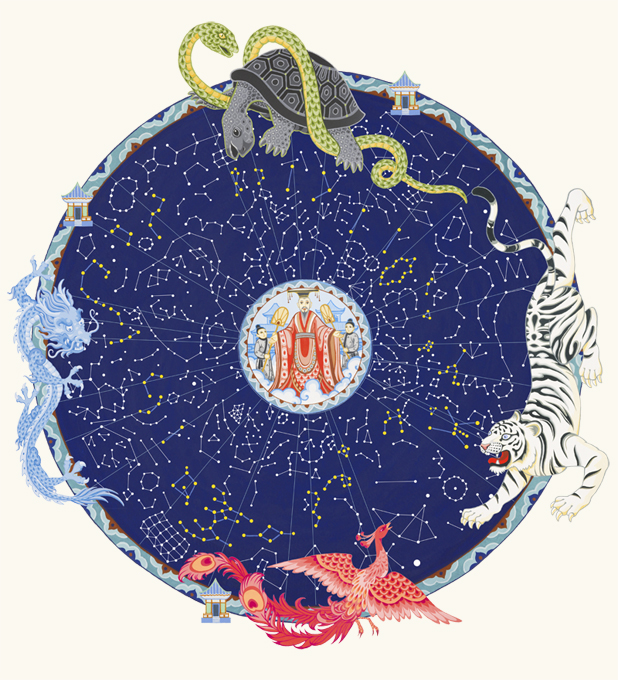 |
|
Sì xiàng, i «quattro simboli» |
|
Mappa celeste tradizionale cinese |
Difficile dirlo. Mesopotamia e Grecia condividevano,
almeno in parte, una comune tradizione astronomica: e
leone e toro erano costellazioni zodiacali presenti nelle
mappe celesti di entrambe le culture. Se
la lettura astronomica del nostro mito è corretta, il
suo adattamento tanto in Mesopotamia tanto in Grecia poteva essere riconosciuto
e gli animali conservati. Ma in Cina? L'astronomia
tradizionale cinese era piuttosto differente: non era basata,
come quella occidentale (babilonese e classica), sulla
posizione del sole lungo l'eclittica, ma suddivideva quest'ultima
in accordo ai movimenti della luna nel corso del mese
lunare. Di conseguenza, le costellazioni venivano ripartite
in ventotto xiù, o «case», secondo un sistema simile
a quello indiano dei nakṣatra. I ventotto xiù
erano a loro volta ripartiti in quattro xiàng o
«simboli», a ciascuno dei quali era collegato un colore e un
animale mitologico. Essi erano:
- Dōngfāng Cānglóng, il «drago azzurro
dell'est»;
- Xīfāng Báihǔ, la «tigre bianca dell'ovest»;
- Nánfāng Zhūquè, l'«uccello rosso del sud»;
- Běifāng Xuánwǔ, la «tartaruga nera del nord».
Non possiamo aspettarci che le immagini di tori e leoni
possano venire conservate in un sistema tanto dissimile. Ma
se anche i mostri uccisi da
Yì avessero un riscontro
astronomico, dovremmo aspettarci che corrispondano ad
asterismi cinesi o ai quattro xiàng. Di sicuro gli esegeti cinesi non hanno
mai riconosciuto i riferimenti astronomici, se ce ne sono.
Non ci resta che lasciare la risposta a qualcuno più
competente di noi in astronomia cinese. Possiamo però
avanzare qualche proposta.
Alcuni dei mostri uccisi da Yì
sono piuttosto interessanti. Prendiamo ad esempio il
Xiūshé e il Dàfēng.
Il Xiūshé era un
gigantesco serpente acquatico emerso dal Dòngtíng hú, allorché i dieci soli ne avevano
prosciugato le acque. Giunto in barca al
centro del lago,
Yì lasciò emergere il serpente
quindi ebbe un gran daffare nel
bersagliarlo di frecce, ma non riuscì nemmeno a
scalfirlo. Alla fine lo uccise affondandogli la spada
nel cuore. Il Xiūshé potrebbe corrispondere al bāshé,
l'enorme serpente divoratore di elefanti che viveva nelle
terre meridionali
(Shānhǎi Jīng [X:
4]), o al chángshé, il serpente
ricoperto di setole porcine del Dàxián
shān, nelle terre occidentali
(Shānhǎi Jīng [III:
5]). Secondo Guō Pú l'uno e l'altro serpente
potevano raggiungere la ragguardevole lunghezza di cento
xún (circa 270 metri).
Il Dàfēng era un invece
un enorme uccello, con becco d'aquila, coda di pavone e ali
tanto ampie che, nella scia del suo volo, si formavano
trombe d'aria. Si nutriva di intere mandrie di armenti e anche di
esseri umani. Per non lasciarselo sfuggire, tanto era
veloce,
Yì si appostò e, al momento giusto, gli scagliò una freccia legata a una fune di seta nera. Colpitolo al petto,
Yì lo trascinò a terra e lo
finì a pugnalate. Si noti che fēng è il termine cinese per
indicare un uccello favoloso, sovente avvicinato al
Saēnā/Simorġ
persiano e sbrigativamente tradotto nella letteratura
divulgativa con «fenice»: dàfēng sta per «grande
fenice». Forse proprio al Dàfēng si è ispirato Zhuāng Zhōu,
che nel paradossale incipit
della sua opera evoca l'uccello
Péng, lungo migliaia di lǐ, che ha come
aspetto alternativo il pesce Kūn,
altrettanto grande, che vive nel Běihǎi, il mar
settentrionale (Zhuāngzǐ [I]).
L'uccisione, da parte di Yì,
tanto del serpente Xiūshé,
tanto dell'uccello Dàfēng,
potrebbe presentare un corrispettivo mitologico
nell'uccisione del drákōn hespérios e dell'aetós
kaukasíos da parte di Hērakls.
Sarebbe interessante poter dimostrare una relazione tra lo
Xiūshé e il drákōn
hespérios, e tra il Dàfēng e
l'aetós kaukasíos: si potrebbe inferire che l'aquila e
il
serpente appartengano a uno strato mitologico più antico che non
il leone
e il toro. Disgraziatamente, la comparazione rimane infondata:
il serpente e l'aquila del mito ellenico sono legati ai punti cardinali, rispettivamente
all'ovest e all'est, cosa che non si può dire per i loro
«colleghi cinesi». Né si può aggirare il problema mediando
una comparazione attraverso i simboli xiàng dei punti
cardinali: lo Cānglóng è un drago [lóng] e non
un serpente [shé]; lo Zhūquè è un passeriforme
[què] e non certo una «fenice» [fēng].
Lo scontro con il dio fluviale
Assai più interessante, a nostro avviso, un'altra delle
imprese di Yì: il suo
scontro con Hé Bó, il dio del Huáng Hé, il «fiume giallo», nella
cui valle era sorta la civiltà cinese. Personaggio assai
importante nella religione della Cina primitiva, il «conte
del fiume» Hé Bó
era chiamato a volte solo Hé,
«fiume», in quanto veniva a confondersi con l'elemento
stesso. In genere Hé Bó era
rappresentato con l'aspetto di un báilóng, un drago
bianco, oppure di un pesce, ma con volto umano. Non era
certo un
dio benevolo: facile all'ira, le sue inondazioni
minacciavano continuamente di devastare vasti territori, e i
terrorizzati abitanti della sua immensa vallata, che lo
vedevano a volte solcare le acque guidando un cocchio tirato
da due lóng, cercavano di ammansirlo con offerte in
giada e, a partire dal IV secolo
avanti Cristo, con sacrifici umani. In genere gli erano
offerte giovani fanciulle, che venivano lasciate annegare
nei suoi gorghi, come sue spose.
Secondo il
Huáinánzǐ, Yì
avrebbe affrontato Hé Bó perché
aveva la pessima abitudine di annegare la gente nei suoi
flutti. Tuttavia, una strofa dal Tiānwèn
(terza composizione del
Chǔcí) ci
suggerisce una storia assai meno nobile, dove
Yì
avrebbe attaccato Hé Bó per amore di Luò Pín,
moglie del dio fluviale:
胡射夫河伯
而妻彼雒嬪 | hú shè fū hé bó
ér qī bǐ luò pín | Perché
[Yì] scoccò a
Hé Bó
e scappò con Luò Pín? |
|
Chǔcí [III]
> Tiānwèn [6] |
Wáng Yì (89-158), bibliotecario imperiale della Hàn
cháo, riferisce, nel suo commentario al
Chǔcí, che Hé Bó
si sarebbe mostrato in aspetto di báilóng e che Yì
gli aveva scoccato una freccia nell'occhio sinistro,
cavandoglielo. Allora il «conte del fiume» andò a protestare
dal supremo Tiāndì, chiedendo
che Yì venisse punito per il
suo crimine, ma il «dominatore celeste» diede ragione
all'arciere: “Se ti fossi dedicato a svolgere i tuoi doveri
di shén, Yì non avrebbe
avuto ragione di nuocerti. Invece ti sei presentato in
aspetto mostruoso: naturale che qualcuno ti abbia preso di
mira. Yì ha agito
correttamente: quale crimine avrebbe mai commesso?”.
La leggenda cinese ricorda irresistibilmente un
importante episodio della carriera di Hērakls,
il quale, concluso il ciclo delle érga,
affrontò il potamós
Akhelos, col quale contese per la mano di
Dēïáneira,
figlia di Oineús, re di Kalydṓn. Il dio fluviale
greco aveva tre aspetti: di serpente
screziato, di toro, oppure umano, con una lunga barba stillante acqua. Ma
Dēïáneira aveva orrore di un tale sposo e avrebbe voluto morire piuttosto che
unirsi a lui. Quando Hērakls giunse in Aithōlía,
lottò contro il potamós per il diritto di sposare la ragazza.
Akhelos si trasformò dapprima in un serpente, ma
Hērakls
non desistette.
Akhelos si trasformò allora in toro, ma Hērakls gli strappò un corno. Ad
Akhelos non rimase che arrendersi ed
Hērakls poté prendere in moglie Dēiáneira.
(Sophokls: Trakhíniai [9-21] |
Ovidius: Metamorphoseon
[IX: -] | Hyginus: Fabulæ [31]).
Il corno strappato ad
Akhelos divenne la cornucopiae,
l'inesauribile recipiente di abbondanza che spandeva fiori e
frutti senza mai svuotarsi.
Questo episodio mostra in filigrana il mito dell'ammansimento
di un potente dio fluviale, medesimo motivo che troviamo nel
mito dello scontro tra Yì ed Hé Bó.
Come il Huáng Hé è il fiume principale della Cina, l'Akhelos
(attuale Aspropótamos) è il corso d'acqua più
importante della Grecia, e vi sono diverse ragioni di
credere che gli venisse tributato un culto importante fin da
un'età remota. Si aggiunga inoltre il motivo che tanto il
hé cinese tanto il potamós greco potevano
assumere forma animale, in particolare di serpente, ed è nel
loro aspetto bestiale che vengono combattuti e sconfitti.
Entrambi gli scontri, infine, sono motivati dal mito di
conquista di una donna.
Riteniamo che quest'antico mito della lotta contro il
dio-fiume possa avere delle correlazioni anche con un altro
episodio del ciclo eracleo. Un giorno Hērakls
e Dēïáneira, ormai sposi, si
trovarono a dover guadare i flutti del fiume Eúēnos. Si
fece avanti un kéntauros,
Néssos, e si offrì di aiutare la donna
a passare dall'altra parte. Ma mentre fu al centro del
fiume, Néssos partì al galoppo,
tentando di portarsi via la ragazza. Hērakls
lo colpì con una delle sue frecce, le cui punte erano
intinte nel sangue dell'hýdra, salvando la sua
sposa. Ormai agonizzante, Néssos
suggerì a Dēïáneira di
utilizzare il suo sangue come pozione d'amore nel caso, in
futuro, Hērakls la
avesse dimenticata e trascurata, e sappiamo tutti come andò
a finire...
Poiché, come abbiamo visto, Hērakls
non scocca mai le sue frecce a caso, e quelle poche volte
che imbraccia l'arco – sia che debba uccidere i propri
figli, sia colpire degli uccelli o bersagliare il sole – le
relazioni con Yì si fanno
subito visibili e interessanti, possiamo chiederci se
il mito del kéntauros Néssos
non potrebbe essere effettivamente una variante del mito di
Akhelos e quindi contenere degli elementi che ci
illuminino sullo scontro tra Yì
ed Hé Bó. Un solo elemento
ritorna però con chiarezza: l'uso dell'arco e delle frecce
quale arma per colpire una creatura semiumana al centro del
fiume. Sebbene nel mito cinese sia l'eroe a prendersi la
donna del dio fluviale e non viceversa, possiamo chiederci
se in questo tema del rapimento non si possa vedere un
residuo dell'antico rito (attestato in Cina ma non in
Grecia) del sacrificio di una fanciulla, che veniva gettata
nei flutti del fiume come sposa del dio fluviale; e se il
tema della lotta contro il dio del fiume non sia alla base
di un mito in cui un eroe mette fine a tali sacrifici umani.
Il gemello/compagno
Abbiamo già studiato il rapporto tra l'eroe e il proprio
compagno. Le relazioni interne tra Gilgameš
di Enkidu e quelle tra Hērakls
e Iphikls/Iólaos,
e appurato che, purtroppo, abbiamo
decisamente pochi appigli per imbastire un solido schema di
comparazioni. Ciò che risultava, tuttavia, era un'affinità,
una quasi-gemellarità tra i due sodali, sbilanciata tuttavia
dalla parte dell'eroe, il quale possedeva un quid che
lo rendeva superiore al sodale. Enkidu
viene creato per essere simile a Gilgameš
come un suo riflesso, e vince addirittura l'amico nella
lotta, eppure ne riconosce il melāmmu, lo splendore
regale, che deriva a Gilgameš
dalla sua sovranità e dai suoi due terzi di divinità. Hērakls
e Iphikls sono gemelli,
nati d'un solo parto, eppure il primo è un hēmítheos, figlio
di Zeús, il secondo un mortale,
figlio di Amphitrýōn.
Mori Masako (che lavora soltanto sulla comparazione tra
il mito mesopotamico e quello cinese) individua una
relazione di questo genere anche tra Yì
e Féng Méng. Come Gilgameš
ed Enkidu erano praticamente
pari nella lotta, così Yì e Féng Méng
sono pari nell'uso dell'arco: «Yì
e Féng Méng
maneggiavano l'arco altrettanto bene»
(Xúnzǐ); «Disposto un bersaglio di cinque
pollici di diametro, soltanto Yì
e Féng Méng potevano centrarlo
senza sbagliare» (Hán Fēizǐ).
Nondimeno, la superiorità di Yì
su Féng Méng
si manifestava in una tecnica superiore, oppure, più
sottilmente, nel fatto che egli era il maestro dei due e
teneva l'altro in posizione subordinata. Ciò porterà il geloso Féng Méng
a organizzare l'uccisione di Yì.
Il fatto che l'ideogramma méng 蒙, nel nome
di Féng Méng, contenga un
radicale dal significato di «infantile, sciocco», secondo la
Mori, potrebbe essere messo in correlazione con la natura
ferina di Enkidu. (Mori² 1991)
Ma il vero problema è un altro: l'assassinio dell'arciere
cinese per mano del suo
compagno crea un forte contrasto con il mito mesopotamico,
dove è invece Enkidu a morire,
lasciando Gilgameš nel
dolore e nella disperazione. La Mori ritiene che il mito
cinese abbia alterato i rapporti originali tra l'eroe e il
suo compagno. Ritiene inoltre che l'uccisione di Yì
da parte di Féng Méng abbia
moralizzato in chiave confuciana l'episodio in cui Enkidu
sconfigge Gilgameš nella
lotta, presentando Féng Méng
come un esempio di ingratitudine del discepolo nei
confronti del maestro. La studiosa pensa che lo
Ša naqba īmuru abbia
meglio conservato l'originale relazione tra l'eroe e il suo
sodale, vicina a quella tra Gilgameš
ed Enkidu, e conclusasi con la
morte di quest'ultimo (Mori² 1991).
La Mori non tiene conto che, anche nel mito
greco, è Iólaos a sopravvivere
a Hērakls.
Certo, la versione greca potrebbe dipendere da quella
fenicia, dove il compagno di Melqkart
è presente alla morte di quest'ultimo (Athḗnaios:
Deipnosophistaí [IX: 392d-e]),
ed essere essa stessa una ulteriore variazione sul tema.
Tuttavia, confrontando le ragioni che spingono i vari eroi (Hērakls,
al-Iskandar/Eskandar
e ora anche Yì) a cercare
l'immortalità, scopriamo che il riconoscimento della propria
mortalità è motivata dalla reazione a quella che il
protagonista avverte come un'ingiustizia personale. In tutti
i casi – tranne in quello di Gilgameš
– non è mai un lutto a scuotere l'eroe. Ciò porterebbe
a credere che, in realtà, sia proprio lo
Ša naqba īmuru a
presentare un'innovazione. La finezza psicologica
della presa di coscienza, da parte di Gilgameš,
dei limiti della propria umanità attraverso la morte
dell'amico-specchio Enkidu, fa
pensare alla mano di un raffinato scrittore, capace di
rinnovare la materia, più che a quella di un mitografo che,
al contrario, cerca di conservare e tramandare una
tradizione antica e forse poco compresa. D'altra
parte, ricordiamoci che la tavola XII
dell'epopea ninivita contiene una diversa versione
della morte di Enkidu, tratto
dal racconto sumerico
Ud rea ud sudra rea, dove il
compagno dell'eroe scende nell'Arali
per recuperare il pukku e il mekku
dell'amico, e
rimane prigioniero del regno dei morti.
Il suo rapporto con le donne: l'avversaria e l'enofora
Il destino del nostro eroe, come già abbiamo visto, è
segnato dal confronto con due figure femminili, le quali
fungono da poli per la sua ricerca dell'immortalità. La
prima figura, l'«avversaria» (Inanna/Ištâr, Hḗra),
è propulsiva: l'eroe ha con essa una tensione politica e/o
erotica, e funge da causa scatenante per il suo viaggio. La
seconda figura, l'«enofora» (Šiduri,
Hḗbē) possiede i mezzi per
esaudire la ricerca dell'eroe ed è benevola e soccorrevole
nei suoi confronti.
Nel mito di Gilgameš
l'avversaria è Inanna/Ištâr.
Ella è la dea poliade di Uruk, città di cui lo stesso
Gilgameš è lugal: nel
poema sumerico Šul meka šul meka,
i due entrano in conflitto per una questione di competenze e
di poteri; nel poema ninivita, il conflitto è causato dal
desiderio sessuale di Ištâr
nei confronti di Gilgameš,
desiderio che l'eroe si rifiuta di soddisfare (Ša naqba īmuru [VI]).
In entrambi i casi, il risultato è che la dea scatena
Gudanna, il toro celeste,
contro Uruk: l'uccisione dell'animale causerà, per
ritorsione, la morte di Enkidu.
Ed ecco la crisi esistenziale che spingerà
Gilgameš a intraprendere il
viaggio alla ricerca della vita. Nel mito di Hērakls,
l'avversaria è Hḗra. Madrina
dell'eroe (forse addirittura madre in una versione anteriore
del mito), Hḗra è la dea
poliade dell'Argolís, regione su cui Hērakls
è destinato a regnare per diritto di nascita: la dea
tuttavia riesce a modificare il destino dell'eroe, facendo
sì che il trono vada a Eurysteús.
Inoltre, offuscando il suo senno, Hḗra
causa spinge Hērakls
a uccidere i suoi stessi figli. L'orribile delitto è causa
della crisi esistenziale che costringerà l'eroe a
consegnarsi in servitù allo stesso Eurysteús.
Tale servizio sarà la ragione tanto della sua ricerca dei
frutti dell'immortalità, tanto, parallelamente, gli meriterà
l'apoteosi.
 |
|
Cháng'é |
|
Stampa di autore non identificato. |
Nel ciclo di Yì, ritroviamo
il mitema dell'avversaria nella stessa moglie dell'eroe,
Cháng'é. Quale dea della luna,
il cui profilo viene riconosciuto, in oriente, nelle
immagini eidoliche presenti sul disco lunare,
Cháng'é è una dea astrale, così
come Inanna/Ištâr
è la «signora del cielo» e la dea del pianeta Venere nel
mito mesopotamico, ed Hḗra è la
regina del cielo in quello ellenico. Bisogna però ammettere
che, secondo la maggior parte degli studiosi,
Yì e
Cháng'é sarebbero personaggi
originariamente appartenenti a tradizioni diverse, che hanno
finito per venire associati – o per meglio dire «sposati» –
solo nel corso dell'elaborazione orale del mito, soprattutto
in occasione di particolari ricorrenze cultuali. Non sappiamo se
Cháng'é abbia occultato una
precedente figura femminile associata al mito di
Yì (magari
Luò Pín?), oppure se sia da
considerare un elemento aggiunto ex novo al ciclo del
divino arciere. Inoltre, al contrario di quanto avviene
nelle «coppie» Gilgameš ~ Ištâr
ed Hērakls ~ Hḗra,
tra Yì e
Cháng'é non sembra esservi una
tensione politica, e forse nemmeno sessuale, visto che sono
presentati come una coppia regolarmente sposata (con tutte le
naturali
tensioni di un matrimonio). La loro opposizione si
muove su un piano quasi simbolico: Yì
è una figura con forti connotazioni solari, mentre
Cháng'é è evidentemente lunare.
Ed è proprio questa complementarità yáng/yīn a
svelare il simbolismo che ha ridefinito, in chiave
tipicamente cinese, il rapporto tra
Yì
e la sua compagna/avversaria. Detto ciò,
Cháng'é, nelle varianti più
note del mito, funge da elemento propulsivo: sono le sue
lamentele a convincere il marito a recarsi sul
Kūnlún
shān per farsi consegnare l'elixir vitae.
La seconda figura femminile, l'enofora, è colei che soddisfa la ricerca della vita da parte
dell'eroe. Nel mito di Hērakls,
essa è Hḗbē, la coppiera che elargisce agli dèi dell'Ólympos il cibo e la
bevanda d'immortalità, il néktar e l'ambrosía.
La sua stretta associazione con Hērakls
è evidenziata dal fatto che è proprio Hḗbē
a divenire sposa dell'eroe dopo la sua apoteosi. Nel mito di
Gilgameš, la figura omologa è
Šiduri: sebbene non
abbia un ruolo ai fini della ricerca dell'eroe ma si limiti
a effettuare una sorta di inesplicabile comparsa nella
tavola X dello Ša naqba īmuru,
essa viene presentata come una locandiera (sābītu),
colei che distilla la birra. È probabile che, in una qualche
versione anteriore del mito, Šiduri
avesse un ruolo più importante nell'economia della
ricerca di Gilgameš, e non ci
stupiremmo se fosse proprio lei a elargire l'elixir
vitae. Quale sia stato lo svolgimento
di questo ipotetico antemito, non possiamo saperlo.
Un buon suggerimento potrebbe però venirci da un confronto
con il ciclo di Yì. Nel mito
cinese,
Xīwángmǔ, la «regina madre dell'occidente»,
soddisfa di buon grado la richiesta dell'arciere,
elargendogli l'elixir vitae, mentre
Cháng'é priva l'arciere dei frutti della propria ricerca
appropriandosi della preziosa bevanda.
Come il serpente nel mito ninivita o al-Ḫiḍr
nella tradizione islāmica, è la donna a bere l'elixir
e a ottenere l'immortalità e la
trascendenza, condannando Yì
alla vecchiezza e alla morte.
Proviamo a riassumere questi rapporti con due schemi. Uno
per la «avversaria»:
| |
GILGAMEŠ |
HĒRAKLS |
YÌ |
| «Avversaria» |
Inanna/Ištâr |
Hḗra
|
Cháng'é |
|
Rapporto |
Spasimante |
Madrina (madre?) |
Moglie |
|
Funzione |
Signora del cielo, dea del
pianeta Venere |
Regina del cielo |
Dea della luna |
|
Opposizione |
Politica |
Politica |
Simbolica |
| Erotica |
|
(Matrimoniale) |
|
Ruolo |
Provoca la crisi esistenziale
che spinge l'eroe alla ricerca della vita |
Provoca la crisi esistenziale
che spinge l'eroe alla ricerca della vita |
Provoca la crisi esistenziale
che spinge l'eroe alla ricerca della vita |
| |
|
Priva Yì
della vita eterna |
E uno per l'«enofora»:
| |
GILGAMEŠ |
HĒRAKLS |
YÌ |
|
«Enofora» |
Šiduri |
Hḗbē |
Xīwángmǔ |
|
Rapporto |
|
Moglie |
|
|
Funzione |
Distilla la birra |
Elargisce agli dèi il néktar
e l'ambrosía. |
Distilla l'elixir vitae |
|
Residenza |
Ai confini della terra, in una
taverna sulle sponde dell'oceano cosmico |
Sull'óros Ólympos |
Ai confini della terra, sul
Kūnlún shān |
|
Ruolo |
Incontra e consiglia l'eroe nel
corso della sua ricerca |
Garantisce l'immortalità e la
giovinezza dell'eroe |
Offre all'eroe l'elixir vitae |
Morte e apoteosi (?)
«Yì
fu un sommo arciere e Jiao
poteva pilotare una nave anche sulla terraferma, ma entrambi
trovarono una morte comune», attesta, con un pizzico di moralismo, un
capitolo degli analecta di Kǒng Fūzǐ
(Lúnyǔ [14]). La
principale fonte sulla morte di Yì
è però lo Huáinánzǐ,
il quale ci informa tanto di quale fu l'arma del delitto (un táobǎng, un «randello di pesco»), tanto di
quale sarebbe stato il luogo dell'omicidio (Táobù, il «posto
dei peschi»). Ma è soprattutto Mèngzǐ a raccontarci i
dettagli del fattaccio:
| |
Páng Méng aveva appreso l'arte
dell'arciere da Yì. Quando ebbe
imparato tutto sul metodo di Yì
pensò che nel regno solo costui poteva superarlo e perciò
lo uccise. | |
Mèngzǐ: Mèngzǐ [113] |
Il confuciano Zhū Xī (1130-1200) suggerisce, nei suoi commentari, che
Yì venne ucciso in una congiura ordita dai
servi della sua casa, e che Páng Méng [Féng Méng]
doveva essere uno di essi. Questo, più o meno, il dossier
sull'omicidio del grande arciere. Ah, segue un'ultima nota: «Yì
eliminò tutte le minacce dal mondo e, dopo la sua morte, divenne
[il dio]
Zōngbù» (Huáinánzǐ).
Questa sorta di aggiuntiva apoteosi, aggiunta quasi in punta di penna,
permette a Mori Masako di avvicinare
Yì
tanto a Hērakls
quanto, conclusione assai meno ovvia, a
Gilgameš. Tutt'e tre gli eroi,
infatti, sarebbero stati divinizzati dopo la morte. Riguardo a Hērakls
ne abbiamo parlato in precedenza. Per quanto riguarda
Gilgameš, l'autrice ci ricorda
che nel testo sumerico intitolato informalmente «Morte
di Ur-Nammu», vengono recate delle offerte a nove divinità del
Kur, ovvero dell'oltretomba:
Nergal, Bilgames,
Ereškigal, Dumuzi,
Namtar, Ḫušbisag,
Ningizzida, Dimpiku,
Ninazimua (Mori² 1991).
La preghiera che accompagna l'offerta a
Bilgames viene formulata in
questo modo:
| |
Una lancia, una bisaccia da sella, un'arma a punta con
la decorazione di un leone del cielo,
uno scudo ben
saldo al suolo, l'arma gloriosa,
un'ascia da guerra,
preferita da Ereškigal,
a Bilgames, il re del
Kur,
il pastore Ur-Nammu offre in sacrificio nel suo palazzo! |
«Morte di Ur-Nammu» [-] |
La comparazione della Mori, tuttavia, ci sembra assai
poco solida e non tiene affatto conto del contesto in
cui è stato elaborata la
«Morte di Ur-Nammu». C'è
innanzitutto la difficoltà di inferire un significato
mitologico a un passo tratto da un poema funerario,
composto in occasione del decesso del lugal
Ur-Nammu (♔ ±2047-2030), fondatore della terza dinastia
di Ur, e soprattutto di applicare le conclusioni tratte
da questo testo al poema ninivita, lo Ša naqba īmuru,
che avrebbe raggiunto la forma a noi nota almeno mille
anni più tardi. Detto ciò, bisogna notare che nel
poema sumerico Ursa [amgale]
banu («Giace
l'eroe [il grande toro]»), la morte di
Bilgames viene trattata in
termini assai differenti: il re giace senza respiro
nella trappola della morte; colui che stabilito la pace
nel paese di Sumer e ha compiuto le più portentose
imprese, viene sepolto – secondo il crudele uso dell'arcaica Mezzaluna Fertile – insieme alla moglie e al figlio,
ai parenti e alle concubine, i cortigiani, i servi, nel
palazzo puro nel cuore di Uruk. L'Ursa
[amgale] banu
si conclude con l'immagine di
Bilgames, che giunto nell'Arali,
presenta le sue offerte ai dèi dell'oltretomba: a
Ereškigal,
Namtar,
Neti,
Dimpiku, Dumuzi,
Ningizzida: e la lista è
perfettamente parallela a quella presente nella
«Morte di Ur-Nammu».
Ora, in tutto questo, non c'è nulla che faccia pensare a
una sorta di apoteosi: il larvale prolungamento
dell'esistenza negli inferi è precisamente il contrario
dell'immortalità di cui godono gli dèi, allo stesso modo
in cui la morte è il contrario della vita. Ma tale
ovvietà tende a sfuggire a molti studiosi. Ed
Enkidu è chiaro, quando
parla a Bilgames del
destino degli uomini nell'Arali:
«Se io ti dicessi degli ordinamenti dell'oltretomba,
allora tu ti sederesti e piangeresti»
(Ud rea ud sudra rea
[-]):
e segue una raccapricciante
descrizione della sorte oltremondana di tutti i
mortali.
Ma allora, come dobbiamo intendere quel «Bilgames,
il re del Kur» in
«Morte di Ur-Nammu» []?
Quest'ultimo testo cita u l'Ursa
[amgale] banu:
come Bilgames, sceso agli
inferi, fa offerte agli dèi del
Kur, così il lugal Ur-Nammu, caduto per le ferite riportate in una battaglia, disceso
anch'egli agli inferi, fa offerte agli stessi dèi e
anche a Bilgames, a cui
aggiunge dei regali personali. Gli dèi della casa del
non-ritorno gli offrono un trono su cui
accomodarsi e gli assegnano un appartamento nel
Kur, provvisto di servitù
composta in massima parte dai suoi stessi soldati caduti
in battaglia. Il re è furibondo per le cose che non è
riuscito a concludere sulla terra (viene in mente
l'amara osservazione di
al-Ḫiḍr a Ḏū ʾl-Qarnayn morente:
“Ora non rimane che quello che hai già fatto”
(Aṣ-Ṣaʿb Ḏu ʾl-Qarnayn)), e le stesse divinità
esprimono rammarico e furore per il destino di Ur-Nammu.
Dunque, nella
«Morte di Ur-Nammu», la «divinizzazione» di
Bilgames quale re del
Kur prelude al destino che
l'autore del testo augurato allo stesso Ur-Nammu
una volta raggiunto il paese dei morti.
Non dimentichiamo che questo testo era destinato a
venire recitato durante o subito dopo le esequie del
lugal, quando il dolore per la sua scomparsa era
ancora vivo presso il popolo di Ur. Quanto vi appare è da leggere come eulogia per il re
defunto: intendere questo testo come una fonte mitologica
per imbastire un'eventuale apoteosi di
Bilgames/Gilgameš
vuol dire, a nostro avviso, tradire lo spirito del mito
mesopotamico.
In quanto all'apoteosi di Yì, per dare una risposta bisognerebbe saperne di
più su questo Zōngbù citato
da Liú Ān nel suo Huáinánzǐ.
Pare fosse un dio che si incaricava di scongiurare
disastri (Yang ~ An
2005), il che potrebbe spiegare con quale criterio
sia stato associato a Yì.
Questo passaggio di un eroe, sovrano o antenato, a
shén tutelare o divinità minore è molto
comune nella mitologia cinese (dove tale tipo di
«promozioni» era regolato da una complessa burocrazia
nell'organigramma divino), e sarebbe fuorviante
considerarlo un tratto peculiare di
Yì. Bisogna stare attenti a
non fare confusione: l'apotesi di Hērakls
(che non va confusa né con la continuazione della
coscienza negli inferi, e neppure con l'immortalità di
coloro che sono stati traslati nelle Makárōn Nsoi)
rimane una straordinaria eccezione tra gli eroi del mito
greco, e soprattutto un'eccezione – che
riteniamo di avere adeguatamente spiegato – nel mito
generale che è argomento di questa pagina: la vana
ricerca dell'immortalità di un antichissimo eroe.
In conclusione, gli studiosi tanto cinesi quanto
giapponesi hanno presentato molte brillanti analisi
comparatistiche nel tentativo di definire le relazioni
tra Yì ed Hērakls,
o Yì e Gilgameš.
Sebbene alcuni di loro ritengano che vi siano delle
influenze, nonostante la distanza geografica, non si è
potuto definire, neppure approssimativamente, né la
natura di tali influenze, né a quando risalgano. Mori Masako ritiene che l'epopea di Gilgameš
possa aver raggiunto la Cina nel corso del Chūnqiū
Zhànguó, il cosiddetto «Periodo primavera e autunno»
(772-221 a.C.), o poco prima. L'epopea mesopotamica si sarebbe
quindi fusa con il preesistente mito di
un arciere che aveva abbattuto un certo numero di soli
in eccesso, i due eroi
sarebbero stati identificati l'uno con l'altro e, con
molte aggiunte, abbellimenti e sovrapposizioni di miti e
personaggi, sarebbe sorto il ciclo di
Yì (Mori² 1991).
L'ipotesi della Mori è ragionevole, e l'autrice
potrebbe aver ragione, ma come mostreremo in
dettaglio in conclusione di questo lavoro, vi sono diversi elementi comuni al ciclo di
Hērakls
e a quello di Yì, ma
non
presenti in quello di Gilgameš.
Questo dato mette in seria discussione le ipotesi della
Mori sull'influenza dello Ša
naqba īmuru sul ciclo di
Yì. Ne parleremo tra non molto. Prima bisogna
però tornare in Europa.
| |
NEL MONDO CELTICO, TRA YNYS
AFAỺON E IL TIR NA N-ÓG Il lettore non si
dispiacerà se saltiamo, con un solo balzo, dall'una all'altra
estremità dell'Eurasia. Dall'antica Cina passiamo ora, con i sandali
alati del mitografo, all'Europa occidentale dell'età del ferro.
 |
|
Massima espansione dei popoli
celtici, tra il IV e il III secolo a.C. |
È stato detto che i Celti siano stati
il primo popolo europeo. Ed effettivamente, nel periodo della loro
massima espansione, intorno al IV-III secolo
avanti Cristo, occupavano buona parte del continente. In tutta la
Gallia, la Belgica, l'Elvezia e l'Italia del nord si parlavano
lingue galliche. Dal sud della Germania e dall'odierna Austria,
gruppi celtici si erano spinti fino in Boemia e sulle sponde del Mar
Nero. I Galati si erano stanziati nel cuore dell'Anatolia e i
Celtiberi – fusi con le popolazioni di substrato – occupavano buone
parti dell'Iberia. Le isole britanniche erano patria di fieri regni
celtici.
Nonostante l'immensa area di diffusione, però, la cultura celtico-continentale sarebbe scomparsa entro il 500-600 dopo Cristo, quasi
senza lasciare traccia. Estranei com'erano all'idea di mettere per
iscritto la loro sapienza tradizionale, druidi e poeti passavano
anni della loro vita a imparare a memoria una quantità sterminata di
racconti, poemi e leggende… E quando, la romanizzazione, le
invasioni germaniche e l'avvento del cristianesimo provocarono la
fine del druidismo, un'intera letteratura e mitologia venne
praticamente cancellata. In mancanza di fonti dirette sulle
credenze, la religione e la mitologia dei Celti continentali, gli
odierni studiosi sono costretti ad affidarsi a due diversi tipi di
testimonianze, difficilmente conciliabili: gli scritti degli autori
classici e il patrimonio archeologico, gli uni e l'altro integrati
dai sussidi della linguistica e della toponomastica. Di fronte alla
scarsità del materiale ma, ancor più, alla difficoltà di
interpretarlo, gli studiosi hanno dovuto ingegnarsi a trarre
informazioni dall'indizio più insignificante e trascurabile.
Ingegnose ipotesi sono state costruite a partire da dati minimi:
l'etimologia di un nome, l'oscuro accenno di un autore romano,
l'incerto attributo di un personaggio figurato. Da tale esiziale
documentazione emergono figure molto incerte, i cui tratti si tenta
di mettere a fuoco ricorrendo ai paralleli con il patrimonio mitico
greco-romano e con quello delle posteriori fonti britanniche e
irlandesi.
Un caso a parte rappresentano infatti la Britannia e, soprattutto,
l'Irlanda. Il cristianesimo, portato nell'Isola di Smeraldo da
noíb Pátraic nel 432, trovò il modo di armonizzarsi al modo di vita del popolo
gaelico, al suo sentire e alla sua
cultura. Anche se vi furono inevitabili
contrasti tra gli evangelizzatori cristiani e i druidi, gelosi del loro
retaggio e dei loro privilegi, col crollo del druidismo
furono i monaci ad ereditarne il ruolo di custodi del sapere e della
tradizione locale. L'amore per la
conoscenza che animava quei monaci, unito
all'attitudine e alla pazienza nell'ars scriptoria, permise loro di tramandare una
grandissima quantità di materiale di valore
inestimabile. In un periodo particolarmente
difficile, essi dedicarono le intere
esistenze a trascrivere le antiche
storie del popolo irlandese, trasmettendo
un'immensa mole di cronache, narrazioni, genealogie, agiografie,
testi sapienziali, storici, teologici e druidici, che fecero della
letteratura gaelica la più vasta e antiche d'Europa dopo la greca e
la latina.
Certamente questa continuità tra mondo classico-cristiano e
celtico, ha anche inquinato il materiale, rendendo a volte difficile
comprendere l'origine di questo o quel racconto o mitema. Ciò che
importa, tuttavia, è che ritroviamo, in Britannia e, soprattutto, in
Irlanda, gli esempi europei più fulgidi e compiuti di alcuni dei
miti che abbiamo analizzato in questa pagina. Il tema delle
meravigliose isole di immortalità, poste al di là del mare (o
addirittura sotto il mare), è infatti preponderante nelle tradizioni dei Celti insulari.
La più nota, a livello popolare, di queste isole oltreoceaniche –
di cui ormai conosciamo tutti i segreti – è sicuramente
Ynys Afaỻon, la Avalon del
ciclo arturiano. Il suo paradigma viene stabilito da Gaufridus
Monemutensis (±1100-±1155), il padre fondatore della matière de
Bretagne, nell'Historia regum Britanniae,
in cui cita Afaỻon come il luogo dove
venne forgiata la spada di Arthur,
Caliburnus [IX, 2],
e quindi come l'isola nella quale fu condotto, moribondo, lo stesso
brenhin
Arthur [IX,
2]. Ma è nella Vita Merlini
che egli mette in bocca al semimitico bardo Taliesin
la prima vivida descrizione letteraria dell'isola avaloniana:
Jnsula pomorum que fortunata uocatur
ex re nomen habet quia per se singula profert
non opus est illi sulcantibus arua colonis
omnis abest cultus nisi quem natura ministrat.
Ultro fecundas segetes producit et uuas
nataque poma suis pretonso germine siluis
omnia gignit humus uice graminis ultro redundans.
Annis centenis aut ultra viuiter illic.
Jllic iura nouem geniali lege sorores
dant his qui ueniunt nostris ex partibus ad se
quarum que prior est fit doctior arte medendi
excedit que suas forma prestante sorores.
Morgen ei nomen didicit que quid utilitatis
gramina cuncta ferant ut languida corpora curet.
ars quoque nota sibi qua scit mutare figuram
et resecare nouis quasi dedalus aera pennis.
Cum uult est Bristi, Carnoti, siue Papie
cum uult in uestris es aere labitur horis
hanc que mathematicam dicunt didicisse sorores
Moronoe, Mazoe, Gliten, Glitonea, Gliton,
Tyronoe, Thiten, cithara notissima Thiton.
Jlluc post bellum camblani uulnere lesum
duximus arcturum nos conducente barintho
equora cui fuerant et celi sydera nota.
Hoc rectore ratis cum principe uenimus illuc
et nos quo decuit Morgen suscepit honore
inque suis talamis posuit super aurea regem
stulta manu que sibi detexit uulnus honesta
inspexit que diu. Tandem que redire salutem
posse sibi dixit, si secum tempore longo
esset et ipsius uellet medicamine fungi.
Gaudentes igitur regem commisimus illi
et dedimus uentis redeundo uela secundis. |
L'Insula Pomorum, detta fortunata,
trae nome dal fatto che essa stessa produce ogni frutto:
non le occorrono coloni che solchino il suolo,
le manca il prodotto della cultura e possiede ciò che la natura
offre.
Produce spontaneamente cereali e uve abbondanti
e i meli nascono nei suoi boschi sull'erba ben rasa,
il suolo genera da sé ogni frutto in gran quantità al posto
dell'erba.
Là si vive per cent'anni e più.
Là nove sorelle, per diritto di stirpe, impongono le loro leggi
a coloro che dalle nostre parti arrivano presso di esse.
La prima di loro è dotta nell'arte del medicare
e supera le sorelle per la sua bellezza.
Morgen ha nome, e sa quali erbe adoperare
nella cura dei corpi malati.
A lei è nota anche l'arte col quale cambiare aspetto
e taglia l'aria con le ali come Daedalus.
Quando vuole è a Bristol (?), a Chartres o a Pavia (?)
quando vuole scivola giù dall'aria sulle vostre coste.
Dicono che abbia insegnato la matematica alle sorelle:
Moronoe,
Mazoe, Gliten,
Glitonea,
Gliton,
Tyronoe, Thiten,
Thiton, che è conosciutissima per
la cetra.
Là, dopo la battaglia di Camlann, portammo, leso da una ferita,
Arthur, e ci guidava
Barinthus,
al quale erano note le acque e le stelle del cielo.
Con lui che guidava le navi, portammo là il principe
e Morgen ci accolse con
l'ossequio che si conveniva,
e pose il re nel suo talamo, sopra un letto d'oro,
e con la sua mano scoperse l'onorevole la ferita
e l'esaminò a lungo. Alla fine disse che la salute
poteva tornargli se fosse rimasto a lungo
e avesse fruito delle arti curative di lei.
Gioiosi, le affidammo il re e
demmo le vele ai venti favorevoli per tornare. | |
Vita Merlini [-] |
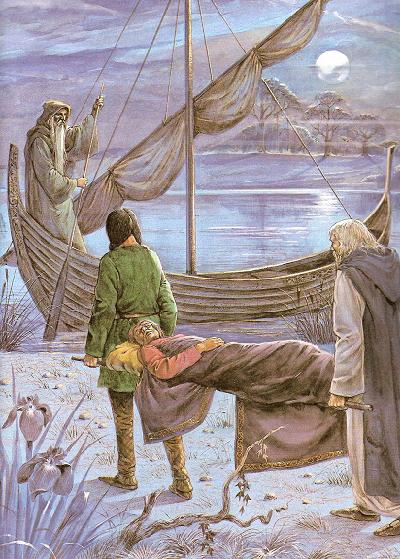 |
|
Arthur condotto ad Ynys Afaỻon |
|
Rifchard Hook, illustrazione. |
È la base di un mito noto e potente:
Arthur ap Uthyr che attende,
immortale, in Ynys Afaỻon il
momento in cui tornerà per strappare Ynys Prydain (la
Britannia) al dominio sassone, è stato un sogno accarezzato
per secoli dai patrioti gallesi. L'associazione tarda e
apocrifa della collina di Glastonbury Tor, nel Somerset, con la mitica
Afaỻon, sostenuta tra gli
altri da Giraldus Cambrensis nel Liber
de Principis instructione, e il presunto
rinvenimento di una tomba di Arthur,
nel territorio della vicina abbazia, la cui iscrizione,
incisa su una croce di piombo, riportava più o meno
«HIC
IACET SEPVLTVS INCLITVS
REX ARTVRIVS IN INSVLA AVALONIA»
...è la prova di quanto fosse avvertita come reale e incombente
la leggenda arturiana alla fine del XII
secolo. Il falso ritrovamento di quella tomba e di quella
croce permetteva ai
sovrani Henry II (♔ 1154-1189) e Richard
I Lionheart (♔ 1189-1199) di distruggere la
speranza dei Gallesi nel mitico brenhin
Arthur
che avrebbe messo fine all'occupazione sassone e normanna,
nonché al ristabilimento della regalità celto-britannica.
Ma tornando indietro, riconosciamo agilmente nella
Vita Merlini moltissimi dei
mitemi che abbiamo esplorato in questa pagina. Re
Arthur che attende, immortale, nella sua isola fuori dal tempo,
rimanda agli eroi greci traslati nelle Makárōn Nsoi...
e risalendo ancor più il flusso dei secoli, mutatis mutandis,
rimanda ai soliti
Ziudsura, Atraḫasîs e Ūtnapištî
nell'isola di Dilmun. Il nome
Ynys Afaỻon deriva in effetti dal gallese afaỻ
«melo», sebbene sia possibile che la lezione «isola dei meli» sia nata per associazione proprio con i frutti
d'oro del Kpos Hesperídōn. Si ritiene
anche, tuttavia, che Ynys Afaỻon sia un'alterazione di un originario
Ynys Afaỻach, «isola di Afallach»,
dal nome di uno dei re di Annỽfyn, l'oltremondo
della mitologia gallese, padre della stessa
Modron.
Modron e le sue
sorelle, figlie di Afallach, hanno probabilmente un corrispettivo nelle Hesperídes,
le nymphaí del tramonto, figlie di
Átlas, nel cui giardino crescano i krýsea mla
che rendono immortali. È uno di quei classici casi in cui gli
studiosi di mitologia celtica, una volta risaliti al
mito ellenico, si strofinano le mani soddisfatti, convinti di aver
trovato le origini del tema. E in questo caso ne hanno ben donde,
perché è anche attestata una fonte intermedia. Lo scrittore latino Pomponius Mela (❀
45 d.C.) riferisce una strana tradizione
gallica, riguardo a un culto praticato su un'isola posta sulla punta
della Bretagna francese, l'attuale Île-de-Sein:
| |
Nell'isola di Sena, posta nel mar britannico, davanti alla terra degli
Osismii, vi è un famoso oracolo, al quale attendono nove fanciulle
consacrate alla perpetua verginità: sono chiamate
Gallicenae, sono dotate di
singolare sapienza, sanno governare il mare e i venti con canti
magici e sanno trasformarsi in animali. Sanno sanare mali che altri
considerano incurabili e predire il futuro.
| |
Pomponius Mela: De
Chorografia [III: 6]
|
Tutto ciò è molto logico, ma bisogna notare che questa
affascinante presenza femminile nei giardini della vita e nelle
isole dell'immortalità, su cui insistono gli autori classici e
celtici, invano la cercheremmo nei miti mesopotamici di
Dilmun e del Pû-nārāti,
nel racconto ebraico del gan ʿĒḏẹn,
o nella tradizione islāmica delle città di Ǧābarsā e Ǧābalqā,
i cui abitanti, anzi, erano tutti maschi. Però, a sorpresa, ci
ricordiamo che gli alberi di giada e i peschi dell'immortalità che
crescono sul monte Kūnlún erano
accuditi da
Xīwángmǔ, la «regina
madre dell'occidente», circondata dalle sue yǜnǚ o
«fanciulle di giada». Inoltre, questi strani poteri di riuscire a
governare il mare e i
venti sono esplicitamente citati tra le capacità che gli
xiān acquistano mentre salgono i livelli del monte Kūnlún
(Huáinánzǐ [IV: 3]). Del resto, quando nei testi cinesi leggiamo
frasi come «A est di Kāimíng
stanno le wū [«sciamane»] Péng,
Dǐ, Yáng,
Lǚ, Fán e
Xiāng, che stringono tra loro la salma
di Yàyǔ; tutte hanno in mano
l'erba dell'immortalità per allontanare [il soffio della morte e
riportarlo in vita]» (Shānhǎi
Jīng [XI: 5]; Guō Pú), o come «A est
di Kāimíng le wū
Péng, Dǐ,
Yáng, Lǚ,
Fán e Xiāng
portarono il corpo di Yàyǔ
e tentarono di riportarlo in vita con l'elixir vitae»
(Hǎinèi Xījīng), il
pensiero corre subito a Morgen e alle
sue sorelle intorno al corpo di Arthur,
e il fatto di sapere che a Péng wū è
attribuita la creazione dell'arte medica (Shuōwén Jiězì)
conferma la nostra impressione.
①▼
Ma il tema delle meravigliose isole d'oltreoceano ha avuto un enorme
sviluppo soprattutto nella letteratura irlandese, dove le storie dei
viaggi per mare di eroi e santi in queste terre paradisiache è stato
addirittura codificato in un genere letterario: apposito quello
degli immráma o
«navigazioni», di cui gli esempi più noti sono l'Immram
Brain maic Febail (VIII sec.), l'Immram
Maele Dúin (X sec.) e la latina
Navigatio sancti Brandani (X sec.),
dove le meravigliose isole su cui sbarcano noíb Brandán
e i suoi monaci si succedono l'una all'altra.
La memoria corre subito alle
Alf layla wa layla, ai viaggi di
Eskander e, ancor più, di Sindbād
il marinaio. I viaggi oceanici di noíb
Brandán e di
Máel Dúin,
quegli immrama che tanta fortuna avrebbero avuto tra i mistici medievali,
rielaborarono quelle leggende marinaresche come itinerari
spirituali. Queste isole d'oltreoceano sono
descritte come luoghi di
letizia e di incanto, bellezza e nobiltà. In esse tutto è lieve e
dolce, non esistono né malattie né morte. Non c'è bisogno di arare
o seminare, perché tutto cresce a
profusione e gli alberi sono sempre carichi di frutti. È sempre
primavera e non vi sono mai gelate, né siccità. Nemmeno si
avverte lo scorrere del tempo e i secoli trascorrono in un soffio.
Queste terre meravigliose hanno molti nomi nella tradizione ibernica. I più noti
sono Tír na nÓg, la
«terra dei giovani», e Tír na mBeo, la «terra della
vita», poiché laggiù non esistono né
dolore, né angosce, né infermità, né
vecchiaia, né morte. La differenza, in termini soprannaturali, che queste
felici isole d'immortalità presentano con il nostro mondo caduco e
doloroso, è forse alla base
del loro altro nome, Tír nAill,
«l'altra terra». In esse, tutto è rimasto com'era all'età dell'oro,
mentre il resto mondo era fatalmente decaduto nell'età del ferro. Un altro nome
a esse collegato è
Emain Ablach, «Emain dei
meli», che la letteratura identifica con l'isola di Arran,
con ovvio rimando a Ynys Afaỻon.
Così la descrive un'antica quartina gaelica (±720 d.C.)
(Meyer 1895):
Cen bron, cen dubae, cen
bás,
cen na galar, cen indgás:
is ed Étargne
nEmnae
ní coimtig a
comamrae. |
Non affanni, non duolo, non morte,
non debolezze né malattie:
questo è il contrassegno di Emain
rara è una meraviglia eguale. |
|
Immram
Brain maic Febail |
 |
|
Oisín e Niam |
|
Jim Fitzpatrick (1952-), illustrazione (particolare). |
A volte questa terra d'oltreoceano veniva anche chiamata
Tír inna mBan, la
«terra
delle donne», poiché affascinanti messaggere venivano da essa per
chiamare e accompagnare gli eroi scelti per andarci a
vivere. Acconsentì all'invito Bran mac Febail,
il quale trascorse molto tempo in queste isole meravigliose tanto che, al suo ritorno in Ériu, scoprì che erano
passati diversi secoli dalla sua partenza (Immram
Brain maic Febail).
Anche il bardo Oisín, il figlio
di Finn mac Cumaill, venne
invitato a recarsi nel Tír na nÓg
da una bellissima fata, Niam Cinn Óir,
che lo condusse via, a cavallo, sulle onde del mare. E quando Oisín tornò
in Ériu, preso dalla nostalgia per il suo paese,
l'epoca degli eroi era ormai tramontata ed egli si accorse
di essere una sorta di gigante tra uomini divenuti di statura
normale. La bella Niam lo aveva avvertito
di non smontare mai da cavallo, ma quando egli
inavvertitamente lo fece, cedendo all'abitudine di
lavarsi le mani prima di entrare nell'antica reggia dei fíanna,
ormai in rovina, i secoli trascorsi gli
crollarono sul capo e il giovane
Oisín si trasformò
d'un tratto in vecchio avvizzito e cadente
(Laoidh Oisín air Thír na nÓg).
Ma ancor peggio toccò a Lóegaire
Líban mac Crimthainn, che tornato dal
Mag Mell, scese da cavallo e si
trasformò in polvere (Echtrae
Lóegairi). In queste terre oltremondane, infatti,
il tempo scorre in maniera diversa, e coloro che vi abitano
non si accorgono nemmeno dello scorrere dei secoli. Ma quando tornano
nella terra dei mortali, quando scendono
dalla nave o da cavallo, quando sfiorano la terra con il piede, il tempo, che hanno
magicamente ingannato e annullato, torna improvvisamente e
disastrosamente a rivendicare i suoi diritti. Alcuni nomi
dell'oltremondo sembrano di origine cristiana: è il caso del Tír na Sorcha,
la «terra di
luce», e del Tír Tairngiri, la «terra della
promessa». Rí di quest'ultimo luogo era Manannán
mac Lir, il cavaliere del mare crestato, che faceva spola con
il suo corach sul Mar d'Irlanda (oppure correva con il suo
carro sulle onde, che ai suoi occhi erano una pianura verde e
fiorita). E vi è ancora il Tír fo Thuinn,
la «terra sotto le onde», poiché
terre paradisiache si stendevano anche sotto la superficie del mare, come vedremo
tra poco. Nella
tradizione irlandese, tuttavia, il concetto delle fatate terre
dell'immortalità viene spesso integrato nella concezione stessa del territorio
ibernico. Come molti
studiosi hanno notato, l'isola di Ériu è trattata, nei testi
gaelici, come una imago mundi: Ériu assume i connotati
cosmologici dell'intero mondo abitato, circondato da ogni lato
dall'oceano (bíth o lér). Ogni volta che
nei testi mitologici irlandesi si parla di terre poste al di là dal
mare, quali le «isole settentrionali del mondo» dove le Túatha Dé
Dánann avevano acquistato la loro scienza druidica, o anche
quando che si tratta di luoghi perfettamente conosciute alla
geografia (come ad esempio la Grecia e la Spagna), dobbiamo pensare
a luoghi posti oltre il mondo, nell'aldilà, del tutto analoghi al
Kpos Hesperídōn.
In questo contesto,
affiora nei testi gaeliche il concetto di síd: le terre
meravigliose non si trovano soltanto oltre l'oceano, ma possono
trovarsi sul suolo stesso di Ériu, anzi, nel suo sottosuolo, all'interno delle colline che costellano il paesaggio
irlandese. Questa parola, síd, è forse derivante da
un celtico *sedos, «dimora», sebbene sia stata
anche
proposta una connessione con il latino sidus «costellazione»: si tratta comunque di una pura illazione, priva di
conferme.
Il mito ibernico,
pervenutoci in una fase già profondamente alterata dalla
interpraetatio christiana, ci narra che quando i
Clanna Míled, gli antenati dei
Gaeli, invasero Ériu, il popolo soprannaturale che abitava in
precedenza sull'isola, le Túatha
Dé Dánann (in cui riconosciamo le divinità del
pántheon celtico), lasciarono la superficie terrestre agli
uomini e se ne fuggirono nel sottosuolo, dove stabilirono il loro regno. Essi
crearono reami fatati
all'interno delle più belle colline e pianure di Ériu,
e in quei síde presero a condurre un'ininterrotta esistenza di gioia e letizia, banchettando, cacciando, amoreggiando e
ascoltando musica bellissima. Potevano persino soddisfare la loro
passione per la guerra, perché i feriti si svegliavano
all'indomani perfettamente guariti. Così gli uomini presero a chiamare questi
esseri daoine síde, la «gente delle colline fatate», o più brevemente
síde.
La mitologia irlandese è ricca di storie dove i daoine síde uscivano dai loro regni
invisibili per intervenire nelle
vicende umane, nel bene come nel male. E talora poteva anche capitare che degli uomini penetrassero
nei síde, a loro rischio e pericolo... o a loro eterna gioia.
Questa terra dentro la terra veniva
chiamata, a volte, Mag Mór,
la «grande pianura», o Mag Mell,
la «pianura del piacere», perché vi si viveva un'eterna vita
di delizie. I copisti medievali, su cui pesava la concezione del gan ʿĒḏẹn,
ereditata dalla cultura biblico-cristiana, associavano l'umana
condizione di caducità e mortalità al concetto di peccato. Di
conseguenza, nell'oltremondo, una vita di piaceri amorosi e di
ininterrotte mangiate non costituiva un peccato. Così Mídir,
signore del síd di Brí Léith, decantò
il proprio regno alla principessa
Étaín quando la invitò ad andare con lui.
A Bé Find, in rega lim,
i tír n-ingnad hi fil rind?
Is barr sobairche folt and;
is dath snechtai corp co ind.
Is and nád bí muí ná taí;
gela dét and; dubai braí;
is lí súla lín ar slúag;
is dath sion and cech grúad.
Is corcur maige cach muin;
is lí súa ugae luin;
cid caín déicsiu Maige Fáil
annam íar n-gnáis Maige Máir.
Cid mesc lib coirm Inse Fáil,
is mescu coirm Tíre Máir;
amra tíre tír as-biur;
ní tét oac and ré siun.
Srotha téithmilsi tar tír,
rogu de mid ocus ḟín,
doíni delgnaidi cen on,
combart cen peccad, cen chol.
Ad-chiam cách for cach leth,
ocus níconn-acci nech:
teimel imorbais Ádaim
dodon-aircheil ar áraim.
A ben, día rís mo thúaith tind,
is barr óir bias fort (chind);
muc úr, laith, lemnacht la lind
rot-bía lim and, a Bé Find. |
Donna radiosa, vuoi venire con me
nella magica terra dove sono le stelle?
Petali di primula son là le chiome
e il corpo tutto è color della neve
Là non c'è mio né tuo;
bianchi i denti, nere le ciglia.
Là è delizia per gli occhi la folta assemblea
e ogni guancia ha il colore della digitale.
Porpora il dorso di ogni pianura.
Delizia per gli occhi le uova del merlo.
Se bella da guardare è Mag Fáil [= Ériu]
è desolata per chi ha goduto il Mág Mór.
Se inebriante è la birra di Inis Fáil [= Ériu]
più inebriante la birra del Tír Mór.
Terra incantata è quella che racconto,
non vi muoiono i giovani prima dei vecchi.
Dolce, gentile, a ruscelli sul terreno,
il vino migliore e l'idromele.
Nobile popolo senza macchia
concepisce senza colpa né peccato.
Vediamo ciascuno ed ovunque
e nessuno ci vede.
La tenebra della colpa di Ádam
è impedimento ad essere scorti.
O donna, se vieni tra la mia gente altera
ti si porrà sul capo una corona d'oro;
fresca carne di porco, birra, latte e bevande
accanto a me avrai, mia radiosa signora. |
|
Tochmarc Étaíne |
Non è facile cercare una formula generale o una regola
che ci permetta di analizzare a fondo le concezioni irlandesi sui
síde o sulle isole oltremondane. I primi sono i
regni incantati posti all'interno delle colline irlandesi, i secondi
delle terre paradisiache poste al di là dal mare o
addirittura sotto il mare. Gli studiosi sono
convinti che gli uni e le altre originino dalle antiche concezioni celtiche
sull'aldilà. Sulle quali, tuttavia, sappiamo pochissimo. Jan De Vries le
riassume in due punti (De Vries 1961):
- Il defunto dimora nella sua tomba sottoterra. Probabilmente
in Irlanda si credeva che i morti rivivessero nei síde, e i síde,
prima di essere le colline fatate del folklore ibernico, erano
tumuli funerari.
- Il defunto dimora in un'isola oltre il mare. Al riguardo, vale
ricordare
sorprendente notizia di Prokópios Kaisareús (500- 562), secondo il quale i
popoli dell'Armorica traghettavano le anime dei loro
morti su un isolotto presso la costa (Hypèr tn polémōn
lógoi [VIII: 20, -]). Il mito irlandese ricorda Tech nDúinn,
la «casa di Donn», in un'isoletta presso la costa, dove i Gaeli
sarebbero andati dopo la morte.
Entrambe le concezioni sono illuminate dal nostro studio
comparatistico. In Grecia si distingueva tra il destino di coloro che scendevano
nella tomba e quello dei grandi eroi mitici destinati a essere traslati nelle
Makáron Nḗsoi. Come nota De Vries, dopo l'avvento del cristianesimo,
il popolo dell'oltremondo venne a diventare un
confuso intruglio delle più diverse specie di esseri
soprannaturali (De Vries 1961). Dai testi
pervenutici (tutti di epoca cristiana) sembrerebbe che nell'oltremondo
vivessero, l'uno accanto all'altro e quasi sullo stesso piano, gli antichi dèi,
le faeries e le anime
dei morti.
Ma sicuramente i Celti pagani distinguevano tra gli dèi,
i morti e i molteplici esseri soprannaturali che
popolavano il loro mondo. Sarebbe strano che i druidi non
avessero catalogato le proprie idee teologiche. Nel
Cath Maige Tuired (una
narrazione del ciclo mitologico) si dice che i
Fomóire vivevano nelle isole
intorno ad Ériu, sotto il mare e nei síde. E all'inizio
del Mesca Ulad (racconto del ciclo
dell'Ulaid), si dice chiaramente che quando le Túatha
Dé Dánann si ritirarono nei síde, assoggettarono
gli esseri che già vi abitavano.
Anche nelle leggende gallesi si parla di un fatato oltremondo,
accomodato secondo le concezioni cristiane. Il pendefig
Pỽyỻ si
reca ad Annỽfyn,
l'oltremondo della mitologia gallese, con la medesima naturalezza
come se
si recasse in un'altra regione del Galles (Pỽyỻ
penndevig Dyvet). Manaỽyddan fab
Ỻŷr
e i suoi uomini, tornati da Ynys Iỽerddon in Ynys Prydein (cioè dall'Irlanda
alla Britannia), banchettarono per ottant'anni, senza accorgersi del
passare del tempo (Manaỽyddan vab
Ỻŷr). In seguito, il mito della terra soprannaturale continua ad
eccheggiare nelle leggende arturiane, dai racconti dei Mabinogion
ai romanzi cortesi di Chrétien de Troyes, in cui
il cavaliere, viaggiando in cerca di avventure, si ritrova sovente in
giardini e castelli incantati.
Ma prima di perderci definitivamente in questa materia vasta e affascinante,
piena peraltro di fanciulle incantevoli, eternamente giovani e perfettamente
disponibili, dobbiamo concentrarci sul mito di cui stiamo analizzando gli esiti.
|
①▲ Secondo Guō Pú,
originariamente
Yàyǔ
aveva una testa umana e un corpo di serpente: dopo essere
stato riportato in vita, acquistò testa di drago e andò a
vivere nel [fiume]
Ruò
hé, dove divorava le persone. Il fatto che abbia un
nome omofono a quello del mostro ucciso da
Yì, potrebbe significare che costui lo
avrebbe incontrato mentre attraversava il
Ruò
hé per raggiungere il
Kūnlún. Si noti che il sesso degli sciamani[wū]
che riportano in vita
Yàyǔ
non è definito nel testo: è Riccardo Fracasso a presumere
che siano delle sciamane, nella sua traduzione dello Shānhǎi Jīng
(Fracasso 1996). |
|
| |
IN IRLANDA: IL TRAGICO DESTINO DEI FIGLI DI
TUIRENN Il popolo
irlandese ama le storie sorprendenti, meravigliose, antiche. Non
sorprende che, nell'ambito della vastissima letteratura
gaelica, quella di argomento mitologico occupi una parte
preponderante; un po' più stupisce forse il fatto che questa
letteratura, che ebbe il suo culmine nei secoli a cavallo del Mille,
continuò a essere prodotta da bardi, storici, antiquari, fin quasi
ai giorni nostri.
L'Oidheadh chloinne Tuireann, il «Tragico
destino dei figli di Tuirenn», è un racconto antico che ci è pervenuto
però in
versioni molto tarde. I circa dieci manoscritti che lo tramandano sono stati
tutti compilati tra il XVIII e la prima metà del
XIX secolo. La versione più
nota, su cui è basata la traduzione inglese di Eoghan Ó
Comhraí (Eugene O'Curry, 1764-1862), è quella
presente nella raccolta ottocentesca Trí
truaighe na sgéalaigheachta, i «Tre tormenti della narrazione»
(nel
Ms. Egerton
142,
oggi custodito al British Museum), in cui sono raggruppati
tre racconti appartenenti al genere dei destini tragici e delle
storie meste, definito in medio irlandese aided (in irlandese
classico e moderno oidheadh), in cui l'Oidheadh
chloinne Tuireann è contenuto con
altri due racconti di argomento
analogo: l'Oidheadh chloinne
Uislenn, il «Tragico destino dei figli di Uisliu», e l'Oidheadh chloinne
Lir, il «Tragico destino dei figli di Lér».
Che il racconto affondi tuttavia le sue radici nell'antichità è testimoniato
da un testo dell'XI secolo, l'Imthechta Tuirill ocus a Mac, le
«Peregrinazioni di Tuirell e dei suoi figli»,
che propone una versione piuttosto diversa della medesima vicenda.
(Botheroyd ~ Botheroyd 1992)
Ⓐ▼
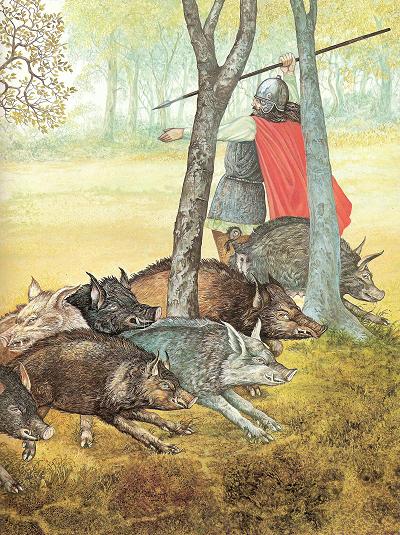 |
| Brian uccide Cían |
| Roger
Garland, illustrazione |
Il racconto si svolge all'epoca in cui i Gaeli non erano ancora
giunti in Ériu, e l'isola apparteneva ancora alla semidivine
Túatha Dé Danann, le quali la
contendevano tuttavia ai Fomóraig, il
popolo di predoni marini stanziati nelle isole circostanti. La
storia inizia con la rivalità tra due gruppi di tre fratelli: da una
parte vi erano i tre figli di Tuirenn:
Brian, Iuchar e
Iucharba. Dall'altra i tre figli di
Cáinte: Cian,
Cú e Ceithen.
Si detestavano e si portavano reciproco odio al punto che, non
importa dove si fossero incontrati, non avrebbero evitato una
contesa mortale. Un giorno capitò che Cian,
che si trovava da solo in Mag Muirthemne, vide arrivare i tre figli
di Tuirenn. Essendo da solo, si colpì
con la sua bacchetta druidica e si trasformò in un porco,
mescolandosi a un branco di suini. Ma Brian
mac Tuireann, avendolo riconosciuto, lo trafisse con la sua
lancia. Il maiale squittì con voce umana, chiedendo pietà. «È stato
un atto malvagio colpirmi, dal momento che mi avete riconosciuto.
Risparmiatemi!» Iuchar e
Iucharba si dissero disposti a
concedere a Cian grazia della vita, ma
Brian rifiutò: «Io non ti farò grazia!
Anzi, giuro sugli spiriti dell'aria che, anche se la vita tornasse
in te per sette volte, per sette volte te la strapperei!», e ancora
in forma di porco, Cian venne lapidato.
Ora, Cian era padre di
Lug, re ad interim delle
Túatha Dé Danann e loro
condottiero nel corso della guerra contro i
Fomóraig. Il radioso Lúg non
tarda a scoprire l'omicidio del padre e a identificare gli
assassini, additando i figli di Tuirenn
dinanzi a tutta l'assemblea danann, nella reggia di Temáir. Le due
parti sembrano arrivare però a un rapido accorto e si decide che
l'omicidio sarà riparato tramite il pagamento di un éiric,
sorta di ammenda o guidrigildo.
“Ecco quale sarà l'éiric che pretendo” dice
Lug ai figli di
Tuirenn. “Mi procurerete tre mele, la pelle di un maiale, una
lancia, un carro e due cavalli, sette maiali, un cucciolo, uno
spiedo e tre grida sopra una collina. Questo è il prezzo che
chiedo.” E poiché i figli di Tuirenn,
stupiti dall'esiguità dell'ammenda, non possono che accettarla,
Lug chiarisce le sue pretese:
- Le tre mele sono i pomi del gardh na-hIsbéirne, a est
del mondo. Hanno il colore dell'oro e il sapore del miele. A chi
ne mangia anche un solo morso guariscono le ferite e sanano le
malattie e, per quanto se ne mangi, non finiscono mai.
- La pelle è del maiale di Túis,
re di Gréige [Grecia]. La sua pelle è in grado di guarire
qualunque ferita e malattia, anche se l'uomo si trovi in fin di
vita, e l'acqua che vi viene filtrata dopo nove giorni diventa
vino.
- La lancia ha nome Aréadbhair e appartiene a
Pisear, re di Persia [sic].
Sceglie da sola il bersaglio e consente di compiere le più
grandiose imprese. La sua punta deve essere tenuta in un
calderone pieno d'acqua affinché il terreno su cui poggia non
bruci e la lancia non vi penetri al punto di non poter più
essere tirata fuori.
- I cavalli e il carro appartengono a
Dobar, re di Sisle [Sicilia]. La loro natura è tale che
corrono allo stesso modo tanto sulla terra quanto sul mare. I
cavalli, per quanto li si possa uccidere, il mattino dopo
ritornano integri, purché si faccia attenzione a non disperdere
o rompere le ossa.
- I sette maiali appartengono a Easal,
re delle Colomain Óir [«colonne d'oro»]. Anche se li si uccide
ogni notte, il giorno dopo sono più vivi di prima. Chiunque ne
gusti un solo boccone non conosce né malattia né infermità.
- Il cucciolo appartiene al re di Ioruadh. Il suo nome è
Failinis ed è in grado di
acchiappare qualsiasi animale.
- Lo spiedo da arrosto è uno di quelli che posseggono le donne
di Inis Fianchaire.
- E infine, le tre grida dovranno risuonare sulla collina di
Miodhchaoin a nord di Lochlann.
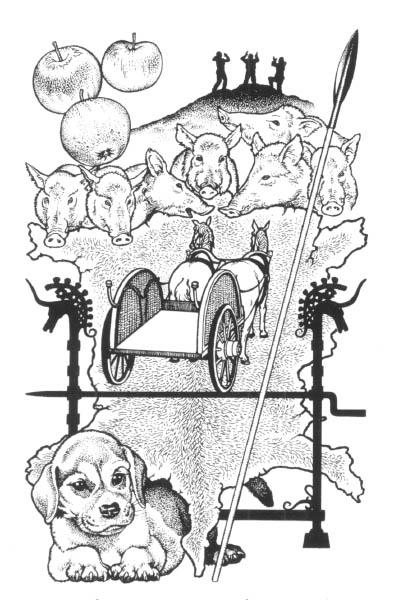 |
| Il prezzo della riparazione dei figli di Tuirell |
| Roger
Garland, illustrazione |
Nel suo classico libro sui miti e le leggende celtiche, Charles Squire dedica un
intero capitolo ai figli di
Tuirenn,
che definisce gli «Argonauti gaelici»
(Squire 1912).
Il malvezzo di trovare paralleli classici alle leggende nordiche o celtiche era
assai diffusa tra gli scrittori e gli studiosi della prima metà del Novecento,
forse nel tentativo inconscio di «nobilitare» la propria area di
interesse. Non si può comunque negare che, come gli Argonaûtai della leggenda
greca, anche i figli di
Tuirenn
viaggiano ai confini del mondo alla ricerca di oggetti straordinari, tra cui una
pelle di porco in grado di guarire qualunque malattia che non è molto lontana
dal chrysómallon déras (il «vello d'oro») del mito classico.
Tuttavia, il paragone di Squire è sbagliato. Le imprese dei figli
di Tuirenn, a ben guardare, sono una serie di «fatiche», esattamente
come quelle imposte a
Hērakls o a
Yì. Sebbene non vi sia, in
questo caso, da uccidere mostri, bensì da trovare oggetti portentosi
(cosa che richiederà in ogni caso un gran numero di feroci scontri
con guerrieri ed esseri soprannaturali), lo schema è esattamente
quello che avevamo già individuato nel caso del campione greco e
dell'arciere cinese. Gli eroi irlandesi, al pari degli altri,
vengono incastrati a causa di un delitto di cui si sono macchiati
(in questo caso l'uccisione di Cian),
sottoposti all'autorità di un sovrano (Lúg),
il quale li spedisce da un'estremità all'altra del mondo per
compiere imprese ai limiti delle forze umane.
L'antropologo Bernard Sergent ha dedicato uno studio alla comparazione del racconto delle imprese dei
figli di Tuirenn con il ciclo di
Hērakls,
utilizzando come medium le epifanie del dio avestico
Vǝrǝθraγna (Yašt
[XIV]) (Sergent
1999). Sfortunatamente, le sue comparazioni si basano
su elementi assai superficiali e tutto il
lavoro risulta assolutamente poco convincente. In realtà non c'è
alcuna ragione per ritenere, ad esempio, che la cattura di
Kérberos e quella del cagnolino di
Ioruadh si basino su un motivo comune,
o che al furto della mandria di Gēryṓn
corrisponda quella dei sette maiali di re
Easal. Non basta la presenza di un cane o una vaga idea di
«mandria» a stabilire un parallelismo. La mancanza di un
qualsivoglia schema, ma soprattutto l'enorme differenza funzionale
che rivestono gli animali e gli oggetti da recuperare, rendono
infondato qualsiasi tentativo di trovarvi una corrispondenza.
Non ha alcun senso imbastire una relazione tra la lancia di re Pisear
e la scena in cui
Hērakls si arma
per andare ad affrontare il leone di Neméa
(tanto più che la belva verrà strangolata a mani nude). E associare le donne sottomarine di Inis
Fianchaire con le Amazónes,
ovvero un gruppo di beansídhe soprannaturali con una comunità distopica di donne guerriere, vuol
dire ignorare l'intero contesto in cui si muovono i rispettivi
gruppi femminili.
In realtà le imprese dei Clanna Tuireann
sono state definite in base a finalità assai differenti che
non quelle di
Hērakls e di Yì.
Le «fatiche» dell'eroe greco e di quello cinese sono finalizzate a
sgombrare il mondo dai mostri che minacciano l'ordine cosmico.
Invece, nell'Oidheadh
chloinne Tuireann, l'elenco delle
richieste di Lúg trova la sua
giustificazione all'interno del mito gaelico, come ha ben sottolineato Charles Squire: tutti gli animali o gli oggetti
possono essere messi in corrispondenza con i tesori che la tradizione attribuisce alle
Túatha Dé Danann. Ad esempio, la lancia di
Pisear sembra essere tutt'uno con la
Sleá Bua, la «lancia di vittoria»
appartenente a Lúg, e il calderone in cui bisognava
immergerne la punta doveva essere il Coire an Dagdae,
che poi sarebbe stato dato al
Dagda Mór (ma giacché ci siamo possiamo
anche pensare al furto del calderone di Hymir
da parte di Þórr). Nella cagna Fáilinis
è forse da vedersi il segugio di Lúg, del
quale si diceva fosse in grado di compiere straordinarie imprese e in grado di mutare in vino ogni acqua corrente in cui si bagnava,
capacità qui trasmessa alla magica pelle di maiale di re
Túis. Il carro trainato da cavalli che correvano tanto sulla terra e sul mare,
appartenente al re delle Colomain Óir, rassomiglia a quello utilizzato da
Manannán mac Lir, che aveva la medesima
facoltà. I sette porci immortali del re di Iruadh devono essere gli
stessi con i quali Manannán avrebbe in seguito preparato il
«banchetto della vecchiaia», al tempo in cui le
Túatha Dé Danann sarebbero
scese nei síde per condurvi una vita immortale. Il racconto sembra dunque
il risultato del tentativo, da parte del narratore irlandese, di tracciare un
quadro più o meno completo di come le
Túatha Dé Danann fossero entrati in possesso dei loro
leggendari attributi clanici. (Squire 1910)
Vi sono solo due eccezioni: una è la pelle di porco di
Túis re di Gréig, dai poteri
taumaturgici, che non sembra essere attestata altrove nei miti
irlandesi: ma come vedremo è indispensabile nell'economia del
racconto.
L'altra eccezione, naturalmente, è costituita dalle mele d'oro
che i Clanna Tuireann dovranno
cogliere nel gardh na-hIsbéirne. Questo toponimo non è altro
che la trascrizione gaelica del Kpos Hesperídōn.
L'uso dell'espressione di origine greca, nel testo irlandese, ha
fatto naturalmente pensare che tutta la leggenda celtica sia
derivativa rispetto a quella ellenica: è probabile che, nel redigere
il testo, suo compilatore avesse in mente il mito di Hērakls
alla ricerca del giardino delle Hesperídes.
Tuttavia, come abbiamo visto, l'insieme delle «fatiche» compiute dai
Clanna Tuireann ha ben poco di
ellenico, e la descrizione del giardino esperidico che troviamo
nell'Oidheadh chloinne Tuireann
– dove le mele sono difesa da uomini armati e da tre principesse che
si trasformano in grifoni – diverge sostanzialmente da quella
fornita nel ciclo greco. Trovandoci in Irlanda, l'impresa di
recuperare le mele verrà compiuta da Brain
e dai suoi fratelli con la forza delle armi e l'impiego della magia
druidica. Il tema, in ogni caso, non è stato mutuato dalla mitologia
greca: il mito celtico conosceva già le isole paradisiache di
Emain Ablach e
Ynys Afaỻon, etimologicamente caratterizzate dagli alberi di
melo. È possibilissimo che il termine ellenico gardh na-hIsbéirne
sia solo una copertura colta, eseguita in epoca tarda, su un
tema originariamente celtico al cento per cento.
I figli di Tuirenn sanno bene che, nel
porre tali richieste, Lug mira a
ottenere la loro morte. Ma anche questo fa parte dello schema: Eurysteús nutre la medesima
speranza quando invia Hērakls
a compiere i suoi érga. L'unica richiesta che
Brian e i suoi fratelli pongono a
Lug, su consiglio dello stesso
Tuirenn, è che conceda loro lo
Sguaba Tuinne, il curach di
Manannán mac Lir. Anche tale richiesta
è perfettamente in linea con il complesso di miti che abbiamo
analizzato, sebbene il redattore dell'Oidheadh
chloinne Tuireann ne sia ignaro. Poiché i
Clanna Tuireann dovranno
muoversi nelle acque oltre il mondo e, come sappiamo dallo Ša naqba īmuru,
solo il dio-sole è in grado di attraversare gli oceani cosmici, i
tre fratelli hanno bisogno di una imbarcazione appropriata.
Equivalente gaelico di Uršanabi,
Manannán mac Lir, il «figlio
dell'oceano» [lér], è l'unico nocchiero capace di compiere il
tragitto tra la terra degli uomini e le isole d'oltremondo. Lo
Sguaba Tuinne corrisponde alla
coppa d'oro che
Hērakls ottiene
dal dio-sole Hḗlios.
È interessante che sia proprio a Lug
che Brian e i suoi fratelli
richiedano il curach di Manannán.
Vi sono due ragioni. La prima è esplicita: nell'Oidheadh,
Lug è il figlio adottivo di
Manannán, cresciuto nel
Tír Tairngiri. Se sarà lui a fare la
richiesta al suo padrino, questi non gliela rifiuterà (e peraltro
lo stesso
Lug viene vincolato con una geis).
La seconda è più sottile: molti studiosi ritengono, sulla scolta
delle interpretazioni astrali che andavano tanto di moda ai primi del Novecento, che
Lug sia stato un dio solare. La
faccenda in realtà è piuttosto delicata: sebbene il nome di
Lug derivi da un celtico *leuk
«luce», nei testi irlandesi egli riveste ampie funzioni tecniche,
regali e guerriere, presentandosi come un personaggio
multifunzionale: ma non è mai presentato come un dio solare. Fa eccezione un
testo: il nostro
Oidheadh chloinne Tuireann, appunto, dove l'arrivo di
Lug da ovest, alla testa delle schiere
danann, viene scambiato dai Fomóraig
per il sorgere del sole:
Is annsin d'éiriꞍ̇ Breas mac Ḃalair, agus a
duḃairt: «Is iongnaꝺ̇
liom» ar se, «an Ɥ̇rian ag éirꞍ̇e a n-iar a n-diu agus a n-oir
gaċa
laoi eile.»
«Ꝺob' ḟeárr go m-buꝺ̇ í,» ar na draoiṫe.
«Sreud eile» ar se.
«Ꝺealraꝺ̇ aigṫe LóꞍ̇a Láṁḟada» ar
siad. |
Si levò allora Breas mac Ḃalair e
disse: «Mi meraviglio che il sole oggi sorga a ovest e non a est
come ogni altro giorno».
«Sarebbe stato meglio così» dissero i druidi.
«Cosa potrebbe essere?» chiese lui.
«È il fulgore dal volto di Lug Laṁḟada»
risposero. | |
Oidheadh chloinne Tuireann [19] |
Sebbene non sia affatto certo che l'autore dell'Oidheadh
chloinne Tuireann abbia correttamente interpretato la
natura del dio gaelico Lúg, la vicenda
incastra i suoi simboli con molta accortezza. Come
Hērakls richiede
al dio-sole Hḗlios la sua coppa d'oro
per attraversare il potamós Ōkeanós,
così i Clanna Tuireann si
rivolgono al «solare» Lúg per ottenere
il curach del suo padrino, Manannán mac
Lir, unico nocchiero in grado di attraversare il lér,
l'oceano cosmico, e giungere alle isole dei beati.
La ricerca degli oggetti richiesti comprende buona parte del
testo dell'Oidheadh chloinne Tuireann.
È una serie di viaggi da un confine all'altro del mondo, con gran
copia di travestimenti, scontri, fughe, avventure e imprese
erotiche. Il tutto si svolge in un contesto geografico fantasioso
in cui nessuno dei luoghi in cui si spingono i figli di
Tuirenn ha la minima pretesa di
realismo. Bernard Sergent ha cercato schemi
comuni
tra l'itinerario di Hērakls
e quello dei figli di Tuirenn, senza
trovare nulla di significativo
(Sergent 1999). Il problema è che lo
schema dei viaggi di
Hērakls è
assai semplice: i primi sei érga si svolgono nel
Peloponneso; i rimanenti sei abbracciano il resto del mondo, di cui
l'eroe tocca gli estremi confini nelle quattro direzioni. Nel tragitto dei Clanna
Tuireann le località sembrano scelte con meno rigore, ma
anche qui vi sono luoghi che sembrano trovarsi nei quattro punti
cardinali. Le Colomain Óir, «colonne d'oro», il luogo dove i
Clanna Tuireann vanno a prendere
la cagnolina di re Éasal, sembrano
essere un ricordo delle Hērákleioi stlai, le
«colonne di
Hērakls», ma è
difficile capire se si tratti di un residuo della concezione delle
portae mundi o di un motivo ricalcato dal mito greco.
È davvero sorprendente l'episodio in cui i tre fratelli si recano nel luogo chiamato
Inis Fianchaire, «isola della bella
Cáer», per prendere lo spiedo richiesto da Lúg.
Di quest'isola tratta il Lebor Laignech,
che la chiama più precisamente Inis Chairé Chennfinné «isola
di Cáer dalla bella testa» (nel senso di «bella chioma») e
aggiunge che tale «isola» si trovi in realtà sul fondale marino, tra Ériu e Alba. Brian indossa un casco di
vetro prima di immergersi, in una sorta di «viaggio verticale»
simile a quello di Gilgameš, ma che
ancor più ricorda un'affine immersione di
Aléxandros in alcune versioni del suo ciclo. L'isola sul
fondo del mare è abitata da donne bellissime, le quali concedono di
buon grado a Brian lo spiedo richiesto,
avvertendolo che, in ogni caso, lui non sarebbe mai stato in grado
di sottrarlo loro con la forza. Si noti che nell'Imthechta Tuirill ocus a Mac
(le
«Peregrinazioni di Tuirell e dei suoi figli»), versione medio-irlandese della
leggenda, è proprio a Inis Fianchaire che
vengono colte le mele dorate.
Lúg è ben soddisfatto di ottenere
tutti i tesori che ha richiesto: li utilizzerà nella battaglia
contro i Fomóraig. L'éiric è
tuttavia incompleto: Brian,
Iuchar e Iucharba
devono soddisfare un'ultima richiesta: lanciare tre urla sulla
collina di Miodhchaoin. Come i tre
fratelli capiscono fin troppo bene, quelle urla hanno come unico
scopo
la loro morte. Infatti, Miodhchaoin e i
suoi figli sono vincolati da una geis per la quale non devono
permettere a nessuno di lanciare delle grida da quell'altura.
“Presso Miodhchaoin mio padre
Cian ha ricevuto l'istruzione
guerresca; anche se io vi perdonassi la sua morte, egli non ve la
condonerebbe mai!” li avverte Lúg. “Laggiù
si compirà su di voi la mia vendetta.”
Tutto avviene come Lúg ha predetto.
Mortalmente feriti dallo scontro con
Miodhchaoin, i tre fratelli tornano in Ériu e implorano
Lúg di concedere loro la pelle di porco
in grado di guarirli dalle ferite. Lúg
risponde sprezzante che non
la consegnerà per tutta l'estensione della terra, a meno che non sia certo che la morte sarebbe comunque arrivata a ghermirli, e questo
per ripagarli del crimine che hanno commesso. Così i tre fratelli spirano, e
il padre Tuirenn con loro.
Ma chi sono i figli di Tuirenn? Che
legame hanno con
Hērakls o con
altri eroi dello stesso ceppo? Pur non essendoci una risposta netta
e precisa, gli indizi sono piuttosto interessanti. Il nome
Tuirenn deriva infatti da un celtico *torann,
«tuono». È dunque etimologicamente corrispondente ai nomi di alcuni
degli esiti del dio-tuono indoeuropeo: il gallico
Taranis, lo scandinavo
Þórr, l'anatolico
Tarḫunta. Tra le figure omologhe vi sono ovviamente il
greco
Hērakls e il
vedico Indra. Il personaggio di
Tuirenn è tuttavia poco elaborato
nel mito irlandese e nessun mito incentrato su di lui può
essere messo in correlazione con quelli relativi al dio-tuono
indoeuropeo. Un caso a parte è però rappresentato dai suoi figli: Brian,
Iuchar e Iucharba. L'emanazione
del dio-tuono in un gruppo triplice è ben noto agli indoeuropeisti,
presentando molti paralleli ben precisi. I
Clanna Tuireann
stanno a Tuirenn come i tre
Horatii stanno a
Tullus Ostilius, o come Eka,
Dvita e Trita Āptya
stanno a Indra. Ma tratteniamoci: stiamo
cascando in un campo assai dispersivo, che dovrà essere
analizzato separatamente.
I testi genealogici parlano di un certo Delbáeth mac Ogma detto
Tuirell Bícreo, il quale sarebbe stato tra l'altro
árd rí di Ériu. Su costui, il Lebor Gabála
Érenn, il «Libro delle invasioni di Ériu», ci fornisce una
serie di interessanti genealogie:
| I sei figli di Delbáeth
figlio di Ogma figlio di
Elatha figlio di Delbáeth figlio di
Nét furono Fíachra,
Ollam, Indui,
Brian, Iucharba e
Iuchar. Danann, la
figlia dello stesso Delbáeth, fu madre degli ultimi
tre, Brian, Iucharba e
Iuchar. Questi furono i tre dèi di
Danann [Trí Dée Danann]
dai quali si chiama la montagna dei tre dèi. E quel
Delbáeth aveva nome Tuirell Bícreo. |
| Lebor Gabála Érenn [64] |
In questo passo
si configura anche una relazione incestuosa: madre di
Brian, Iucharba e
Iuchar è
Danann, figlia anch'essa di
Tuirell Bícreo. Dunque i tre fratelli, qui chiamati Trí Dé Danann, «i tre dèi di Danann»,
sarebbero figli della loro sorella.
Anche lo storico e mitografo Seathrún Céitinn [Geoffrey Keating],
nella sua monumentale opera storica, conferma la discendenza dei
Clanna Tuirell da Danann,
anch'egli definendoli Trí Dé Danann, e afferma che le stesse
Túatha Dé Danann avessero
tratto il loro nome proprio dai tre figli di Danann. Insomma
Brian, Iucharba
e Iuchar sarebbero stati
talmente abili ed esperti in tutte le arti druidiche che l'intero popolo delle
Túatha Dé Danann non
avrebbe disdegnato di chiamarsi così per via dei suoi tre membri illustri.
|
Adeirid drong re seanċus gurab ó'n triar mac
rug Ꝺanann, inꞍ̇ean Ꝺealḃaoiṫ, eaꝺ̇on, Brian, Iuċar, agus Iuċarḃa, eaꝺ̇on, triar
do ċlainn Ꝺealḃaoiṫ [...], gairṫear Túatha Ꝺé Ꝺanann,
do ḃríꞍ̇ go raḃadar an
triar reaṁráiꝺ̇te coiṁ-ꝺ̇earsgnaiꞍ̇ṫe a's sin i
gcéardaiḃ geintliꝺ̇e, gur ṫoil leis
na tuaṫaiḃ seo ag a raḃadar dée do Ɥ̇airm díoḃ, agus
iad féin d'ainmniuꞍ̇aꝺ̇ uaṫa. Ag so rann deismireaċta ag a ꝺ̇eiṁniuꞍ̇aꝺ̇
gurab iad an triar so na trí Ꝺée Ꝺanann,
aṁail adeir an duain darab tosaċ ÉistiꞍ̇ a eolċa gan on &c... |
Alcuni eruditi dicono che è dai tre figli di
Danann figlia di Delbáeth
che le Túatha Dé Danann presero il loro
nome, e cioè Brian, Iuchar
e Iucharba, i tre figli di
Delbáeth [...]. La ragione è che i suddetti tre erano così esperti nelle
arti pagane, che quelle tribù con le quali vivevano li chiamavano dèi, tanto che
presero nome proprio da loro. In questi versi è attestato che questi tre furono
i tre dèi di Danann [Trí
Dé Danann], come dice anche quel poema che inizia con le parole,
«Ascoltate, o voi istruiti senza biasimo»... |
|
Seathrún Céitinn [Geoffrey Keating]:
Foras feasa ar Éirinn [II: 10] |
Céitinn riferisce quest'origine dell'etnonimo
Túatha Dé Danann per
dovere di cronaca, insieme ad altre possibili «etimologie». «Tra tutti, [i figli di
Tuirenn] erano gli uomini
giudicati migliori per destrezza e agilità, i più belli e più onorati tra quanti
si trovavano allora a Temáir» conferma d'altronde l'Oidheadh
chloinne Tuireann. Sembra tuttavia piuttosto strano che un intero
pántheon prenda nome da tre suoi membri, per quanto abili e illustri. È più
probabile che l'etimologia vada girata in senso opposto.
Danann, come maldestramente attestano altre fonti, dovrebbe essere stata una sorta di dea clanica delle
stesse
Túatha Dé Danann. Il fatto che Brian,
Iuchar e Iucharba
siano chiamati con epiteto teoforo dal nome di questa dea, potrebbe indicare un
loro rapporto particolare con essa. Viene in mente la relazione di
Hērakls con la dea
Hḗra, sua madre mancata e avversaria politica, di cui
tuttavia porta il nome. La vicenda dell'Oidheadh
chloinne Tuireann appare lacunosa sotto molti punti di vista: non
vengono per esempio narrate le ragioni che opponevano i figli di
Tuirenn ai figli di
Cáinte, che forse avevano avuto una
maggiore importanza nell'originaria mitologia dei Celti insulari, e
in proposito gli studiosi hanno presentato interessanti ipotesi (una
semplice faida tra clanna (Rolleston 1911)?
un'antica disputa sulla sovranità tra due rami della stessa famiglia
divina
(Agrati ~ Magini 1993)?) La relazione tra i Trí
Dée Danann
e le
Túatha Dé Danann, al di là dell'etimologia
popolare per la quale i secondi avrebbero preso nomi dai primi, non
è stata ancora spiegata in maniera soddisfacente. Non dimentichiamo,
inoltre, che in passato esistevano altre versioni della vicenda. Nel più antico Imthechta Tuirill ocus a Mac,
Brian,
Iuchar e Iucharba
risarciscono Lug recandogli
puntualmente tutti gli oggetti magici richiesti, e la narrazione
non si conclude con la loro morte, né con quella di loro
padre Tuirell/Tuirenn
(Botheroyd ~ Botheroyd 1992). D'altra parte, gli
Annála Ríoghdhachta Éireann ci
informano che
Delbáeth mac Ogma (cioè
Tuirell/Tuirenn) regnò per
dieci anni, quale árd rí di Ériu, dopo la morte di
Lug e del
Dagda Mór, e che in seguito cadde per
mano di un altro suo figlio, Fiachra mac Delbáeth, il quale gli
succedette a Temáir per altri dieci anni. Invece, Seathrún Céitinn riporta il passo di un poema gnomico
di Flánn Mainstrech, anch'esso tratto dal
Lebor Gabála Érenn,
in cui si legge che i figli di Tuirenn morirono per mano di
Lug a Mana
[l'isola di Man].
Brian, Iuċarḃa, is Iuċar ann,
trí dée Túaiṫe Ꝺé Ꝺanann;
marḃ iad ag Mana os muir meann,
do láiṁ LóꞍ̇a, mic Eiṫneann. |
Brian,
Iuchar e Iucharba,
tre dèi delle
Túatha Dé Danann;
furono uccisi a Mana sopra il gran mare
per mano di Lug figlio di
Ethné. |
Flánn
Mainstrech apud
Lebor Gabála Érenn
[64]
apud Seathrún Céitinn [Geoffrey Keating]:
Foras feasa ar Éirinn [II: 10] |
In conclusione, nonostante nella leggenda dei figli
di Tuirenn si riconoscano alcuni dei
temi principali del mito della ricerca della vita, bisogna ammettere
che la materia è alterata al punto tale da rendere impossibile
confronti più netti e dettagliati.
|
|
TAGLI, RITAGLI E FRATTAGLIE Tutta
la materia disponibile, a nostro avviso, è stata esposta. A quanto
sappiamo, non esiste – in altre culture o sistemi mitici – alcuna
evidente traccia dell'esistenza del mito del viaggio di un eroe ai confini del
mondo, alla ricerca della vita eterna. Ma prima di arrivare a una
sintesi, sarà necessario vedere se non si riesca a rintracciare
qualche altro frammento del nostro antico tema nella mitologia
eurasiatica.
India
Il mondo indo-iranico, pur nel suo immenso sviluppo mitologico,
non ci offre nulla di evidente, ma forse il tema è solo ben
mascherato. In tal caso, future ricerche potranno forse riuscire a svelarlo. In
India, il dio-tuono Indra – che pure è
un noto omologo di Hērakls
e Þórr – sembra estraneo al nostro
tema. Un margine di dubbio rimane su Trita
Āptya, una figura antica e piuttosto sbiadita,
le cui funzioni stavano già passando a Indra
nella letteratura vedica. Nel Ṛgveda è citato
innanzitutto come
compagno e sodale di Indra nella lotta
contro il serpente Vṛtra
[VIII: 7, ]. Tra le imprese eraclee
che lo riguardano, vi è un furto di buoi compiuto ai danni del
tricefalo Viśvarūpa, figlio di
Tvaṣṭṛ, mito omologo a quello del furto
delle mandrie di Gēryṓn
[VIII: 8, - | 99, ],
e l'uccisione di un demoniaco cinghiale [VIII:
99, ]. In altri inni, Trita
viene deputato alla preparazione e purificazione del soma, la bevanda
inebriante e d'immortalità [II: 11, | IX:
34, ]. Nei Brāhmaṇa, Trita
(cioè il «terzo»), viene esplicitamente indicato come l'ultimo di
tre fratelli, dopo Eka e
Dvita («primo» e «secondo»): i tre sono
detti figli di Agni e nati dalle acque
[āptya]
(Śatapatha Brāhmaṇa [I: ii, 3, ] |
Taittirīya Brāhmaṇa [III: ii, 8, -]). È anche
attestato un fallito tentativo di Eka e
Dvita di uccidere
Trita, che venne gettato in un pozzo pieno d'acqua. Il
racconto viene esposto da Sāyaṇa († 1387) nel suo commentario a
Ṛgveda [I: 105]. Se l'espansione
eroica del dio-tuono in una emanazione triplice è, come abbiamo
detto, ben fondata nella mitologia indoeuropea (pensiamo ai
Clanna Tuirenn), il mito del
tentativo di omicidio dei fratelli maggiori ai danni del minore si iscrive invece in un motivo fiabesco
assai comune e non ha probabilmente nulla a che vedere con i delitti
e le crisi eroiche narrati in queste pagine.
Sebbene la mitologia vedica non attesti alcun mito che sia
direttamente confrontabile con il nostro tema, l'epica indiana
conosce bene il motivo della sorgente della vita. La professoressa
Aleksandra Szalc elenca molti loci dove questo tema si
presenta con insistenza. È il caso ad esempio dell'erculeo
Bhīma, eroe che abbiamo già citato come
prototipo indiano del «guerriero con la clava»; in un episodio del
ciclo dei Paṇḍāva, mentre ascende sul
mitico monte Kaylasa,
Bhīma arriva a una sorgente di acque
dal gusto celestiale, ma i rākṣasa di guardia al laghetto gli
impediscono il passaggio ammonendolo con le parole: “gli uomini soggetti alla morte
non possono bere quest'acqua” (Mahābhārata
[III: 152]). Questo racconto è compreso
nel Tīrthayatra
Parva, un capitolo del Mahābhārata
dove si elenca un gran numero di sorgenti, laghi, fonti
e pozzi meravigliosi che conferiscono immortalità e giovinezza a chi vi si
bagna.
Il tema compare anche nella letteratura posteriore: in una
collezione di storie fantastiche risalente al
IX
secolo, si narra la storia del bodhisattva
Vintimatī, che ritorna in vita dopo che
il suo cadavere è stato spruzzato con un'acqua magica
(Kathāsaritsāgara [72]). (Szalc
2012). In un vecchio articolo assai tradotto e ristampato,
Ānanda Kentiś Kumāraswāmī presentava una vasta favolistica, diffusa nell'India
settentrionale, dove le sorgenti dell'acqua della vita erano
custodite da un personaggio chiamato Khvāja
Khadir, Pir Badar o
Rāja Kidār. Questi altri non è che una
versione orientale del
buon vecchio
al-Ḫiḍr/Ḵeżr,
il cui culto – stando al discusso tradizionalista śrīlaṅkese – era
noto tanto a indù quanto a musulmani nel Paṃjāb pākistāno, nel
Bihāra e, in misura minore, nel Bāṃlādeśā. In alcune di
queste storie, la sorgente era legata alle nāginī,
esseri ofidomorfi femminili della mitologia indù. (Kumāraswāmī
1934)
Armenia
Scarse le tracce del nostro tema presso gli Armeni,
dove esisteva un ciclo sull'eroe
Vahagn, una sorta di eracle locale, anch'esso uccisore di
mostri e destinato all'apoteosi, secondo quanto afferma Movsēs
Korenac‘i:
|
Zays
ergelov omanc‘ p‘andṙamb, lowak‘ merovk‘ isk akanǰōk‘. Yet oroy
ew ǝnd višapac‘ asēin yergin kṙowel nma ew yałt‘el, ew kari imn
nmanagoyns zHerakleay nahatakowt‘iwnsn nma ergēin. Ayl asen zsa
ew astowacac‘eal. ew andri i Vrac‘ ašxarhin zsora č‘ap‘ hasakin
kangneal; patowēin zohiwk‘. |
Si cantavano i suoi elogi al suono del pampiṙn e
noi li udimmo con le nostre orecchie. Quindi si ripetevano nei
canti le sue battaglie, le sue vittorie contro i višapac‘, e
imprese che uguagliano quelle di Hērakls.
Si diceva che fosse stato innalzato al rango degli dèi e che,
nel paese degli Iberi,
gli innalzarono una statua alla quale venivano tributati
sacrifici. | |
Movsēs
Korenac‘i:
Hayoc‘ Patmowt‘yown
[31d] |
Poche altre notizie Movsēs riferisce su
Vahagn,
nel quale riconosciamo una versione armena del dio iranico
Vǝrǝθraγna:
riporta un canto sulla sua nascita – praticamente l'unico
documento del paganesimo armeno arrivato fino a noi –, ma non ci
illumina sul nostro tema. Quello che qui ci interessa è la relazione
che Movsēs imbastisce tra
Vahagn ed Hērakls,
giustificata da una serie di imprese che eguaglierebbero quelle
dell'eroe greco, tra cui le sue battaglie e le sue vittorie contro i
višap («serpenti, draghi»). Possiamo chiederci se alcune
di queste leggende riguardassero il viaggio dell'eroe verso una
qualche versione locale del
Kpos Hesperídōn.
Particolarmente significativa la notazione secondo la quale
Vahagn sarebbe stato «innalzato al
rango degli dèi», tanto che gli Iberi [Vrac‘] avrebbero
fondato un culto su di lui. Tale notizia farebbero pensare a un
percorso dell'eroe armeno verso l'apoteosi, analogo a quello di
Hērakls. Se la notizia di Movsēs
Korenac‘i corrisponde a un mito armeno – se cioè non è stata
condizionata da un'interpretazione a posteriori modellata sul mito
greco – possiamo pensare che il declassamento del dio-tuono a
hēmítheos, di cui abbiamo registrato l'esito in Grecia,
possa essere un mito più antico, non limitato al mondo ellenico ma
con un'ampia area di difufsione
Russia
Nel processo di cristianizzazione, il mondo slavo ha operato una
cesura talmente netta con la tradizione precedente, che quasi tutta
la sapienza pagana è andata perduta. Ci rimangono solo pochi nomi di
divinità (Perunŭ,
Svarogŭ, Dažĭbogŭ,
Stribogŭ,
Chŭrsŭ, Volosŭ,
Mokošĭ...) a cui accennano le fonti
cristiane al solo scopo di condannare chiunque indugiasse nella
riprorevole pratica della dvoeverie (la «bicredenza» in cui
viveva parte della popolazione fino a tempi recenti).
Scomparsi quasi del tutto i miti precristiani, moltissimi elementi
sono però sopravvissuti nel folklore, nelle fiabe e nelle ballate
epiche, di cui soprattutto la Serbia e la Russia si sono rivelate
essere dei serbatoi inesauribili. Certamente sbaglieremmo a cercare
una forma completa e coerente del nostro Ur-Myth: rimangono
però, incagliati nelle tradizioni slave, alcuni elementi importanti
e interessanti che rimandano ai mitemi di cui abbiamo parlato in
questa pagina.
 |
| Michajlo Potyk
(✍ 1908) |
| Nikolaj Nikolaevič Karazin (1842-1908), dipinto |
In Russia, in particolare, tanto il patrimonio delle fiabe (skazki)
quanto quelle delle ballate epiche (byliny) presenta il
tema ricorrente della živaja voda, l'«acqua viva», che non
è esattamente un medium di immortalità ma si immette nel
medesimo ordine di idee: è infatti in grado di resuscitare chiunque
ne venga a contatto. Un buon esempio di questo tema lo troviamo
nella lunga e articolata bylina incentrata sull'eroe epico
Michajlo Potyk. Il giovane
bogatyr' («cavaliere») prende in sposa una fanciulla
che è anche una strega, l'inquietante
Mar'ja lebed' belaja («bianco cigno»). Lei lo
vincola con un giuramento: se uno dei due coniugi morirà per primo,
il superstite dovrà seguirlo nella tomba. Mentre
Michajlo è assente, lontano per
conto di Vladimir, knjaz' di Kiev e della Svjataja Rus',
gli arriva la notizia che Mar'ja
lebed' belaja è deceduta. L'eroe torna al galoppo a Kiev e
ordina che lo calino vivo nella tomba (con tutto il cavallo) insieme al cadavere della moglie.
Mentre Michajlo attende nel buio sepolcro, s'intrufola all'interno
uno zmej, un drago-serpente che le sovente le
fiabe russe descrivono policefalo e
in grado di volare. Non appena lo zmej vede il cadavere della
donna, a cui si aggiunge un cristiano vivo, si fa avanti per
divorarli. Svelto, Michajlo lo agguanta con un paio di tenaglie e lo
comincia a colpire con una verga di ferro. Lo zmej implora
pietà. “Aj, tu, Michajlo Ivanovič, non mi battere, non ricoprirmi di
sangue, ti porterò la živaja voda!”. Michajlo prende in
ostaggio gli zmenyši, i «serpentelli», figli dello zmej,
e ordina a quest'ultimo di recargli quanto ha promesso. Il rettile
assolve al suo compito. Torna una fiaschetta nella quale è contenuta
la živaja voda. Michajlo
uccide uno degli zmenyši e poi lo cosparge con il liquido.
L'animaletto resuscita. Rassicurato,
Michajlo spruzza l'acqua viva sul corpo di
Mar'ja lebed' belaja e la
sua sposa torna in vita. Allora Michajlo
tira una corda che aveva precedentemente collegato alla campana
della chiesa: il segnale concordato fa sì che la tomba venga aperta,
permettendo a lui e alla sua sposa di uscire.
(Byliny > Michajlo Potyk).
Il patrimonio fiabesco russo, che ha la sua principale fonte nella
splendida raccolta Narodnye russkie
skazki (1855-1863), di Aleksandr Nikolaevič Afanas'ev
(1826-1871), presenta a più riprese simili temi arcaici. Nelle
skazki, alla živaja voda, l'«acqua viva», è spesso
collegata la mertvaja voda, l'«acqua morta». Di solito
entrambe le «acque» vengono impiegate in successione in caso di
necessità: «Spruzzò Ivan carevič
con l'acqua morta e le sue ferite guarirono; lo spruzzò con l'acqua
viva e Ivan carevič
sorse in piedi» [168: Skazka ob
Ivane-careviče, žar-ptice i o serom volke] è la formula
canonica nell'uso di queste vody soprannaturali.
Il folklorista sovietico Vladimir
Jakovlevič Propp (1895-1970) si è chiesto perché, in tali
operazioni, non basti semplicemente l'«acqua viva» per resuscitare
l'eroe ucciso, ma sia necessario bagnarlo con tutt'e due le vody. Ne
dà un'interpretazione assai suggestiva: nelle skazki queste
operazioni di resurrezione vengono si solito compiute in un contesto
liminale, in cui l'eroe o l'eroina non sono né morti né vivi,
suscettibili dunque di tornare alla vita come revenant o
come vampiri. L'acqua morta provoca il trapasso definitivo dal mondo
dei vivi a quello dei morti, l'acqua viva permette il passaggio
inverso (Propp 1972). Noi, dal
punto di vista comparatistico, pensiamo piuttosto alla māʾ al-ḥayāt,
l'«acqua della vita» delle leggende arabe, e alle mê mūti,
le «acque della morte» dell'epopea di
Gilgameš, e ci stupiamo del fatto che i due temi trovino una
loro naturale simmetria proprio nelle skazki russe. Secondo
Propp, lo zmej è il guardiano dei passaggi per l'altro
mondo: ma non ce ne voglia il grande folklorista sovietico se
riteniamo, alla luce di tutto quello che abbiamo analizzato fin qui, che nello zmej
russo si riuniscono due valenze tradizionali legate al serpente:
- il serpente come guardiano dell'albero della vita: il nāḥāš
sulle fronde del ʿēṣ haḥayyîm nel racconto del gan ʿĒḏẹn,
il serpente che divora la šammu nikitti nell'epopea di
Gilgameš, il drákōn hespérios
Ládōn che custodisce i
frutti d'oro del Kpos Hesperídōn, etc.;
- il serpente che giace nel profondo delle acque cosmiche e/o
ai confini del mondo (ʿpop,
Vṛtra,
Jǫrmungandr) o nell'abisso acqueo e sotterraneo
(il serpente nell'epopea di Gilgameš,
Níðhǫggr, etc.).
Tutti i mitemi vengono in qualche modo sintetizzati nella figura
russa dello zmej: essere ctonio, sotterraneo, legato al
mondo dei morti, diviene il guardiano dell'acqua della vita.
Un altro tema assai diffuso in questo tipo di narrazione è quello
delle molodil'nye jabloka, le «melucce della giovinezza». In
una serie di fiabe riportate da Afanas'ev, esse si
affiancano al motivo della živaja voda, senza creare alcuna
contraddizione, come nella «Fiaba
del giovane ardito, delle melucce della giovinezza e dell'acqua viva», presente in
ben otto
varianti [171-178:
Skazka o molodce-udal'ce, molodil'nychl
jablokach i živoj vode]. L'incipit non stupirà i
nostri lettori: «Uno car' era molto vecchio e non ci vedeva
più. Venne a sapere che in un reame ai confini del mondo c'era un
giardino con delle mele che ringiovanivano e inoltre un pozzo con
l'acqua viva: se un vecchio avesse mangiato una di quelle mele,
sarebbe tornato giovane, e se avesse messo dell'acqua sugli occhi un
cieco, avrebbe riacquistato la vista» (Narodnye russkie
skazki [171]). Lo car'
manda i suoi tre figli a prendergli le mele della giovinezza e
l'acqua viva, e anche qui si sviluppa il motivo fiabesco dei
fratelli più grandi che falliscono là dove riesce il minore. Gelosi,
gli careviči maggiori gettano il giovane protagonista in un
precipizio profondissimo, in cui tuttavia questi trova un regno
ipoctonio e una principessa destinata a essere divorata da uno
zmej. Lo carevič uccide lo zmej, ma viene a sua
volta ucciso e fatto a pezzi da un rivale. Ma di nascosto la
carevna lo resuscita con l'acqua della vita... e la skazka
corre verso il suo finale, intrecciando tutti i nostri temi in una
narrazione ancora una volta sempre differente e sempre uguale.
Le fiabe russe, a spulciarle, si rivelano essere un catalogo
incontenibile di meraviglie. In molte skazki, al tema
dell'albero dai frutti dorati è collegato quello dello žar-ptica,
l'«uccello di fuoco». Come nel caso del fēng cinese,
anche qui i folkloristi pensano al Saǝna mǝrǝγo che i testi iranici
descrivono appollaiato sull'albero Gaokǝrǝna
(Avestā: Yasnā [x: 10]),
da cui sarebbe derivato anche il favoloso Sīmorġ
della letteratura mistica persiano-classica (cfr. il
Mantiq aṭ-ṭ̣ayr di Farīd
ud-Dīn ʿAṭṭār). Per quanto i motivi non siano mai collegati in un
insieme coerente, lo žar-ptica, l'albero dai
frutti dorati, il tema delle molodil'nye jabloka, a cui si
aggiunge quello dello zmej sotterraneo che custodisce la živaja voda e la
mertvaja voda, testimoniano un intreccio disordinato, ma tenace
e
persistente, di temi antichissimi, infine divenuti elementi
di un immaginario epico e fiabesco di grande bellezza e suggestione.
|
|
CONCLUSIONE Arrivati in quest'isola
ai confini del mondo, ben oltre l'oceano cosmico e la terra
dell'oscurità, possiamo tirar fuori dallo zaino il nostro diario di
viaggio, tutte le mappe che abbiamo faticosamente tracciato, e fare
il punto. Il percorso per arrivare in questo meraviglioso giardino
d'immortalità è stato lungo e ripetitivo. A ogni
svolta abbiamo ritrovato gli stessi bivi, gli stessi temi e mitemi: dovunque
mari invalicabili, isole e montagne che si somigliavano le une alle
altre, dovunque alberi con frutti dorati e un bestiario ricorrente
di aquile e serpenti, tori e leoni.
Eppure, i miti di cui abbiamo dipanato i fili, provenivano dalla
Mesopotamia e dal mondo arabo, dalla Grecia e dalle isole
britanniche, dall'Īrān e dalla Cina. Uno spazio vasto
quanto l'intera Eurasia. È permesso chiederci: dove si sono originati questi temi? Chi li ha elaborati e attraverso quali direttrici si sono diffusi? E soprattutto, quanto
sono antichi? In questo capitolo tenteremo a dare
una risposta.
La riscoperta dell'epopea mesopotamica di Gilgameš,
tra le seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, diede
agli studiosi una nuova prospettiva spazio-temporale, nonché un
archetipo di indubbia forza letteraria a cui ricondurre una quantità
di temi mitici diffusi tanto in Europa quanto in Asia. Inevitabilmente esagerando:
l'orientalista tedesco Peter Ch. A. Jensen (1861-1936), per
fare un esempio, riuscì a
ricondurre al Gilgamesch-Epos miti egizi, greci,
ebraici, iranici, indiani, arabi, romani e germanici, e persino vari dettagli della
vicenda del Buddha
(Jensen 1926 | Jensen 1928). E sebbene
questo pan-babilonismo oggi non sia più accettato, nel corso
dell'ultimo secolo gli studiosi hanno visto – o voluto vedere – nell'epopea di Gilgameš una
possibile fonte per i miti di Odysseús,
Akhilleús, Hērakls, Mōšẹh,
Yēšûʿ,
al-Iskandar,
e chi ne ha più ne metta. Sono state avanzate molte ipotesi di parallelismi e
correlazioni, ma non tutte con il medesimo rigore. Come abbiamo più volte sottolineato, non basta
segnalare un isomitema – la compresenza di un tema mitologico – per
confrontare efficacemente due tradizioni. Bisognerebbe riuscire a far
collimare degli schemi di una certa complessità.
Per quanto riguarda il mito della ricerca della vita, la tendenza
generale degli studiosi è riconoscere il primato storico dell'epopea
di Gilgameš, alla cui influenza si
attribuiscono generalmente i motivi affini evidenziati nei cicli di Hērakls,
al-Iskandar e Yì.
Lo stesso lugal urukita viene considerato l'archetipo di
tutti i viaggi alla ricerca dell'immortalità e, soprattutto nella
letteratura divulgativa, Gilgameš viene
definito tout-court come «l'eroe alla ricerca della vita».
Abbiamo intrapreso questo percorso dando anche noi per scontato uno scenario di questo
genere. Ma alla luce delle nostre analisi, dobbiamo domandarci
ora se tale scenario sia realistico. Può
l'epopea di Gilgameš – che nella sua
redazione neo-assira risale al periodo 1000-700 a.C. – essere alla
base di uno schema mitico così vasto e diffuso?
Per cominciare, ipotizziamo l'esistenza di un antico Ur-Myth
su un eroe che viaggia ai confini del mondo alla ricerca
di un modo per sconfiggere la morte e ottenere una vita immortale.
Ricapitoliamo brevemente i focus geografici dei suoi esiti
principali e avanziamo una sorta di critica delle fonti... Medio Oriente.
Argomento centrale del ciclo di Gilgameš,
il mito della ricerca della vita è tuttavia attestato unicamente
nella versione accadica dell'epopea: è centrale nell'epopea ninivita dello Ša naqba īmuru
(1000-700 a.C.), sebbene sia implicito in alcune versioni
antico-babilonesi del Šūtur eli šarrī,
ad esempio nella tavoletta di
Berlino/Londra (prima metà del Secondo millennio avanti Cristo).
Au contraire, nessun poema sumerico, a nostra conoscenza, ha tramandato il mito
della ricerca dell'immortalità, a meno di non considerare tale il
viaggio di Bilgames ed
Enkidu nel
KUR, che potrebbe
essere una versione arcaica del viaggio dell'eroe allo šadû Māšu.
L'assenza di prove non è una prova dell'assenza, ma
considerando la versione alternativa della morte di
Enkidu in
Ud rea ud sudra rea (= Ša naqba īmuru
[XII]), bisogna concludere –
provvisoriamente – che il
mito della ricerca dell'immortalità, nella forma in cui è arrivato
fino a noi, era probabilmente assente nelle tradizioni sumeriche su
Bilgames ed è stato introdotto
solo nella rielaborazione semitica effettuata all'alba del Secondo millennio
avanti Cristo. D'altra parte, un'attenta analisi dello
Ša naqba īmuru
mostra la presenza di alcuni temi vestigiali,
evidentemente ereditati da una tradizione più antica ma non compresa
dagli autori accadici. Tali temi non hanno alcuna funzione
nell'economia dell'intreccio ma sono utilizzati a fini estetici, ad esempio: (i)
il giardino degli «alberi degli dèi» [iṣû ilī],
trasformato in un episodio pittoresco nell'itinerario di Gilgameš
ma ormai del tutto scisso dal motivo dei frutti dell'immortalità; (ii)
la presenza di Šiduri che, pur essendo
definita una sābītu (ostessa, taverniera), ed
essendo quindi confrontabile con il motivo dell'enofora che elargisce
all'eroe il cibo o la bevanda dell'immortalità, ha perso qualsiasi
funzione e si è trasformata in una semplice tappa nel viaggio di Gilgameš
verso il Pû-nārāti. Viceversa, il
confronto con le versioni sumeriche dell'epopea ci informa che (iii)
il tema della crisi di
Gilgameš causata dalla morte di
Enkidu è probabilmente una
rielaborazione letteraria avvenuta in epoca accadica. Ci possiamo
chiedere se l'autore di tali rielaborazioni non possa essere stato il
fantomatico Sîn-lēqi-unninni. Europa.
Il mito della ricerca della vita presenta una struttura coerente in Grecia, all'interno del ciclo di Hērakls,
e in Irlanda, nella narrazione dei Clanna
Tuireann. Ne abbiamo rilevato delle tracce anche in Scandinavia, nei cicli
di Þórr e di
Thorkillus. Diversa
l'antichità di queste tre tradizioni mitiche: (a) Il ciclo di Hērakls risale probabilmente alla seconda metà del Secondo
millennio avanti Cristo, sebbene abbia continuato a venire elaborato
fino all'età classica e oltre; (b) Il racconto dei
Clanna
Tuireann è
molto tardo: i manoscritti dell'Oidheadh
chloinne Tuireann risalgono alla fine del
xviii secolo, sebbene esista anche una versione medievale
della vicenda e ve ne siano tracce nei poemi bardici inclusi
nel Lebor Gabála Érenn, i quali
risalgono all'viii-ix
secolo; (c) i miti di Þórr che contengono gli elementi del
nostro tema sono contenuti in due fonti: la
Prose Edda di Snorri Sturluson
(composta tra il 1222 e il 1225) e il poema eddico
Hymiskviða
(anteriore di circa
un secolo), ma lo stato di deterioramento in cui
il nostro tema è pervenuto ai due testimoni germanici è indice che i
suoi elementi
risalgono a una notevole antichità. Il ciclo parallelo di
Thorkillus è di poco più antico: il
Gesta Danorum fu composto da Saxo Grammaticus tra la fine
dell'xi e l'inizio del
xii secolo, e contiene
in nuce gli elementi della leggenda di
Guthmundus/Guðmund, signore di
un oltreboreale reame d'immortalità. Uno sguardo complessivo alle
tre versioni europee (greca, celtica e germanica) ci mostra che i
tre protagonisti sono gli esiti del dio-tuono indoeuropeo nei
rispettivi sistemi mitologici (Hērakls
e Þórr/Thorkillus) o una sua emanazione in forma
triplice (i Clanna
Tuireann). Una tale coerenza potrebbe implicare che l'Ur-Myth
fosse presente nella comune eredità indoeuropea in epoca antica; cosa che non esclude una posteriore
influenza mesopotamica avvenuta, almeno nel caso della versione
greca, attraverso la mediazione anatolica. Possiamo anche escludere che il racconto
dei Clanna
Tuireann derivi da quello di Hērakls:
sebbene sia altamente probabile che il
redattore settecentesco conoscesse la mitologia greca, sussistono nel
racconto irlandese molti elementi presenti nella tradizione comune
ma che egli non poteva identificare. Cina. Il ciclo del
divino arciere Yì è
già attestato ai primordi
della letteratura cinese (Shānhǎijīng,
Huáinánzǐ,
Chǔcí),
dandoci una buona sicurezza che si fosse già formato nel 500 a.C. In
questa fase, esso contiene il mito dell'abbattimento dei soli
soprannumerari (che è un tema tipico dell'Asia orientale), quello
delle «fatiche» dell'eroe, quello del suo viaggio sul
Kūnlún shān per procurarsi l'elixir
vitae e quello della sua uccisione da parte di Féng Méng.
La sottotrama inerente al matrimonio dell'eroe con
Cháng'é, tradizionalmente tramandata da fonti folkloriche, sembra successiva o secondaria.
Qualche sia l'origine di
Cháng'é, tuttavia, sembra indubbio che la sua
associazione a Yì ne abbia strutturato
il mito, almeno in parte,
secondo il tradizionale rapporto dell'eroe con la dea avversaria.
Il fatto di trovare il tema mitico attestato ai due opposti
estremi dell'Eurasia, tanto in Irlanda tanto in Cina, è una
preziosa indicazione di quanto il nostro Ur-Myth fosse antico e pervasivo.
Come abbiamo visto, gli specialisti tendono di solito a pensare che
il ciclo di Gilgameš sia alla base
tanto di quello ellenico di
Hērakls quanto di quello cinese di
Yì. Tuttavia un'analisi ad ampio spettro – non
limitata cioè al confronto di singole «coppie» di miti – dimostra che vi sono
molti elementi comuni al ciclo di
Hērakls
e a quello di
Yì, che non sono presenti nel ciclo di
Gilgameš.
Ad esempio:
- Sia
Hērakls
che
Yì si macchiano di
un delitto, dovuto a un eccesso di hýbris
funzionale (l'uno uccide i propri figli, l'altro i figli del dio celeste
Dìjùn) e, in seguito
all'espiazione del delitto, finiscono con il
mettersi a servizio di un sovrano
(rispettivamente Eurysteús e
Yào dì), il quale li invia a
eliminare mostri ed esseri pericolosi. Nulla di
tutto questo può dirsi di
Gilgameš.
- La funzione dell'enofora, che elargisce la
bevanda d'immortalità all'eroe, è conservata in Grecia (Hḗbē)
e in Cina (Xīwángmǔ).
Ma non in Mesopotamia, dove Šiduri
non viene mai mostrata nella funzione di una sābītu.
- Nel giardino degli dèi crescono gli alberi che
generano i frutti dell'immortalità, e questo tema è
conservato tanto in Grecia, con il
Kpos Hesperídōn,
tanto in Cina, con il Kūnlún
shān. Il giardino è invece divenuto un elemento defunzionalizzato nel mito mesopotamico, dove
Gilgameš si limita a passare sbalordito tra gli «alberi degli dèi»
[iṣû ilī],
ammirandone semplicemente la bellezza.
- Il mito dell'abbattimento dell'aquila e del serpente
è
presente nel mito di
Hērakls
e (forse) in quello di
Yì; il tema è del tutto sconosciuto al mito di
Gilgameš, dove il serpente ha una funzione affatto differente.
- La figura del compagno sopravvive all'eroe tanto in
Grecia (in alcune versioni è proprio Iólaos
a dar fuoco alla pira di
Hērakls) e in
Cina (dove Féng Méng
uccide
Yì), mentre l'epopea di
Gilgameš vi sostituisce la vicenda
romanzesca, di grande qualità letteraria e senza
dubbio impressionante, della morte di
Enkidu.
Queste note implicano una conclusione paradossale: il
mito greco di Hērakls
e quello cinese di Yì sono
più vicini a un ipotetico Ur-Myth, di quanto non
sia lo Ša naqba īmuru.
Ciò implica che il ciclo di
Gilgameš, che di solito gli
studiosi considerano il più arcaico di tutti, se non
addirittura la fonte dei temi mitici attestati tanto in
Grecia quanto in Cina, è in realtà una versione
divergente, che ha
subito maggiori rielaborazioni letterarie.
Il mito della ricerca della vita
Una volta eliminato il falso problema posto da
Gilgameš, possiamo cominciare a dare
forma al nostro Ur-Myth. Un confronto tra i motivi comuni presenti
nei miti di Hērakls, Yì
e dei Clanna Tuireann,
ci può dare qualche ragguaglio su quella che avrebbe potuto essere
la forma originaria del mito: (a)
l'eroe, dopo essersi macchiato di un orribile delitto,
viene privato dell'immortalità e subisce una crisi esistenziale; (b)
costretto a servire un sovrano, deve compiere una serie di «fatiche»,
che prevedono solitamente l'eliminazione di esseri o animali
mostruosi;
(c) spedito ai confini del mondo, giunge alla montagna
dove il sole sorge e tramonta, oltre la quale si spalanca l'oceano
cosmico; (d) arriva al giardino
degli dèi, custodito da un serpente, e ruba o ottiene i frutti
della vita; (e) nonostante tutto, perde il
frutto delle sue fatiche e deve soggiacere alla morte.
In questo
dramma, possono comparire alcune figure ricorrenti: (α) una dea celeste,
avversaria dell'eroe, che è la causa della sua crisi e il motivo
propulsivo della sua ricerca; (β) un'enofora, elargitrice del
cibo e/o della bevanda della vita, che
fornisce all'eroe il medium
d'immortalità; (γ) un compagno, che affianca l'eroe in alcune
sue imprese ed è presente alla sua morte.
Se la nostra analisi è corretta, possiamo ora cominciare a capire
a quale livello storico collocare il nostro Ur-Myth.
Considerando che il tema è presente sia nello strato semitico della
letteratura mesopotamica, sia nella letteratura di alcuni popoli di
lingua indoeuropea (Elleni, Celti e Germani), si può stabilire,
provvisoriamente, un'ipotesi di questo genere: 1. L'Ur-Myth
si sviluppa in ambito indoeuropeo, all'interno del ciclo del
dio-tuono, approssimativamente tra il Quarto e il Terzo millennio
avanti Cristo (oppure viene assorbito da un gruppo proto-indoeuropeo
da una cultura di substrato). La presenza dei medesimi temi nella letteratura accadica ci porto ad abbracciare l'ipotesi della continuità tra
proto-indoeuropeo e proto-semitico, sostenuta dai linguisti russi a
partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, sulla base di
isoglosse lessicali tra le due proto-famiglie linguistiche
(Illič-Svityč 1964 | Gamqʻreliʒe ~ Ivanov
1984). Secondo questa ipotesi, la Ur-Heimat
indoeuropea andrebbe localizzata tra il nord della Mesopotamia e il
lato meridionale della catena del Caucaso, a est dell'Anatolia
(Starostin 2001 | Gamqʻreliʒe 2001). Questa
regione potrebbe essere il luogo dove si è formato l'Ur-Myth
dell'eroe alla ricerca dell'immortalità.
2. Terzo millennio avanti Cristo: una prima migrazione
dei proto-indoeuropei oltre il Caucaso costituisce la seconda
patria kurganica, da cui le espansioni in direzione ovest. 2a. Una prima espansione invia il tema in direzione dell'Europa centrale, forse per tramite della
«cultura della ceramica cordata»: da questa diffusione deriveranno i futuri esiti celtico e germanico. 2b.
Una seconda espansione, dovuta alla «cultura della tomba a
fossa» (o di Jamna), porta il tema nei Balcani. Nel corso
dell'etnogenesi ellenica, il dio-tuono indoeuropeo (il futuro Hērakls) viene
declassato a hēmítheos; questo può essere avvenuto tanto
in una fase precoce nella formazione del mito ellenico (Terzo
millennio avanti Cristo), quanto dopo la discesa degli Elleni
nella penisola greca, nel corso della rielaborazione teologica
avvenuta a contatto con la cultura medio-orientale, di cui
fungono da medium tanto i popoli dell'Anatolia quanto i
Fenici e, forse, i Popoli del Mare (Secondo millennio avanti
Cristo).
3. Una seconda direttiva indoeuropea, assai precoce,
si sposta verso est: ne abbiamo probabili tracce nelle culture di Afanasevo (circa 3500-2000 a.C.)
e/o
di Andronovo (2000-1200 a.C.). Gli ultimi discendenti di questa
migrazione in Oriente sono i Tocari, presenti tra il
vi e l'viii secolo
nello Xīnjiāng cinese. È possibile che una versione dell'Ur-Myth
sia arrivata in Oriente attraverso questa direttiva. Una volta
giunto in quelle che oggi sono le regioni orientali della Cina, il tema della ricerca dell'immortalità si sarebbe
innestato sul mito, preesistente, di un eroe (il futuro
Yì) che abbatte i soli soprannumerari.
È più difficile che il tema possa essere arrivato in Cina
dall'India, visto che esso è sconosciuto
presso i popoli indoiranici. Non si può escludere, tuttavia,
che lo stesso Yì si sia
in certa misura indoeuropeizzato anche grazie all'apporto indiano. Possiamo
anche chiederci se il mito di Yì
abbia qualche legame con l'episodio di Arjūna
che abbatte
Karṇa, figlio di
Sūrya, nel Mahābhārata,
e con quello di Hērakls
che bersaglia Hḗlios di
frecce, o se non si tratti di una fortunata coincidenza. (A
essere sospetto è il fatto che tale motivo sia
collegato al complesso di temi organizzati nelle biografie
mitiche dei nostri tre eroi.)
4. Metà del Terzo millennio avanti Cristo: il
mito dell'eroe alla ricerca della vita arriva nella media
Mesopotamia, dove viene portato nel corso delle migrazioni degli
Accadi. Essi avevano assorbito il mitema
attraverso i contatti avvenuti all'epoca della continuità tra
protosemiti e protoindoeuropei, nella ipotetica Ur-Heimat
nord-mesopotamica, oppure attraverso la cultura di Majkop,
stanziata nell'attuale Adygėzia tra il 3500 e il 2500 a.C. Arrivato in Mesopotamia, il tema della ricerca della vita si sarebbe
integrato con i miti sumerici su Bilgames
e, verso la fine del
Terzo e l'inizio del Secondo
millennio avanti Cristo, avrebbe portato alla formazione del
ciclo antico-babilonese incentrato su Gilgameš
(lo Šūtur eli šarrī,
da cui lo Ša naqba īmuru).
L'adattamento di un tema indoeuropeo in ambito semitico avrebbe
comportato la palese incomprensione di alcuni episodi che, nelle
versioni accadiche dell'epopea, perdono di significato e
divengono elementi vestigiali, quali il mitema degli iṣû ilī
e quello di Šiduri. Rielaborazioni
letterarie avrebbero poi portato al tema della crisi causata dalla
morte di Enkidu.
5. L'arrivo degli indoeuropei in Anatolia (il
gruppo luvio-ḫittita) potrebbe essere avvenuto direttamente, con una
migrazione verso est dalla ipotetica Ur-Heimat
nord-mesopotamica ipotizzata dai linguisti russi, oppure – se
accettiamo l'ipotesi kurganica – attraverso la cultura di Majkop. È possibile che, passando dalla letteratura accadica a quella
ḫittita, all'inizio del Secondo millennio avanti Cristo, il
ciclo di Gilgameš si sia incrociato
con versioni anatoliche dell'Ur-Myth già presenti sul
territorio. Questo milieu potrebbe avere a sua volta
influenzato – sia creando un substrato, sia direttamente – il mito
di Hērakls
una volta importato dagli Elleni nella penisola
balcanica e sul mar Egeo.
6. Verso la metà del Secondo millennio
avanti Cristo, allorché le diverse popolazioni indoeuropee sono
per buona parte arrivate nelle loro sedi storiche,
differenziandosi anche grazie alle influenze di substrato, l'Ur-Myth
comincia a venire elaborato separatamente dalle varie culture;
in molti casi scompare lasciando poche o nessuna
traccia. Il mito dell'eroe alla
ricerca della vita viene conservato esplicitamente presso Elleni e
Celti, parzialmente presso i Germani. Non lo troviamo presso
i Balto-Slavi, sebbene lascerà profonde tracce nel folklore
dell'Europa orientale. Scarse le sue tracce presso gli Armeni,
dove esisteva un ciclo sull'eroe
Vahagn, una sorta di eracle locale, anch'esso uccisore di
mostri e destinato all'apoteosi. Del tutto scomparso nel mondo indoiranico.
È curioso notare che questa distribuzione rispecchia la vecchia
distinzione, oggi superata, tra lingue centum
e lingue satǝm, soprattutto se venisse confermata la
nostra ipotesi della presenza del tema presso i Tocari (popolazione
di lingua centum). Poiché si ritiene che il processo di satǝmizzazione
sia successivo alla diffusione delle lingue centum
verso est e verso ovest, possiamo chiederci se il nostro
Ur-Myth sia un'elaborazione secondaria dei popoli
indoeuropei occidentali (e in tal caso
bisogna trovare un'altra spiegazione sia per la sua migrazione in
Cina, sia per la sua presenza in Mesopotamia) o sia andato
semplicemente perduto presso Indoiranici e Baltoslavi.
7. Nel Primo millennio avanti Cristo, il ciclo di Gilgameš,
che ormai ha raggiunto la sua elaborazione definitiva, con lo Ša naqba īmuru,
è ormai popolarissimo nel Medio Oriente. Gli ebrei, dopo la
cattività babilonese, ne utilizzeranno alcuni schemi
nell'operazione di adattamento dei comuni miti
cananei, alla luce della nuova teologia post-esilica. Il tema della caduta
dell'uomo e della cacciata dal gan ʿĒḏẹn,
attestato nel Bǝrēʾšîṯ,
utilizza alcuni simboli comuni alla tradizione gilgamešaica, ma
li rielabora in maniera originale, probabilmente anche su
influenza del pensiero cosmologico iranico. Il mito risulta
essere una versione peculiare del tema della fine dell'età dell'oro,
come abbiamo suggerito altrove. Tuttavia, nella forma in cui
viene elaborato dai redattori del canone biblico, appare essere una
rilettura, abilmente rovesciata, del mito del viaggio dell'eroe
nel giardino meraviglioso.
8. Nei primi secoli della nostra èra, la vicenda del
condottiero macedone Mégas Aléxandros, trasformata in
leggenda, viene rielaborata, ad Alexandreía, anche sulla base dei
mitemi tradizionalmente legati ad Hērakls. Nel
complesso
processo di scambi culturali che interessano lo spazio tra il
Mediterraneo orientale e il golfo Persico, stessa cosa accade
alle leggende sudarabiche su Ṣaʿb ibn Ḏī Marāṯid/Ḏū ʾl-Qarnayn.
Gli antichi temi gilgamešaici, che ancora aleggiano nel Medio
Oriente, tornano a incastrarsi in questo nuovo puzzle,
formando, un po' alla volta, e grazie anche al milieu
siriaco, quella che sarà la leggenda
islāmica su al-Iskandar.
Nell'esito medio-orientale è però
assente il tema del giardino meraviglioso, che era stato
ridotto a una vestigia defunzionalizzata già nello
Ša naqba īmuru. Viene
sostituito da un tema giunto probabilmente dall'Īrān o
dall'India: quello dell'acqua della vita. Alcuni elementi
cosmologici, attenuati o alterati nelle concezioni islāmiche
(quali quello del monte assiale, o quello delle isole dei beati), ritornano però
con forza nelle versioni persiane della storia di
Eskander, grazie al substrato
iranico.
Lo schema cosmologico
In questa pagina abbiamo seguito il nostro eroe nel suo
viaggio ai confini del mondo e abbiamo visto come, nella maggior
parte degli esiti, l'eroe si muova nell'ambito di una cosmologia
più o meno coincidente.
La concezione generale è quella di una terra abitata (oikouménē)
di forma circolare, circondata dal mare. Vi è a volte un sistema
anulare di monti che circonda il mondo, nel quale si aprono
le porte orientali e occidentali che permettono il passaggio del
sole. Al centro del sistema – vale a dire in direzione nord – sorge
un'immensa montagna, posta sotto il polo celeste, attorno alla
quale ruotano gli astri e l'intero firmamento. È in prossimità
di questo axis mundi che, in genere, si trova il giardino con gli
alberi della vita, o sgorga l'acqua dell'immortalità. Oltre il
mare vi sono invece le «isole dei beati»: terre separate
dall'esperienza umana, praticamente irraggiungibili, dove pochi
prescelti sono stati chiamati a condurre una vita immortale.
Oltre queste isole, l'oceano si fonde con il firmamento (kósmos).
Sebbene le singole concezioni apportino molte modifiche
secondarie, lo schema si ripete con sorprendente regolarità in Mesopotamia, Grecia, Scandinavia, Arabia,
Īrān, India e Cina. In tutti questi schemi è presente la dicotomia tra
la montagna centrale e le isole dei beati, anche
laddove i due motivi appartengano a contesti mitici o
narrazioni differenti. Ad esempio, sia in Grecia sia in Cina –
alle due estremità dell'areale di diffusione del nostro
mito – sono presenti tanto il mitema della montagna cosmica
(rispettivamente l'óros Átlas e il Kūnlún
shān), tanto quello delle isole dei beati (le
Makárōn Nsoi e le isole degli xiān); sia in
Grecia che in Cina, inoltre, tanto Hērakls
tanto Yì raggiungono il monte, in prossimità della quale crescono gli
alberi della vita, mentre le isole dei beati non compaiano affatto
nei loro miti, per quanto godano di una lunga tradizione
tanto nell'una, quanto nell'altra mitologia.
Tale cosmologia sussiste
anche in quegli ambiti dove il mito della ricerca
della vita non è affatto attestato, ad esempio in Īrān e in India.
Dunque, il
nostro Ur-Myth è semplicemente situato in questa
cosmologia, che ne costituisce, per così dire, l'impalcatura.
| |
Montagne
periferiche
(cingulus mundi) |
Montagna
centrale
(axis mundi) |
Oceano
cosmico |
Isole dei
beati |
| Sumeri |
|
KUR (?) |
|
Dilmun |
|
Accadi |
Šadû Ḫašur
Šadû Budugḫudug |
BÀD.GULA, il «grande muro [...]
dove Šamaš non è visto» (?) |
Il
Marratu, il «fiume» amaro |
I nagi˒ānu |
| šadû
Māšu (?) |
šadû
Māšu (?) |
Il tâmtu |
Il
Pû-nārāti |
| Greci |
Óros
Átlas a occidente, óros Kaúkasos a oriente |
Óros Átlas nella terra degli
Hyperbóreoi |
Il potamós Ōkeanós |
L'isola di Erýtheia e le
Makárōn Nsoi |
| Le colonne di
Átlas |
| Germani |
|
Himinbjǫrg, la «montagna
del cielo» |
Útháf, il «mare esterno» |
Útgarðr, il «recinto
esterno»; Glæsisvellir e
Ódáinsakr, i reami di
Guðmundr. |
| Celti |
|
Tul Tuinne
(?), la collina del diluvio |
Il bíth o lér |
Tír na nÓg, Tír na mBeo, Tír nAill,
Emain Ablach, Ynys Afaỻon,
etc. |
| Arabia |
Il
ǧabal al-Qāf |
Il ǧabal al-Qāf |
Il Baḥr al-muḥīṭ,
l'oceano onniavvolgente |
L'isola di al-Ḫīḍr |
| La montagna
di Yamlīḫā |
Le città di smeraldo Ǧābarsā e Ǧābalqā |
| Īrān |
Il monte
Harā Bǝrǝzaitī / Harborz / Alborz |
Il kōf ī
Tērag-ī-Harborz o
il kōf ī
Čagād-ī-Dāiti |
Il mare
Vourukaa / Frāxwkard / Warkaš |
I sei karvąr/kešwar
periferici |
| India |
Il Lokāloka |
Il monte Meru |
Gli oceani
anulari |
I sei dvīpa
periferici |
| Cina |
Svariate
montagne citate nei testi cosmologici |
Il Kūnlún
shān |
I sì hǎi,
i «quattro mari» che circondano le terre |
Le isole di Dàiyǘ,
Yüánjiào, Fānghú,
Yíngzhōu e Pénglái
shān |
In conclusione, mentre nel caso del mito della ricerca della
vita non possiamo probabilmente scendere sotto il Quarto
millennio avanti Cristo, e vi sono comunque limiti di
diffusione geografica e alcune varianti dovute al suo
adattamento nelle diverse culture, l'ambiente cosmologico in cui
si svolge la vicenda appare essere uniforme, solido e
omogeneo, oltre che molto antico. Non crediamo di sbagliare
asserendo che il mito della ricerca della vita sia un tema
sviluppatosi separatamente, e in un secondo tempo, rispetto allo
schema cosmologico utilizzato come scenario. In altre parole, la
cosmologia qui definita sembra essere una sorta di substrato
culturale comune all'intera area eurasiatica, e come tale,
affonda le sue radici in una antichità portentosa.
Cercare di definire l'antichità di questa Ur-Kosmologie
è difficile. Le nostre (fragilissime) considerazioni astronomiche
forniscono il 3000 a.C. come data più recente per la formazione del
motivo dell'aquila e del serpente quali «sostegni» dell'equatore
celeste, ma si potrebbe risalire altrettanto bene all'8000 a.C. Uno scenario di questo genere
potrebbe
collocarsi nel varco delle ipotesi di Vladislav Illič-Svityč
(1934-1966) e Aron Dolgopol'skij (1930-2012) sulla protolingua
nostratica (Illič-Svityč 1964 | Starostin
1988 | Starostin 2001) e avrebbe il pregio di
stabilire una continuità culturale in epoche piuttosto remote (anche
quindicimila anni fa).
I medium dell'immortalità
In un suo saggio, la professoressa Alexandra Szalc ha analizzato i
media d'immortalità in alcuni esiti di questo mito
(mesopotamico, greco, arabo),
sottolineandone le numerose differenze. Il medium è una pianta sottomarina, ad
esempio, nell'epopea di Gilgameš
(la šammu nikitti, la «pianta dell'irrequietezza»); sono dei
frutti colti da un meraviglioso giardino nel ciclo di Hērakls
(i pomi del
Kpos Hesperídōn); è una
sorgente nel ciclo islāmico di al-Iskandar/Eskander
(la māʾ al-ḥayāt, l'«acqua della vita»).
La Szalc ritiene che questi temi abbiano un'origine diversa e,
cercando un collegamento occidentale del tema della šammu nikitti
presente nell'epopea di
Gilgameš, addita la strana erba magica che
compare nelle due versioni della leggenda greca di
Glaûkos e nota come alcuni
elementi di questa vicenda (i pesci che resuscitano) siano entrati nella
tradizione alessandrina. (Szalc 2012)
La Szalc
nega che il tema alessandrino della māʾ al-ḥayāt
derivi da quello gilgamešaico e ne ipotizza invece un'origine indiana. Ella nota,
giustamente, che il Mahābhārata
contiene diverse descrizioni di sorgenti che eliminano la
vecchiaia, le malattie e la morte (Szalc 2012). In
alcuni casi i temi appaiono combinati insieme
tra loro in modo da rendere molto difficile effettuare delle
distinzioni precise. Ad esempio, la tradizione iranica fonde il medium arboreo e quello liquido: sull'albero Gaokǝrǝna, che cresce nel
mezzo dell'oceano Vourukaa,
fruttifica il bianco haoma (medio persiano hōm-ī-sped), l'elixir
vitae distillato da Ahura Mazdāh
che, nel frasōkǝrǝti,
sconfiggerà la vecchiaia, farà risorgere i morti e
renderà immortali i viventi. Il mitema del Gaokǝrǝna/haoma può essere collegato tanto alla šammu nikitti che Gilgameš coglie sul fondo dell'Apsū,
tanto alla sorgente della māʾ al-ḥayāt
che al-Iskandar prova a raggiungere
oltre il ǧabal al-Qāf.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza e distinguere i media
d'immortalità:
| |
Frutti
d'immortalità |
Piante/erba d'immortalità |
Elixir
vitae |
Sorgente
d'immortalità |
| Germani |
Le mele d'oro
di Iðunn |
|
|
|
| Celti |
I frutti
(d'oro) di
Ynys Afaỻon e di
Emain Ablach |
|
La birra di
Goibniu |
|
| Greci |
I krýsea mla,
i «frutti d'oro» del Kpos Hesperídōn |
L'erba
dell'immortalità nelle due versioni della leggenda di
Glaûkos. |
Il cibo e la
bevanda degli dèi: néktar e ambrosía |
|
| Slavi |
Le molodil'nye jabloka,
le «mele della giovinezza» |
|
La živaja voda, l'«acqua viva»
(e la mertvaja voda, l'«acqua morta») |
|
| Mesopotamia |
Gli iṣû ilī,
gli «alberi degli dèi» (tema defunzionalizzato) |
La šammu nikitti,
la «pianta dell'irrequietezza» che cresce sul fondo
dell'Apsū. |
Il cibo di
vita e l'acqua di vita nel racconto di
Adapa |
|
| Ebrei
|
Il frutto del ʿēṣ haḥayyîm, l'«albero
della vita» |
|
|
|
| Islām |
I frutti
d'oro del giardino di Iram (tema defunzionalizzato) |
L'erba dell'immortalità
sulla montagna di Yamlīḫā |
|
La māʾ al-ḥayāt, l'«acqua
della vita» |
| Īrān |
L'albero Gaokǝrǝna |
Il haoma/hōm |
| India |
|
L'erba di
Hanuman nel
Rāmāyaṇa |
L'amṛta,
il cibo di non-morte |
Sorgenti e
fiumi sacri citati nel
Mahābhārata |
| Cina |
Gli alberi di giada e perle
nei giardini
del Kūnlún
shān |
L'erba delle [sciamane] Péng,
Dǐ, Yáng,
Lǚ, Fán e
Xiāng wū |
L'elixir
vitae di
Xīwángmǔ (anche
diffuso nella tradizione taoista) |
Le acque del
[fiume] Dān
hé |
Questo specchietto, ordinato secondo
un'approssimativa sequenza da ovest a est, evidenzia i seguenti punti:
- Il motivo della sorgente dell'acqua della vita sembra
tipica dei miti orientali: il suo nucleo, come nota
la professoressa Szalc, sembra effettivamente essere l'India, da
dove il tema può essere arrivato tanto in Cina (dove
è però meno importante rispetto a quello degli alberi
della vita e dell'elixir vitae di
Xīwángmǔ), tanto
in Īrān e, da qui, sia nel mondo arabo, sia in Russia. Sebbene esso sia sconosciuto
allo strato più antico del mito ellenico, è presente nei
romanzi dello pseudo Kallisthénēs, ma solo nelle
tarde recensiones β e γ, a indicazione che il
tema è arrivato in Europa soltanto in epoca tardo-antica,
attraverso la letteratura siriaca. Solo nel
Medioevo il tema della fonte della giovinezza diverrà popolare
in Europa.
- Il tema del cibo d'immortalità, invece, sembra essere indoeuropeo: l'amṛta
indiana e l'ambrosía greca sono mitemi strettamente collegati, sia
etimologicamente, sia nei contesti di schemi mitici piuttosto
dettagliati. Tuttavia esso compare unicamente come nutrimento
degli dèi e non sembrano presenti eventuali racconti della sua
acquisizione da parte dei mortali (con l'eccezione di
Hērakls dopo la sua
apoteosi).
- Il motivo dell'erba dell'immortalità è legato a temi
acquatici: in genere l'eroe deve scendere sul fondo del mare per
riuscire a coglierla. Questo tema sembra soprattutto medio-orientale: è importante nell'epopea di
Gilgameš (la šammu nikitti),
ed è anche arrivato anche in Grecia, dove è presente nelle due
versioni del mito di Glaûkos: in
uno, Glaûkos figlio di
Mínos viene resuscitato grazie a
un'erba conosciuta da un serpente; nell'altro,
il pescatore
Glaûkos, nutrendosi di quest'erba,
si trasforma in una divinità marina (e qui compare anche, per la
prima volta, il tema della resurrezione del pesce). Ritroviamo
il motivo dell'erba della vita anche nella leggenda di
Balūqiyā, dove cresce però
su una montagna, sebbene vicino a un'altra specie erbacea che
permetterà al protagonista di camminare sulla superficie del
mare.
- Il mitema dei frutti dell'immortalità è universale: lo troviamo attestato
indifferentemente dall'Europa alla Cina,
compreso il Medio Oriente. Il mito sembra tuttavia originario del mondo
indoeuropeo, visto che è in quest'ambito che ne troviamo gli
sviluppi migliori. Nel mito greco è dichiarato che i frutti
d'oro del Kpos Hesperídōn
rendano immortali chi ne mangia, sebbene non vengano mai messi
alla prova. Tali frutti hanno tuttavia una funzione importante nel
mito scandinavo, la cui locale enofora, Iðunn, custodisce le epli ellilyf, le «mele contro
la vecchiaia», che permettono agli dèi di rimanere eternamente
giovani. Pomi dorati dai simili poteri sono presenti anche nelle
skazki
russe. Il mitema non è invece attivo nelle tradizioni
medio-orientali. Nel racconto di Gilgameš,
ad esempio, gli iṣû ilī, gli «alberi degli
dèi», sono un motivo letterario
ormai privo della sua antica funzione: e non ci stupiamo di
ritrovarlo proposto, in forma esclusivamente estetica, anche nei
racconti islāmici, dove al-Iskandar/Eskandar arriva nel giardino di
Iram e ne ammira i frutti simili a
pietre preziose e gemme. Sorprende, nell'ambito semitico, che il tema sia
attivo nel mito biblico del del ʿēṣ haḥayyîm, l'«albero
della vita»: ottima dimostrazione del fatto che il Bǝrēʾšîṯ
è indipendente dallo
Ša naqba īmuru e che,
in molti punti, ha conservato elementi più antichi. In Cina, il
motivo degli alberi di giada e di perle, e dei peschi
dell'immortalità, è invece perfettamente funzionale.
|
L'OCEANO ESPUGNATO. Con la fine
dell'evo medio, il grande oceano che circondava l'oikouménē
smise
di essere una notazione cosmologica per ridursi, semplicemente, a
un tratto di mare. Certamente molto più vasto, profondo e pericoloso
del Mediterraneo e del golfo Persico, ma in fondo non diverso da
quelli. E non vi erano favolose isole
di immortalità, oltre l'oceano, ma – cosa forse ancor più
inaspettata – continenti nuovi di zecca, da colonizzare, sfruttare e
depredare.
Continenti abitati da uomini che, pur diversissimi come lingua e costumi, non
erano che rami divergenti della stessa umanità. Da
questo incontro/scontro tra civiltà, alcune avrebbero trattato
vantaggio e ricchezze oltre ogni immaginazione; altre avrebbero
subito l'urto e sarebbero andate incontro a destini assai meno
lieti.
Gli antichi miti persero d'un tratto il loro significato e con
l'Umanesimo si aprì l'età moderna. Vascelli e galeoni carichi di
ricchezze, spezie e schiavi, cominciarono a
veleggiare attraverso gli oceani. A farsi strada erano nuove
concezioni di commercio, imperialismo e capitalismo. Fiumi d'oro
confluirono nei forzieri di
Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Olanda. Dimenticate le
vecchie epopee, bisognava creare una nuova epica, più adatta ai
tempi: un'epica marinaresca e mercantile. Come questa:
As armas e os barões assinalados
que da Ocidental praia Lusitana,
por mares nunca dantes navegados
passaram ainda além da Taprobana,
em perigos e guerras esforçados
mais do que prometia a força humana
e entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram; |
L'armi e i gentiluomini famosi
che dall'estremo riva lusitana
per mari inesplorati e tenebrosi
si spinsero fin oltre Taprobana
guerre e rischi affrontando numerosi
molto al di sopra d'ogni forza umana;
e che eressero regni, nei remoti
lidi, da loro resi illustri e noti; |
e também as memórias gloriosas
daqueles Reis que foram dilatando
a Fé, o Império, e as terras viciosas
de África e de Ásia andaram devastando,
e aqueles que por obras valerosas
se vão da lei da Morte libertando
cantando espalharei por toda a parte
ce a tanto me ajudar o engenho e arte. |
le memorie gloriose dei sovrani
che acquistarono fama, propagando
la Fede ed il suo Impero fra i pagani,
terre d'Africa e d'Asia conquistando;
e degli eroi, che gesti sovrumani
compiron, sulla morte trionfando;
diffonderò col canto in ogni parte,
se a tanto mi varranno ingegno e arte. |
Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandro e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Neptuno e Marte obedeceram:
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta. |
Cessi l'elogio dell'eroe troiano
e dell'astuto greco, per le storie
del lungo navigare, o di Traiano
e d'Alessandro l'inno alle vittorie;
ch'io celebro d'un cuore lusitano
sopra Marte e Nettun più eccelse glorie:
tutto ciò che la musa antica vanta
taccia, valor più vero qui si canta. | |
Luís Vaz de Camões:
Os Lusíadas [I: 1-3] |
Quando Luís Vaz de Camões effonde nelle sonore ottave ariostesche dei suoi
Lusíadas (1572) la conquista
degli oceani ad opera di Vasco de Gama, il mondo si arricchisce di quello che è forse il più bel poema epico dell'età moderna.
Ormai il mondo l'abbiamo circumnavigato per non intero e non vi è alcun mistero,
alcun mito, alcuna metafisica. Cessino gli elogi di
Gilgameš,
Hērakls e
al-Iskandar. È l'epoca moderna,
baby. | |
|