IL PROMETEO
INCATENATO
 |
|
Promētheús (✍ 1900) |
Reinhold Begas (1831-1911)
Akademie der Künste, Berlino. |
C'era una volta un prometeo che osò sfidare l'autorità del re
degli dèi. Venne incatenato tra le cime di aspre montagne, e
lasciato lì a soffrire, sospeso tra il cielo e la terra, fino alla fine del
mondo. È uno dei miti più antichi di cui sia rimasta traccia, conservato in molte e difformi varianti. Il
cuore di questa narrazione sembra essere il Caucaso, con il suo
complesso mosaico di popoli: esso è il centro di un triangolo i cui vertici
toccano la Grecia, il mondo indoiranico e la lontana Scandinavia, luoghi dove
si sono conservati gli elementi dell'antico mito.
Sebbene il racconto originale sia andato perduto, possiamo
ancora individuarne i singoli mitemi, attestati tanto nella letteratura quanto
nel folklore, e in tempi e luoghi lontanissimi tra loro. Brani
appartenenti a un'unica sinfonia, suonati su strumenti differenti e
secondo diversi timbri e tonalità, a volte variati e alterati fino a divenire
irriconoscibili, a volte interpolati in composizioni differenti. Rimangono
tuttavia strutture, più o meno complesse, che si ripetono incessantemente, come
un eco che continui a rimbalzare attraverso i secoli.
Il ruolo del prometeo incatenato può essere via via
interpretato da un titano, un campione, un mostruoso sovrano, un tricefalo, e la sua sfida al dio supremo può muoversi tanto
nella sfera della forza quanto in quella dell'intelligenza. In certi esiti,
sembra legato al fuoco, in altri no. Unico elemento distintivo, il possente giro
di catene che lo imprigiona, vuoi sulla cima di un monte, vuoi nel profondo
della terra. Un cane alato può fargli da compagno, un'aquila da torturatrice,
quando non compaiono invece dei serpenti. Nella maggior parte dei casi la sua
punizione è destinata a durare fino alla fine del mondo, che, anzi, sarà lui
stesso a darne a provocare, liberandosi dalla sua prigione.
Se in questa sede lo chiamiamo «prometeo», trasformando un
nome proprio in comune, è perché l'esito più noto di questo personaggio è
attestato nel mito ellenico, ed è quel Promētheús
che creò gli uomini, ingannò gli dèi, rubò il fuoco e fu incatenato da
Zeús tra le aspre cime del Caucaso. La figura del
titano classico, in realtà, ha caratteristiche proprie, che ne fanno
un'elaborazione originale del pensiero greco; non può assolutamente essere preso
come modello generale di una classe di personaggi. L'uso sostantivato del suo
nome ha qui il valore di un ruolo generico.
È difficile, se non impossibile, pretendere di ricostruire un
ipotetico «mito originario». Possiamo soltanto analizzarne gli esiti, nei modi
in cui ci sono pervenuti, sottolineandone le affinità e e differenze. Cominciamo il nostro viaggio da quello che compare
essere il centro di questa sinfonia mitologica. Il Caucaso.
|
CAUCASO, IL LUOGO DEL SUPPLIZIO
 |
|
Popoli e lingue del Caucaso |
Il Caucaso è uno straordinario museo
etnologico. Nel corso dei millenni, i suoi massicci montuosi, corrugati tra il Mar Nero e il Mar Caspio,
hanno trattenuto molti piccoli popoli nelle vallate tra le
montagne, conservandone i linguaggi, i costumi e le tradizioni. La
ricchezza e la complessità linguistica della regione era nota fin
dall'antichità. Strábōn ricorda che nella città di Dioskouriás (georgiano
Soxumi, abxaso Ak̄ǝa), sulla costa caucasica del Ponto Eusino, si radunavano settanta tribù
diverse per svolgere le loro attività commerciali, e ciascuna aveva la propria
lingua, «e questo perché, trattandosi di stirpi selvagge e arroganti, vivono
sparse e senza mescolarsi» (Geōgraphiká
[XI: 2, 16]). Plinius assicura che a Dioskouriás i Romani negoziavano con l'ausilio di centotrenta interpreti
(Naturalis historia [VI: 12]). Anche i
geografi arabi rimasero impressionati dalla varietà di etnie che s'incontravano
nel Caucaso, tanto che la regione veniva definita come Ǧabal al-alsun, la
«montagna delle lingue». Secondo lo storico Abū al-Ḥasan ʿAlī al-Masʿūdī, i
monti del Caucaso erano abitati da così tante genti che solo Allāh avrebbe
potuto contarle (Murūǧ aḏ-ḏahab wa maʿādin al-ǧawahir
[443]).
Se l'alta densità linguistica è segnale di antichità,
la maggior parte dei
popoli del Caucaso devono essere presenti in situ da un'epoca incredibilmente
remota. E se ci limitiamo allo strato autoctono, troviamo ben tre
famiglie linguistiche serrate le une a ridosso delle altre.
-
A sud, la famiglia caucasico-meridionale, o cartvelica,
dominata dal georgiano, oggi lingua ufficiale della repubblica di Georgia. Veicolo, fin dall'alto Medioevo, di una splendida e
ricca letteratura, è l'unica delle lingue caucasiche a vantare una tradizione
colta. A questo gruppo appartengono lingue minori come il mingrelio e lo svanete, parlati nella Georgia nord-occidentale, e il lazo, che è
localizzato invece sulla costa sud-occidentale, presso il confine della Turchia.
-
A nord della Georgia, troviamo la famiglia
caucasico-nordoccidentale. È dominata dall'abxasico, lingua del controverso
stato di Abxazia, sito lungo la costa del Mar Nero.
Il gruppo circasso (a sua volta distinto in adighe e cabardino) è
invece sparso in diverse isole linguistiche oltre il confine russo. L'ubyx si è
estinto nel 1992, con la morte del suo ultimo parlante, Tevfik Esenç.
-
A nord e ad est della Georgia, in territorio russo, è invece
stanziata la ricca famiglia caucasico-nordorientale. Esso è diviso a sua
volta in due sottogruppi principali: quello delle lingue veynax, dominato dall'ingušo-čečeno,
e quello daghestano, a sua volta
suddiviso in dozzine di lingue e dialetti sparpagliati lungo la linea del Mar Caspio, fino al confine dell'Azǝrbaycan.
Le relazioni tra le tre famiglie linguistiche caucasiche non sono chiare.
Esse vengono raggruppate insieme per comodità, ma i
glottologi non hanno riscontrato affinità tali che
si possa raggrupparle in macro-famiglie. Consenso vi è soltanto sulle lingue
caucasico-meridionali o cartveliche, che formano un gruppo piuttosto compatto.
Più complessa la questione sulle altre due famiglie, la nordoccidentale e la
nordorientale, che molti linguisti ritengono correlate. Alcuni sostengono che le
lingue veynax siano a loro volta un gruppo indipendente e intermedio tra gli
ultimi due gruppi.
Nella regione sono però presenti anche alcuni popoli indoeuropei. Nel
vasto acrocoro sotto le Alpi Pontiche, quasi a chiudere il Caucaso sul lato
meridionale, sono
stanziati gli Armeni, con
la loro antichissima e ricca cultura nazionale. Gli Osseti, di lingua indoiranica,
si sono insinuati in una piccola regione oggi tagliata in due dal confine
tra la Georgia e la Russia. Gruppi di Curdi, sparsi tra
Armenia, Turchia e Īrān, completano il quadro indoeuropeo.
Vi sono infine
diversi popoli altaici, giunti nel Caucaso per buoni ultimi, di cui il
più importante è quello degli Azeri, la cui lingua è oggi ufficiale nell'Azǝrbaycan.
Altre lingue altaiche attualmente rappresentate nella regione sono il turkmeno,
il karakalpaco, il noğai, il karačai, il balkario e il calmucco.
Queste note non sono inutili: chiariscono l'antichità e la
complessità etnica di questa regione. È qui che il mito del prometeo incatenato è ben conosciuta, in molte varianti, su entrambi i versanti
del massiccio caucasico. Il suo nome è
Amirani presso Georgiani e Svaneti,
Abrysk’yl presso gli Abxasi,
Teʒau
presso i Circassi Adighi, Nesren presso i
Circassi Cabardini,
sebbene esistano anche altre lezioni.
Tutti questi racconti, confinati per anni nell'ambito degli accademici russi, sono rimasti a lungo pressoché
sconosciuti in Europa occidentale. Tra i primi a farne accenno, il danese Axel
Olrik (1864-1917), ai primi del Novecento; ma è stato solo grazie agli studi
pionieristici di Georges Dumézil (1898-1986) che la cultura mitologica del
Caucaso ha cominciato ad avere i suoi primi riscontri in occidente. A spalancare il
mondo caucasico agli studiosi europei è stato però il
franco-georgiano Georges Charachidzé (Giorgi Šarašiʒe, 1930-2010), allievo
di Dumézil, il quale ha analizzato
minuziosamente il «ciclo amiranico», comparandolo con il mito greco. È soprattutto
ai suoi lavori che faremo riferimento in alcuni dei capitoli che seguono.
Ma prima di entrare in dettaglio, analizziamo singolarmente i
vari esiti caucasici, e facciamo la conoscenza con Amirani,
Abrysk’yl e
tutti gli altri... |
|
LA VERSIONE GEORGIANA. AMIRANI
I Georgiani (georgiano arṫvelebi, russo Gruziny,
persiano Gurǧī) sono ritenuti gli eredi degli antichi regni di Colchide
e Iberia.
La Colchide (greco Kolchís, georgiano Kʻolxeṫi),
affacciata sulla costa occidentale del Mar Nero, era conosciuta ai Greci, in
epoca arcaica, come il limite orientale del mondo conosciuto. Era la
meta degli Argonaûtai, nella loro
leggendaria spedizione alla ricerca del vello d'oro. Ma passando dal mito alla
storia, la lavorazione del ferro, sviluppata nel Caucaso tra l'XI e l'VIII secolo a.C.,
produceva una fitta rete di traffici con il Mar Egeo. Già intorno al VII secolo
a.C. i mercanti Milesi avevano stabilito i primi emporia commerciali
sulla costa del Mar Nero, poi divenuti vere e proprie colonie. In quanto al regno di Iberia (greco
Ibería, Georgiano arṫli), sorse successivamente
nell'entroterra, a est della Colchide. Le fonti antiche – greche, romane, armene
– riportano un gran numero di etnonimi, svelando una situazione composita
di popolazioni di lingua proto-cartvelica alla base di queste prime
organizzazioni statali della Georgia.
Situate al crocevia tra oriente e occidente, tra la
pervadente cultura della Persia e gli influssi che arrivano dalla Grecia, le
piccole nazioni caucasiche barcollano tra brevi periodi di indipendenza e fasi in cui
sono tributarie dei grandi imperi: satrapie persiane,
province romane, poi bizantine. L'Iberia diviene una delle prime nazioni a convertirsi al
Cristianesimo, nel 317, anno in cui re Mirian III (♔ 306-337) lo proclama
religione di stato, seppur trovando una tenace resistenza nel Mazdeismo,
che nel clima cartvelico si era contaminato con il pántheon
locale. Riguardo al substrato pagano, è lo stesso Mirian a dichiarare, al
momento della sua conversione: «Agli orrendi idoli i genitori immolavano i
loro figli e le genti innocenti di questa nostra contrada. Alcuni dei nostri
padri falciarono i propri bambini come fieno, nell'intento di compiacere gli
idoli, specialmente su questi monti, le cui pietre sono ancora intrise del
loro sangue».
 |
|
Kʻopʻala combatte i devebi |
|
Levan Kʻikʻališvili |
Dio supremo degli antichi Cartveli,
Morige Ḡmerṫi era l'ordinatore del mondo. Confusosi in seguito
con il Dio cristiano, era rappresentato nella funzione di sorvegliare e
mantenere l'ordine da lui istituito. Tendeva a manifestare il suo volere attraverso
Kʻviria, un amministratore che ne rappresentava
il potere
in terra e ne amministrava la giustizia.
Kʻviria era scortato dalla muta degli
Iessaul, lupi celesti in grado di portare malattie
e devastazioni; quando i loro ululati si udivano ai confini del cielo, le
persone si mettevano al riparo e pregavano con fervore.
Al livello inferiore, l'antica religione cartvelica contava
centinaia divinità locali e specializzate, definite in georgiano saḡmṫo «divinità», ǯuar
«croce», o xatʻi «segno»; quest'ultimo termine poteva
indifferentemente applicarsi al dio quanto alla sua manifestazione materiale e
concreta (simbolo,
oggetto, santuario).
Tra i principali xatʻebi, si annoverano
Givargi (svanete Ǯgǝræg), una sorta di
san Giorgio custode degli
spazi selvaggi, protettore dei pastori, dei viandanti e dei montanari; il genio folgoratore Kʻopʻala, signore della tempesta e
distruttore dei devebi (dèmoni); Pʻiruša, il dio-fabbro; la
dea solare Ṫamar, con il suo
fratello-sposo, il dio guerriero Lašari. Le divinità
della caccia comprendevano un piccolo pántheon, soprattutto presso gli
Svaneti, e tra queste spiccavano Beršišvliš, il
«signore della montagna nuda», che risiedeva sulle cime spoglie e rocciose del Gran Caucaso,
dove era responsabile di tutte le fiere selvagge; Čekiš Angelwez, l'«angelo della foresta», patrono di
tutti i carnivori, volpi, sciacalli, orsi, e della rara pantera caucasica, quasi
estinta ai nostri giorni; e infine la bionda dea Dali
(svanete Dæl), signora
della selvaggina cornuta, di cui parleremo poi.
(Charachidzé 1989²)
Nonostante gli sforzi dei sovrani e dei religiosi, il
Cristianesimo stentò a diffondersi nel popolo georgiano; a lungo diviso tra gli
imperi bizantino e persiano, il piccolo paese poté risorgere solo nel IX secolo, quando i piccoli principati di cui si componeva vennero uniti
sotto la dinastia dei Bagrationi. Il regno di Georgia durò dal 978 al 1466 e,
al suo apogeo, comprendeva territori dell'Armenia, dell'Azǝrbaycan
e della Ciscaucasia. Il periodo compreso tra il regno di Daviṫ IV
Aḡmašenebeli (♔ 1089-1125) e quello della regina Ṫamar (♔ 1160-1213),
è
l'epoca d'oro della letteratura cartvelica, dominata dalla figura di Šoṫa
Rusṫaveli (1172-1216), autore del Veṗxis Tʻqʻaosani,
«L'uomo dalla pelle di pantera», il raffinato poema nazionale georgiano. Alla stessa epoca
risale anche l'Amiran-Dareǯaniani,
un romanzo di Mose Xoneli (XII sec.) incentrato sul mitico eroe Amirani.
L'opera è però una rielaborazione letteraria di stampo cavalleresco e non è di
alcuna utilità per il mitologo.
Il regno di Ṫamar fu seguito da un lungo periodo di declino.
La Georgia si ritrovò frammentata in una moltitudine di regni e
principati cristiani, contesi tra gli imperi Ottomano e Persiano, e in uno stato di guerra pressoché ininterrotto.
Uno stato di cose che perdurò fino ai primi
del XIX secolo, quando un nuovo impero, quello Russo, annetté la Georgia e, nel giro di pochi
decenni, il resto
del Caucaso. Nemmeno un secolo dopo, nelle sanguinose guerre civili che seguirono la Rivoluzione Russa,
la Georgia poté accarezzare una breve stagione di libertà, dal 1918 al 1921. Occupata
subito dopo dall'Armata Rossa, la Georgia fu annessa
all'U. Solo nel 1991, ha potuto riconquistare la propria
indipendenza.
È quasi sorprendente che, in tutte queste vicissitudini, il
popolo georgiano sia rimasto fedele alle proprie tradizioni, conservando un
ricco patrimonio di
fiabe, leggende, proverbi, canti, nenie funebri, danze, e persino rappresentazioni
mascherate (berikʻaoba in carnevale, qʻeenoba in quaresima)
assai vicine al nostro teatro dell'arte. La leggenda di Amirani ci è nota
attraverso circa duecento versioni raccolte dai folkloristi tra la fine del XIX e
la metà del XX secolo. E ancora intorno agli anni Ottanta, Charachidzé
scriveva che l'attività creatrice dei cantastorie georgiani era ancora viva e
produttiva, e non escludeva che in futuro potessero venire ancora raccolte nuove versioni del
mito
(Charachidzé 1986¹). Gli anni successivi hanno visto la
disintegrazione dell'U e l'inizio di una serie di sanguinosi conflitti nella
regione, e ignoriamo quale possa essere stato l'esito di questi studi.
Le versioni del ciclo amiranico sono diverse tra loro, a volte in maniera decisiva,
ma è la naturale conseguenza di una trasmissione orale, affidata tanto alla
memoria quanto all'improvvisazione dei cantastorie. Sebbene alcune varianti
divergano in maniera interessante (e alcune di esse saranno prese in
considerazione nel nostro studio), la maggior parte delle versioni percorre un
canovaccio di massima da cui, vagliando accuratamente le varie parti, si può
ipotizzare, più che una forma «canonica» del ciclo, una sorta di minimo comune multiplo. In questo nostro excursus, attingiamo soprattutto al
materiale fornito da Charachidzé, il quale aveva utilizzato come «mito di riferimento» una versione raccolta tra i montanari georgiani del
Q‘azbegi,
pubblicata nel 1896 (L1), e una versione svanete
(L2), pubblicata nel 1893. La numerazione
delle varianti è quella fornita dallo stesso autore
(Charachidzé 1986¹).
 |
|
Nascita di Amirani |
|
B. Kutatelaʒe. (Aa.Vv. 1975) |
L'incipit è degno di una leggenda gallese. Un
cacciatore, Dareǯani, dopo aver a lungo
inseguito un animale tra le balze di una montagna, viene attirato nella dimora
della bionda e pallida Dali, dea della selvaggina
cornuta, a cui appartengono le specie più ricercate dai cacciatori:
cervi, caprioli, mufloni, camosci e i maestosi stambecchi caucasici
(Tuite 2000). Essi si amano e passano insieme la notte. Il giorno
successivo, la dea insiste che l'uomo torni a casa, prima che la moglie cominci
a insospettirsi della sua assenza e scopra il loro nascondiglio. Ma la passione
induce il cacciatore a fermarsi ancora una notte, e la notte successiva. A
questo punto, la moglie di Dareǯani, dopo
aver seguito le tracce del marito sulla neve, penetra nella dimora di
Dali e trova gli amanti addormentati. Senza
svegliarli, si impadronisce delle forbici d'oro della dea e le taglia le trecce,
anch'esse d'oro. Se ne torna a casa, senza svegliarli. Il mattino successivo, al
risveglio, Dali si accorge dell'accaduto e,
dichiarando che la vita per lei non ha più valore, rivela all'amante di essere
incinta.
È il classico mitema degli amori melusiniani, secondo la
felice definizione di Laurence Harf-Lancner: una volta infranto l'interdetto,
Dali deve svanire per sempre dal mondo e dalla vita
del suo amante (Harf-Lancner 1984). Ma prima chiede
a Dareǯani a
squarciarle il ventre ed egli ne estrae un bambino prematuro, la cui gestazione
sarà portata a termine successivamente nel ventre di un torello e di una
giumenta. Esposto infine presso una sorgente, il bimbo viene «battezzato» da un
vecchio viandante, il quale non è altri che il dio supremo Morige Ḡmerṫi.
L'eccezionale padrino gli conferisce, oltre al nome,
Amirani, anche delle capacità sovrumane. Poi un contadino, Iaman, raccoglie il bimbo e lo alleva
con i suoi due figli Badri e
Usip‘.
(Charachidzé 1984).
Divenuti adolescenti, Amirani, Badri e
Usip‘ lasciano l'abitazione paterna e compiono l'«uscita in piano» [velad gasvla], avventurandosi in regioni lontane
e selvagge per il loro apprendistato eroico. Dapprima i tre giovani vivono come briganti
assaltando tutti i viandanti che incontrano, senza
distinzione e soprattutto senza ragione, secondo una pratica di iniziazione guerresca
che troviamo diffusa
in particolare presso gli indoeuropei
(cfr. Tacitus, Germania [31]). In seguito i
tre cominciano ad aggredire i devebi (cfr. iranico daēvā), i dèmoni
che vivono nei luoghi più aspri e isolati, che sconfiggono senza alcuno sforzo.
| |
Noi tre ci scontrammo con trecento
devebi a Čabalxeti,
noi ci incontrammo sotto una tenda a Balxeti e li annientammo tutti quanti.
noi resistemmo nella battaglia, riparati sotto i nostri scudi.
Ah! Eran là i devebi? Noi li stendemmo sotto le
nostre spade. |
|
L1 |
In questo modo i tre fratelli crescono e diventano forti; in quanto ad
Amirani, «egli diviene talmente possente che la
terra faceva fatica a portarlo» (L1). A questo punto il terzetto è pronto per compiti
ancora più grandi.
Dopo una partita di caccia, i tre scoprono una torre di cristallo, dove giace
un morto, che è lo zio (o il nipote) di Usip‘. I
giovani eroi decidono di vendicarlo e si mettono alla ricerca del suo
uccisore, il dev tricefalo Baq‘baq‘. Quest'ultimo
viene affrontato in duello da Amirani, che prima
gli strappa una spalla, poi gli taglia le tre teste. Da queste escono tre vermi,
che subito si trasformano in altrettanti vešapʻebi. Questo termine
(sing. vešapʻi), che oggi in
georgiano indica la balena, deriva da un armeno višap, parola che
indicava in origine una sorta di enorme serpente, legato all'acqua (cfr. avestico višāpa
«velenoso», sanscrito viṣa «veleno»). Sono dunque tre dragoni
serpentiformi, quelli che
Amirani si trova di fronte: uno bianco, uno rosso e uno nero. L'eroe divide tra i fratelli il compito di
uccidere i tre mostri, ma Badri e
Usip‘, presi dal terrore, se la danno a gambe. Per la
prima volta nella sua vita, Amirani riconosce che
il suo coraggio e la sua forza soprannaturali lo isolano dal resto dell'umanità
ed ha improvvisa consapevolezza della propria solitudine. Dopo aver pregato invano i fratelli,
Amirani si rivolge alle sue armi: «O mia spada, o
mia corazza, voi almeno, soccorretemi!» Uccide il vešapʻi bianco e poi quello rosso,
ma il vešapʻi nero lo ingoia e si rifugia nel mondo ipoctonio.
Nella cosmologia georgiana, l'universo è un trimundio costituito da tre livelli
cosmici, chiamati sk‘neli. Essi sono:
- Lo ze-sk‘neli, «livello di sopra», cioè il mondo celeste, patria delle
divinità;
- Il gare-sk‘neli, «livello esterno», cioè il mondo terrestre, patria
degli esseri umani;
- Il ve-sk‘neli, «livello di sotto», cioè il mondo sotterraneo e
ipoctonio, patria dei dèmoni e dei mostri.
È appunto nel ve-sk‘neli che si rifugia il vešapʻi. Questi è il
serpente che ingoia il sole ogni notte e nel corso delle eclissi, e che tenta di
divorarlo per sempre al solstizio di inverno. Con il suo pugnale,
Amirani gli squarcia il ventre e riesce a uscire
fuori.
Il vešapʻi gli chiede di riparare alla ferita, fabbricandogli un fianco di
metallo. L'eroe gliene applica però uno di legno, che il sole può bruciare per
liberarsi. Se così non avesse fatto, il mondo sarebbe perito.
Per venire fuori dal mondo sotterraneo,
Amirani sale a cavalcioni sul dorso di una
gigantesca aquila. Ma l'ascesa si rivela lunga e faticosa anche per il poderoso rapace, e
Amirani, ogni volta che l'aquila perde le forze e
minaccia di precipitare, le infila nel becco un pezzo di carne che ha tagliato
via dalla propria coscia. In questo modo, l'uccello completa l'ascesa tra i mondi,
ed Amirani può tornare sulla terra. Ma a causa della sua
permanenza nel ventre del vešapʻi, è privo di barba e di
capelli, e i suoi parenti si prendono gioco di lui equiparandolo a un neonato.
Si troviamo di fronte a un motivo iniziatico: l'eroe, ingoiato dal
mostro, è andato incontro a una morte e a una rinascita simbolici. Ora
Amirani è stato rigenerato ed è ancora più forte e
più potente di prima. In breve tempo, egli riacquista la sua chioma e suoi
mustacchi, entrambi motivi di orgoglio presso i guerrieri caucasici.
 |
|
Amirani rapisce Q‘amar
(✍
2010?) |
|
Unita Nightroud, illustrazione |
A questo punto, seguendo un consiglio ricevuto da Baq‘baq‘,
Amirani va a cercarsi una fidanzata nel paese dei dèmoni-fabbri
aǯebi. La
terra di aǯeti si trova al di là dei mari, ed
Amirani riesce ad arrivarvi in groppa a un cavallo
miracoloso, Ṫeṫroni, che compie un
balzo vertiginoso attraverso il cielo. Arrivato a destinazione,
Amirani rapisce Q‘amar,
figlia del re aǯe, e torna indietro nello stesso modo, inseguito da
tutta l'armata demoniaca.
Badri e Usip‘
intervengono in suo aiuto, ma vengono uccisi. Amirani
riesce a sbaragliare le coorti aǯebi, ma si ritrova a
combattere contro il loro re: un colosso mostruoso, coperto da macine di mulino
in luogo di elmo e di corazza. Amirani riesce a sconfiggerlo
grazie ai consigli di Q‘amar, che gli insegna nuove
tattiche di combattimento prima ignorate. Vincitore, ma disperato per la morte
dei suoi fratelli, Amirani si uccide, ma viene tosto
resuscitato dalla demoniaca fanciulla.
Dopo aver abbandonato fratelli e fidanzata, ormai del tutto solo,
Amirani riprende il suo vagabondare. Nulla gli resiste:
qualsiasi impresa è divenuta per lui pura routine. Un giorno si imbatte su un carro
trainato a gran fatica da dodici paia di bufali. Su questo, giace morto un
gigante, Ambri Arabi. La sua gamba penzola giù dal
carro e scava un solco nel terreno. La madre del gigante chiede ad
Amirani di rimettere la gamba di
Ambri sul carro. L'eroe ci prova, ma non è
in grado di smuoverla, né di sollevarla. Quest'inaspettata défaillance, e
contro una «cosa» inerte, priva di vita, getta Amirani
nel più cupo sconforto. Prega allora il suo padrino, il dio supremo
Morige Ḡmerṫi, il quale gli accorda una forza
supplementare, quanto gli basta per portare a termine l'impresa, ma lo
avverte: «Io so bene che non farai buon uso di questa forza: la userai per fini
malvagi e sarai ancora umiliato».
Amirani riprende il suo cammino. È ormai
arrivato al culmine della sua potenza e, di conseguenza, la sua solitudine si è
fatta assoluta, totale. Rotti gli ultimi legami che univano l'eroe agli esseri di questo
mondo, egli è senza più parenti, amici, fidanzata, e il mondo è ridotto
a una landa desolata. Sulla terra non restano che «tre dèmoni, tre cinghiali,
tre querce» (L2), ultimi avanzi di vita in mezzo
al deserto provocato dal campione troppo vigoroso. La solitudine è ancor più
accentuata dalla natura bellicosa dell'eroe e dalla purezza della sua unica
passione, quella di combattere. Ma Amirani ha ormai
sterminato tutti gli avversari degni di lui e si ritrova di fronte a un punto
culminante nella carriera degli eroi caucasici, una «nevrosi del destino»
(secondo la bella espressione di Charachidzé) espressa dalla domanda:
esiste qualcuno più forte di me?
È un motivo presente soprattutto nell'epopea ossetica dei nartæ, e
che Georges Dumézil ha più volte sottolineato nei suoi lavori
(Dumézil 1930 | Dumézil 1965). È il momento in cui l'eroe,
giunto al culmine della sua potenza,
parte alla ricerca dell'avversario definitivo, necessario, introvabile. La
situazione di Amirani è però ancor più drammatica:
il gare-sk‘neli, o «livello esterno», non gli offre più alcuno con cui
misurarsi, e d'altra parte egli ha sconfitto devebi e aǯebi,
esseri legati al ve-sk‘neli, o «livello di sotto». Non gli resta che
rivolgere lo sguardo verso l'alto, allo ze-sk‘neli, o «livello di sopra».
Arriva così, nel modo più naturale, l'idea di sfidare il dio
supremo
Ḡmerṫi.
|
Non c'era nessuno che potesse farcela con lui. Amirani si inorgoglì
e si esaltò. Alla fine disse: «È stato il mio padrino a darmi la forza: che io
lotti con lui, che io provi la mia gagliardia!» |
|
L1 |
Ḡmerṫi rifiuta
la lotta, ma gli impone una sfida: svellere il bastone che egli pianterà al
suolo. Amirani accetta. Il dio pianta il bastone al
suolo, ma l'eroe riesce a strapparlo per ben due volte. La terza volta, però, il bastone
mette radici così profonde che avvolgono la terra intera, e Amirani non
riesce nemmeno a smuoverlo. È allora che Ḡmerṫi, per punirlo della sua tracotanza,
incatena Amirani al bastone, ormai divenuto un
palo inamovibile.
(L1)
Il motivo del bastone è attestato in
diverse versioni della vicenda (L1 | L9),
ma esistono altre varianti. Ad esempio, al posto del bastone compare assai
spesso un robusto palo di
ferro, conficcato profondamente al suolo (L2 | L16 |
L19 | L20). In alcuni casi,
Amirani viene sfidato a sollevare una pietra, ma
non riesce neppure a smuoverla e rimane con le mani attaccate alla roccia
(L21). In questa versione, Cristo (georgiano
rist‘e),
prende il posto di Ḡmerṫi:
|
Amirani interpellò
rist‘e con boria:
«Allora, sembra che sia tu che voglia di misurarti con me?»
Prendendo una pietra grande quasi come una montagna, egli lanciò a più di
quaranta verste. rist‘e prese la
stessa pietra e, ordinandole di sorvolare nove montagne, la lanciò con una tale
forza che essa non solo sorvolò nove montagne, ma anche sprofondò quasi
completamente nella terra.
rist‘e disse ad
Amirani: «Se sei davvero un così gran campione, strappa un po' questa
pietra dalla terra!»
Amirani corse dove era la pietra, ce la mise tutta
per spostarla, ma non riuscì nemmeno a scuoterla e, quel che è peggio, non poté
staccarsi da essa. Allora rist‘e ordinò
che egli fosse incatenato proprio a quella pietra. |
|
L21 |
Ḡmerṫi non si offre mai a uno scontro diretto con Amirani,
né provvede mai fisicamente all'incatenamento
dell'eroe. Su questo punto, i testi si limitano
a dire che «Ḡmerṫi incatenò Amirani»,
assumendo che la volontà divina sia sufficiente per assicurare
le catene intorno al corpo dell'eroe. Alcune varianti specificano che
Ḡmerṫi incaricò i aǯebi
di
catturare Amirani; essi circondano l'eroe nel sonno e lo incatenano al palo.
 |
|
Amirani e
Q‘urša (✍
2010?) |
|
Unita Nightroud, illustrazione. |
Il castigo, però, non è ancora terminato. Ḡmerṫi scuote le montagne e fa
precipitare su Amirani
la cima di una montagna, che è il Q‘azbegi/Kazbegi nelle versioni orientali
della leggenda, o dello Ialbuzi/Ėl'brus,
in quelle
occidentali. L'eroe si ritrova così ricoperto da una cupola di roccia, che lo isola
completamente dal mondo, condannandolo a una tenebra assoluta. Come compagno di prigione, ha
il cane alato
Q‘urša, figlio di un'aquila. Il cane lecca giorno e notte una maglia
della catena, assottigliandola sempre di più. Ma, vuole la tradizione, all'alba
del giovedì santo, nel momento in cui la catena sta per cedere all'usura e
Amirani è sul punto di essere liberato, i fabbri di
tutta l'umanità entrano nella fucina e, nel più assoluto silenzio, percuotono a
tre riprese l'incudine e plasmano un piccolo oggetto simbolico. Immediatamente,
le catene di
Amirani riprendono la loro
saldezza, l'eroe rimane prigioniero all'interno della montagna e il cane alato ricomincia il suo lavoro,
fino all'anno successivo.
Secondo altre versioni, la prigione di
Amirani si squarcia a intervalli regolari, ogni
certo numero di anni, permettendo all'eroe incatenato di
affacciarsi sulla terra. Leggende, diffuse tra i montanari della Georgia e della Svanezia, raccontano di un pastore,
un fabbro, un cacciatore che, dopo essersi perduto
tra le asperrime cime del Gran Caucaso, si trova di fronte la spaventosa visione
dell'eroe, legato al suo
palo, lo sguardo furente, la barba e i capelli incolti. Il nuovo venuto cerca di liberare Amirani,
ma senza riuscirci. La spada dell'eroe si trova abbandonata a pochi passi e,
se Amirani riuscisse a brandirla, potrebbe
spezzare le catene, ma l'uomo non riesce neppure a sollevarla. In alcune
versioni della leggenda, Amirani chiede all'uomo
di andare a casa per portargli la catena del focolare, o quella dell'aratro, in
modo da trascinare la spada, ma il disgraziato non riesce mai nella sua impresa.
Spesso è la moglie a bloccarlo con domande inopportune, impedendogli di
portare aiuto all'eroe incatenato. Intanto, la montagna si richiude ed
Amirani torna a sprofondare nelle tenebre della sua
eterna prigionia. Allora si scuote, furibondo, causando spaventosi terremoti.
(Charachidzé 1986¹)
|
|
LA VERSIONE ABXASICA. ABRYSK’YL Gli Abxasi (endonimo Aṗsuac°a, georgiano Aṗxazebi,
russo Abchazy) sono un
gruppo etnico stanziato a nord-ovest della Georgia, lungo la costa del
Mar Nero. Presenti sul posto da tempo immemorabile – le fonti classiche li
conoscono come Abazgoi –, gli Abxasi parlano una lingua classificata,
insieme con il circasso e l'estinto ubyx, al gruppo caucasico nordoccidentale.
Inizialmente compresa nella sfera d'influenza dell'impero bizantino, subito dopo
il 1000 l'Abxasia,
o Aṗsny, entrò nell'orbita del
regno georgiano. Quando la sponda orientale del Mar Nero
passò sotto gli Ottomani, tra il XVI e il XVII secolo, l'Abxasia divenne una
provincia dell'impero e divenne oggetto di un profondo processo di islamizzazione.
È solo nel XIX secolo, a cavallo dell'annessione del Caucaso all'Impero
Russo, che la piccola Abxasia cominciò a cercare una
propria voce. Cosa non facile, stretta com'era tra due vicini tanto ingombranti
come la Georgia e la Russia. Furono proposti degli alfabeti nazionali, sviluppati
dal latino o dal cirillico, sebbene l'inventario consonantico dell'abxasico,
tra i più estesi del mondo, mettesse a dura prova i tentativi di
trascrizione grafica. Ai giorni nostri, conclusa la parentesi sovietica, il piccolo paese non ha ancora uno status ben
definito: un lungo stato di guerra con la Georgia, caratterizzato da episodi di
inaudita ferocia, si trascina almeno dal 1989.
Ma a noi non interessa la politica, bensì la mitologia. Convertiti al
Cristianesimo in epoca bizantina, all'Islām sotto gli Ottomani,
gli Abxasi hanno visto la loro religione tradizionale spegnersi assai rapidamente, lasciando
poche credenze frammentarie, insufficienti per ricostruirne il sistema
originario. Il dio supremo degli Abxasi era invocato col nome di Anc°a.
Per quanto sia questo il modo con cui gli Abxasi chiamano ancora oggi il Dio delle
religioni monoteiste, la curiosa etimologia del nome ne tradisce l'origine pagana.
Infatti Anc°a [ɑnʦʷʰɑ] significa
letteralmente «i là» (con a-, articolo definito; -n-, avverbio «là», -c°a,
suffisso del plurale). Questo bizzarro nome collettivo sembra intendere, secondo Charachidzé, «l'insieme delle parti divine concepite presenti dovunque
nell'universo, ma riunite in un Tutto unico»; traccia puramente verbale di una
teologia che non doveva avere nulla da invidiare, in fatto di complessità, ad
altre assai più illustri (e si pensi pure al trattamento plurale del biblico
lōhîm). Altre divinità abxase erano Š’as°,
signore della fucina, anch'egli declinato al plurale, e
Až°aiṗšaa, dio della caccia e degli animali
selvatici.
(Charachidzé 1989¹)
 |
|
Trittico delle leggende caucasiche |
|
Levars Butba (1960-) |
Scomparsa la mitologia originaria, i suoi frammenti vennero conservati nel folklore. Se, dal Medioevo, la letteratura colta aveva
scelto il georgiano come mezzo di espressione, il popolo abxasico conservò
nella lingua materna un ricco e interessante patrimonio di fiabe e
racconti, tra cui spicca una versione locale del
mito del campione incatenato. Difficile definire il suo grado di originalità
rispetto alla versione georgiana: le affinità sono strette, le differenze
interessanti. Il racconto che qui riassumiamo è stato pubblicato in
russo nel 1892, ma solo da poco si è reso disponibile il testo abxasico
(Charachidzé 1986¹ | Džapua 2003). L'eroe
è chiamato Abrysk’yl.
La sua nascita, come quella di Amirani, è
miracolosa. Una vergine, «fecondata da una forza celeste», lo mette al mondo, e
il bimbo cresce con velocità prodigiosa. A dieci anni,
Abrysk’yl è già in grado di tenere testa ai più valenti campioni.
Divenuto uomo, è un eroe audace e generoso, di grande forza e coraggio
ineguagliabile. Il paese di Aṗsny vede d'un tratto esaudite le sue più fervide
preghiere: Abrysk’yl depone il malvagio
sovrano che tiranneggia il popolo; uccide senza pietà i membri dei due clan di stregoni,
gli Aeš°ba e gli Aac°ba; elimina tutti gli uomini dai capelli rossi e gli
occhi azzurri, affinché non gettino il malocchio sulla popolazione; combatte gli
Adauc°a, sorta di orribili
orchi cannibali, finché non li ha sterminati fino all'ultimo.
Abrysk’yl si muove rapidamente attraverso il
paese, dovunque vi siano torti da raddrizzare, deboli e oppressi da difendere.
Il suo cavallo, Araš’, è dotato di ali ed è in
grado di volare; inoltre, possiede il dono della favella. Se
Abrysk’yl dorme, Araš’
veglia, e lo difende dagli agguati dei nemici e dei briganti. L'eroe possiede
due rifugi inattaccabili: uno in alto, sulla cima del monte Ercax°, l'altro in
basso, sulla costa del Mar Nero. Da quelle posizioni, egli può vedere i nemici
da qualsiasi parte provengano: dal mare, oppure dai monti.
Sotto la protezione di Abrysk’yl, la terra di
Aṗsny «fiorisce», «diviene più vasta e più grande». Tutti gli Aṗsuac°a godono
dell'amicizia e della protezione dell'eroe, e persino i suoi nemici cercano di
conciliarselo. È un'età benedetta, quella di Abrysk’yl:
la vacca dà latte tre volte al giorno, la capra quattro o addirittura cinque
volte, perché l'eroe ha sradicato le felci e tutte le piante nocive, e le
praterie sono ora coperte di una coltre d'erbetta grassa e fresca. La gloria di
Abrysk’yl si diffonde nel mondo, tanto che nessun
nemico osa più attaccare l'Aṗsny. È tale il rispetto di cui gode, che al suo
passaggio, tutti si inchinano dinanzi a lui.
Inevitabilmente l'eroe si inorgoglisce. Sulla terra non è rimasto
nessuno che possa contendere con lui ed Abrysk’yl pretende di essere alla pari con il supremo
Anc°a. L'eroe arriva al punto di rubare
al dio le proprie prerogative. Quando vuole che tuoni,
Abrysk’yl
riempie di sassi dei sacchi di pelle di vacca, li attacca ai fianchi di
Araš’
e corre sulla terra e per il cielo: i sassi, battendo gli uni contro gli altri,
provocano rumori simili a tuoni. Quando vuole che lampeggi, lancia in cielo
ciottoli di selce e li colpisce con la lama della spada: le scintille si levano
crepitando come fulmini.
Altrettanto inevitabilmente,
Anc°a si irrita contro l'eroe ribelle e ordina ai suoi spiriti
subalterni, gli aṗeambarc°a, di catturarlo e di gettarlo,
le mani e i piedi legati, nel mondo sotterraneo, e di torturarlo crudelmente, finché
non si sottometta al volere divino.
Ma non è facile catturare l'eroe. Ora è sulla cima del monte Ercax°, ora
nella sua dimora sul Mar Nero. Come vede avvicinarsi gli aṗeambarc°a,
balza in groppa ad Araš’ e il fedele
cavallo lo conduce in un balzo dal mare alle montagne, dalle montagne al
mare. Quando Araš’ è al pascolo,
Abrysk’yl utilizza allo stesso modo una lunghissima
pertica,
che lo porta in un lampo dall'uno all'altro suo rifugio. Estenuato dalla lunga
caccia, l'eroe dorme ogni volta per tre giorni e tre notti, per poi rimanere
sveglio e vigile altrettanto tempo. Gli aṗeambarc°a, afflitti perché
non riescono ad eseguire la volontà di Anc°a, si
rivolgono allora a una vecchia strega. Costei manda un picchio che, a colpi di
becco, assottiglia la pertica di Abrysk’yl; in cambio,
l'uccellino riceve in capo il suo bel berrettino rosso. A questo punto, gli
aṗeambarc°a si fanno avanti per catturare l'eroe. Questi afferra la pertica
e spicca il suo prodigioso balzo: ma l'asta si spezza, ed egli precipita in una
radura presso il villaggio di lou.
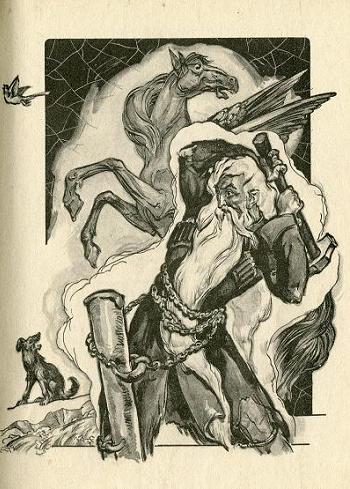 |
|
Abrysk’yl incatenato |
|
Autore sconosciuto |
In un'altra versione, la strega consiglia agli aṗeambarc°a di
stendere davanti a uno dei due rifugi di
Abrysk’yl delle pelli di bue spalmate di grasso.
Avendo seguito questo consiglio, gli inviati di Anc°a
si dividono in due gruppi: uno si apposta nella foresta vicino al luogo dove
si trovano le pelli di bue, il secondo si lancia all'inseguimento di
Abrysk’yl. Questi, lancia il cavallo al galoppo, ma
Araš’ scivola sulle pelli di bue e cade trascinando nella caduta il
cavaliere.
Gli aṗeambarc°a catturano Abrysk’yl e,
guidati dalla strega, lo trascinano nelle profondità di una caverna, scavata nel
fianco di una montagna. Il fedele Araš’ li insegue,
lanciando nitriti infuriati, e viene anch'egli catturato. Due pali di ferro
vengono conficcati al suolo: a uno viene legato Abrysk’yl,
all'altro Araš’.
Il tempo passa, ed Abrysk’yl rimane lì
incatenato. La sofferenza dell'eroe è indicibile: ha i capelli e la barba sempre
più lunghi. Scuote il pilastro, nel tentativo di scardinarlo, finché,
dopo un anno, questo sta ormai per uscire dal foro in cui è conficcato. È allora
che un uccellino blu [bolok̄ank̄ara] si posa sulla cima del palo.
Abrysk’yl lo colpisce con un martello, intenzionalmente posto alla sua
portata dagli aṗeambarc°a, e il pilastro torna a conficcarsi al suolo,
imprigionandolo ancora una volta.
Intanto gli Aṗsuac°a stanno cercando il loro eroe per tutto il paese. Un giorno,
qualcuno nota del letame di cavallo nella sorgente che sgorga dal fianco del
monte. Un gruppo di coraggiosi si dirige così verso la vicina caverna, con sette
muli e un gran numero di candele. Gli uomini scendono nelle buie
profondità della terra e, dopo un lungo percorso, le candele si spengono. A
questo punto, essi odono le grida dell'infelice.
“Uanaǯʼalbeit, sei ancora vivo?” si stupiscono gli uomini.
“Sono vivo, ma nessuno arriva a me!” è la risposta.
“Coraggio, siamo scesi alla tua ricerca. Ti libereremo e ti riporteremo in
Aṗsny”
“Ditemi prima come vanno le cose nel paese natale” chiede
Abrysk’yl. “Di nuovo crescono e si moltiplicano
gli Aeš°ba e gli Aac°ba? E le genti dai capelli rossi e dagli occhi azzurri?
E gli adauc°a sono ritornati? Ricrescono già la felce e le altre piante
nocive che ostacolavano lo sviluppo delle piante utili? Le vacche danno ancora
latte tre volte al giorno e le capre cinque? I nemici esterni molestano gli
Aṗsuac°a come accadeva prima della mia nascita?”
I soccorritori non posso nascondergli la desolante realtà, e cioè che, con la
sua scomparsa, tutto è tornato come prima della sua nascita.
Abrysk’yl geme: “Allora non parlatemi più della mia
amata patria. Non posso né sentirne parlare né soffrire ulteriormente”. Consiglia ai soccorritori di aggrapparsi alle code delle mule, che li
condurranno di nuovo fuori dalla caverna, e conclude: “Non è ancora il giorno della
mia liberazione”.
|
| LA VERSIONE CIRCASSA. TEƷAU
Tra i popoli caucasici nordoccidentali, spiccano i Circassi, le cui tribù, caratterizzate da una
continuità di dialetti, sono sparse in un certo numero di isole linguistiche nel
territorio della Russia caucasica. Essi si dividono, in grosse linee, in
Circassi occidentali o Adighi (circasso
Adǝgė, russo Adygency) e Circassi orientali o Cabardini (circasso Qʻėbėrtajxėr-Adǝgė, russo
Kabardincy).
L'antico pántheon circasso era piuttosto ricco.
Tė (Tėšxo)
era il dio supremo, colui che aveva fissato le leggi dell'universo. Un posto di
primaria importanza era attribuito a Λėpš, il dio
fabbro dai sette corni, che lavorava il metallo a mani nude, mentre
Šǝblė era il genio folgoratore, signore del
fulmine. Diverse dee erano preposte al controllo degli elementi naturali:
Xǝg°aśė dominava il mare,
Psǝχ°ėg°aśė i fiumi,
ancėg°aśė la pioggia. Vi erano infine diverse divinità specializzate
nell'amministrazione della fauna: Taḡėlėǯ
controllava la fertilità, Pśǝmėzǝta la caccia e la
selvaggina, Amǝš gli ovini,
Zekḣ°atė i cavalli, Axǝn i bovini.
Quest'ultimo era una specie di gigante, padrone di una mandria così vasta da
coprire l'intero giro dell'orizzonte. Il suo abituale mezzo di trasporto – che
abbiamo visto anche attribuito ad
Abrysk’yl – era una
pertica lunga più di duecento metri, che egli piantava sul fondo delle valli per
saltare da una montagna all'altra. Un giorno, racconta uno dei rari miti
circassi sopravvissuti, Axǝn decise di
andare a far visita al suocero e si mise in cammino con la sua pertica
smisurata. Il suocero, preoccupato dall'arrivo del suo spaventoso genero,
approfittò del fatto che Axǝn dormiva una settimana
su due, per segargli la pertica in vari punti. Così, quando
Axǝn fece per saltare da una vetta all'altra, l'asta si spezzò nel bel mezzo del balzo e lo sventurato gigante precipitò in
un fiume, scomparendo per sempre nelle sue correnti. Da allora, per commemorare
l'avvenimento e consentire ai circassi di scontare la loro colpa, ogni anno,
alla stessa data, si procede al sacrificio di una vacca. La vicenda del titano
incatenato è conosciuta in diverse versioni tra i vari gruppi circassi. Il suo
nome, presso gli Adighi è perlopiù Teʒau; presso
i Cabardini è Nesren. Le leggende che riportiamo di
seguito sono tratte da fonti secondarie. Rispetto ai racconti georgiani e
abxasici, il materiale circasso a nostra disposizione appare di qualità
inferiore, piuttosto eterogeneo e certamente non esaustivo: insufficiente per
trarre delle conclusioni generali. Lo riportiamo a puro scopo illustrativo.
Teʒau, secondo la leggenda riportata da Axel Olrik, si era conquistato la
fiducia del dio supremo, Tė, che lo aveva ammesso
al suo fianco – sembra – come consigliere. Ma poiché Teʒau
aveva abusato dei suoi privilegi e aveva tentato di detronizzare
Tė, quest'ultimo lo aveva ferocemente punito
incatenandolo per l'eternità. Teʒau si trova
ai piedi di un'alta montagna, legato solidamente alla roccia con sette catene.
Ha una spada posta poco sopra il suo capo, e
si protende nel tentativo di afferrarla. Nonostante sia alto quanto la roccia,
non vi riesce mai. Ma ad ogni suo movimento, le catene si assottigliano. Dicono
i Circassi: «Quando Teʒau recupererà la spada
– ciò avverrà in un giorno che non è prossimo – taglierà le catene, si libererà
e circolerà per il mondo per sottometterlo» (Olrik 1902).
| Il vecchio è generalmente in stato di torpore. Quando ne esce chiede ai suoi
custodi: «La terra produce ancora canne e montoni?» Rispondono i custodi: «Sulla terra spuntano sempre canne e nascono sempre montoni». A questo punto, [Teʒau]
diviene furibondo, perché sa che la sua torture continuerà finché la terra
produrrà canne e montoni. Disperato, vuol spezzare la roccia. I suoi movimenti
fanno tremare la terra, le sue catene producono lampi e tuoni, l'ansare del suo
respiro causa gli uragani, i suoi gemiti i boati sotterranei; dalle sue lacrime
scaturisce mugghiando ai piedi del monte Ėl'brus il fiume spumeggiante. |
| Leggenda di Teʒau |
I Circassi orientali, o Cabardini, conoscono una versione ancora differente del racconto. In
una di esse, il protagonista non ha nome, ma è descritto come un gigante monocolo:
|
Molti, molti anni fa, un gigante che aveva un solo occhio sulla
fronte, osò penetrare il mistero con il quale Tė
ha circondato le vette dell'Elbruz. Salì alla sella che s'incava tra le due
cime, presso le rocce dalle quali scaturisce una fonte cristallina. Ma
Tė non tollerò tanto ardire e con una lunga catena
legò alle rocce il profanatore dei misteri. Molti anni sono passati da allora; il
gigante è diventato vecchio. La lunga barba gli giunge alle ginocchia. Il corpo,
un tempo vigoroso, è divenuto cadente, il suo viso altero si è coperto di rughe.
Per aumentare la punizione, Tė gli ha inviato un
uccello da preda: ogni giorno un avvoltoio vola sul gigante e gli scava
spietatamente il cuore. Quando poi il martoriato si curva per bere, l'avvoltoio
lo precede e beve fino all'ultima goccia l'acqua che ha il meraviglioso potere
di rendere immortale chi la gusta. |
|
Ma verrà un giorno in cui Tė si adirerà coi
peccatori figli di Adamo. Allora libererà il monocolo e per gli uomini saranno
guai, perché egli si vendicherà su di loro di secoli di sofferenza. |
|
Leggenda del prometeo monocolo |
Sempre presso i Cabardini, l'eroe incatenato
ha nome Nesren, e viene considerato uno dei nartæ, i leggendari campioni
che i Circassi hanno assorbito dai loro vicini Osseti. Uno di questi racconti
sembra essere un sunto di tutti i motivi legati al mitema caucasico del campione
incatenato:
|
O nart Nesren! I tuoi piani sono stati malvagi e tu rechi
oltraggio a ciò che Tė dice e fa. O maledetto da Tė, che hanno portato sulla
montagna, che hanno inchiodato alla montagna, con un'aquila sopra. Il tuo cane è
al tuo fianco! Con grida e fracasso tu prendi lo slancio; il palo, al quale sei
incatenato, lo fai piegare. Un uccello vola verso di te, si posa sul palo, tu ti
incollerisci, malamente, tu gridi con fracasso di tuono, tu tiri al palo, tu
batti il palo, tu batti ancora più forte. Il cane, che è accucciato al tuo
fianco, assottiglia le catene. Esse sono ormai come un filo sottile. I fabbri,
che si trovano nella fucina, si alzano in fretta, quella brava gente! battono
sull'incudine, le catene si rafforzano [...]. Che Tė ti tenga legato, che Tė ti faccia morire! |
|
Leggenda di Nesren |
I racconti circassi, o almeno quei pochi che siamo riusciti illustrare,
sembrano assai vicini all'archetipo greco; certamente sono più «ellenici» di
quanto non siano quelli georgiani e abxasici. Vi è addirittura un racconto
cabardino su Nesren praticamente identico al mito
greco di Promētheús, in maniera fin allarmante.
Disgraziatamente, l'esiguo materiale a nostra disposizione deriva da fonti prive
di approfondimenti critici, e c'è un forte sospetto di inquinamento del
materiale. Di conseguenza, questi racconti circassi saranno perlopiù esclusi
dalle nostre comparazioni.
|
PROMETEI
CAUCASICI A CONFRONTO
 |
|
Trittico delle leggende caucasiche |
|
Levars Butba (1960-) |
Il prometeo caucasico si presenta nella maggior parte dei casi come un eroe
di notevole forza fisica e valore guerriero. Ma una volta definito l'ambito in
cui si muove il nostro «campione incatenato», bisognerà definire attentamente le
affinità e le differenze tra le sue molte incarnazioni locali. La variante georgiana di
Amirani, quella abxasica di
Abrysk’yl, quella circassa di Teʒau
o Nesren,
possono essere facilmente utilizzate come paradigmi della distanza
che intercorre tra le numerose versioni di questo archetipo caucasico.
Ragione della severa punizione è, in tutti i casi, un eccesso di
hýbris che porta l'eroe, al culmine della sua potenza, a rivolgere la sua
sfida al dio supremo. Quest'ultimo ribadisce la propria autorità incatenando il
ribelle a un palo, inchiodandolo alle rocce, comunque relegandolo in un luogo isolato tra le più
impervie montagne e caverne del Grande Caucaso.
Il meccanismo della sfida e della punizione si ripete costantemente, ed è
questo, infatti, il
nucleo del mito che stiamo analizzando, se non il suo più importante elemento
discriminatorio.
Ma intorno a questo tema, che si ripete pressoché identico in
tutte le versioni, ruotano delle psicologie eroiche assai differenti: se
Amirani avanza solo, di vittoria in vittoria, in
una prospettiva del tutto egoistica, attraverso un mondo privo di
consorzio umano,
Abrysk’yl rivolge i suoi sforzi alla tutela del
proprio paese natale, l'Abxasia, e del popolo che gli è caro. In
quanto a Teʒau, appare proiettato, ancora più
degli altri, nel tempo assoluto del mito. Una profonda differenza ideologica
separa i tre eroi, differenza che si riflette, inevitabilmente, sul motivo della
loro futura liberazione. Agognata dagli abxasi, per
Abrysk’yl; eternamente ritardata dai fabbri
georgiani che battono sulle loro incudini, per Amirani;
paventata dai Circassi, che vedono nella liberazione di Teʒau
o Nesren
una punizione escatologica nei confronti del genere umano.
L'unico a presentare una biografia elaborata e ricca di episodi, è Amirani: il suo
percorso è un percorso iniziatico, in cui la potenza e le capacità guerriere dell'eroe si accrescono
costantemente a ogni sfida affrontata e vinta. La cosa curiosa è che la maggior parte degli episodi presenti nella leggenda
di Amirani sembrano essere non di origine caucasica, ma indoeuropea. I mitemi coinvolti sono infatti perfettamente
trasparenti e presentano precise corrispondenze con complessi mitici ben
conosciuti:
- Lotta di Amirani con il dev tricefalo
Baqʻbaqʻ.
È il mitema dell'abbattimento del tricefalo, ben attestato in molte mitologie di
matrice indoeuropea. In India, è rappresentato dall'uccisione di Viśvarūpa
da parte di Indra o Trita Āptya;
in Īrān, dalla vittoria di Θraētaona su
Aži Dahāka; in Grecia, è la lotta di
Hērakls contro
Geryṓn; etc. Tratteremo in seguito della relazione
che questo importante mitema ha con il nostro prometeo.
- Scontro di Amirani contro il serpente.
È il mitema della lotta del dio-tuono contro il serpente-delle acque. In
Anatolia è rappresentato dalla lotta di Tarḫunta
contro il serpente Illuyanka; In India è la
vittoria di Indra sul serpente
Vṛtra; in Grecia, quella di
Hērakls contro il serpente
Ládōn; in Scandinavia, lo scontro
escatologico di Þórr contro il serpente
Jǫmungandr.
Tra l'altro, anche a Indra capita di venire
temporaneamente ingoiato dal serpente; anche Hērakls
passa tre giorni nello stomaco del mostro marino che è stato inviato a divorare
la sfortunata Hēsiónē, e ne viene fuori privo di
barba e di capelli.
- Rapimento di Q‘amar, figlia del re dei
aǯebi.
L'eroe irlandese Cú Chulainn,
sul punto di sposarsi con Emer, figlia del
fomóir Forgall Monach, viene mandato in Alba
per ricevere la sua istruzione guerriera da tre agguerrite virago, Scáthach,
Úathach e Aífe.
Tornato in Ériu, uccide Forgall e rapisce Emer, portandola via con un balzo fuori dal
ráth.
- Amirani non riesce a sollevare la gamba del defunto
gigante Ambri Arabi.
Abbattuto il gigante Hrungnir,
Þórr rimane schiacciato sotto la
sua gamba e non riesce più a
liberarsi. Sarà suo figlio Magni, di tre anni, a spostare senza alcuno sforzo
la gamba del gigante.
Le corrispondenze sono piuttosto precise, dettagliate e numerose, per poter
parlare di semplici coincidenze: la biografia di
Amirani è stata riscritta sulla base di racconti di
matrice indoeuropea. Ma poiché tali vicende riguardano unicamente
il prometeo georgiano (e non i suoi «colleghi» abxasico e circasso), possiamo
considerarle delle rielaborazioni accessorie.
Ma dimentichiamo per il momento la carriera eroica di
Amirani, così come le imprese a sfondo
nazionale che riguardano Abrysk’yl,
e concentriamoci sul nucleo del complesso che stiamo analizzando: la
sfida al dio supremo e la conseguente punizione. Il mito è
strutturato su un sistema ricorrente di elementi, che possiamo elencare in questo modo:
- Il campione, giunto al culmine della sua potenza, non avendo nessun nemico
con cui possa battersi, sfida il dio supremo. In Georgia,
Amirani invita Ḡmerṫi
a battersi con lui. In Abxasia, Abrysk’yl
manifesta la propria empietà nei confronti di Anc°a affermando
di essere altrettanto potente di lui e rubandogli le prerogative
temporalesche. Presso i Circassi, Teʒau
tradisce
Tė tentando di detronizzarlo, oppure (nella prima variante cabardina) si introduce nel giardino in cui
Tė tiene l'acqua di vita.
- Il campione viene sopraffatto e catturato dal dio supremo. Questo può
avvenire direttamente, con un semplice atto di volontà da parte del dio. Alcune versioni georgiane presentano Amirani
catturato e incatenato dai dèmoni-fabbri aǯebi. Nella versione abxasica, la cattura dell'eroe, da
parte degli aṗeambarc°a, è piuttosto difficoltosa, e richiede
il concorso di una strega.
- Il campione viene solitamente incatenato a un palo; in alcune versioni
georgiane, si tratta del bastone che Ḡmerṫi
ha piantato al
suolo. L'immagine dell'eroe incatenato alla roccia appare
accessoria in Georgia, ma sembra regolare presso i Circassi occidentali.
- Il supplizio viene applicato in un luogo isolato, inaccessibile, tra le più alte montagne del
Grande Caucaso. Nella
maggior parte dei casi, il campione viene rinchiuso in una profonda caverna,
ottenuta facendo cadere la cima cava di una montagna sopra di lui.
- Il campione è quasi sempre affiancato da un animale. Nel caso di
Amirani è il cane alato
Qʻurša; nel caso di
Abrysk’yl
è il cavallo alato Araš’. L'uno e l'altro
rosicchiano le catene che imprigionano il loro padrone, tentando di
liberarlo.
- In molti casi, un uccello si
posa in cima al palo che il campione è quasi riuscito a svellere dal suolo.
Infuriato, l'eroe tenta di colpirlo con un martello che
tiene a portata di mano, ma ottiene soltanto di ribadire di nuovo il palo nel
terreno. Nelle versioni circasse, l'uccello è solitamente un avvoltoio o
un'aquila. In quella cabardina, un avvoltoio rosicchia il cuore di Teʒau
e prosciuga l'acqua di vita che il campione cerca di bere.
- I tentativi d'evasione del campione sono destinati all'insuccesso. Nella
versione georgiana, la roccia si apre a intervalli regolari, permettendo ad
Amirani di affacciarsi al mondo esterno; a
questo punto, un
fabbro o un pastore cerca di portargli aiuto, ma i suoi tentativi falliscono. Allo stesso modo, il tentativo degli aṗsuac°a di
liberare Abrysk’yl non ha successo, e qui la
ragione sta nella necessità mitica che impone all'eroe di rimanere incatenato fino
a un tempo escatologico. Nella versione circassa, Teʒau
riesce ad assottigliare le catene, ma queste riprendono ogni volta il loro
spessore.
- L'incatenamento del campione è necessario per il mantenimento dell'ordine
cosmico. Alla prigionia di
Abrysk’yl corrisponde il mondo che tutti noi conosciamo, in cui l'Abxasia
è un paese afflitto dalla povertà e minacciato da nemici interni ed esterni.
Nella versione circassa, Teʒau chiede se
la terra produca ancora canne e montoni, appunto perché la sua prigionia è
legata alla continuazione del mondo a noi familiare.
- Di conseguenza, la liberazione del campione viene proiettata in un futuro
escatologico, il quale ha differenti connotazioni a seconda
dell'ideologia attribuita al mito. Alla liberazione di
Amirani sembra debba corrispondere una sorta di fine del
mondo e della società così come la conosciamo, ragione per cui i
fabbri georgiani cercano di rimandarla il più possibile. I Circassi
addirittura vedono nella liberazione di Teʒau
il segno della fine dei tempi, una punizione per i peccati degli uomini. Al
contrario, gli Abxasi sperano nella liberazione di
Abrysk’yl,
destinata a riportare l'età dell'oro sul loro sventurato paese.
Tentiamo uno schema della materia caucasica, con l'accortezza che stiamo
operando una scelta «mirata» tra molte e difformi varianti. Seppur con il
rischio di un «effetto selezione», possiamo proporre uno specchietto del
genere:
| |
GEORGIANI |
ABXASI |
CIRCASSI |
| 1 |
Amirani agisce in un mondo
separato da quello umano, combattendo contro esseri
soprannaturali. |
Abrysk’yl combatte per la sicurezza
del proprio paese, l'Abxasia, per la serenità e la prosperità dei
suoi abitanti. |
|
| 2 |
Amirani, giunto al
culmine della sua potenza, si inorgoglisce e sfida il dio
supremo Morige Ḡmerṫi, suo
padrino, a combattere contro di lui. Ḡmerṫi
gli impone di estrarre un bastone
piantato al suolo. |
Abrysk’yl, giunto al culmine della
sua potenza, si inorgoglisce e sfida il dio supremo,
Anc°a, con atti di empietà. |
Teʒau, posto al fianco del dio
supremo
Tė, si ribella e tenta di detronizzarlo. |
| 3 |
La cattura e l'incatenamento di
Amirani sono un immediato risultato della volontà divina. |
In alcuni casi, Ḡmerṫi
ordina ai dèmoni-fabbri aǯi
di catturare e incatenare Amirani.
|
Anc°a ordina ai suoi inviati, gli aṗeambarc°a,
di catturare Abrysk’yl. Ma
l'operazione si rivela piuttosto difficoltosa, in quanto
Abrysk’yl vede arrivare i suoi
nemici da lontano ed è in grado di spostarsi, grazie a una pertica
lunghissima, dal mare alle montagne. |
La cattura e
l'incatenamento di Teʒau sono
un immediato risultato della volontà divina. |
| 4 |
Amirani viene
incatenato a un palo (o a una roccia), e ricoperto dalla volta
cava di una montagna. |
Abrysk’yl viene condotto nel
profondo di una caverna, e lì incatenato a un palo. |
Teʒau viene incatenato alle
rocce di una montagna. |
| 5 |
Il cane alato Qʻurša
rimane al fianco del padrone, nella sua prigione. Tenta
di liberarlo rosicchiando le catene ma, a intervalli regolari,
queste ritornano intatte. |
Il cavallo alato
Araš’ rimane al fianco del padrone, nella sua prigione.
Tenta di liberarlo rosicchiando le catene ma, a intervalli
regolari, queste ritornano intatte. |
|
| 6 |
|
Un uccello vola sul
palo: l'eroe tenta di colpirlo con una bastone, ma ottiene
soltanto di ribadire di nuovo il palo al suolo. |
Un avvoltoio scava
il petto di Teʒau con il suo becco
e lo condanna alla sete prosciugando l'acqua della vita. |
| 7 |
La roccia che imprigiona
Amirani si apre a intervalli regolari. Un giorno, un uomo
vede il campione incatenato e tenta di liberarlo, o di
trascinare verso di lui la sua pesante spada: non vi riuscirà. |
Gli Aṗsuac°a
organizzano una spedizione nel tentativo di liberare
Abrysk’yl
e riportare l'Abxasia all'età aurea, ma l'eroe li sconsiglia dal
procedere. |
Teʒau si tende, assottigliando
le catene, e cerca di arrivare alla propria spada. Quando vi
riuscirà, potrà liberarsi. |
| 8 |
La liberazione di Amirani
segnerà la fine del mondo come noi lo conosciamo. I
Georgiani cercano di procrastinarla il più possibile. |
La liberazione di
Abrysk’yl
riporterà l'età aurea sull'Abxasia. Gli Aṗsuac°a
sperano nel
suo ritorno. |
La liberazione di
Teʒau, rimandata alla fine del
mondo, è vista come una punizione
per il genere umano. |
|
| IN ARMENIA. ARTAWAZD Quant'è antico il mito del prometeo caucasico? Il fatto che le versioni
conosciute delle leggende amiraniche siano state raccolte solo tra il XIX e il
XX secolo non deve indurci a ritenerle composte in epoca recente. Che
tradizioni tramandate oralmente possano risalire a un'antichità portentosa è più
la regola che l'eccezione, in questo campo, e i racconti georgiani, abxasi e circassi non fanno
probabilmente eccezione.
Che qualche versione della leggenda prometeica fosse diffusa nella regione
del Caucaso già in epoca tardo-antica, ce ne dà testimonianza lo scrittore
armeno Movsēs Xorenac‘i (±410-±490). Nella sua monumentale
Hayoc‘
Partmowt‘yown, o «Storia della grande Armenia», Movsēs riporta un
gran numero di episodi relativi a eroi e sovrani dell'antichità, che egli
stesso afferma più volte di aver tratto da tradizioni popolari, e in cui si
riconoscono frammenti di mitologie scomparse.
Nel secondo libro della sua opera, egli riporta le imprese di un antico re
armeno chiamato Artašēs, e si sente in dovere
di mettere in guardia il lettore: «Le azioni di questo Artašēs ti
saranno in
parte note attraverso le leggende che si raccontano nel Gołt‘an» [Artašisi
vernoy gorck‘, bazowm inč‘ yaytni en k‘ez i vipasanc‘n, or patmin i Gołt‘an–šinel]
(Hayoc‘
Partmowt‘yown [II,
49]). La parola vipasank‘ indica racconti con andamento epico; per la
vera storia, quella degli storici, il vocabolo armeno è
appunto partmowt‘yown. Movsēs sta parlando di una vicenda che intende come
leggendaria, se non apertamente fantastica.
 |
|
I funerali di Artašēs |
|
Giuseppe Canella (1788-1847) |
Re Artašēs (gr. Artaxias) regnò
probabilmente tra il 190 e il 160 a.C. Si emancipò del tutto dalla tutela
persiana, inaugurò una dinastia destinata a diventare potente e fondò Artašat, la
sua capitale, nella pianura di fronte al monte Ararat (Uluhogian
2009). Nonostante Artašēs sia un
personaggio storico, la sua biografia è largamente leggendaria.
Sposa la bella regina degli Alani,
Sat‘inik, dopo averla acciuffata con un lazo;
combatte i višapazowns, i «figli del drago», discendenti del demoniaco re medo Aždahak,
massacrandoli e incendiandone il paese. Persino i suoi funerali sono eccezionali:
il corpo di Artašēs viene posto su una bara
d'oro, foderata di bisso, coperto da un mantello intessuto d'oro. Gli viene
posta in capo la corona d'oro; le armi, anch'esse d'oro, al fianco. Un tesoro immane
viene sepolto con lui. Tutte le sue donne e concubine lo seguono nella
tomba, e con loro un interminabile corteo di servi. Un'enorme folla di sudditi muore
insieme al re, in parte volontariamente, in parte perché costretti.
(Hayoc‘
Partmowt‘yown [II,
60])
Ad Artašēs succede il figlio Artawazd.
Di quest'ultimo, Movsēs non fornisce un ritratto simpatico: lo descrive
come un giovane arrivista, astuto, privo di scrupoli, pronto a tradire gli
stessi fratelli per soddisfare le proprie ambizioni. Ma dopo pochi giorni di
regno, mentre si trova a caccia di onagri e
cinghiali, Artawazd impazzisce e, dopo aver lanciato il cavallo per le
balze e le forre del monte Masis, cade con tutto l'animale in una
profondissima voragine e scomparve per sempre.
Un finale di certo credibile, ma piuttosto affrettato, dopo una premessa tanto
lunga e convulsa. Si avverte l'esigenza di un contrappasso romanzesco. Evidentemente
insoddisfatto dello scarno racconto «storico», Movsēs riporta
subito dopo la versione leggendaria:
|
Zsamnē ergič‘k‘n Gołt‘an
aṙaspelabanen ayspēs; et‘ē i mahowann
Artašisi bazowm kotorack‘ linēin ǝst ōrini
het‘anosac‘; džowari, asen, Artawazdē aselov
zhayrn; «Minč‘ dow gnac‘er, ew zerkirs
amenayn ǝnd k‘ez tarar, es awerakac‘s owm
t‘agaworem?» |
I cantori [ergic‘k‘] del Gołt‘an, riguardo a costui, così
favoleggiavano. Ai funerali di Artašēs,
essendosi sparso molto sangue, secondo l'uso pagano, Artawazd
si rivolse con ribrezzo (così dicono i cantori) a suo padre: «Ora che tu te ne
sei andato, portandoti dietro tutto il paese, come posso io regnare su queste
rovine?» |
|
Vasn oroy aniceal zna Artašisi, asac‘ ayspēs;
«Et‘ē dowyors hecc‘is yAztn i ver i Masis,
zk‘ez kalc‘in k‘ak‘, tarc‘in yAzatn i ver i
Masis; znd kayc‘es, ew zloys mi tesc‘es». |
Dall'altro mondo, Artašēs lo maledisse e gli
disse: «Se tu andrai a caccia a cavallo sull'Azat, in cima al Masis, ti
prenderanno i k‘ak‘, ti condurranno sull'Azat,
in cima al Masis; tu resterai là e non vedrai più la luce». |
|
Zrowc‘en zsmanē ew paṙawownk‘, et‘ē argeleal
kay yayri miowm, kapeal erkat‘i šłt‘ayiwk‘;
ew erkow šownk‘ hanapaz krcelov zšłt‘aysn, anal
elanel ew aṙnel vaxčan ašxarhi; ayl i jaynē
kṙanaharowt‘ean da ew bnac‘ zōranan, asen,
kapank‘n. Vasn oroy ew aṙ merov isk
žamanakaw bazowmk‘ i darbnac‘, zhet ert‘alov
aṙaspelin, yawowr miašabat‘wo eric‘s kam č‘oric‘s
baxen zsaln, zi zōrasc‘in, asen šłt‘ayk‘n
Artawazday. Bayc‘ ē čšmartowt‘eamb ayspēs,
orpēs asac‘ak‘a veragoyn. |
E persino le vecchierelle raccontano di costui, che è impastoiato in una grotta,
carico di catene di ferro; che due cani rodono senza sosta le catene; e che egli
cerca di liberarsi per attuare la fine del mondo. Ma al rumore del martello dei
fabbri, così dice la favola, le catene si rafforzano. Per questo motivo ancora
oggi molti fabbri, conformandosi alla leggenda, battono l'incudine tre o quattro
volte il primo giorno della settimana, per rafforzare, dicono le catene di Artawazd.
Ma in verità le cose stanno come abbiamo detto sopra. |
|
Movsēs Xorenac‘i:
Hayoc‘ Partmowt‘yown [II,
61] |
 |
|
Fine di Artawazd |
|
Giuseppe Canella (1788-1847) |
Movsēs Xorenac‘i sottolinea più volte il carattere
popolare di questa leggenda, che per lui è solo un racconto di
«vecchierelle». Ma è anche l'esito
armeno del tema prometeico. I dettagli dell'incatenamento di Artawazd
corrispondono infatti, punto per punto, all'ultima parte della biografia di
Amirani. Vi sono, insomma, dei temi comuni ai due
cicli.
Charachidzé nota innanzitutto un parallelismo nelle relazioni tra i due
protagonisti del mito. In Georgia, il confronto ha luogo tra
Amirani e il suo padrino, il dio
Morige
Ḡmerṫi; in Armenia è tra Artawazd
e il proprio padre, il defunto re Artašēs. Vi
è, nei due casi, un rapporto sociologico padre/figlio, dove il padre è investito
di poteri soprannaturali.
Alcuni episodi della biografia di Amirani, sono
qui ripartiti tra i due re armeni, afferma giustamente Charachidzé. Nel caso di Artašēs,
la cattura della sposa Sat‘inik con un lazo può
essere messo correlazione con il ratto di Q‘amar da
parte di Amirani, operato con un balzo del cavallo
al di là dei mari; lo sterminio dei višapazowns o «figli del drago»
può corrispondere alla lotta di Amirani contro i
višap‘i nati da Baq‘baq‘. Artawazd assume su di sé la parte più interessante,
relativa alla sfida di Amirani nei confronti del
dio supremo e del suo incatenamento, sebbene con alcuni interessanti
rovesciamenti.
| |
ARMENIA |
GEORGIA |
| Carriera eroica e distruzione parziale
del mondo
|
Artašēs |
Amirani |
| Insubordinazione e supplizio |
Artawazd |
In Georgia, Amirani oppone la propria potenza
all'ordine cosmico imposto da
Ḡmerṫi. Lo abbiamo visto combattere fino a sterminare ogni
possibile avversario, tanto che sulla terra, secondo la versione svanete, non
restavano che «tre dèmoni, tre cinghiali, tre querce» (L2).
Ḡmerṫi interviene per punire l'insubordinazione del campione,
ma anche per impedirgli di distruggere ogni forma di vita sulla faccia della
terra. In Armenia, è invece Artawazd a imputare al
padre Artašēs di non lasciargli in eredità che
un paese quasi deserto. Qui il conflitto di sovranità è invertito: l'hýbris
di Artawazd agisce piuttosto per difetto: rifiuta
di assumere la sovranità alle condizioni imposte dal padre; tale rifiuto – una
sfida per difetto – provoca la
maledizione di Artašēs.
(Charachidzé 1986¹)
Il destino di Artawazd corrisponde al supplizio mito georgiano attribuiva ad Amirani,
a partire dalla cattura da parte dei k‘ak‘, dèmoni-fabbri
armeni perfettamente omologhi, anche etimologicamente, ai aǯebi georgiani. Tutti i dettagli
della prigionia di Artawazd, compresi l'operazione
apotropaica dei fabbri che battono sulle loro incudini per impedire il ritorno
dell'incatenato e il motivo della sua liberazione finale, mostrano un parallelismo così
stretto con il mito georgiano di Amirani da non lasciare adito a dubbi sulla
sostanziale unità del mitema. Da qui, la conferma che il ciclo amiranico,
sebbene sia stato raccolto in Georgia tra il XIX e il XX secolo, risalga almeno
al V secolo. (Charachidzé 1986¹)
Il motivo escatologico legato alla liberazione di
Artawazd è ancor più rimarcato dalla penna arguta del vescovo armeno
Eznik Kołbac‘i. Nel suo End ałandoc‘ o
«Confutazione delle sette», composto intorno al 440, Eznik combatte con energia
le false credenze attestate a suo tempo, fornendo informazioni preziose sui miti
e le leggende pagane che fiorivano in Armenia nel V secolo. Così egli è indotto a fornire notizie su una credenza popolare
incentrata proprio su Artawazd:
|
|
L'arte seduttrice dei diwac‘ ingannò gli adoratori dei falsi dèi presso
gli Armeni, facendo creder loro che i diwac‘ avrebbero messo in ceppi un
tale chiamato Artawazd, che vive ancora ai nostri
giorni e deve liberarsi per prendere possesso di questo mondo; e gli infedeli
restano legati a questa falsa speranza come gli Ebrei che sperano che Davide
debba venire a ricostruire Gerusalemme, a raccogliere i Giudei e a regnare su di
loro a Gerusalemme. |
|
Eznik Kołbac‘i: End
ałandoc‘ [136] |
Eznik Kołbac‘i vuole dimostrare la tesi che
le entità malefiche, quali i draghi-serpenti [višap] o i dèmoni [diwac‘] non hanno alcun potere sugli esseri umani, e per
tale ragione illustra la falsa credenza di
Artawazd. Così facendo, il bravo vescovo non solo
conferma la leggenda riportata da Movsēs Xorenac‘i, ma le conferisce
un carattere popolare. Gli Armeni pagani, all'epoca di Eznik,
non solo davano credito alla leggenda di Artawazd,
ma vi associavano la speranza in una riscossa futura. Così, mentre i fabbri
nominati da Movsēs facevano del tutto per tenere incatenato
Artawazd, il popolino pagano lo aveva
trasformato in una sorta di liberatore. Un liberatore che «deve prendere
possesso di questo mondo», dunque un futuro sovrano che ricondurrà gli Armeni pagani ai loro antichi fasti. La catastrofe per l'umanità,
era la loro
speranza.
La testimonianza dell'apologeta di Kołb recupera, a mille e cinquecento anni
nel passato, la stessa ideologia che anima la variante di
Abrysk’yl, dove la liberazione del campione incatenato è destinata a
liberare l'Abxasia dai suoi nemici e restituire la libertà al popolo del piccolo
paese caucasico.
Ma questo non è altro che il mitema universale dell'«eroe dormiente», dove le
future speranze di riscatto di un paese o di un popolo sono legate a un eroe nazionale, via via esiliato, imprigionato, addormentato, trasformato in
pietra, che nel momento di maggior pericolo per il suo paese tornerà per
guidarlo alla vittoria e per restaurarne le antiche glorie e fasti. È abbastanza
agevole condurre degli esempi di questo mitema. Eznik parla di un ritorno
messianico del re Dāwiḏ, ma da parte nostra possiamo aggiungere
Arthur ap Uthyr
per i Britanni, Finn mac Cumaill per gli Irlandesi,
Kalevipoeg per gli Estoni,
Holger Danske per i Danesi, tutti destinati a ritornare in vita nel
momento di maggior pericolo per il loro paese.
Il nostro prometeo incatenato appartiene tuttavia a un ordine di idee
completamente diverso. Sebbene legato a precise realtà culturali, non è mai un
eroe nazionale. La situazione in Abxasia e quella tra gli Armeni pagani sembrano
varianti accessorie. Nel resto del Caucaso, il suo esilio è necessario per il mantenimento dell'ordine
cosmico, e il suo ritorno coinciderà con un cambiamento epocale, con una sorta
di apocalisse finale, o forse di apocatastasi. Ma non anticipiamo troppo le
nostre conclusioni. Dobbiamo tornare ancora più indietro nel tempo. E spostarci
a ovest, questa volta, verso il mondo ellenico.
|
| UNO SGUARDO DAL MONDO ELLENICO Quant'è antico il mito
del prometeo caucasico? Movsēs Xorenac‘i
ed Eznik Kołbac‘i, con i loro miti di Artawazd, avevano
riavvolto le
lancette dell'orologio di quasi mille e cinquecento anni. Ma in questa
fantasiosa ricerca, dobbiamo risalire ancora più indietro del tempo.
Tra i primi Greci a raggiungere il Caucaso vi furono, come abbiamo già anticipato, e come ben sanno gli appassionati di miti
classici, Iásōn
e il suo equipaggio di coraggiosi, a bordo della leggendaria nave
Argṓ.
Quando essi giunsero in vista della costa dirupata della Colchide, narra Apollṓnios Rhódios
(295-215 a.C.), udirono da lontano le grida del gigante incatenato e videro
l'aquila che calava a straziarlo ferocemente:
| |
E già ai naviganti appariva il seno segreto del Póntos
e si levavano le cime impervie dei monti del Kaúkasos,
là dove, le membra inchiodate dalle catene di bronzo
all'aspra roccia, Promētheús nutriva col proprio
fegato l'aquila,
che sempre e sempre tornava a scagliarsi contro di lui.
La videro, a sera, volare vicino alle nuvole,
con uno stridore acuto, alta sopra la nave,
eppure sconvolse tutte le vele col battito delle sue ali,
perché non aveva natura d'uccello del cielo,
ma muoveva le ali simili a remi politi.
Poco dopo udirono anche la voce, il lamento
del titán straziato nel fegato; dei suoi gemiti
risuonava l'aria, finché di nuovo dal monte
videro l'aquila ingorda scagliarsi allo stesso bersaglio. |
|
Apollṓnios Rhódios: Tá Argonautiká [II: -] |
 |
|
Promētheús incatenato (✍
1868) |
|
Gustave Moreau (1826-1898) |
Stiamo sbarcando sulle sponde di
uno dei più noti e duraturi miti ellenici, quello
di Promētheús,
incatenato per aver sfidato l'autorità di
Zeús. Che esso sia da collegare al
racconto caucasico del campione incatenato, ce lo assicurano gli stessi
mitologi greci, che proprio tra le vette del Caucaso occidentale, in un luogo
inaccessibile tra il Mar Nero e il monte Ėl'brus, collocavano il
«banchetto dell'aquila», il luogo di
punizione del ribelle titán. Un'insistente tradizione, nota
fin dall'antichità, affermava
che il mito di Promētheús provenisse proprio dal
Caucaso.
Lucius Flavius Arrianus (±95-±175), che esplorò il Ponto Eusino intorno al
130, annota che, presso Dioskouriás, in Colchide, gli fu indicato il monte dove, secondo le tradizioni locali, era stato incatenato Promētheús:
«Ci mostrarono un cima del Caucaso, chiamata Strobil, sulla quale, come
dicono i miti, Promētheús era stato
incatenato da Hḗphaistos, per comando di
Zeús» (Periplus Ponti
Euxini [II, 5]).
Secondo Doûris di Samo (±340-±270 a.C.), a sua volta citato
dallo scoliaste di
Apollṓnios Rhódios, il personaggio di Promētheús
era così popolare presso gli abitanti del Caucaso occidentale, che essi si
rifiutavano di praticare il culto di Zeús
e di Athēnâ, ritenuti responsabili del suo
supplizio, ma celebravano invece Hērakls, suo liberatore.
Il sofista Phláuios Philóstratos (170/172-247/250) riporta tutta una serie di
interessanti indicazioni a proposito delle leggende legate al prometeo caucasico:
|
|
Riguardo a queste montagne circolano tra i barbari le stesse tradizioni dei
poeti greci, che cioè vi era stato incatenato Promētheús,
per la sua filantropia, e che Hērakls, non avendo
sopportato tale cosa, uccise con una freccia l'uccello che dilaniava le viscere
di Promētheús. Secondo gli uni, egli era
incatenato in una caverna sul fianco della montagna, che viene ancora indicata.
Dámis dice addirittura che nella roccia sono ancora infisse le sue catene, la
cui grandezza è inimmaginabile. Secondo altri, [Promētheús
era incatenato] sulla vetta di una certa montagna: questo monte ha due cime che
distano tra loro più di uno stadio, e si dice che egli era incatenato con una
mano a una e con l'altra all'altra, tanto era smisurato! Quanto all'aquila, gli
abitanti del Caucaso la considerano nemica e dànno fuoco, per mezzo di frecce
incendiarie, ai nidi da essa costruiti sulle rocce e le tendono insidie,
spiegando questo modo d'agire col desiderio di vendicare Promētheús:
questo mostra fino a che punto essi sono convinti della verità della tradizione. |
|
Phláuios Philóstratos:
Tà ès tòn Tyanéa' Apollṓnio [II, 3] |
Difficile dire quanto siano effettivamente «caucasiche» le notizie riferite da Doûris, Philóstratos e Arrianus,
e se non siano state piuttosto colorate a tinte elleniche. Dioskouriás,
l'attuale Soxumi in Abxazia, era una colonia greca: i racconti riferiti ai
viaggiatori classici avevano avuto tutto il tempo di decantare nei tini
ellenici. Rimane però il
fatto che, quando si parlava di Promētheús, lo
sguardo dei Greci correva subito ad oriente, alle lontane vette del Caucaso, che
in epoca remota erano considerate l'estremo lembo orientale del mondo.
|
|
I Greci hanno chiamato questi monti Kaukásos, pur se distano dall'India più di
tremila stadi. Lì si svolge il racconto mitico di Promētheús
e del suo incatenamento: ma questo perché, allora, il Kaukásos era l'estremo
limite orientale conosciuto! |
|
Strábōn: Geōgraphiká [XI,
5, 5] |
Sarà dunque Promētheús in persona a confrontarsi, in questo
stadio della ricerca, con il mitema caucasico. E bisogna tornare, ancora una volta, al prodigioso Hēsíodos,
nostra fidata guida negli stadi più antichi del mito ellenico. È lui a fissare per
primo il «canone» del mito prometeico, tra
l'VIII e il VII secolo a.C., e
sarà il tragediografo
Aischýlos, due secoli più tardi, a consegnare Promētheús alla letteratura universale. L'uno
e l'altro saranno i nostri principali interlocutori in questo nostro cammino dal
selvaggio cuore del Caucaso alla Grecia classica.
Su Promētheús è stato scritto di tutto:
rimane purtuttavia un personaggio ancora sfuggente, sfaccettato. Hēsíodos lo
descrive ingegnoso, creativo, astuto, dispettoso. I termini con cui lo definisce
nella
Theogonía insistono su questo suo lato
del carattere: è aiolómētis «scaltro» [],
poikilóboulos «dalle molte astuzie» [],
aŋkylómētis «dai torti pensieri» []. La
qualità che lo contraddistingue è la mtis, l'astuzia, una delle forme
dell'intelligenza. Promētheús è contorto,
imprevedibile, spesso ribelle. Ha un concetto vago della lealtà, che mette in
dubbio più di una volta.
Promētheús è figlio del titán
Iapetós: i suoi fratelli sono Átlas,
il tracotante Menoítios
e il malaccorto Epimētheús. Ma quando il
giovane Zeús dichiara guerra a
Krónos, e l'intera stirpe titanica si schiera a
fianco del proprio sovrano, Promētheús è
l'unico a cambiare bandiera. Egli stesso spiega le ragioni del proprio
tradimento, in un importante passo della tragedia di
Aischýlos:
«Epeì táchist' ḗrxanto daímones chólou
stásis t' en allḗloisin ōrothýneto,
hoi mèn thélontes ekbaleîn hédras Krónon,
hōs Zeùs anássoi dthen, hoi dè toúmpalin
speúdontes, hōs Zeùs mḗpot' árxeien then,
entaûth' egṑ tà lista bouleúōn pitheîn
Titânas, Ouranoû te kaì Chthonòs tékna,
ouk ēdynḗthēn. haimýlas dè mēchanàs
atimásantes karteroîs phronḗmasin
ṓont' amochthì pròs bían te despósein.
emoì dè mḗtēr ouch hápax mónon Thémis
kaì Gaîa, polln onomátōn morphḕ mía,
tò méllon h kranoîto proutethespíkei,
hōs ou kat' ischỳn oudè pròs tò karteròn
chreíē, dólōi dé, toùs hyperschóntas krateîn.
toiaût' emoû lógoisin exēgouménou
ouk ēxíōsan oudè prosblépsai tò pân.
krátista dḗ moi tn parestṓtōn tóte
ephaínet' eînai proslabónta mētéra
hekónth' hekónti Zēnì symparastateîn.
emaîs dè boulaîs Tartárou melambathḕs
keuthmṑn kalýptei tòn palaigen Krónon
autoîsi symmáchoisi.» |
Promētheús: «[...]
Come ebbe inizio l'ira degli dèi,
si volsero violenti gli uni agli altri,
s'accese tra loro la contesa,
tra chi voleva rovesciare Krónos
perché il re fosse Zeús, e chi lottava
perché Zeús
tra gli dèi non fosse il primo.
E io volevo persuadere al meglio
i Titânes nati da
Ouranós e G,
ma non potei. Spregiarono l'astuzia,
avevano pensieri di violenza,
credevano di ascendere al potere
con la violenza senza darsi pena.
G che ha molti nomi e una forma
profetava il futuro e mi diceva:
“Non di forza e potenza c'è bisogno,
ma il primo in astuzia sarà il re”.
Queste cose chiarivo argomentando,
ma quelli non degnarono guardarmi.
Di fronte a ciò mi parve dunque il meglio
conciliarmi alla madre ed affiancarmi
a Zeús, come io volevo e lui voleva.
Per il mio senno il Tártaros nasconde,
nelle tenebre fonde del suo abisso,
Krónos l'antico e chi lottò al suo fianco.» |
|
Aischýlos: Promētheús
desmṓtēs
[-] |
I Titânes
avevano un concetto della regalità basata unicamente
sulla forza e sulla sopraffazione, e nessun
interesse a governare un kósmos razionale, fondato
sulla giustizia e sull'intelligenza. Questa è la ragione del
dissidio tra
Promētheús e i fratelli di suo
padre. Nella prospettiva
della tragedia eschilea, Promētheús
è fornito di
un'astuzia prodigiosa. Egli potrebbe
aiutare i
Titânes con la forza del
suo intelletto, ma questi ultimi
disprezzano il suo contributo. Perciò
Promētheús lascia il campo
titanico e si rivolge a
Zeús.
Tantopiù che l'oracolo di
G ha dichiarato che l'astuzia, non la violenza,
sarà decisiva della battaglia, e
Promētheús non è tipo da schierarsi con la squadra perdente.
Il risultato della titanomachia è noto.
Zeús sconfigge i suoi nemici, anche grazie al
contributo di
Promētheús.
I
Titânes vengono
scagliati nelle tenebre del Tártaros. Átlas,
che era stato condottiero degli eserciti titanici, è
condannato a reggere il peso del cielo sulle sue spalle,
mentre il tracotante Menoítios
viene fulminato.
Zeús è il nuovo e definitivo sovrano dell'universo,
padre di una nuova generazione di dèi, gli
Olýmpikoi.
Un nuovo kósmos, nel quale
Promētheús non si trova
evidentemente a suo agio, nonostante abbia contribuito a fondarlo. Egli è un
eterno bastian contrario: la sua
mtis lo porta inevitabilmente a rovesciare il proprio punto di
vista e porsi in opposizione con l'ordine costituito. Una volta tolti di
mezzo i
Titânes, troppo rozzi e
viscerali per i suoi gusti, la partita si gioca sul piano della razionalità, della
pura intelligenza. |
|
IN GRECIA. IL MITO DI PROMĒTHEÚS
 |
|
Promētheús plasma l'uomo, Athēnâ lo
anima (✍
1802) |
|
Jean-Simon Berthélemy (1743-1811) |
Il racconto greco di
Promētheús
è parte di un complesso mitico che andrebbe analizzato nel suo insieme. Esso
comprende una serie di episodi tra loro collegati, che comprendono tanto la
vicenda di
Promētheús
quanto quella di
Pandṓra. Nel suo insieme, il ciclo
complessivo disegna un mito della creazione e caduta dell'uomo. Motore ne è il
braccio di ferro tra
Promētheús
e Zeús: le sfide che il
titán pone
all'autorità del re degli dèi si risolvono immancabilmente in solenni punizioni
ereditate dal genere umano.
Abbiamo trattato altrove il tema antropologico
inerente a questi complessi di miti: di come
Promētheús
abbia creato l'umanità e abbia fornito loro le conoscenze e le tecniche
necessarie a un'esistenza civile, e di come
Zeús,
sia direttamente, sia tramite l'introduzione della prima donna,
Pandṓra, abbia condannato l'uomo ad uscire dallo stato atemporale dei primordi e l'abbia costretto all'esistenza che noi
tutti conosciamo, fatta di lavoro, fatica, disagi, malattie e... svantaggi
matrimoniali. È un complesso mitico grandioso, di cui abbiamo seguito gli
addentellati nelle più antiche mitologie del Medio Oriente, dai poemi sumerici e
babilonesi, fino alla meditata e solenne rielaborazione biblica. ①
Ma in questo grande ciclo mitico, il racconto greco presenta un tema estraneo al mondo medio-orientale. Seppure
sia incastonato
nell'insieme, il racconto della punizione di
Promētheús
risalta come un elemento a sé stante, rispetto al tema di creazione e caduta
dell'uomo. È un dramma
personale, non antropologico. Ed è proprio il mito che stiano analizzando.
Esso è formato da quattro episodi giustapposti e legati tra loro:
- Il sacrificio di Mēkṓnē.
- Il sequestro del fuoco.
- La riconquista del fuoco.
- L'incatenamento di Promētheús.
Facciamo un bel respiro lungo ed esaminiamoli uno per volta, nelle loro fonti
primarie.
1. Il sacrificio di Mēkṓnē.
Sebbene Hēsíodos non lo dica, ed
Aischýlos lo faccia soltanto capire, il braccio di ferro
tra
Zeús e
Promētheús ha inizio con
la creazione degli uomini, ad opera di
Promētheús. Gli dèi
guardano con disinteresse misto a disprezzo questa nuova razza di esseri, troppo
simili agli dèi nell'aspetto, per quanto privi di statura e poteri divini.
Zeús minaccia più volte di sterminarli, ed è forse
questa la «contesa» di cui parla Hēsíodos,
quando esordisce con il mito del sacrificio di Mēkṓnē.
Kaì gar hót’ ekrínonto theoì thnētoí t’ ánthrōpoi
Mēkṓnēı, tót’ épeita mégan boûn próphroni thymōı
dassámenos proéthēke, Diòs nóon exapaphískōn... |
Infatti, quando la loro contesa dirimevano gli dèi e i
mortali
a Mēkṓnē, [Promētheús]
con subdola mente, spartì un bue
dopo averlo diviso, volendo ingannare la mente di
Zeús... |
|
Hēsíodos: Theogonía [-] |
Un bue è stato abbattuto e Promētheús è
stato chiamato a spartirlo. Una parte toccherà agli uomini, l'altra allo stesso Zeús.
È un momento importante: una divisione che istituirà, da allora in poi, il rapporto tra mortali e
immortali. Per Promētheús è un'occasione
troppo ghiotta: farà le parti, sì, ma a modo suo. Ingannerà Zeús
e favorirà gli esseri umani. Abbiamo già trattato questo mito nei dettagli in
un'altra pagina, ma ora dobbiamo tornarci, seppure rapidamente, per segnalare i
punti necessari alla nostra indagine. ②
Innanzitutto, l'attore che interpreta il ruolo: Promētheús.
Non è un caso che le necessità del mito abbiano chiamato proprio lui,
l'aiolomtis, a fare le porzioni del bue. Che Promētheús
non sarà equo nel fare le parti è fin ovvio. Ma la sua sarà una parzialità ingannevole,
costruita ad arte per nascondere ulteriori inganni.
Macellato il bue, Promētheús
prepara due porzioni. Da un lato, separa i kréa, le carni commestibili e
croccanti, e le nasconde dentro la gastḗr, lo stomaco dell'animale,
viscido e poco gradevole a vedersi. Dall'altra, raccoglie le ossa del bue,
coprendole con uno strato di grasso, bianco e appetitoso.
Toîs mèn gar sárkas te kaì éŋkata píona dēmōı
en hrinōı katéthēke kalýpsas gastrì boeíēı,
tōı d’ aût’ ostéa leyka boòs dolíēı epì téchnēı
euthetísas katéthēke kalýpsas argéti dēmōı. |
Da una parte egli pose le carni e le interiora
ricche di grasso nella pelle del bue, ben coperte nel ventre,
dall'altra dispose ad arte le candide ossa
spolpate, nascoste nel bianco grasso. |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-] |
Queste sono le due porzioni che Promētheús mette dinanzi a
Zeús, ostentando una faccia da poker, e lo
invita a scegliere quella che preferisce. Il re degli dèi osserva quei due mucchi così esplicitamente disuguali, e
sospetta - lo avremmo fatto anche noi - che Promētheús
ne stia macchinando una delle sue.
Dḕ tóte min proséeipe patḕr andrn te then te;
«Iapetionídē, pántōn arideíket' anáktōn,
pépon, ōs heterozḗlōs diedássao moíras».
Hṓs pháto kertoméōn Zeùs áphthita mḗdea eidṓs.
Tòn d'
aûte proséeipe Promētheùs aŋkylomḗtēs
k' epimeidḗsas, dolíēs d' ou lḗtheto téchnēs;
«Zeû kýdiste mégiste then aieigenetáōn,
tn d' héle', hoppotérēn se enì phresì thymòs anṓgei».
Ph hra dolophronéōn... |
E allora [Zeús], padre
degli uomini e degli dei, disse:
«Figlio di Iapetós, illustre fra tutti i signori,
mio caro, con quanta ingiustizia hai fatto le parti!»
Così disse Zeús che conosce gli eterni consigli;
E Promētheús dai torti pensieri rispose,
ridendo sommesso, e non dimenticava le arti dell'inganno:
«Nobilissimo Zeús, sommo tra gli dèi immortali,
scegli la tua parte come ti suggerisce il cuore».
Così disse, tramando l'inganno... |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-] |
«Così disse, tramando l'inganno» [ph hra dolophronéōn]
sottolinea Hēsíodos. La parola dólos «inganno» e il suo
derivato dólios «ingannevole» compaiono ben sette volte
nel passo [-], in un inarrestabile leitmotiv. E
quando il titân offre a Zeús di scegliere,
tra i due mucchi, quello che preferisce, il lettore sa già cosa sta per
accadere. Tra un attimo, il goloso re di Ólympos sceglierà la porzione che gli appare più
appetitosa ma, sotto lo strato di grasso, troverà solo un mucchio di bianche
ossa.
Chersì d' hó g' amphotérēısin aneíleto leykòn áleiphar.
Chṓsato dè phrénas amphí, chólos dé min híketo thymón,
ōs íden ostéa leyka boòs dolíēı epì téchnēı... |
[Zeús] raccolse il bianco grasso con ambedue le mani,
si adirò nell'animo e l'ira raggiunse il suo cuore,
quando vide le ossa bianche del bue, frutto dell'inganno... |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-] |
L'inganno perpetrato da Promētheús farà sì che,
da quel momento in poi, gli uomini offriranno agli dèi le ossa bruciate sugli
altari e terranno per loro la carne commestibile. Il mito del sacrificio di Mēkṓnē
è dunque eziologico: fonda la pratica dei sacrifici, su cui si basa il rapporto
d'interscambio tra l'umanità e gli dèi. Vi è un universo di significati che
meriterebbero qui di essere approfonditi, e ne abbiamo parlato altrove. ③
Ci preme ora arrivare al dunque. Promētheús
ride soddisfatto, ma Zeús è adirato. Gli
uomini hanno voluta la carne del bue? Ebbene, che se la mangino cruda!
2. Il sequestro del fuoco.
La vendetta di Zeús è immediata: priva i mortali del fuoco.
Il racconto è riferito da
Hēsíodos in entrambe le sue opere. Nella
Érga kaì
Hēmérai è puttosto laconico: «Per questo [Zeús]
procurò ai mortali tristi affanni: nascose loro il fuoco»
[-]. Nella
Theogonía
rivela però dei dettagli
piuttosto interessanti:
|
...ek toútou dḕ épeita dólou memnēménos aieì
ouk edídou melíēısi pyròs ménos akamátoio
thnētoîs anthrṓpois, hoì epì chthonì naietáousin. |
...e da quel giorno, sempre memore della frode,
[Zeús] negò
ai frassini la forza del fuoco indomabile
agli uomini mortali che hanno dimora sulla terra. |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-] |
Dunque, in quella lontana epoca antidiluviana, gli uomini
alimentavano i loro focolari con le fiamme che ardevano sugli alberi, allorché
Zeús li colpiva con le sue folgori. Gli uomini
raccoglievano direttamente il fuoco celeste, ma non erano in grado di
accenderlo con mezzi tecnici; né evidentemente sapevano mantenere il fuoco acceso,
visto che, nel momento in cui Zeús smette di far cadere i suoi fulmini, l'umanità
si ritrova sprovvista di ogni sorgente ignea e incapace di accendere anche la
più piccola e rudimentale fiammella.
3. La riconquista del fuoco.
Come e dove Promētheús abbia rubato il fuoco,
non viene riferito dalla maggior parte delle fonti, le quali paiono dare i particolari
per scontati.
È il caso di Hēsíodos, che si limita a citare
l'avvenuto furto, sottolineando piuttosto il dettaglio che il fuoco viene
portato ai mortali nascosto dentro una canna di nartece. L'episodio è narrato in meno di
tre versi sia nelle Érga kaì
Hēmérai [-]
che nella
Theogonía [-], e quasi con le
stesse parole:
Allá min exapátēsen eùs páis Iapetoîo
klépsas akamátoio pyròs tēléskopon augḕn
en koḯlōı nárthēki... |
Ma il prode figlio di Iapetós
lo ingannò
e rubò il bagliore lungisplendente del fuoco indomabile
e lo mise in una cava ferula di nartece... |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-] |
Pittoreschi dettagli del furto sono riferiti nella tarda versione di Hyginus,
secondo il quale Promētheús
si sarebbe recato di nascosto sulla cima dell'Ólympos, per giungere al
«fuoco di Zeús». Rimane qui un sospetto di
contraddizione, in quanto Zeús dominava piuttosto
i fulmini. Il «fuoco di Zeús» erano dunque le
folgori? Hyginus non lo spiega. Aggiunge però che Promētheús
corse via con il fuoco nascosto in una canna, e afferma che da questo
episodio sarebbe derivato il rito olimpionico dei dadofori
(De
Astronomia [II: 15, ]). Più poetica la versione riferita da Servius nel suo commento alla
sesta egloga di Virgilius (Carmina Bucolica [VI:
]), dove si dice che Promētheús abbia
raggiunto addirittura il sole e abbia acceso la sua fiaccola sulla ruota solare.
Più poetica, ma di poca sostanza. E una volta esclusi i fulmini e la
vampa solare, esauriamo la lista delle fonti del fuoco celeste.
Meno conservata, ma più insistente, una versione alternativa, nella quale Promētheús
si sarebbe invece recato a Lḗmnos, l'isola dove Hḗphaistos
aveva la sua fucina, e proprio lì abbia rubato il fuoco. Lo apprendiamo di
sfuggita in
Aischýlos, dalle
parole che Krátos, uno dei due esecutori della
condanna ordinata da
Zeús, rivolge
ad Hḗphaistos per esortarlo a incatenare il
titán alla roccia.
Hḗphaiste, soì dè chrḕ mélein epistolàs
hás soi patḕr epheîto, tónde pròs pétrais
hypsēlokrḗmnois tòn leōrgòn ochmásai
adamantínōn desmn en arrhḗktois pédais.
tò sòn gàr ánthos, pantéchnou pyròs sélas,
thnētoîsi klépsas ṓpasen. |
Krátos: «[...] Ora, è tua cura ciò che il padre
impone,
Hḗphaistos: ora avvincerai
il colpevole
a queste rocce ardue sull'abisso
con catene più dure del diamante.
La luce artefice di tutto, il fuoco,
il fiore tuo, egli lo ha rubato
e ne ha fatto partecipi i mortali». |
|
Aischýlos:
Promētheús
desmṓtēs [-] |
E poiché Hḗphaistos è riluttante ad assumersi
il ruolo di carnefice, Krátos insiste:
Eîhen, tí mélleis kaì katoiktízēi mátēn?
tí tòn theoîs échthiston ou stygeîs theón,
hóstis tò sòn thnētoîsi proúdōken géras? |
Krátos: «Perché indugi? Hai pietà per nulla?
Non odi un dio che gli dèi maledicono,
che ai mortali donò il tuo privilegio?» |
|
Aischýlos:
Promētheús
desmṓtēs [-] |
Per due volte
Aischýlos si preoccupa di
precisare, in termini molto chiari, che il fuoco è stato rubato ad
Hḗphaistos, del quale costituisce il «fiore» [ánthos]
e il «privilegio» [géras]. Il motivo appare anche in
Loukianós Samosateús, dove
Hḗphaistos accusa
Promētheús: «Tu mi rubasti il fuoco e mi
lasciasti fredda la fucina» (Promētheús
ē Kaúkasos [5]). Allo stesso furto si riferisce probabilmente anche
Marcus Tullius Cicero quando parla del «furto Lemnio» [furtum Lemnium],
senza dare altra precisazione (Tuscolanae [XI: 10,
]).
Premesso tutto questo, possiamo contestualizzare l'apologo in forma di mito che
Plátōn riporta nel suo
Prōtagóras, dove il furto del fuoco viene compiuto per
permettere all'umanità, appena creata, nuda e inerme, di sopravvivere:
|
|
Promētheús, allora, trovandosi in difficoltà circa
il mezzo di conservazione che potesse trovare per l'uomo, ruba ad
Hḗphaistos e ad Athēnâ
la loro sapienza tecnica, insieme al fuoco, perché senza il fuoco era
impossibile acquisirla o utilizzarla, e così ne fa dono all'uomo. Grazie ad essa
l'uomo possedeva la sapienza necessaria a sopravvivere, ma gli mancava ancora la
sapienza politica, perché questa era in mano a Zeús. Promētheús
non aveva più accesso all'acropoli, dimora di Zeús;
per di più c'erano anche le terribili guardie di Zeús.
Egli allora si introduce furtivamente nell'officina che
Athēnâ ed Hḗphaistos avevano in comune, in
cui essi lavoravano insieme e, rubata l'arte del fuoco di
Hḗphaistos e quell'altra arte che apparteneva ad
Athēnâ, le dona all'uomo: di qui vennero all'uomo i mezzi per vivere. Ma
in seguito, come si racconta, Promētheús
[...] venne punito per quel furto. |
|
Plátōn:
Prōtagóras
[321c-322a] |
 |
|
Promētheús porta il fuoco agli uomini (✍
±1637) |
Jan Cossiers (1600-1671)
Museo del Prado, Madrid (Spagna) |
Ora, lo sappiamo bene anche noi,
Plátōn non è una attendibile fonte mitologica. È un
filosofo, e non si fa scrupolo di reinventare i
racconti mitici per i suoi scopi espositivi. Bisogna dunque prendere il suo
racconto cum grano salis. Affiorano tuttavia alcuni interessanti motivi,
prima di tutto la conferma che il furto di
Promētheús
sarebbe stato compiuto ai danni di Hḗphaistos.
Plátōn fornisce anche una spiegazione sul perché Promētheús
avesse rubato ad Hḗphaistos e non a Zeús:
gli inflessibili guardiani dell'Ólympos (Krátos e
Bía) gli avevano infatti sbarrato l'accesso
all'acropoli divina.
Il motivo del furtum Lemnium –
qui ribadito con forza – presenta alcuni interessanti addentellati.
Ricapitoliamo. Inizialmente, gli uomini utilizzavano il fuoco celeste, inviato
da Zeús sulla terra attraverso le folgori. Allorché
l'invio di fulmini viene sospeso, è necessario rivolgersi a un'altra fonte
ignea, e questa è rappresentata dal fuoco ipoctonio: le fiamme che ardono
all'interno della terra. Promētheús attinge
appunto ad esse,
raccogliendole dalla fucina di Hḗphaistos.
Ma
Plátōn esplicita anche un altro dettaglio:
possedere il fuoco non basta. Bisogna che gli uomini imparino ad accenderlo: ecco perché, insieme al fuoco, bisogna insegnare loro la technḗ.
Il furto diviene doppio: del fuoco (da
Hḗphaistos), e della tecnica di accensione (da
Athēnâ).
In quanto al modo di conservare e
trasportare il fuoco, le fonti insistono sul motivo della ferula di
nartece: una tecnica antichissima,
ancora in uso nelle isole Egee nel XVIII o
XIX secolo.
Diódōros Sikeliṓtēs, che accenna di sfuggita all'episodio del furto, si sofferma
a spiegare che l'uso di trasportare il fuoco in una canna era stato inventato
dallo stesso Promētheús
(Bibliothḗkē Historikḗ [V: 67, ]).
In questo modo, Promētheús
si assicura che gli uomini non rimarranno più senza il «bagliore lungisplendente del fuoco indefesso»
(Theogonía []).
4. L'incatenamento di Promētheús. È in punizione del suo furto, per aver dato il fuoco ai
mortali, che Promētheús viene incatenato alle vette del
Caucaso. È la parte più importante del mito ellenico, ma anche quella più delicata,
soprattutto per la nostra difficoltà a far combaciare i testi.
Hēsíodos, come al solito, è avaro di
dettagli. Afferma che Promētheús venne
legato a una colonna, con lacci indissolubili, e direttamente da
Zeús.
|
Dse d' alyktopédēısi Promēthéa poikilóboulon
desmoîs argaléoisi méson dia kíon' elássas... |
[Zeús] legò con
inestricabili lacci Promētheús mente sottile,
con legami tremendi, spingendo una colonna nel mezzo... |
| Hēsíodos:
Theogonía [-] |
L'espressione méson
dia kíon’ elássas è piuttosto
problematica. Si è voluto vedere Promētheús
impalato, il corpo trafitto longitudinalmente da un palo, sebbene un tale supplizio renderebbe inutili le corde.
L'interpretazione più semplice è che Promētheús sia stato legato a una colonna,
così come del resto compare in molte figurazione d'epoca greca. In quanto al
luogo del supplizio, Hēsíodos
non ce lo dice.
 |
|
Atlas e Promētheús (✍
560-550 a.C.) |
Kylix laconico, da Cerveteri
Musei Vaticani, Roma (Italia) |
È Aischýlos a introdurre l'armamentario
di tortura divenuto «canonico». Nel suo dramma, sono
Krátos e Bía, il
«potere» e la «forza», le due guardie del corpo di Zeús,
a trascinare Promētheús nel luogo del
supplizio, indicato come «l'estrema plaga della terra,
la Scizia solitaria, inaccessibile» [chthonòs mèn es tēlouròn hḗkomen pédon,
Skýthēn es hoîmon, ábroton eis erēmían]
(Promētheús
desmṓtēs [-]).
Che il Caucaso fosse considerato una vetta della Scizia, lo testimonia
Apollódōros
(Bibliothḗkē
[I: 7]). E che fosse anche
questa la concezione di
Aischýlos, lo
apprendiamo da un'annotazione di Cicero. Il celebre avvocato, introducendo una ventina di
versi del
Promētheús
luómenos (una delle
perdute tragedie eschilee), da lui adattati in latino, traduce un passo dove si
dice che
Promētheús venne incatenato sulla vetta
del monte Caucaso (Tusculanae
[II: 23]).
In
Aischýlos, l'operazione
di incatenamento viene compiuta da Hḗphaistos,
insostituibile tecnico esperto in lavori metallici. Il dio-fabbro si presenta
piuttosto riluttante a obbedire all'ordine di Zeús,
e la pietà traspare più volte dai suoi gesti e dalle sue parole, ma non può
disobbedire al comando che gli è stato ingiunto, e del resto
Krátos e
Bía lo esortano, con i loro modi spietati,
a imprigionare il titán. Hḗphaistos
esegue, soffrendo egli stesso. Gli attacca morsi di ferro ai polsi e alle
caviglie, e questi vengono fissati alla roccia; un cuneo di ferro dinanzi al
petto, un altro a mo' di cintura. Ecco fatto. Promētheús è
incatenato ora alla sua rupe, ad attendere immobile il lento scorrere dei
secoli.
Ma Zeús non è ancora soddisfatto, ed aggiunge
alla tremenda tortura un'ulteriore crudeltà. Ogni giorno un'aquila scende su Promētheús e gli strappa con il becco brandelli di
fegato dal ventre; ogni notte, il corpo immortale del titán rigenera la
parte divorata. Instancabile, e altrettanto immortale, l'aquila torna ogni
giorno per ripetere la sua eterna tortura. E Promētheús, incatenato alle vette del
Caucaso, grida contro Zeús tutta la sua rabbia e la
sua indignazione:
Kaì mḕn érgōi koukéti mýthōi
chthṑn sesáleutai.
brychía d' ēchṑ paramykâtai
bronts, hélikes d' eklámpousi
sterops zápyroi, strómboi dè kónin
heilíssousin. skirtâi d' anémōn
pneúmata pántōn eis állēla
stásin antípnoun [apodeiknýmena].
xyntetáraktai d' aithḕr póntōi.
toiád' ep' emoì rhipḕ Dióthen
teúchousa phóbon steíchei phaners.
mētròs ems sébas, pántōn
aithḕr koinòn pháos heilíssōn,
esorâis hōs ékdika páschō. |
Promētheús: «Non è più parola. La terra trema.
È l'urlo cupo sordo del tuono,
il bagliore del lampo, il vortice del fuoco,
turbina polvere, i venti si lanciano
violenti, in lotta aperta,
cielo e mare sconvolti.
È la mano di Zeús su di me,
visibile, viene: io tremo.
Guardate, tu santità di mia madre,
tu cielo che volgi la luce del mondo:
quello che soffro è contro la giustizia». |
|
Aischýlos:
Promētheús
desmṓtēs [-] |
Ma lasciamo Promētheús, vinto ma non
domato, tra le rocce del Caucaso. Tiriamo piuttosto il fiato e facciamo il punto
della situazione.
|
CAUCASO E GRECIA: IDENTITÀ NELLE VARIANTI
 |
|
Promētheús incatenato da Hḗphaistos (✍
1623) |
Dirck van Baburen (1595-1624)
Olio su tela. Rijksmuseum, Amsterdam (Paesi Bassi) |
Il rapporto tra il mito ellenico di
Promētheús
e le leggende caucasiche del campione incatenato ha tormentato gli studiosi a
partire almeno dalla seconda metà dell'Ottocento: al riguardo vi è un'enorme
letteratura, fiorita soprattutto presso i filologi russi, e ripresa in Francia da Georges Dumézil e
Georges Charachidzé.
Quest'ultimo, soprattutto, ha studiato le relazioni tra il
mito greco e quello caucasico, con risultati a volte sorprendenti.
La comparazione tra Caucaso e Grecia è agevole soprattutto sul tema della sfida
dell'eroe al dio supremo e del suo conseguente incatenamento. Anzi, su questo
punto i dettagli coincidenti sono numerosissimi. Vi è convergenza persino
laddove l'uno o l'altro mitema appaiono in forme alternative.
Ad esempio, nelle versioni principali del mito caucasico, Amirani risulta incatenato a un palo, e
stessa sorte è riservata ad Abrysk’yl. Sono però
attestate delle versioni alternative in cui l'eroe georgiano viene incatenato direttamente alla roccia.
Ora, queste due versioni si alternano anche nel mito greco.
Infatti, mentre Hēsíodos afferma che Promētheús
venne legato a un palo o a una colonna [kiṓn] con «inestricabili lacci» [poikilóboulon]
(Theogonía [-]),
come compare a volte anche
nelle figurazioni antiche, Aischýlos descrive nei
dettagli l'incatenamento di Promētheús
alla roccia, ed è un passo di enorme forza drammaturgica:
|
Hḗphaistos: kaì dḕ prócheira psália dérkesthai pára.
Krátos: balṓn nin amphì chersìn enkrateî sthénei
rhaistri theîne, passáleue pròs pétrais.
Hḗphaistos: peraínetai dḕ kou matâi toúrgon tóde.
Krátos: árasse mâllon, sphínge, mēdami chála.
deinòs gàr heureîn kax amēchánōn póron.
Hḗphaistos: áraren hḗde g' ōlénē dyseklýtōs.
Krátos: kaì tḗnde nŷn pórpason asphals, hína
máthēi sophistḕs ṑn Diòs nōthésteros.
Hḗphaistos: plḕn toûd' àn oudeìs endíkōs mémpsaitó moi.
Krátos: adamantínou nŷn sphēnòs authádē gnáthon
stérnōn diampàx passáleu' errhōménōs.
Hḗphaistos: aiaî, Promētheû, sn hýper sténō pónōn.
Krátos: sỳ d' aû katokneîs tn Diós t' echthrn hýper
sténeis? hópōs mḕ sautòn oiktieîs pote.
Hḗphaistos: horâis théama dysthéaton ómmasin.
Krátos: hor kyroûnta tónde tn epaxíōn.
all' amphì pleuraîs maschalistras bále.
Hḗphaistos: drân taût' anánkē, mēdèn enkéleu' ágan.
Krátos: mḕn keleúsō kapithōýxō ge prós.
chṓrei kátō, skélē dè kírkōson bíāi.
Hḗphaistos: kaì dḕ pépraktai toúrgon ou makri pónōi.
Krátos: errhōménōs nŷn theîne diatórous pédas.
hōs houpitimētḗs ge tn érgōn barýs.
Hḗphaistos: hómoia morphi glssá sou gērýetai.
Krátos: sỳ malthakízou, tḕn d' emḕn authadían
orgs te trachytta mḕ 'píplēssé moi.
Hḗphaistos: steíchōmen. hōs kṓloisin amphíblēstr' échei. |
Hḗphaistos: «Ecco, li guardi il padre, il
morso è pronto».
Krátos: «Mettili ai polsi e batti con il maglio
con grande forza, inchiodalo alla rupe».
Hḗphaistos: «E l'opera si compie. E non si perde».
Krátos: «Picchia più forte, chiudi, stringi bene.
È terribile, scopre l'impossibile».
Hḗphaistos: «Un braccio è già fissato. Non si libera».
Krátos: «Aggancia duro anche l'altro braccio.
Impari, il savio, che è più tardo di Zeús».
Hḗphaistos: «Nessuno può rimproverarmi: se non lui».
Krátos: «E il cuneo di ferro, una mascella splendida,
inchioda forte, fissala sul petto».
Hḗphaistos: «Promētheús, quanta
pena al tuo patire!»
Krátos: «Esiti ancora? Soffri per chi è nemico di Zeús?
Che tu non debba avere pietà per te, un giorno».
Hḗphaistos: «È visione di orrore a questi occhi».
Krátos: «Visione di una sorte meritata.
Via, applica ai suoi fianchi la cintura».
Hḗphaistos: «Farlo si deve: dunque, perché ordini?»
Krátos: «Ordinerò, aizzerò ancora. Càlati,
inanella le gambe con la forza».
Hḗphaistos: «Fatto. Non era fatica lunga».
Krátos: «Ora ribatti i ceppi in ogni foro:
il giudice dell'opera è severo».
Hḗphaistos: «Somiglia al tuo aspetto il tuo parlare».
Krátos: «E sii tu mite, ma non mi accusare,
per l'ira o la superbia o la durezza».
Hḗphaistos: «Andiamo. È imprigionato membro a membro». |
|
Aischýlos:
Promētheús
desmṓtēs [-] |
Anche il contributo di
Hḗphaistos, scortato da
Krátos e Bía,
all'incatenamento di Promētheús, presenta
un'altra serie di strette corrispondenze con i miti caucasici. In questi ultimi,
generalmente, è il dio supremo a incatenare l'eroe ribelle con un atto
di volontà, e i racconti tendono a svolgere l'imprigionamento con il numero
minimo di parole, enfatizzando
l'onnipotenza divina: «Per tali azioni, Ḡmerṫi
incatenò Amirani a un palo di
ferro» (L2); «Ḡmerṫi
fece il segno della croce [sic] e lo incatenò al palo»
(L16); «Ma
Tė non tollerò tanto ardire e con una
lunga catena legò alle rocce il profanatore dei misteri» (Leggenda
cabardina del prometeo monocolo).
Analoga è la formulazione che compare nel testo di Hēsíodos,
dove l'operazione di incatenamento procede direttamente da
Zeús a Promētheús:
|
Dse d' alyktopédēısi Promēthéa poikilóboulon
desmoîs argaléoisi méson dia kíon' elássas... |
[Zeús] legò con
inestricabili lacci Promētheús mente sottile,
con legami tremendi, spingendo una colonna nel mezzo... |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-] |
In
Aischýlos, però,
la volontà di
Zeús
viene messa in atto da due entità specifiche,
Krátos
e
Bía,
la «forza» e il «potere». Presentati dai mitografi come le guardie del
corpo di Zeús, costoro rappresentano il potere esecutivo del
re degli dèi. Sono loro a trascinare Promētheús
al luogo del supplizio, al fine di compiere, secondo la formula eschilea, una
«missione per conto di Zeús» [entolḗ Diós] (Promētheús
desmṓtēs []).
Krátos
e
Bía,
inoltre, controllano il lavoro di
Hḗphaistos, badando che
il recalcitrante dio-fabbro incateni saldamente Promētheús
alla roccia.
Ma anche nei miti caucasici, come abbiamo visto, è talvolta presente un
simile ordine di esseri subalterni, inviati dal dio supremo affinché catturino e incatenino
il campione ribelle. Nella versione georgiana, a occuparsi di
Amirani sono i dèmoni-fabbri: «I aǯebi lo circondarono e lo
attaccarono al bastone che ristʻe aveva piantato
in terra» (L9); nella versione abxasica,
Anc°a invia i suoi subalterni a catturare
e incatenare Abrysk’yl: «Allora
Anc°a, irritato contro l'eroe ribelle, comandò agli
aṗeambarc°a di prenderlo, di gettarlo, mani e piedi legati, nel mondo
sotterraneo, e di torturarlo crudelmente, finché non avesse inteso ragioni e non
si fosse sottomesso a lui» (L23).
Gli esseri subalterni che appaiono separatamente nelle versioni
georgiana e abxasica, corrispondono ai due tipi di ausiliari che
Aischýlos riunisce nella sua
versione del mito greco. Se i aǯebi georgiani possono
essere equiparati ad
Hḗphaistos, nella qualità
di geni della fucina e impareggiabili fabbri, gli aṗeambarc°a abxasici
hanno una corrispondenza piuttosto precisa con
Krátos
e
Bía. Resi a volte in
traduzione con «angeli», gli aṗeambarc°a sono definiti dagli Abxasi la «forza del dio supremo», perché incarnano la manifestazione attiva
della potenza e della volontà di Anc°a. È la medesima
funzione assunta da
Krátos
e
Bía nel mito greco.
(Charachidzé 1986¹)
 |
|
Caverna di Abryskyl |
|
Presso Otap'i, Abxazia (Georgia) |
I miti caucasici tendono inoltre a mostrare il campione ribelle
imprigionato in una caverna all'interno dei monti del Caucaso. Per
quanto esistano versioni in cui Amirani sia esposto
en plein air, molte versioni georgiane descrivono un catastrofico sommovimento orografico: Ḡmerṫi
manda in pezzi le montagne e ricopre il ribelle con un cumulo di
rocce, formando una sorta di buia caverna. «Scoppiò una terribile tempesta, con
tuoni e lampi; le montagne si squarciarono e chiusero la via che portava ad
Amirani» (L24). Il
massiccio montuoso che viene spostato e rimodellato per imprigionare
Amirani è il Q‘azbegi nelle versioni
orientali, l'Ėl'brus in quelle occidentali.
Nella versione abxasica, non c'è alcun bisogno di disturbare le montagne.
Abrysk’yl
viene direttamente condotto in una profondissima grotta, e lì incatenato.
Questa è identificata con una caverna monumentale, ricca di eleganti
stalattiti e stalagmiti, che si trova presso il villaggio di Otap‘i, in Abxazia;
in georgiano è chiamata Abrsk‘ilis Mḡvime, «Caverna di
Abrysk’yl».
Potrebbe sembrare una differenza non da poco con il mito greco, in cui il
teatro della tortura di Promētheús non è mai
una caverna, ma in un luogo esposto al sole, alla pioggia e alle
intemperie, tra le alte cime del Caucaso occidentale. Che delle versioni alternative
circolassero anche nel mondo classico, per lo meno in epoca tarda, lo aveva confermato il sofista
Phláuios Philóstratos, di cui riportiamo ancora una volta
la testimonianza:
|
|
Secondo gli uni, [Promētheús] era incatenato in una caverna sul fianco della
montagna, che viene ancora indicata. Dámis dice addirittura che nella roccia
sono ancora infisse le sue catene, la cui grandezza è inimmaginabile. Secondo
altri, [Promētheús era incatenato] sulla vetta
di una certa montagna: questo monte ha due cime che distano tra loro più di uno
stadio, e si dice che egli era incatenato con una mano a una e con l'altra
all'altra, tanto era smisurato! |
|
Phláuios Philóstratos:
Tà ès tòn Tyanéa' Apollṓnio [II, 3] |
Difficile dire a quali tipi di tradizioni facesse capo
Philóstratos, e quanto siano attendibili. La letteratura classica mostra sempre
Promētheús esposto al sole e alle
intemperie. Non si parla mai di caverne o prigioni sotterranee. È però anche vero che, nel dramma di Aischýlos,
Herms affronta il titán,
riottoso a sottomettersi alla volontà di Zeús,
paventandogli un supplizio pressoché identico a quello effettivamente subito dal suo «collega» caucasico:
|
Hoîós se cheimṑn kaì kakn trikymía
épeis̱' áphyktos. prta mèn gàr okrída
pháranga bronti kaì kerauníāi phlogì
patḕr sparáxei tḗnde, kaì krýpsei démas
tò són, petraía d' ankálē se bastásei.
makròn dè mkos ekteleutḗsas chrónou
ápsorrhon hḗxeis eis pháos.
|
Herms: «[...] Ma se le mie parole non
convincono,
rifletti alla bufera e ai marosi
che ti assaliranno. Senza fuga il padre
frantumerà nel tuono e nella folgore
questa roccia irta e ti seppellirà:
ti reggerà la morsa della pietra.
Poi dopo un lungo scorrere di tempo
risorgerai e rivedrai la luce...» |
|
Aischýlos:
Promētheús desmṓtēs [-] |
La tempesta, il frantumarsi della rocce, il seppellimento dell'eroe: i
singoli fotogrammi della minaccia di
Herms hanno una corrispondenza puntuale con
quanto la versione caucasica effettivamente realizza. Si accenna anche al motivo
di un ritorno alla luce dopo un tempo
lunghissimo e indefinibile, ed è quanto accade nel racconto georgiano. A intervalli regolari, infatti, la roccia si
squarcia e Amirani può tornare a contemplare la
luce del giorno, sebbene per un tempo brevissimo. In sintesi, Aischýlos sembra accennare a
una versione del mito prometeico che non è stata attuata in Grecia, ma che è
fondamentale nel Caucaso. (Charachidzé 1986¹)
Parleremo in seguito del motivo dell'aquila che strazia il fegato di Promētheús. Ci preme ora, in questa serie di
corrispondenze, rilevare il principale punto di distacco tra i due complessi
mitici, che risiede nella psicologia dell'eroe e nella natura della sua
ribellione.
Tra Promētheús e
Amirani/Abrysk’yl vi è un'incolmabile differenza di carattere: il titán
greco è caratterizzato dalla sua intelligenza, laddove gli eroi caucasici
sono presentati soprattutto come guerrieri. A tale differenza fa da contraltare, simmetricamente, il fatto che Promētheús
non è mai un guerriero. Anzi, rifiuta con decisione l'uso sistematico della violenza
propugnato dai Titânes, per mettere la sua astuzia dalla
parte di Zeús. I campioni caucasici, al contrario,
sembrano del tutto ignari della possibilità di utilizzare strategie più
complesse della semplice applicazione di un impeto che superi quello del nemico. Quando si
trovano di fronte ad avversari più potenti di loro, risolvono imparando nuove
tecniche di combattimento (contro il re aǯe) o chiedono al dio supremo una forza
supplementare che li aiuti a superare l'ostacolo (per sollevare la gamba di
Ambri Arabi).
Più significativo, in questa sede, è definire il modo in cui i vari
personaggi esplicano le loro facoltà. Promētheús
eccelle in intelligenza, tanto che può permettersi
di gareggiare in scaltrezza con lo stesso Zeús. Nel
Caucaso, Amirani e Abrysk’yl
sono i più forti guerrieri del mondo: hanno
sconfitto ogni possibile nemico, esterno o interno, umano o diabolico, tanto che
non vi è più, sulla Terra, un avversario che possa sostenere il loro impeto: è a
questo punto che, nella loro sicurezza e tracotanza, arrivano a sfidare il dio supremo.
Dunque, seppure diversi nella natura delle loro capacità,
Promētheús ed Amirani/Abrysk’yl
sono presentati come coloro che hanno elevato le loro capacità – rispettivamente
intellettuali e guerriere – al massimo grado concepibile. Il dettaglio, come
giustamente nota Charachidzé, è connaturato agli schemi ideologici delle due
aree culturali, la Grecia e il Caucaso. Un campione che disputi su livelli
diversi dal valore guerriero, sarebbe stato del tutto inconcepibile tra i
montanari della Georgia e dell'Abxasia. La sfida che
Amirani o Abrysk’yl
lanciano al dio supremo è un invito a battersi; e la risposta del dio prende sempre la forma
di una sfida fisica, sebbene opponga poi una resistenza ontologica.
(Charachidzé 1986¹)
Quel che è importante, a questo punto, non è tanto la modalità del
contendere, quanto il fatto stesso che vi sia una sfida lanciata dal campione al dio
supremo. Si tratta di una sfida all'ordine cosmico: ciò che l'eroe mette
in discussione è proprio l'autorità divina, il diritto legittimo del dio di
imporre sul mondo un sistema di leggi che il campione non sa accettare, o che intende
capovolgere.
Nello specchietto sottostante, A e H testimoniano
rispettivamente le versioni greche di Aischýlos ed Hēsíodos.
G1 e G2 sono le versioni
georgiane, in ordine di importanza, C ed A, rispettivamente,
quella circassa e quella abxasica.
| |
|
GRECIA |
CAUCASO |
| 1 |
H |
Zeús incatena
Promētheús. |
G1 |
Ḡmerṫi
incatena Amirani. |
|
C |
Tė incatena
Teʒau. |
| A |
Zeús ordina alle
sue guardie del corpo,
Krátos
e
Bía, di condurre
Promētheús nel Caucaso e
accertarsi che il dio fabbro
Hḗphaistos lo incateni. |
G2 |
Ḡmerṫi
ordina ai dèmoni-fabbri, i aǯebi
di catturare e incatenare Amirani. |
|
A |
Anc°a ordina ai suoi inviati, gli aṗeambarc°a,
di catturare e incatenare Abrysk’yl. |
| 2 |
H |
Promētheús
viene legato a una colonna. |
G1 |
Amirani viene legato a un palo o a un bastone
conficcato al suolo. |
|
A |
Abrysk’yl viene legato a un palo. |
| A |
Promētheús
viene incatenato a una roccia. |
G2 |
Amirani viene incatenato a una roccia. |
|
C |
Teʒau viene incatenato a una roccia. |
| 3 |
A H |
Promētheús
rimane a cielo aperto, sottoposto al sole, alla pioggia e alle
intemperie. |
G2 |
Amirani rimane a cielo aperto. |
|
C |
Teʒau rimane a cielo aperto. |
| A |
Herms minaccia il
seppellimento di Promētheús
sotto una cascata di rocce, da cui sarebbe tornato alla luce
solo dopo moltissimo tempo. |
G1 |
Amirani
viene seppellito sotto una montagna deposta su di lui come una
volta di roccia. A intervalli regolari, la roccia si apre e gli
permette di affacciarsi sul mondo. |
| A |
Abrysk’yl
viene incatenato in una profonda caverna. |
|
|
ANCORA NEL CAUCASO,
MA IL FUOCO DOV'È?
Tra le difficoltà sollevate nel confronto tra il mito ellenico di Promētheús
e le varianti caucasiche del gigante incatenato, una delle più pertinaci è dovuta
proprio ai preconcetti degli studiosi. È difficile essere del tutto obiettivi,
considerando che le opere di
Hēsíodos (la
Theogonía e le
Érga kaì Hēmérai), tra le più antiche della letteratura occidentale,
fanno parte del nostro DNA culturale. E non è facile
retorica affermare che il mito greco di Promētheús sia uno dei temi
più rappresentativi della
cultura europea. Aischýlos vi vede l'archetipo dell'etica autonoma contro le
imposizioni del potere (Promētheús
desmṓtēs); Ovidius ne fa il
demiurgo della sua genesi
laica (Metamorphoseon
[I: -]); Tertullianus, in un punto importante della sua teodicea, lo paragona
addirittura a Cristo (Apologeticum [XVIII]).
Né la fortuna di Promētheús si esaurisce
nell'evo antico. Anzi, le interpretazioni e le rivisitazioni del suo mito
accompagnano nel corso dei secoli lo sviluppo culturale dell'occidente. Rousseau
condanna Promētheús per aver trascinato
l'umanità fuori dal suo felice stato di natura; Goethe ne fa il demiurgo che
invita gli uomini a fare a meno degli dèi; Mary Shelley lo recupera nel suo
Frankenstein fornendolo del gusto faustiano della conoscenza proibita;
Herder fonda su di lui il mito positivista della
vittoria dell'intelletto umano e vede nel titán colui che reca sulla
terra la fiamma simbolo del progresso umano, e via elencando, attraverso il XX
secolo fino ai nostri giorni.
 |
|
Amirani/Promētheús (✍
2007) |
|
Devi K̇malaʒe, Tbilisi (Georgia) |
Ma ecco, a dispetto dell'incredibile fortuna toccata al Promētheús
ellenico, i suoi «colleghi» orientali – il georgiano Amirani,
l'abxasico Abrysk’yl, il circasso
Teʒau – sono rimasti confinati
per millenni tra le montagne del Caucaso, del tutto sconosciuti al resto del
mondo. È solo tra il XIX e il XX secolo che i folkloristi hanno potuto raccoglierne le gesta dalla viva voce dei montanari
locali. Non bisogna stupirsi se, nell'analizzare i miti caucasici, gli studiosi hanno cercato di compararli al
«modello» greco, preso più o meno inconsciamente come metro di paragone di ogni altro
materiale.
Abbiamo prima suddiviso il mito greco di Promētheús
in quattro temi distinti:
- Il sacrificio di Mēkṓnē.
- Il sequestro del fuoco.
- La riconquista del fuoco.
- L'incatenamento di Promētheús.
Le relazioni tra il mito ellenico e il complesso mitico caucasico, come
abbiamo visto, riguardano
soltanto il quarto tema. Su questo punto, gli schemi coincidono alla perfezione,
considerando l'enorme distanza di spazio e tempo che separa le
documentazioni letterarie greche dalle assai più recenti testimonianze
popolari del Caucaso. Ma per quanto riguarda i primi tre temi, i racconti caucasici non presentano alcun
mito, alcuna vicenda, che possa
essere messa in corrispondenza con il modello greco. Questa «lacuna» ha sempre
costituito un cruccio non da poco per i caucasologi, soprattutto per quanto riguarda il
motivo «principe» del sequestro e della riconquista del fuoco.
E come si può biasimarli? L'immagine di Promētheús
che porta il fuoco dal cielo per donarlo agli uomini si presta alle più sublimi interpretazioni,
ma anche a ciniche strumentalizzazioni
ideologiche. È l'aspetto proverbiale di Promētheús,
quello che ha maggiormente colpito l'immaginazione di scrittori, filosofi e poeti
nel corso dei secoli. Ancora oggi la
letteratura e l'arte continuano a ispirarsi alla potente figura dei titán che
scende dal cielo impugnando la sua fiaccola ardente.
Il non trovare un mito corrispondente, nelle biografie di
Amirani o Abrysk’yl, è
stato un duro colpo per gli intellettuali caucasici,
specie considerando le solite questioni di orgoglio nazionale. I
Georgiani hanno preferito ignorare la questione filologica e, almeno a livello
popolare, l'identificazione tra Promētheús e
Amirani è spacciata per totale. La massiccia
statua dedicata ad Amirani, che incombe da una
collinetta nel distretto di Marneuli, impugna una spada nella mano destra e una
fiaccola nella sinistra. Anche la più snella e aggraziata scultura di Devi malaʒe, inaugurata a Ṫbilisi nel 2007, protende
in avanti le palme delle
mani, sulle quali arde una fiamma.
Ciononostante, nel mito caucasico del campione incatenato, il tema
del furto del fuoco brilla... per la sua assenza.
 |
|
Trittico delle leggende caucasiche |
|
Levars Butba (1960-) |
I caucasologi si sono affannati a rovistare tutte le varianti del ciclo amiranico,
cercando di rintracciare elementi
che potessero suggerire l'esistenza di un perduto mito igneo. E quando si cerca disperatamente qualcosa, si finisce
spesso per trovarla...
anche quando non c'è. Per fare un esempio, il filosofo georgiano Šalva Nuċubiʒe
(1888-1969) ha voluto interpretare il personaggio di
Q‘amar, figlia del re dei aǯebi, come un'ipostasi solare. Di conseguenza, il suo rapimento da parte di
Amirani rappresenterebbe un equivalente metaforico del furto del fuoco
(Nuċubiʒe 1960).
Con tutto il rispetto per l'illustre cattedratico, la sua ipotesi è tirata per i
capelli, e oltretutto si riferisce a un mitema differente, ben conosciuto, e attestato presso
altre tradizioni tanto
indoeuropee quanto caucasiche. In un racconto svanete, il dio
Givargi si reca nel aǯeti
per rubare ai aǯebi gli strumenti della loro
fucina; al suo ritorno, rapisce tre diavolesse, una delle quali,
Samʒimari, diventerà la sua sorella-sposa, fondando
con lei l'istituzione matrimoniale
(Šaniʒe
1934 | Tuite 2000).
Senza entrare troppo nel dettaglio, il mito del ratto della prima sposa dal regno dei dèmoni-fabbri
sembra piuttosto omologo a quello esiodeo di Pandṓra,
la prima donna forgiata da Hḗphaistos nella sua fucina e condotta
al genere umano per rovinarlo attraverso il matrimonio (Érga kaì Hēmérai
[-]) ①. Vedere il furto del fuoco, in
questo complesso mitico, è solo una pia illusione. Eppure, l'ipotesi «solare» di Nuċubiʒe, nonostante la decisa
opposizione dello stesso Charachidzé, è ancora piuttosto popolare tra studiosi e appassionati.
Per dirne un'altra, nel 1948 il folklorista Mixeil Čʻikʻovani affermò di
aver raccolto, in uno sperduto villaggio del distretto georgiano di Imereṫi, «un frammento della leggenda
di Amirani, da cui si ricava che l'eroe fu
incatenato per aver rubato il fuoco» (Čʻikʻovani 1966).
Di fronte a tale notizia, Charachidzé ha confessato la propria
perplessità, anche perché Čʻikʻovani non fornisce alcun racconto,
alcun poema, alcun testo, ma una semplice dichiarazione, non verificabile. Altre
allusioni del genere, presenti in letteratura, non possono che essere accolte
allo stesso modo. (Charachidzé 1986¹)
È pure attestato un racconto cabardino – ma di origine ossetica –
straordinariamente vicino al mito esiodeo. Il malvagio dio
Pak°ʻe, irritato contro i valorosi nartæ, che non gli hanno
riservato nulla del festino sacrificale, toglie loro il fuoco: spegne con il suo
soffio le fiamme in tutti i focolari degli uomini, lasciandoli senza le più
piccole braci. Non sapendo più come accendere il fuoco, i nartæ invitano
il loro campione Nesren ad andare a recuperare
questo bene vitale. Pak°ʻe lo incatena in cima ai
monti del Caucaso, poi gli lancia contro un avvoltoio gigante, le cui ali
coprono l'intera vallata. Il rapace cala su Nesren
e con il becco gli succhia il sangue proprio dal cuore.
Interviene allora l'eroe Bataraz (il
Batraʒ ossetico): uccide l'avvoltoio con due frecce
e riporta indietro Nesren e il fuoco
(Andreev-Krivič 1957). Questa versione del mito
è talmente vicina
al modello greco, persino nei più minuti particolari, da far sospettare un
plagio dotto o letterario. È questa l'opinione di Georges Charachidzé, che al
racconto ha addirittura dedicato un articolo di disamina, Un
Prométhée tcherkesse trop prométhéen
(Charachidzé 1986²).
Assai più originale e interessante, un'ulteriore variante del ciclo di Amirani
(L15),
segnalata sempre da Charachidzé. Il campione è alla ricerca dell'occhio del suo
padre adottivo Iaman, che un dev ha rubato e
incastonato nella colonna che sostiene la sua dimora. Seduto su un cinghiale, il
dev fa la guardia al suo tesoro e brucia chiunque si avvicini per mezzo
del «fuoco di Elia». Su consiglio di
Iaman, Amirani e i
suoi fratelli adottivi Badri e
Usip‘ si muniscono di tre teste di cavallo disseccate, di una misura di
midollo d'asino e di una misura di grano, e si recano alla dimora del dev.
Il dèmone è occupato ad arrostire un pezzo di selvaggina sulle fiamme del focolare.
Amirani sale sul tetto e lascia cadere nel camino
una delle tre teste di cavallo: questa piomba nel focolare, sollevando un fiotto
di scintille, ma il dev non ne è affatto disturbato. Anche il secondo
tentativo va a vuoto. Al terzo, però, le scintille accecano il dev, il
quale si riscuote, inforca il cinghiale, e armato del «fuoco di
Elia», vola all'esterno della dimora.
Usip‘ fugge, ma Badri spegne il fuoco
spargendovi sopra il midollo d'asino, poi doma il cinghiale spandendovi sopra il
grano. Amirani abbatte il dev e recupera
l'occhio di Iaman. A questo punto, i tre eroi
tornano a casa e restituiscono l'occhio al padre. Tuttavia, nel frattempo, il
fuoco si è spento nel loro focolare, e bisogna fare qualcosa...
|
|
Da nessuna parte nei dintorni c'era fuoco, salvo in un luogo dove vivevano nove
fratelli, uno dei quali era zoppo. Decisero che Amirani
sarebbe andato a cercare il fuoco. Giunto alla casa dei nove fratelli egli si
fermò ad ascoltare la loro conversazione. Il più giovane, quello zoppo, diceva:
«Se in questo istante, qualcuno entrasse, ci colpisse e rubasse il fuoco, cosa
potremmo fare?»
I fratelli si irritarono con lo zoppo. «Disgraziato, chi sarà così audace da
penetrare nella casa, darci uno schiaffo e portare via il fuoco?»
A queste parole, Amirani si slanciò nella casa,
percosse ogni fratello, escluse lo zoppo, si impadronì del fuoco e se ne andò.
[...]. Amirani portò il fuoco a casa e lo
attizzarono subito. |
|
L15 |
Il dio georgiano Elia – sorto per evidente
sincretismo con la figura del profeta biblico – è un genio folgoratore, diffuso
in tutto il Caucaso, signore
del fulmine e della pioggia. Il «fuoco di Elia», di
cui è armato il dev, altro non è che il fuoco sviluppato dalla folgore.
Nel momento in cui questo viene spento, Amirani e i
suoi fratelli, rimasti senza fiamma, si rivolgono a un'altra sorgente ignea, e
la trovano nella casa dei nove fratelli. Forse non è un caso che il più giovane
dei nove – l'unico a cui Amirani risparmia i suoi
solenni ceffoni – sia zoppo, così come è zoppo Hḗphaistos
nel mito greco.
Se la casa dei nove fratelli fosse una fucina, allora ritroveremmo in
L15
lo stesso rapporto tra fuoco celeste e fuoco ipoctonio già presente nello
schema esiodeo: dove il primo, elargito da Zeús
tramite i suoi fulmini, viene tolto all'umanità, e Promētheús
ruba il secondo dalla fucina di Hḗphaistos
(Charachidzé 1986¹). Certo, è un po' poco per
istituire un parallelo convincente, ma l'idea è molto interessante.
A questo punto un'osservazione è d'obbligo: il mitema della conquista del fuoco sembra essere universale.
È attestato in Nuova Zelanda, dove l'eroe Māui ruba
il fuoco all'antenata Mahuike per farne dono
all'umanità. In Nord America, dove il trickster
Nanabozho, eroe culturale degli Ojibwa, s'impadronisce del
fuoco per darlo agli uomini. Miti simili compaiono presso Algonchini, Cherokee,
Creek, Ute e altri nativi americani. Li ritroviamo
in Sud America, in Africa, in Asia orientale e in Australia. Raffaele Pettazzoni, nella sua monumentale raccolta di miti dei popoli senza scrittura,
riporta non meno di venticinque versioni del mito della conquista del fuoco, alcune delle quali
molto vicine al racconto esiodeo (Pettazzoni 1948-1959).
Ad esempio, secondo un mito dei Tucuna dell'Amazzonia occidentale,
il fuoco era originariamente in possesso della vecchia Topetine.
Poiché suo figlio adottivo veniva deriso a causa della sua bruttezza,
Topetine lasciò la terra degli uomini e si ritirò
in cielo, irata e stizzita, lasciando il mondo senza fuoco. Suo nipote
Dyoi si recò allora in cielo e, con un inganno,
portò via un tizzone ardente dal focolare della nonna e restituì il fuoco agli
esseri umani. Topetine, infuriata, tagliò la scala
che univa il cielo e la terra, dividendo per sempre il mondo degli dèi e quello
degli uomini. (Nimuendajú 1952).
Non basta segnalare un racconto dove un personaggio conquista, ruba o si
procura il fuoco, per stabilire delle
relazioni di omologia con il mito greco. Nella maggior parte dei casi
possiamo parlare di semplici analogie. Abbiamo delle omologie solo
dove si possa dimostrare che due o più miti si siano
sviluppati per evoluzione da un tema comune. Bisogna poter comparare degli schemi complessi, che comprendono una
rete ben precisa di relazioni tra personaggi e vicende. I motivi possono anche
risultare alterati o rovesciati, nel passaggio da una cultura all'altra: è però
indispensabile che gli schemi rimangano riconoscibili.
Abbiamo già notato la complessità di partenza dello schema esiodeo, che
riportiamo ancora una volta:
- Il sacrificio di Mēkṓnē.
- Il sequestro del fuoco.
- La riconquista del fuoco.
- L'incatenamento di Promētheús.
Il mitema igneo occupa il secondo e il terzo tema, dove il fuoco viene prima
sequestrato da Zeús, poi riconquistato
da Promētheús. Questi due temi non sono
necessariamente legati tra loro: in molte mitologie, infatti, manca il tema del
sequestro e si ha solo la conquista del fuoco (non la
riconquista). Tanto più un mito si avvicina allo schema esiodeo, quanto più si può
ipotizzare un'omologia con il racconto ellenico.
 |
|
Amirani, con spada e fiaccola |
|
Marneuli (Georgia) |
Ora, come abbiamo visto, i miti
caucasici ignorano del tutto i primi tre temi, e presentano di regola solo il quarto, quello della sfida al
dio supremo e del conseguente incatenamento.
Fa eccezione il citato racconto L15,
dove il furto del fuoco, operato da Amirani,
rimanda a uno schema di sequestro e riconquista, per
quanto il secondo e il terzo tema appaiano slegati (il narratore tenta di
imbastire un rapporto logico tra la lotta con il dev e lo spegnimento del
fuoco a casa di Iaman giustificandolo con il tempo speso nell'impresa).
Indipendente è il quarto tema, il motivo
dell'incatenamento dell'eroe, che compare in coda alla narrazione e
nelle modalità già illustrate. Per quanto rimanga un
sospetto di omologia tra il furto del fuoco in
Theogonía e
in L15,
i dati sono ambigui ed è difficile arrivare a una conclusione.
In realtà, anche l'assenza di un elemento può essere utile al fine di ricostruire il processo che ha portato alla distinzione
e separazione di due o più complessi mitici. Se il quarto tema, quello della
sfida al dio supremo e dell'incatenamento del campione ribelle, è il nucleo del
mito «originale», bisogna forse dedurre che gli altri tre temi – il sacrificio di Mēkṓnē,
il sequestro e
la riconquista del fuoco – siano delle innovazioni greche, applicate successivamente
al tema principale. Ma è davvero così?
Le cose, come vedremo, stanno in maniera assai più complessa, e lo schema «esiodeo»
in quattro punti è più diffuso di quanto non si pensi. Per accertarcene, però, dobbiamo fare un
salto in Scandinavia e fare conoscenza con il perfido Loki.
|
| PROMĒTHEÚS E LOKI
Dalla Grecia arcaica alla Scandinavia medievale. È un balzo
ardito, sia nel tempo che nello spazio, ma non senza scopo. I ruvidi
vichinghi appaiono molto lontani dalla grazia classica degli Elleni, ma la loro
cultura affonda le sue radici nel medesimo humus indoeuropeo. La
cosmogonia scandinava ha molti tratti in comune con
Hēsíodos, e non stupirà di incontrare, nel variegato
pántheon scandinavo, un
personaggio assai simile a Promētheús.
Meno idealista del titán greco, ma altrettanto astuto, e facile
all'inganno e ai voltafaccia.
Stiamo parlando di Loki, il cui
simpatico epiteto era bǫlsmiðr, il «fabbro di
mali». Se gli dèi vichinghi, gli Æsir,
non andavano molto per il sottile per raggiungere i loro scopi,
Loki
spiccava tra tutti per il suo carattere subdolo, falso e ingannatore. Così ce lo presenta lo scrittore islandese Snorri Sturluson
(1178-1241) in un capitolo della sua
Prose Edda, ultima figura in una
dettagliata galleria del pántheon scandinavo:
|
Sá er enn talðr með ásum er sumir
kalla rógbera ásanna ok frumkveða
flærðanna ok vǫmm allra guða ok
manna. Sá er nefndr Loki [...]. Loki er
fríðr ok fagr sýnum, illr í skaplyndi, mjǫk fjǫlbreytinn at
háttum. Hann hafði þá speki umfram
aðra menn er slǿgð heitir ok vélar
til allra hluta. Hann kom ásum
jafnan í fullt vandræði ok opt leysti hann þá með vélræðum. Kona
hans heitir Sigyn, son þeira Nari
eða Narfi |
Si annovera ancora fra gli Æsir
colui che taluni chiamano il calunniatore degli
Æsir, origine della falsità e disgrazia per tutti gli dèi e degli
uomini. Questi è chiamato
Loki [...].
Loki è bello e avvenente alla vista, malvagio nell'animo e molto volubile
nel temperamento. Egli ricevette più di ogni altro quella capacità che si chiama
astuzia e ordisce inganni in tutte le occasioni. Egli condusse sempre gli
Æsir a grandi affanni, anche se poi spesso li soccorse con i suoi
inganni. |
|
Snorri:
Prose Edda
> Gylfaginning [33] |
Le affinità tra Loki e
Promētheús sono state puntualmente segnalate dagli studiosi. Ciò che
colpisce, innanzitutto, è il loro singolare destino: anche
Loki, infatti, è destinato a venire
incatenato dagli dèi in punizione delle sue malefatte. Ma non anticipiamo il
finale e procediamo un passo alla volta. Mettiamo
Loki e
Promētheús a confronto: troveremo un gran numero di sorprendenti
somiglianze e, naturalmente, degli interessanti punti di distacco.
 |
|
Loki (✍
1765-1766) |
|
Ms. SÁM 66. Stofnum Árna Magnússonar,
Reykjavík (Islanda). |
Entrambi sono degli elementi inizialmente estranei ai rispettivi pánthea.
Anzi, diciamolo in maniera più decisa, entrambi appartengono per nascita alla
schiera dei nemici degli dèi.
Promētheús è figlio di un
titán, accolto sull'Ólympos da Zeús, come suo
stratega, nel corso della titanomachia.
Loki è figlio di due giganti,
Fárbauti e Laufey, e
ci piacerebbe sapere in quale modo sia stato accolto in
Ásgarðr. Il mito in questione
non è stato tramandato, sebbene in un poema eddico si parli di un
patto di sangue che Óðinn e
Loki avrebbero stipulato all'inizio dei
tempi (Lokasenna [9]).
Loki è caratterizzato da un'intelligenza
astuta, beffarda,
capricciosa, assai
affine a quella di Promētheús. Ma mentre
Promētheús è incline a prendersi gioco del potere e a mettere in dubbio
l'autorità costituita, Loki non
sembra avere alcun intento ideologico. È una mina vagante, dalle
reazioni imprevedibili, e non fa
alcuna distinzione sulle vittime che prende di mira. Dèi, uomini, nani, giganti:
Loki gode semplicemente nel fare
scherzi atroci, nel danneggiare gli altri con i suoi tiri birboni. Sia lui che
Promētheús sono essenzialmente degli anarchici, sebbene
Loki appaia assai più infantile del
suo corrispettivo greco. Entrambi sembrano inoltre incapaci di prevedere le
conseguenze delle loro azioni.
Loki, in particolare, commette le
sue malefatte obbedendo al genio del momento, senza nessuna preoccupazione sulle
inevitabili conseguenze delle sue azioni. La semplice considerazione che sarà
scoperto e severamente punito, è ovvia a tutti, tranne che a lui.
Riguardo a Promētheús, la questione è più
sottile. Nella scena del sacrificio di Mēkṓnē, narrata in
Theogonía [-], il
titán
sembra animato principalmente dal desiderio di ingannare
Zeús. La personalità che Hēsíodos
gli attribuisce non è quella dell'eroe che agisce con lo scopo specifico di
favorire il genere umano, ma quella del trickster che si propone di irridere l'autorità e seminare scompiglio.
Ora, la tipologia di sacrificio che
Promētheús stabilisce per il futuro, assegna in
realtà agli dèi la parte nobile ed eterna del cadavere, le ossa, mentre all'uomo
e alla sua natura mortale non possono spettare che le parti deperibili, ovvero
la carne e le interiora. L'inganno che Promētheús
progetta ai danni di
Zeús ha il risultato di tirare una linea tra l'umanità e la divinità,
separando per sempre i mortali dagli immortali, e di stabilire la norma dei
rapporti cultuali tra gli uni e gli altri ①. Nel
suo ruolo di mediatore, dunque, Promētheús non appare
affatto padrone della situazione, ma piuttosto una sorta di arroseur arrosé,
di ingannatore gabbato. La sua burla, costerà agli uomini l'uso del
fuoco e, in seguito, la fine del felice status primordiale e l'inizio
dell'esistenza come noi la conosciamo: una successione interminabile di affanni,
malattie e dolore, caratterizzata dall'obbligo del lavoro, dall'inevitabilità
della morte e dalla necessità del
matrimonio.
A dispetto del significato del suo nome, il
«preveggente», Promētheús sembra incapace di
prevedere le conseguenze delle sue azioni. La contraddizione è
talmente palese che
Aischýlos sente addirittura la necessità
di esplicitarla. Una volta incatenato il titán alla sua rupe, infatti,
Krátos
e Bíē si
allontanano sibilando queste parole:
Pseudōnýmōs se daímones Promēthéa
kaloûsin. autòn gár se deî promēthéōs,
hótōi trópōi tsd' ekkylisthḗsēi téchnēs. |
Krátos: «[...] Le potenze celesti hanno mentito
chiamandoti Promētheús, il preveggente,
perché hai bisogno tu, di chi preveda
come uscire da questi nodi esperti». |
|
Aischýlos:
Promētheús
desmṓtēs [-] |
Studiosi e appassionati hanno proposto molti altri
punti di confronto tra
Loki e Promētheús,
a costo di avventurarsi su terreni inaspettatamente fragili. È facile, ad
esempio, invocare una relazione «ignea» tra i due personaggi, basandosi sulla
possibile definizione di
Loki quale «dio del fuoco». Avanzata nell'Ottocento, questa ipotesi resiste
in modo piuttosto pertinace nei libri di divulgazione, sebbene i filologi
dubitino che il nome del dio derivi dal norreno logi «fuoco». Inoltre,
non conosciamo alcun mito dove
Loki venga messo in relazione con il fuoco, se si eccettua il racconto dove
viene sfidato dal gigante di fuoco
Logi a una gara di mangiate
(Gylfaginning [46]).
In tutto questo, tuttavia, non s'intravede nulla di «prometeico».
Altro fragile esempio. Miti sicuramente antichi, benché ignorati da Hēsíodos, ci informano che Promētheús
aveva creato il genere umano. Vi è la possibilità che anche
Loki sia coinvolto nel mito antropogonico scandinavo, ma essa dipende in realtà da
un'identificazione tra
Loki e il misterioso
Lóðurr, che interviene insieme ad
Óðinn ed Hǿnir
nella creazione della prima coppia umana
(Vǫluspá
[17-18]). Il problema è piuttosto arduo,
per non dire insolubile, e al riguardo non si possono esprimere giudizi definitivi.
Affrontiamo questi argomenti soltanto per sgombrare il campo da parallelismi
poco solidi. È facile, fin
troppo facile, nello studio dei miti, sottolineare punti in comune tra temi,
personaggi e vicende; più difficile è stabilire quanto i parallelismi che
imbastiamo siano
effettivamente fondati. Di rado la ricorrenza di un singolo elemento (ad
esempio, il fuoco) si rivela significativa, se non è supportata dal fitto e
puntuale confronto di schemi dettagliati e complessi. È quanto
cercheremo di fare nei prossimi capitoli, evidenziando relazioni tra miti
diverse che, a nostra conoscenza, vengono notate ora per la prima volta. Quanto segue è un lavoro pionieristico e richiederà attente
valutazioni.
|
|
IN SCANDINAVIA.
DIVINITÀ AFFAMATE
Nello
Skáldskaparmál, Snorri racconta il mito
del rapimento della dea Iðunn
da parte del gigante Þjazi trasformato in aquila:
storia interessantissima e ricca di addentellati, di cui abbiamo
parlato alla pagina apposita ①. Snorri trae la vicenda da una composizione dello
scaldo Þjóðólfr ór
Hvíni (attivo tra la fine del IX e l'inizio del
X secolo), l'Haustlǫng, o «lungo
come un autunno», nel quale il medesimo mito è narrato nello stile ellittico
e involuto della poesia scaldica.
In entrambe le versioni – sia la composizione di Þjóðólfr,
sia la rielaborazione prosastica di Snorri – il mito del rapimento di
Iðunn
viene fatto precedere da un lungo racconto introduttivo, nel quale si spiega in
che modo Þjazi sia riuscito a
convincere Loki a consegnargli la
giovane dea. Ed è proprio questo episodio l'argomento della nostra indagine.
|
Þrír æsir fóru heiman, Óðinn ok Loki ok
Hǿnir, ok fóru um fjǫll ok eyðimerkr, ok var ilt til matar. En er þeir koma ofan
í dal nakkvarn, sjá þeir øxna flokk ok taka einn uxann ok snúa til seyðis. En er
þeir hyggja at soðit mun vera, raufa þeir seyðinn ok var ekki soðit. Ok í annat
sinn, er þeir raufa seyðinn, þá er stund var liðin, ok var ekki soðit. Mæla þeir
þá sín á milli hverju þetta mun gegna. |
Tre
Æsir partirono da casa,
Óðinn,
Loki e Hǿnir,
viaggiarono fra monti e lande desolate ed era dura trovare il cibo. Quando però
giunsero in una certa valle, videro una mandria di buoi, ne presero quindi uno e
lo prepararono per il seyðir. Quando pensarono che fosse pronto,
scoprirono il seyðir, ma [il bue] non era cotto. Una seconda volta, dopo
un po', scoprirono il seyðir dopo un certo tempo, ma [il bue] non era
ancora cotto.
[I tre] discussero fra loro su come ciò potesse accadere. |
|
Þá heyra þeir mál í eikina upp
yfir sik, at sá, er þar sat, kvazk ráða því er eigi soðnaði á seyðinum. Þeir
litu til ok sat þar ǫrn ok eigi lítill. |
Udirono allora una voce proveniente dalla quercia sopra di loro e
chi stava lassù disse di essere la causa per cui nulla si cuoceva nel seyðir.
Essi si voltarono e videro un'aquila, non certo piccola. |
|
Þá mælti ǫrninn: «Vilið þér gefa
mér fylli mína af oxanum, þá mun soðna á seyðinum». |
Disse allora l'aquila: «Se vorrete darmi la mia parte di bue,
allora il seyðir cuocerà». |
|
Þeir játa því. Þá lætr hann
sígast ór trénu ok sezt á seyðinn ok leggr upp þegar it fyrsta lær oxans tvau ok
báða bógana. |
Essi acconsentirono, perciò l'aquila scese dall'albero, si posò sul
seyðir da cui prese come prima porzione le due cosce del bue ed entrambe
le spalle. |
|
Snorri:
Skáldskaparmál [2] |
Il primo punto da osservare è che la vicenda del rapimento di Iðunn
si regge perfettamente anche senza questo prologo.
Il racconto del
seyðir che non cuoce è evidentemente un mito separato. Autore della
cucitura potrebbe essere lo stesso Þjóðólfr,
ma forse anch'egli aveva ereditato il racconto nella forma in cui lo ha
trasmesso. Non importa. Separiamo il prologo dalla vicenda principale e
analizziamolo come fosse un racconto isolato.
La situazione di base è interessante: tre dèi hanno ucciso un bue
e stanno cercando di cuocerlo. Il
seyðir è una sorta di forno campestre, allestito in una buca scavata nel
terreno; si dispone la carne tra due pietre arroventate, quindi si copre il
seyðir con del terriccio, e si attende la cottura.
Nonostante tutte queste accortezze, però, la carne rimane fredda e cruda. Il fuoco è stato privato della
sua funzione ignea. La colpevole è un'aquila appollaiata sulla vicina quercia.
Il rapace consentirà al fuoco di ardere, solo se le sarà assegnata una porzione
del bue. I tre æsir accettano l'imposizione
e a questo punto la carne comincia a sfrigolare.
Nella versione di Þjóðólfr, è proprio a
Loki che
Óðinn chiede di fare le parti.
Loki esegue. Allora l'aquila
vola giù dalla quercia e ghermisce i quattro quarti del bue, ovvero l'intero animale:
Fljótt bað foldar dróttinn
Fárbauta mǫg Várar
þekkiligr með þegnum
þrymseilar hval deila,
en af breiðu bjóði
bragðvíss at þat lagði
ósvífrandi ása
upp þjórhluti fjóra. |
Lo splendido signore della terra
pregò il figlio di Fárbauti
di dividere in fretta fra tutti
la balena dell'arco di Vǫr.
Ma dalla larga mensa,
ingegno fertile, tolse
l'avversario degli æsir,
i quattro quarti del bue. |
|
Þjóðólfr ór Hvíni: Haustlǫng [5] |
 |
|
Óðinn,
Loki e Hǿnir attendono alla cottura del
bue (✍
1760) |
|
Ms. SÁM 66. Stofnum Árna Magnússonar,
Reykjavík (Islanda). |
La situazione, nel mito vichingo, si presenta analoga a quanto
avevamo visto in Grecia a proposito del sacrificio di Mēkṓnē. C'è da suddividere
un animale abbattuto tra due fazioni. In Grecia, avevamo da una parte gli
uomini, dall'altra parte Zeús; in Scandinavia,
abbiamo da una parte gli æsir, dall'altra parte un'aquila
appollaiata su una quercia.
Forse non è inutile far notare che il secondo partito, nei due complessi mitici, si
equivale, perlomeno a livello simbolico: l'aquila e la quercia erano
rispettivamente l'uccello e l'albero sacri a Zeús.
In posizione di mediatore, abbiamo
Loki in Scandinavia e Promētheús in
Grecia: è a loro che
viene chiesto di fare le parti.
In entrambi i miti, la divisione si risolve con un inganno. In Scandinavia è l'aquila
a prendersi l'intero bue, mentre in Grecia Zeús
appare piuttosto la vittima della beffa (sebbene la sua porzione si rivelerà poi la
migliore).
Il sequestro del fuoco, in entrambi i miti, serve a impedire la cottura
del bue a chi vorrebbe cibarsene, ma le finalità sono diverse: in Grecia,
Zeús vuole punire coloro che si sono aggiudicati la
carne con l'inganno; in Scandinavia,
Þjazi impedisce l'uso del fuoco per costringerli
i tre æsir a consegnargli un quarto del bue. Il racconto
scandinavo sembra il più alterato: non ha senso che
Þjazi renda inoperante il
fuoco al fine di estorcere agli æsir la promessa di cedergli un quarto del
bue, se poi ha intenzione di prenderselo tutto.
In Grecia, d'altra parte, Zeús s'infuria per un
inganno che aveva previsto e che, in fondo, gioca a suo vantaggio. Detto questo, i due miti hanno rielaborato, ciascuno a suo modo, il medesimo
complesso di elementi.
- Abbattimento di un animale.
Sia a Loki
che Promētheús viene chiesto di fare le parti del bue
abbattuto, allo scopo di dirimere una contesa nella spartizione della carne.
- Inganno nella spartizione. Promētheús presenta
due porzioni «taroccate» in modo che Zeús scelga
quella sbagliata e tocchi agli uomini la parte commestibile.
Þjazi estorce la promessa che
gli toccherà una porzione, ma sarà lui stesso a trasgredire al patto prendendosi
tutto il bue.
- Sequestro del fuoco.
Zeús toglie agli uomini il fuoco per punirli dell'inganno e costringerli
a mangiare cruda la parte che hanno ottenut.
Þjazi rende il fuoco inoperante
per estorcere loro la promessa di cedergli una porzione.
Ma non è finita qui. La reazione di
Loki, nel mito scandinavo, è
quantomeno comprensibile, ma l'esito è singolare:
|
Þá varð Loki reiðr ok greip upp
mikla stǫng ok reiðir af ǫllu afli ok rekr á kroppinn erninum. Ǫrninn bregzk við
hǫggit ok flýgr upp. Þá var fǫst stǫngin við kropp arnarins ok hendr Loka við
annan enda. Ǫrninn flýgr hátt svá at fǿtr taka niðr grjótit ok urðir ok viðu, en
hendr hans hyggr hann at slitna munu ór ǫxlum. Hann kallar ok biðr allþarfliga ǫrninn friðar, en hann segir at Loki skal aldri lauss verða nema hann veiti
honum svardaga at koma Iðunni út of Ásgarð með epli sín, en Loki vill þat. Verðr
hann þá lauss ok ferr til lagsmanna sinna ok er eigi at sinni sǫgð fleiri
tíðindi um þeira ferð áðr þeir koma heim. |
Loki si infuriò, prese un grosso bastone e lo scagliò con tutta la sua
forza, colpendo il corpo dell'aquila. L'aquila evitò il colpo volando in alto.
Il bastone rimase però conficcato nella schiena dell'aquila e le mani di
Loki dall'altra parte del bastone. L'aquila
volò così in alto che i piedi di Loki
prendevano contro a rocce, sassi e alberi, mentre le sue braccia gli pareva che
si dovessero staccare dal tronco. Egli gridava e supplicava ripetutamente
l'aquila di lasciarlo, ma ella disse che mai avrebbe lasciato andare
Loki, se prima egli non le avesse giurato
di portare Iðunn fuori da
Ásgarðr insieme alle sue mele;
Loki acconsentì. In questo modo
egli tornò libero e andò dai suoi compagni e non ci sono altri fatti da
raccontare sul loro viaggio, prima che tornassero a casa. |
|
Snorri:
Skáldskaparmál [2] |
E nella versione di Þjóðólfr:
Þá varð fastr við fóstra
farmr Sigvinjar arma,
sás ǫll regin eygja,
ǫndurgoðs, í bǫndum;
loddi rö́ við ramman
reimuð Jǫtunheima,
en holls vinar Hǿnis
hendr við stangar enda. |
Ma rimase attaccato, il fardello
delle braccia di Sigyn, al padre
della dea degli sci (ora lo guardano
in catene, tutti i potenti).
Il bastone si appiccica al robusto
tiranno del paese dei giganti,
e in fondo alla stanga, le mani
dell'amico affettuoso di Hǿnir. |
Fló með fróðgum tívi
fangsæll of veg langan
sveita nagr, svát slitna
sundr ulfs faðir mundi;
þá varð Þórs of-rúni
(þungr vas Loptr of sprunginn)
mö́lunaut, hvat's mátti,
miðjungs friðar biðja. |
Col dio ingegnoso se ne volò via,
fiero della cattura, un lungo tratto
l'uccello di sangue, e credeva
di cadere a pezzi, il padre del lupo.
Allora fu costretto, non aveva
scelte diverse il consigliere di Þórr,
(sul punto, Loptr, di squartarsi dal
peso)
a chiedere tregua al gigante. |
|
Þjóðólfr ór Hvíni: Haustlǫng [7-8] |
 |
|
Loki colpisce Þjazi (✍
1760) |
Ólafur Brynjúlfsson
Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek, Ms. NKS 1867 4°. |
Una scena piuttosto grottesca. Loki
sospeso in cielo, le mani incollate a un bastone, il quale aderisce a sua volta
al dorso di
un'aquila. Non era assai più semplice che l'aquila lo ghermisse con i
suoi artigli e lo sollevasse in
aria, se lo scopo era quello di estorcergli la promessa di condurre
Iðunn fuori da
Ásgarðr?
Perché una soluzione tanto macchinosa? Quando, in un mito, troviamo elementi così ridondanti e mal
combinati, è segno che l'autore cerca di rimanere fedele a una materia che non comprende
del tutto. Gli
elementi di questa scena appartengono senza dubbio a un mito ancora più
antico, divenuto ormai incomprensibile sia a Þjóðólfr che a Snorri.
Un possibile suggerimento su come sciogliere l'enigma ci arriva proprio dal
Caucaso. Vi è infatti una versione alternativa della cattura di
Amirani (L22) che fa intervenire il dio Givargi,
il San Giorgio degli spazi selvaggi, di cui abbiamo accennato in precedenza. In questa
storia, piuttosto romanzata,
Amirani
tenta di
sedurre e rapire la figlioccia di
Givargi. Il nume
si reca allora da
Ḡmerṫi e gli propone
di far morire
Amirani. Il dio supremo preferisce però essere
conciliante, e intima ad
Amirani di rinunciare alla fanciulla. La risposta di
Amirani
è tracotante: «Non solo io farò a modo mio, ma se tu mi sbarri la strada, io
lotterò con te».
|
Ḡmerṫi gli disse: «Se le cose stanno
così, io ora lascerò libero un uccello, Tu siediti sul tuo tappeto volante e inseguilo.
Se lo pigli, allora sei un valoroso».
«Bene» disse
Amirani.
E si lanciò sul suo tappeto all'inseguimento dell'uccello. Ma più andavano e più
cresceva la distanza tra loro. L'uccello volava sempre più in alto e finì per
raggiungere il monte Ialbuzi [Ėl'brus].
Amirani
non abbandonò l'inseguimento e raggiunse l'uccello sullo Ialbuzi.
Mentre si preparava ad afferrarlo, si accorse che teneva tra le mani un palo, un
gran palo di ferro. Ed era incatenato a questo palo.
Amirani
si disperò, ma che fare? |
|
L22 |
Sebbene sia lontana dalle altre versioni caucasiche, questo strano
inseguimento aereo di
Amirani
ricorda in maniera
irresistibile la scena del volo di
Loki. Non deve trarci in inganno il fatto che qui l'eroe
disponga di un tappeto volante, che è una
trovata puramente accessoria di
L22. Quello che ci interessa è piuttosto il riaffacciarsi degli stessi elementi in
contesti simili, sebbene
differisca la loro funzione. Nelle due vicende, un
uccello è causa del sollevamento dell'eroe:
Loki
viene sollevato da Þjazi, trasformato in aquila, contro la sua
volontà; Amirani si ritrova a inseguire un uccello
che vola sempre più in alto, ben oltre le sue capacità di raggiungerlo. In
entrambi i casi, si presenta il superamento di un limite:
Loki
viene sollevato oltre la resistenza fisica del suo corpo, Amirani
si ritrova a inseguire un uccello più veloce di quanto lui stesso non riesca a volare.
In entrambi i casi, infine, il contatto tra il protagonista e l'uccello non è diretto, ma mediato da un bastone, da un'asta. Loki
si ritrova le mani incollate al bastone e non riesce a staccarle, mentre l'aquila lo trascina in cielo.
Nella versione caucasica,
Amirani, nel momento in cui sta per catturare
l'uccello, si ritrova una bastone tra le mani, senza che l'autore del testo
sappia dirci come e perché, e rimane incatenato ad esso. È evidente che, il materiale, è corrotto in entrambi
i racconti, ma a questo punto una cosa è chiara: il bastone
è il palo del
supplizio.
Dopo quanto abbiamo detto, è
facile pensare all'immagine di Promētheús punito da Zeús,
incatenato a una colonna, sulla cima a un'altissima montagna, con un'aquila che
scende a rodergli il fegato.
Loki non è incatenato a una
colonna, ma è avvinto a una stanga, ed anch'egli è sospeso tra il cielo e
la terra; l'aquila è anche qui uno strumento di tortura, sebbene non gli
frughi il ventre con il becco, ma è essa stessa a sollevarlo in cielo. Gli elementi
del supplizio sono gli stessi per
Loki e Promētheús,
sebbene utilizzati in maniera affatto diversa.
- Incatenamento a una colonna o a una stanga (con lacci e/o catene nel mito
greco, con un incantesimo in quello nordico).
- Sollevamento tra il cielo e la terra (letterale nel caso di
Loki, sulla cima di una montagna
per Promētheús).
- Presenza di un'aquila (la quale solleva
Loki nel mito nordico; in quello
greco si limita a torturare Promētheús
rodendogli il fegato).
In conclusione, è evidente che
Þjóðólfr ór Hvíni – o un suo antigrafo –
ha utilizzato gli elementi di un mito assai più antico, ma
tali elementi, sebbene singolarmente scombinati, appartengono al medesimo tema che in Grecia ha prodotto il
complesso mitico del sacrificio di Mēkṓnē, con relativo inganno,
sequestro del fuoco e condanna di Promētheús.
Ed è curioso
che, nel mezzo della strofa
[7], Þjóðólfr infili l'inciso, «ora lo guardano | in catene, tutti i
potenti» [sás ǫll regin eygja... í bǫndum],
associando, all'episodio di Loki
trascinato in cielo dall'aquila, il presente narrativo in cui
Loki
è stato incatenato dagli dèi. Ignoriamo quali scelte abbia effettuato Þjóðólfr nel combinare la sua materia, e forse l'inciso è solo una coincidenza
poetica. Ma secondo la nostra ipotesi, si tratta di due esiti – o due
momenti – del medesimo mito.
Al mitema del sequestro del fuoco, manca, in Scandinavia, il motivo della
riconquista dello stesso. Bisogna ammettere che non esiste un mito dove
Loki va a cercare o riprendersi il
fuoco (anche se partirà alla ricerca di
Iðunn rapita da
Þjazi: ma è difficile sostenere
la sostituzione di un tema con un altro tanto diverso). Dobbiamo
dunque rinunciare a questo motivo, presente in Grecia, ma non in Scandinavia, e
accontentarci di mettere in sequenza il resto del racconto.
|
| IN OSSEZIA. SYRDON, L'ASTUTO
Nel complicatissimo patchwork di popoli del Caucaso, un posto d'eccezione
spetta agli Osseti. Attualmente stanziati in una piccola area a cavallo sul confine tra Georgia e
Russia, essi costituiscono l'ultimo residuo di un gruppo di Alani che,
intorno al 200 d.C., si stabilirono sulle pendici settentrionali del Grande Caucaso.
Gli Osseti sono gli unici, in mezzo a tanti idiomi caucasici, a parlare
una lingua indoiranica. Le loro tradizioni leggendarie, a tutt'oggi vive e
vegete, sono incentrate su un gruppo di agguerritissimi eroi, i
Nartæ.
I racconti delle loro imprese, i
Narty kaǯǯitæ, sono divenuti così popolari,
nella Ciscaucasia, da trasbordare nei corpora mitologici dei popoli circostanti, in special modo
dei Circassi. Georges Dumézil, che ha dedicato una magistrale serie
di studi agli Osseti, ha potuto evidenziare gli schemi trifunzionali che
sottendono al loro vivido patrimonio mitologico. Pur circondati da tanti popoli
caucasici, gli Osseti sono dunque, a tutti gli effetti, un rispettabilissimo
membro della grande famiglia indoeuropea.
 |
|
Lotta dei nartæ |
Maxarbeg Safarovič Tuganov (1881-1952)
Particolare |
Tra i vari eroi nartæ – il vecchio Uryzmæg,
il radioso Soslan, il metallico
Batraʒ – spicca in particolar modo
Syrdon: una singolare figura di trickster
caratterizzata da un'astuzia contorta, non di rado maligna; un
personaggio ambivalente, ora utile ai nartæ, ora dannoso. Dumézil lo ha
ripetutamente avvicinato a
Loki, indicando le molte affinità
psicologiche e funzionali tra i due personaggi (Dumézil 1947). Saremmo
dunque giustificati se ci chiedessimo se sia possibile introdurre anche
Syrdon nel nostro gioco di relazioni tra
Loki e
Promētheús. Allo scopo, bisogna richiamare un racconto di cui Georges Dumézil ha
pubblicato ben sette varianti (quattro ossetiche, una čečena, una cabardina e
una tatara) nel suo Légendes sur les Nartes, pur senza notare le affinità
con il mito greco (Dumézil 1930).
Un giorno tutti i più famosi eroi nartæ partono per una
spedizione: vi sono tra loro Uryzmæg,
Xæmyc, Soslan,
Batraʒ e molti altri. In partenza, invitano
Syrdon affinché li diverta, con il segreto intento
di prendersi gioco di lui nel corso del viaggio. Syrdon
dapprima ricusa l'invito, non avendo un cavallo come gli altri, ma i
nartæ lo
tranquillizzano dicendo: «Non dire così,
Syrdon! I nostri cavalli non sono forse i tuoi
cavalli? Un po' sarai tu che andrai a piedi e noi a cavallo, un po' saremo noi
che andremo a cavallo e tu a piedi». Ma quando, dopo una lunga marcia, ormai
stanco, Syrdon chiede di poter salire a cavallo, i
nartæ gli fanno notare l'ingannevole formulazione della
promessa e lo esasperano con scherzi e dispetti.
Tempo dopo, catturato un cervo, i nartæ si accingono a cuocerlo, ma
d'un tratto si accorgono di non avere più i loro acciarini. Naturalmente è stato
Syrdon a farli sparire, per vendicarsi,
ma i nartæ si disperano, non sapendo come fare per accendere un fuoco. A
sera, scorgono da lontano una fiamma e spediscono
Syrdon a farsi dare delle braci. Questi,
contrariato, evita di adempiere all'incarico. I nartæ sono costretti a
recarsi uno dopo l'altro all'edificio nel quale vedono brillare il fuoco.
All'interno è in corso un banchetto di wæjug, orribili orchi o giganti, i
quali, con la scusa di offrire agli ospiti una tazza di arak caldo, li
fanno accomodare al loro tavolo. Ma sullo sgabello è stato spalmata del buræmæʒ,
una colla magica che d'incanto imprigiona tutti i nartæ.
Dopodiché, i wæjug cominciano ad affilare i loro coltellacci, decisi
a sgozzare i nartæ per il loro banchetto.
 |
|
I nartæ prigionieri
(✍
1977) |
|
Azanbek Vasil'evič Ǯanaev (1919-1989) |
Intanto, rimasto solo nell'accampamento, Syrdon
ha acceso il fuoco e cotta la selvaggina. Dopo essersi rimpinzato di
čačlyk di cervo, infila in uno spiedo i rognoni con il loro grasso e, quando
sono belli e cotti, se li appende ai baffi e si reca alla dimora dei wæjug.
Gli orchi lo fanno entrare e lo invitano alla tavolata.
Notata l'innaturale immobilità dei nartæ, Syrdon
rifiuta di accomodarsi, affermando di essere di rango inferiore, ma intanto
passa dinanzi ai suoi affamati e spaventati compagni, leccando maliziosamente i
rognoni che gli pendono dai baffi. Ottenuto infine un paiolo sfondato,
Syrdon fa scorrere via la colla buræmæʒ
prima di sedersi. A quel punto, i wæjug passano alle vie di fatto.
Afferrano Soslan per scannarlo, quando
Syrdon interviene chiedendo loro quale sia il più
nobile tra gli attrezzi del fabbro, se l'incudine, il mantice, le tenaglie o il
martello. La domanda scatena una violenta discussione tra gli orchi, i quali
cominciano a picchiarsi gli uni con gli altri, mentre
Syrdon li istiga. I wæjug si massacrano
a vicenda e in breve giacciono tutti e sette al suolo, morti.
A quel punto, Syrdon si alza dal paiolo e libera i
suoi compagni dalle panche, strappando loro via la pelle del sedere e delle
cosce.
Così conciati, i nartæ non riescono a stare a cavallo e si contorcono
in sella per il dolore, tra le pazze risate di Syrdon.
Esasperati, i nartæ agguantano Syrdon
e, piegato un altissimo albero, ve lo legano per i baffi. Poi rilasciano
l'albero e
Syrdon si ritrova appeso proprio sulla sua cima.
Abbandonato tra la terra e il cielo, Syrdon è ormai convinto della
sua prossima fine, quando vede passare un pastore con le sue bestie. Il pastore
lo vede e gli chiede cosa faccia in cima all'albero. Dopo aver nicchiato,
Syrdon gli rivela che sta contemplando il dio
supremo
Xucau trebbiare il grano, e che, da quando
lo osserva, non sente più alcuna necessità di mangiare e bere. A quel punto l'ingenuo
pastore lo implora di poter dare un'occhiata anche a lui. Libera
Syrdon, il quale lo lega al suo posto e lo
abbandona
in cima all'albero.
«I miei occhi vedono meno chiaro di prima» protesta il
pastore. Lo rassicura Syrdon: «Stai tranquillo,
caro, ancora un po' e i tuoi occhi non vedranno più niente del tutto!» E
radunata la mandria del pastore, la spinge fino al villaggio dei nartæ. I
suoi compagni, che pensavano di essersi liberato di lui, si stupiscono
grandemente di vederlo tornare, vivo e vegeto, e perdipiù con una mandria immensa.
(Dumézil 1965)
Questo racconto si presenta come un innocuo divertissment. Se è un
mito, manca del tutto l'impronta ideologica: siamo quasi nell'ambito della
fiaba, sebbene si indovinino gli elementi del mito prometeico. A un'analisi più
attenta, troviamo tutti e quattro i temi del mito esiodeo. Abbiamo della selvaggina, un cervo è stato
abbattuto, ma i nostri amici si scoprono incapaci di cuocerlo. È la stessa
situazione che avevamo trovato in Grecia, quando gli uomini sono costretti a
mangiare cruda la carne del bue sacrificato, perché Zeús
ha tolto loro il «bagliore lungisplendente del fuoco indefesso»
(Theogonía []); o in Scandinavia, dove
Óðinn,
Loki e Hǿnir
non riescono a cuocere il bue che hanno ucciso, perché l'aquila ha reso il fuoco
inoperante. Qui è Syrdon a far sparire
gli acciarini dei nartæ, ottenendo lo stesso risultato. C'è la carne, ma
non c'è il fuoco. I nartæ sono furiosi e mandano proprio lui a cercare il
fuoco: compito che Syrdon – al contrario di
Promētheús – si guarderà bene dal compiere. Manderà gli altri
al suo posto. Rimasto solo, cuocerà lui il cervo e ne mangerà i bocconi
migliori. Simpatica la scena in cui Syrdon si lega i rognoni ai baffi per
leccarli
sotto gli occhi dei suoi affamatissimi compagni, i quali non solo sono
impossibilitati a mangiare, ma stanno essi stessi per diventare cibo dei wæjug.
Vi riconosciamo l'astuzia trionfante di
Promētheús che lascia Zeús
a bocca asciutta davanti alle ossa che gli ha imbandito. L'intervento di Syrdon
che, grazie alla sua astuzia, salva i suoi compagni dall'essere uccisi dai wæjug,
può essere messo in relazione con il contributo, tutto giocato sul piano della
mtis, che
Promētheús offre agli dèi permettendo loro di vincere la guerra
contro i titânes.
Vi sono dunque molti scambi di ruolo, tra il mito ossetico, scandinavo e greco,
per quanto il tema sia rimasto identico. Il racconto ossetico è l'unico in cui
è il trickster a compiere tutte le azioni: sequestra il fuoco, medita
l'inganno, e fa le parti del cervo a suo favore. Ma se l'inganno di
Syrdon è decretato dal successo, non così in Grecia
quello di
Promētheús, che si risolve in un clamoroso autogol. In Scandinavia, per
uno strano scambio, la parte dell'ingannatore passa a
Þjazi e
Loki si comporta con inaspettata onestà; quando gli viene chiesto
di fare le parti del bue, lo taglia in parti uguali.
| |
GRECIA |
SCANDINAVIA |
OSSEZIA |
| Sequestra il fuoco |
Zeús |
Þjazi |
Syrdon |
| Medita l'inganno |
Promētheús |
Þjazi |
Syrdon |
| Fa le porzioni |
Promētheús |
Loki |
Syrdon |
| Ottiene la porzione migliore |
Zeús |
Þjazi |
Syrdon |
Tutto l'episodio dei nartæ sequestrati dai wæjug sembra un
tema intrusivo nel corpo del mito che stiamo analizzando. Il tema dei
deretani incollati alle sedie, malamente strappati al momento della
liberazione, ha un'eco nel racconto greco di Thēseús
e Peiríthoos, i quali, nel corso del loro
viaggio ipoctonio, vengono fatti accomodare su due speciali sedie in grado
di trasformarsi in carne della carne dei malcapitati.
Hērakls libera in seguito Thēseús con
uno strappo lacerante, ma Peiríthoos rimane nel
Tártaros. È significativo
che, alla fine del racconto ossetico, Syrdon venga
incatenato alla cima d'un albero e abbandonato dai suoi compagni. Più che il
mito di Promētheús,
la punizione ricorda alcune varianti georgiane, dove
Amirani viene incatenato al bastone piantato in terra dal dio supremo Ḡmerṫi,
bastone che in alcune versioni è indistinguibile da un albero:
|
Allora Ḡmerṫi prese il
bastone, lo piantò e gli ordinò di crescere in modo che le radici fossero
abbastanza lunghe da cingere, a guisa di cintura, la terra intera e la sua cima
raggiungesse il cielo. E quindi ordinò ad Amirani di strapparlo [dal suolo].
Amirani afferrò il bastone ma invano: poté
solamente scuoterlo.
Allora Ḡmerṫi maledisse
Amirani e lo incatenò a questo albero. |
|
L1 |
Il bastone/albero potrebbe anche ricordare il legno a cui
Loki si trova appeso, sebbene nel racconto ossetico manchi l'aquila. Il
trucco con cui Syrdon riesce a trarsi d'impaccio –
come Tom Sawyer davanti alla staccionata – sembra essere un'innovazione arguta
del racconto ossetico. |
DI NUOVO IN
SCANDINAVIA. IL DESTINO DI LOKI
Se prima abbiamo introdotto il perfido
Loki, è perché condivide il comune destino di tutti i prometei: venire
incatenato ai confini del mondo. È a quest'immagine che accenna, in un inciso
gocciolato in punta di penna,
lo scaldo
Þjóðólfr ór Hvíni. Si tratta di un mito importante, per la
nostra definizione di
Loki, e difficilmente dissociabile dal complesso ideologico che sottende
l'intera mitologia nordica.
Sarà però necessario non limitarci alla descrizione della macchina di
tortura che gli
Æsir impongono a
Loki, ma andare a localizzare le ragioni della punizione, che hanno la loro
causa nell'uccisione del figlio di
Óðinn. Secondo il mito narrato da
Snorri, dal luminoso
Baldr, signore della giustizia e
della pace, sembra dipendesse la stabilità etica dell'universo. Gli
Æsir prendono quindi tutte le possibili precauzioni per impedirne la
morte, e impongono un giuramento a tutte le creature dell'universo, compresi armi, oggetti e
piante, affinché promettano di non arrecare alcun danno al figlio di
Óðinn. Com'è ovvio,
Loki non resiste alla tentazione di raggirare un così ben congegnato
sistema di difesa. Scopre che una pianticella di vischio non aveva prestato
giuramento e la mette in mano a Hǫðr,
il fratello cieco di Baldr,
indicandogli la direzione in cui lanciarla.
Hǫðr esegue e
Baldr cade ucciso.
(Gylfaginning [49-50])
Il mito della morte di Baldr è
talmente complesso, in tutti i suoi addentellati, che
richiederebbe uno studio a parte: su di esso sono stati versati i proverbiali
fiumi di inchiostro. Ma limitiamoci a tenere il nostro sguardo puntato su
Loki. Mentre Baldr
scende nel regno dei morti e gli
Æsir si accingono a tributargli grandioso funerale vichingo,
Loki comincia a realizzare le ovvie conseguenze del suo delitto, e si rende
conto che
questa volta gli
Æsir non gliela faranno passare liscia. Ma diamo la parola a Snorri:
|
Goldit var honum þetta svá at hann mun lengi kennask. Þá er guðin váru orðin
honum svá reið sem ván var, hljóp hann á braut ok fal sik í fjalli nǫkkvoru,
gerði þar hús ok fjórar dyrr at hann mátti sjá ór húsinu í allar áttir. En opt
um daga brá hann sér í lax líki, ok falsk þá þar sem heitir Fránangrsfors. Þá
hugsaði hann fyrir sér hverja væl æsir mundu til finna at taka hann í forsinum.
En er hann sat í húsinu, tók hann língarn ok reið á ræxna, svá sem net er síðan,
en eldr brann fyrir honum. |
[Loki] fu punito per questi
misfatti in modo che se ne ricorderà a lungo. Quando gli dèi divennero furibondi
con lui, come ci si aspettava, egli fuggì lontano e si nascose su un monte e vi
costruì una casa con quattro porte, in modo da poter guardare fuori in tutte le
direzioni. Spesso, durante il giorno, egli si tramutava in salmone e si
nascondeva nelle cascate dette di Fránangr. Là pensava a come gli
Æsir avrebbero potuto
catturarlo nelle cascate. Un giorno, mentre sedeva in casa, prese un filo di
lino e lo intrecciò ottenendone un tessuto a maglie, così come da allora in poi
si fanno le reti, mentre un fuoco ardeva davanti a lui. |
|
Snorri:
Gylfaginning
[50] |
Anche l'abxaso Abrysk’yl aveva
disposto le sue dimore – una sulla cima del monte Ercax°, l'altra sulla costa
del Mar Nero – in modo da poter scorgere in tempo l'arrivo dei nemici, sia
che giungessero
dal mare, sia dai monti, e perciò gli aṗeambarc°a non riuscivano mai a
sorprenderlo e catturarlo. Ogni volta che si avvicinavano,
Abrysk’yl fuggiva in groppa al suo cavallo alato
Araš’, oppure usava la sua lunghissima pertica per passare con un balzo
vertiginoso dall'una all'altra dimora.
|
Þá sá
hann at æsir áttu skamt til hans, ok hafði Óðinn sét ór Hliðskjálfinni hvar hann
var. Hann hljóp þegar upp ok út í ána ok kastaði netinu fram á eldinn. |
[Loki] si accorse a un tratto che gli
Æsir gli erano vicini e che
Óðinn aveva visto dal
[trono]
Hliðskjálf ove egli si trovasse.
Immediatamente si alzò e fuggì fino al fiume, gettando la rete nel fuoco. |
|
En er
æsir koma til hússins þá gekk sá fyrst inn er allra var vitrastr, er Kvasir
heitir, ok er hann sá á eldinum fǫlskann er netit hafði brunnit, þá skilði hann
at þat mundi væl vera til at taka fiska, ok sagði ásunum. Því næst tóku þeir ok
gerðu sér net eptir því sem þeir sá á fǫlska at Loki hafði gert. Ok er búit var
netit, þá fara æsir til árinnar ok kasta neti í forsinn. |
Quando
gli
Æsir giunsero alla casa, vi entrò per primo colui che era il più saggio, che
si chiama Kvasir, il quale, quando vide vicino al fuoco la cenere bianca dov'era
bruciata la rete, comprese che quella poteva essere usata per prendere i pesci e
lo disse agli
Æsir. [Questi] si misero subito al lavoro e fecero una rete come quella che
avevano visto nelle ceneri bianche, che aveva fatto
Loki. Quando fu pronta, gli
Æsir si recarono al fiume e
lanciarono la rete nelle cascate. |
|
Snorri:
Gylfaginning
[50] |
Nel mito abxaso, gli aṗeambarc°a, incapaci di catturare
Abrysk’yl, si rivolgono a una strega, che provvede a
far scivolare il cavallo su una pelle spalmata di grasso o a sabotare la pertica in modo che si
spezzi a metà di un balzo, accorgimenti che permetteranno agli aṗeambarc°a
di mettere le mani sull'eroe ribelle. Nel mito
scandinavo, gli
Æsir usufruiscono di un aiuto
analogo da parte del saggio Kvasir, il quale
ricostruisce il ragionamento di
Loki e reinventa la rete con la
quale sarà possibile catturare il malvagio bǫlsmiðr.
La battuta di pesca è coronata dal successo. Nonostante
Loki, tramutato in salmone, cerchi
di insinuarsi sotto la rete o di balzarvi al di sopra, alla fine viene
catturato. È il dio-tuono Þórr ad
acchiapparlo per la coda. A questo punto, scatta la punizione degli dèi.
| Nú var
Loki tekinn griðalauss ok farit með hann í helli nǫkkvorn. Þá tóku þeir þrjár
hellur ok settu á egg ok lustu rauf á hellunni hverri. Þá váru teknir synir Loka,
Váli ok Nari eða Narfi. Brugðu æsir Vála í vargslíki ok reif hann í sundr Narfa,
bróður sinn. Þá tóku æsir þarma hans ok bundu Loka með yfir þá þrjá eggsteina,
einn undir herðum, annarr undir lendum, þriði undir knésfótum, ok urðu þau bǫnd
at járni. Þá tók Skaði eitrorm ok festi upp yfir hann svá at eitrit skyldi
drjúpa ór orminum í andlit honum. En Sigyn kona hans stendr hjá honum ok heldr
mundlaugu undir eitrdropa, en þá er full er munnlaugin, þá gengr hon ok slær út
eitrinu, en meðan drýpr eitrit í andlit honum. Þá kippisk hann svá hart við at
jǫrð ǫll skelfr. Þat kallið þér landskjálpta. Þar liggr hann í bǫndum til
ragnarøkrs. |
Loki fu dunque imprigionato senza scampo e
portato dentro una caverna. Qui gli
Æsir presero tre lastre di pietra, le appoggiarono su un lato e fecero
un foro su ciascuna. Furono quindi presi i figli di
Loki,
Váli e
Nari o
Narfi.
Gli Æsir tramutarono in lupo
Váli, il quale straziò immediatamente
Narfi, suo
fratello. Ne presero dunque le budella e le usarono per legare
Loki sulle tre
lastre: una gli sta sotto le sue spalle, la seconda sotto i reni e la terza
sotto le caviglie e quelle corde divennero di ferro.
Skaði, poi, prese un
serpente velenoso e lo fissò sopra di lui, in modo che il veleno uscisse dal
serpente e cadesse sul suo volto, ma Sigyn, moglie di
Loki, gli sta vicino e
tiene una conca sotto la pioggia velenosa. Quando la conca è piena, ella si alza
per vuotarla, ma nel frattempo il veleno cade sulla faccia di
Loki, il quale si
agita così violentemente che la terra tutta trema. Voi chiamate questi
terremoti. Laggiù Loki resterà legato fino al
ragnarøkr.
|
|
Snorri:
Gylfaginning
[50] |
 |
|
Loki incatenato (✍±1890) |
|
James Doyle Penrose (1862-1932) |
La prima domanda che sorge è che rapporto potrebbe esserci tra questo mito e
quello citato in precedenza, dove
Loki rimane incollato all'asta
trascinata in cielo dall'aquila. Partiamo dal presupposto che quest'ultimo
racconto sia una variante del tema prometeico. È
abbastanza curioso, in tal caso, che l'alternanza delle due modalità di
incatenamento (alle rocce o a un palo), già individuata tanto nel mito georgiano
di Amirani quanto in quello greco di
Promētheús, sia presente anche in Scandinavia.
Inoltre, il mito scandinavo realizza entrambe le possibili
locazioni della tortura: la prima, dove Loki
è sospeso in cielo, attaccato a un'aquila; la seconda, dov'è sprofondato in una
buia caverna. Anche questa alternanza è ben presente nel Caucaso, tra le varie
versioni del mito amiranico; la Grecia – come abbiamo visto – realizza
unicamente la prima modalità, lasciando che la seconda riaffiori in forma di
minaccia, proferita da Herms.
Nel mito nordico, invece, le due varianti non sono presentati come versioni
alternative di uno stesso racconto, ma come due episodi distinti e separati.
La duplicazione del mito potrebbe essere stata resa possibile dal fatto che l'episodio di
Loki trascinato in cielo
dall'aquila aveva ormai perduto completamente ogni rapporto con il tema
prometeico, divenuto di fatto irriconoscibile. Dare un'interpretazione a queste
difformità è però piuttosto difficile: per ora accontentiamoci di rilevare gli
schemi. Il nostro viaggio riserverà ancora molte sorprese. |
| TRA L'AQUILA
E IL SERPENTE Un particolare fondamentale del mito prometeico, pressoché in ogni esito che ci
sia pervenuto, è la regolare comparsa di un animale che diviene parte integrante
della macchina di tortura del protagonista. La sua natura è differente nelle
varie versioni: può essere un'aquila, un avvoltoio, un cane, un cavallo, un
serpente. Dettaglio ancora più sfuggente, le varie versioni del mito sembrano in
disaccordo sulla natura negativa o positiva dell'animale. A volte è un inviato
del dio supremo e infierisce sul prigioniero torturandolo ancora di più; altre
volte, è un fedele compagno dell'eroe, di cui divide la prigionia, e tenta di
farlo fuggire rosicchiandogli le catene.
È possibile intravedere una correlazione tra gli esiti così divergenti di
questo tema? Crediamo di sì. Ma prima, un rapido excursus sulla natura e
l'inclinazione di questi «compagni animali» del nostro prometeo incatenato.
Nella versione ellenica del mito, la più popolare, ultimo e più crudele elemento della tremenda tortura messa in
essere da
Zeús ai danni di Promētheús,
è un'aquila [aetós kaukasíos] che ogni giorno
cala sul disgraziato per frugargli nel ventre con il becco. Il tremendo rapace è presente già
nella versione più antica:
...kaí hoi ep' aietòn rse tanýpteron; autar hó g' hpar
ḗsthien athánaton, tò d' aéxeto îson hapántē
nyktós, hóson própan
mar édoi tanysípteros órnis. |
...e sopra [Zeús] gli
avventò un'aquila dalle ampie ali, che gli sbranava
il fegato immortale, ma questo ricresceva
la notte, quanto il giorno ne aveva sbranato l'uccello dalle ampie ali. |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-] |
La tortura dell'aquila diviene
ancor più cruenta nelle parole che Aischýlos mette in bocca ad
Herms:
Diòs dé soi
ptēnòs kýōn, daphoinòs aietós, lábrōs
diartamḗsei sṓmatos méga rhákos,
áklētos hérpōn daitaleùs panḗmeros,
kelainóbrōton d' hpar ekthoinḗsetai.
toioûde móchthou térma mḗ ti prosdóka... |
Herms: «[...] Il cane di Zeús, il cane
alato,
l'aquila fulva come il sangue, avida,
straccerà il grande straccio del tuo corpo;
verrà senza richiamo, silenziosa,
a dilaniarti tutto il lungo giorno,
a cibarsi del tuo fegato nero,
e questa pena non avrà mai fine...» |
|
Aischýlos:
Promētheús
desmṓtēs [-] |
L'immortalità di Promētheús è la ragione
principale
della sua sofferenza. Ogni giorno l'aquila gli cava con il becco brandelli di
fegato dal ventre; ogni notte, il corpo immortale del titán rigenera la
parte divorata. Instancabile, e altrettanto immortale, l'aquila torna ogni
giorno per ripetere la sua eterna tortura.
 |
|
Promētheús
(✍
1610) |
Peter Paul Rubens (1577-1640)
Philadelphia Museum of Art |
Riguardo a quest'aquila, i mitografi si sono sbizzarriti. Secondo
Apollódōros, il rapace era figlio di Typhn
ed
Échidna (Bibliothḗkē
[II: 10]): dunque rampollo di una delle più tremende progenie di
mostri della mitologia greca. Typhn, mostro
ctonio dalle cento teste di serpente, e la «lacrimosa»
Échidna, metà donna e metà
serpente, erano infatti genitori di
Órthros, Kérberos,
della
Lernaía Hýdra, della
Chímaira e, sembra, anche del serpente Ládōn. Non si trattava dunque di un essere appartenente alla
classe degli uccelli: e del
resto lo avevamo visto scuotere l'intera nave Argṓ
con il battito delle sue poderose ali, le cui penne erano ampie come remi
(Tá Argonautiká [II: -]).
Riguardo alla paternità di questo uccello, Hyginus riporta tre tradizioni
diverse: secondo
alcuni, l'aquila era figlia di Typhn ed
Échidna, secondo altri di Tártaros e
G,
ma secondo i più, dice Hyginus, si trattava di una creatura
artificiale: era stata infatti fabbricata da
Hḗphaistos e
Zeús le aveva dato la vita al
preciso
scopo di torturare Promētheús (De Astronomia [II:
15: ]). Sempre Hyginus fornisce
altrove il presunto nome dell'aquila: Æton, la «fulva», in realtà una trasparente latinizzazione del greco aetós «aquila», e afferma divorasse
il cuore – e non il fegato – di Promētheús
(Fabulae [31]).
Che nel mito greco l'animale torturatore assuma l'aspetto di
un'aquila è una scelta quasi ovvia, visto che l'aquila era l'animale sacro a
Zeús. Questi rapaci fungevano da ausiliari del re
degli dèi e da esecutori della sua volontà. Nel mito di
Promētheús,
l'aquila diviene una proiezione dello stesso Zeús,
o comunque del suo spirito di giustizia o di vendetta.
Se
Aischýlos definisce l'aquila
prometeica come «cane alato» [ptēnós kuón] di
Zeús (Promētheús
desmṓtēs []), stupisce ancor più il fatto che l'animale più
rappresentativo, al fianco del prometeo caucasico, sia proprio un cane dotato di
ali. Nelle versioni georgiane, esso ha un nome: Q‘urša
(da q‘ur-šav «orecchio nero»). Una tradizione svanete, raccolta
nel 1887, lo definisce figlio di un'aquila. Infatti, spiegano i montanari della
Svanezia, capita a volte che nei nidi
d'aquila, tra tanti aquilotti, si trovi un cucciolo: allora l'aquila lo
afferra tra gli artigli e, dopo averlo sollevato a un'altezza vertiginosa, lo
lascia cadere tra le rocce. Il nostro Q‘urša aveva avuto
però la ventura di salvarsi ed era divenuto lo straordinario, fedele cane da
caccia di Amirani (L2).
Perciò lo troviamo accanto al suo padrone incatenato:
|
|
Dio incatenò Amirani a un palo e lo ricoprì con una
montagna immensa. Da allora, il cagnolino di Amirani
lecca incessantemente per dodici mesi la catena che lega
Amirani. |
|
L4 |
 |
|
Nascita di
Q‘urša (✍
2010?) |
|
Unita Nightroud, illustrazione. |
Il cane tenta di liberare Amirani e, leccando la
catena, ne assottiglia gradatamente le maglie. Ma poi, il giovedì santo, i
fabbri entrano nelle loro fucine, battono sulle loro incudini e d'incanto la
catena riprende la sua saldezza. Così il cane ricomincia il suo paziente lavoro
fino all'anno successivo.
Pur avendo aspetto canino, Q‘urša è un essere celeste, e conserva la natura e le ali dei suoi genitori. Di
«cani celesti» abbonda del resto la mitologia georgiana. Presso i Xevsuri, nella
Georgia orientale, gli xat‘ebi hanno al loro seguito delle mute di
cani soprannaturali, i Mc‘evar, che accompagnano le divinità nelle loro spedizioni e fungono da esecutori della loro
volontà. Essi sono immaginati come giganteschi cani multicolori – bianco, rosso,
azzurro – con gli artigli costantemente grondanti di sangue, il collo cinto da
catene d'oro. In ogni santuario ve ne sono due e le divinità xevsurete li
inviano per combattere invisibili al fianco dei guerrieri in difficoltà, oppure
li scagliano contro gli uomini colpevoli di delitti o di empietà.
Sempre presso
i Xevsuri, il dio supremo Morige Ḡmerṫi invia lupi
contro gli esseri umani per riscuotere tributi o per eseguire punizioni o
condanne a morte. (Bardavelidze 1957). «Che Dio ti
aizzi i suoi cani» era un'abituale formula di maledizione presso svaneti e
xevsuri. Gli Svaneti si riferiscono ai lupi come ai «cani di
Givargi» [Ǯgǝrǣgi žeḡær]
(Tuite 2000).
|
|
Segugi dagli unghioni insanguinati e dal collare d'oro, sguinzagliati da dio,
investiti della grazia di dio!
Se appaiono i lupi di dio, sguinzagliati da dio per riscuotere tributo o tassa
dagli uomini, non lasciateli venire fino alle case di chi prega; se si deve,
fate in modo che prendano un tributo lecito e indicate loro altre case, altre
strade! |
|
Materiale etnologico georgiano |
I cani caucasici hanno dunque la stessa funzione dell'aquila ellenica:
fungono da esecutori della volontà divina. Ma le due zoofanie, il cane nel
Caucaso e l'aquila in Grecia, non solo si corrispondono perfettamente, nella
loro funzione, ma presentano ciascuno dei tratti dell'altro:
Q‘urša è un cane alato figlio di aquile, così come
l'Aetós Kaukasíos è, almeno in chiave metaforica,
il «cane alato» [ptēnòs kýōn] di Zeús. Queste note non spiegano
tuttavia perché il cane Q‘urša, nel mito amiranico,
appaia piuttosto in conflitto con la volontà divina, tentando di liberare il suo
padrone.
Anche nel mondo scandinavo, il dio
Óðinn è spesso accompagnato da due lupi, Freki
e Geri, la cui funzione non sembra differente da
quella dei cani soprannaturali che scortano gli dèi caucasici. Ma tra Caucaso e
Scandinavia sembra esserci più di un collegamento: se nella prigione dove giace,
incatenato, Loki, non compaiono
cani, non dimentichiamo che il suo feroce figlio-lupo,
Fenrir, è destinato a condividere
il medesimo fato, sebbene non accanto al proprio padre. Quasi un prometeo in
forma lupesca, Fenrir è destinato
a venire legato con un laccio magico in un isolotto ai confini del mondo, e lì
rimarrà fino al tempo escatologico
(Gylfaginning
[34]). Egli si libererà infatti insieme a Loki, nel giorno di
Ragnarǫk, e avanzerà
al suo fianco per l'ultima battaglia
(Vǫluspá [51]). Riuscirà a uccidere
Óðinn, ma verrà eliminato dal dio
Víðarr prima che riesca a
divorare il cielo e la terra (Vǫluspá [53 | 55] |
Gylfaginning [34]).
Ora, sebbene appaia assai diverso dal fedele e docile
Q‘urša,
Fenrir sembra appartenere a un medesimo mitema. Entrambi i canidi sono
fedeli al prometeo incatenato (che è il padrone del segugio nel mito caucasico, ma padre
del lupo in quello scandinavo), con il quale condividono il destino di rimanere
imprigionati fino alla fine del mondo. Il ruolo apocalittico di
Fenrir è più esplicitamente definito di quello di
Q‘urša, il quale appare soltanto nella scena della
prigionia, al fianco del padrone, e tace su un suo eventuale ruolo futuro,
allorché Amirani si libererà e porterà il mondo
alla distruzione. È però evidente che
Q‘urša, nel suo continuo tentativo di liberare il
padrone, lavora affinché si affretti la catastrofe finale.
In abxasia, Abrysk’yl ha accanto a sé il suo
cavallo, Araš’. Seppure incavezzato a un proprio
palo, il fedele destriero è anch'esso intento a rosicchiare le catene del suo
padrone, con le stesse modalità del cane georgiano. La sostituzione di un cane
con un cavallo appare del tutto accessoria, tantopiù che di
Q‘urša l'equino ha ereditato addirittura un bel
paio d'ali. Inoltre, il motivo del cavallo ha un'origine ben chiara:
Araš’ altro non è che una versione locale del
mitico Raxš, il destriero dell'eroe persiano
Rustem, la cui popolarità è sconfinata ben oltre i
confini dell'Īrān.
Immagini di aquile o avvoltoi compaiono invece tra i Circassi o altri popoli
caucasici nord-orientali, dove il modello, come abbiamo visto, si avvicina in
maniera sospetta, a quello ellenico. Nella versione cabardina, il rapace non ha
soltanto il compito di martoriare il corpo del prometeo, ma anche quello di
precederlo alla sorgente, impedendogli di bere.
|
Per aumentare la punizione, Tė gli ha inviato un
uccello da preda: ogni giorno un avvoltoio vola sul gigante e gli scava
spietatamente il cuore. Quando poi il martoriato si curva per bere, l'avvoltoio
lo precede e beve fino all'ultima goccia l'acqua che ha il meraviglioso potere
di rendere immortale chi la gusta. |
|
Versione cabardina |
Nella lontana Scandinavia, invece, l'aquila è una figura che si alterna a quella del
serpente. Loki
viene infatti trascinato in cielo da un'aquila nel racconto «alterato» riportato
tanto da
Þjóðólfr ór Hvíni quanto da Snorri Sturluson. Nel racconto «canonico»
dell'incatenamento, invece, è un serpente a costituire l'elemento animale della
tortura:
| Þá tók Skaði eitrorm ok festi upp yfir hann svá at eitrit skyldi
drjúpa ór orminum í andlit honum. En Sigyn kona hans stendr hjá honum ok heldr
mundlaugu undir eitrdropa, en þá er full er munnlaugin, þá gengr hon ok slær út
eitrinu, en meðan drýpr eitrit í andlit honum. Þá kippisk hann svá hart við at
jǫrð ǫll skelfr. Þat kallið þér landskjálpta. |
Skaði, poi, prese un
serpente velenoso e lo fissò sopra di lui, in modo che il veleno uscisse dal
serpente e cadesse sul suo volto, ma Sigyn, moglie di
Loki, gli sta vicino e
tiene una conca sotto la pioggia velenosa. Quando la conca è piena, ella si alza
per vuotarla, ma nel frattempo il veleno cade sulla faccia di
Loki, il quale si agita così
violentemente che la terra tutta trema. Voi chiamate questi terremoti. |
|
Snorri:
Gylfaginning
[50] |
Tutti questi mitemi hanno in comune l'elemento della periodicità. Ogni giorno
l'aquila strappa brandelli di fegato dal petto di Promētheús,
ma di notte questo ricresce nel ventre del titán, pronto a essere
divorato il giorno successivo; il cane lecca le catene di
Amirani assottigliandone gli anelli ma, dopo un anno, il rumore delle
incudini percosse dai fabbri le fa tornare di nuovo integre; il veleno che il
serpente spunta sul volto di
Loki viene raccolto in una conca
dalla pietosa Sigyn, ma quando la donna va a
vuotare il recipiente, il veleno arriva agli occhi del condannato, che si
contorce in preda alla sofferenza, provocando terremoti.
Questa tortura procede, in questi tre esiti, in tre modi diversi, ma tutti e
tre presentano ciclicità. Ripetizione del dolore in Grecia, delusione nelle
proprie speranze in Georgia, interruzione della protezione in Scandinavia.
Ma analizziamo più da vicino la natura degli animali coinvolti nella tortura.
Abbiamo già vista che il cane è una variante dell'aquila, ed entrambi si muovono
in un medesimo ordine di idee: essi simboleggiano, in Grecia e nel Caucaso, la
volontà divina. Possiamo quindi stabilire l'equazione cane = aquila. Non si può dire certamente la stessa cosa del serpente in Scandinavia. Quest'ultimo animale è, anzi, una creatura ctonia, eversiva,
malefica; l'immenso serpente
Jǫmungandr destinato a combattere contro Þórr
è un'emanazione maligna dello stesso
Loki. L'alternanza aquila ⇆
serpente dovrà essere analizzata su un diverso ordine di idee.
Notiamo innanzitutto che, nel mito scandinavo, un serpente e un aquila sono collocati agli estremi
dell'asse del mondo, simboleggiato dal frassino
Yggdrasill. Nella cosmologia
vichinga, si ricorderà, impalcatura dell'universo è il frassino cosmico, le cui
radici arrivano in tutti i mondi; l'arbor mundi è peraltro abitato da un
certo numero di animali, tra cui spiccano il serpente
Níðhǫggr, che ne rode
incessantemente le radici, e un'aquila senza nome, che si trova appollaiata tra
i suoi rami (e che ha il falco
Veðrfǫlnir acquattato
tra i suoi occhi).
|
Ǫrn einn sitr í limum
asksins, ok er hann margs vitandi,
en í milli augna honum sitr haukr
sá er heitir Veðrfǫlnir. Íkorni sá
er heitir Ratatoskr renn upp ok
niðr eptir askinum, ok berr
ǫfundarorð milli arnarins ok Níðhǫggs. En fjórir hirtir renna í
limum asksins ok bíta barr, þeir
heita svá: Dáinn, Dvalinn, Duneyrr,
Duraþrór. En svá margir ormar eru í Hvergelmi með Níðhǫgg at engi
tunga má telja. |
Un'aquila siede sui rami del frassino; essa conosce molte cose e in mezzo ai
suoi occhi sta quel falco che si chiama
Veðrfǫlnir. Lo scoiattolo che si
chiama
Ratatoskr corre su e giù per il
frassino e riporta le calunnie fra l'aquila e
Níðhǫggr, mentre quattro cervi corrono per i rami del frassino e brucano le
foglie. Essi si chiamano
Dáinn,
Dvalinn,
Duneyrr,
Duraþrór. Ci sono
poi così tanti serpenti dentro a
Hvergelmir insieme a
Níðhǫggr, che nessuna lingua può
contarli. |
|
Snorri:
Gylfaginning
[50] |
Questi animali sono dannosi al grande albero, come ci informa un
poema eddico citato dallo stesso Snorri:
Askr Yggdrasils
drýgir erfiði
meira enn menn viti:
hjǫrtr bitr ofan,
en á hliðo fúnar,
skerðer Níðhǫggr neðan. |
Il frassino
Yggdrasill
sopporta pene
più grandi di quanto gli uomini
sappiano:
il cervo lo bruca in alto,
da un parte marcisce
lo rode
Níðhǫggr da sotto. |
|
Ljóða Edda >
Grímnismál [35] |
In Īrān, la medesima nozione viene ripartita tra due mitici alberi: (1) l'albero
Vanąm yąm Saēnahe, che cresce al centro del lago cosmico
Vourukaa, è considerato «l'albero di tutti i
semi»; sui suoi rami fa il nido il mitico uccello Saēna
(avestico mǝrǝγō Saēnō, pahlavico Sēn Murw, persiano
Sīmurġ) (Yašt [XII, 14 | XIV, 41]); e
(2) l'albero Gaokǝrǝna- (pahlavico Gōkarn), che produce l'haoma,
l'elisir d'immortalità: in questo caso sono una rana, o una lucertola, a tentare
di danneggiare l'albero, ma il pesce Kara vi gira
attorno per difenderlo dai suoi nemici (Bundahišn
[18, -] | Vendīdād [19, ]).
Ma il mitema è già presente in Mesopotamia in epoca antichissima. Nel poema
sumerico conosciuto dagli studiosi con il titolo informale di Inanna,
Gilgameš e gli inferi, ma probabilmente intitolato, dal suo incipit,
Ud re-a ud su₃-ra₂ re-a, «In quei
giorni, in quei giorni lontani», la giovane dea Inanna pianta nel suo giardino,
a Uruk, l'albero Ḫuluppu (sumerico ḫa-lu-ub₂),
che il vento aveva strappato dalla riva dell'Eufrate e gettato nel fiume. Questo
attecchisce e cresce, ma tre creature soprannaturali lo infestano: un serpente tra le radici, un'aquila tra le fronde e un essere non ben identificato (forse un
gufo, o la demoniessa Līlītu) nel suo tronco:
mu 5-am₃ ⸢mu⸣
[10-am₃ ba-e-zal-la-ri]
iš ba-gur₄ kuš-bi nu-mu-un-da-dar
ur₂-bi-a muš tu₆ nu-zu-e gud₃ im-ma-ni-ib-us₂
pa-bi-a mušen anzud-de₃ amar im-ma-ni-ib-ar
šab-bi-a ki-sikil lil₂-la₂-ke₄ e₂ im-ma-ni-ib-du₃
ki-sikil zu₂ li₉-li₉ šag₄ ḫul₂-ḫul₂
kug inana-ke₄ er₂ e-ne ba-še₈-še₈ |
Dopo che cinque anni, dopo che dieci anni furono
passati,
l'albero crebbe imponente, ma il suo tronco non aveva foglie.
Nelle sue radici un serpente che non teme magia, vi aveva fatto il nido;
nei suoi rami l'aquila Anzud vi aveva deposto i
suoi piccoli;
nel suo tronco Ki-sikil-lil-la-ke vi aveva
costruito la sua casa;
la vergine [altrimenti] allegra e con il cuore gioioso
la pura Inanna cominciò a piangere. |
|
Ud re-a ud su₃-ra₂
re-a
[-] |
Questo mitema sembra universale. Ad esempio, nella
leggenda azteca, i Mexica, obbedendo al dio
Huītzilopōchtli, fondano la futura capitale del loro regno, Tenōchtitlān (attuale Ciudad de México), nel luogo dove
scorgono un'aquila
divorare un serpente sopra un cactus nopal. Il mito è tuttora celebrato
nello stemma della bandiera messicana.
L'aquila e il serpente sembrano dunque simboli collegati all'arbor mundi,
all'asse terrestre, alla colonna che unisce il cielo e la terra. Come abbiamo visto, il materiale caucasico è molto
eterogeneo, ma vi sono versioni dove il palo di Amirani
assume connotazioni cosmologiche:
Allora Ḡmerṫi prese il
bastone, lo piantò e gli ordinò di crescere in modo che le radici fossero
abbastanza lunghe da cingere, a guisa di cintura, la terra intera e la sua cima
raggiungesse il cielo. E quindi ordinò ad Amirani di strapparlo [dal suolo].
Amirani afferrò il bastone ma invano: poté
solamente scuoterlo.
Allora Ḡmerṫi maledisse
Amirani e lo incatenò a questo albero. |
|
L1 |
Un albero la cui cima raggiunge il cielo e le cui radici cingono la terra.
Sembra una descrizione del frassino
Yggdrasill. Secondo la
tradizione georgiana, ancora oggi viva e vegeta, sono proprio a causa degli
sforzi con cui
Amirani cerca di sradicare il palo che lo trattiene
prigioniero, che si producono i terremoti che investono la terra. Questa è
un'indicazione molto preziosa della natura cosmologica del palo, o dell'albero,
a cui l'eroe è incatenato. La medesima nozione è presente in Scandinavia, dove i
terremoti sono prodotti dal contorcersi di
Loki, allorché il veleno del
serpente gli arriva in volto
(Gylfaginning
[50]).
Alcuni
studiosi hanno tentato, effettivamente, di ricondurre a questo mitema la
colonna a cui Promētheús fu incatenato, almeno
nella versione esiodea. Al riguardo, però, non era stato possibile portare
alcuna prova, tantopiù che nelle figurazioni greche la colonna risulta spezzata
a metà e piuttosto bassa. In realtà, nel mito greco, il destino di fungere da
asse cosmico, tocca non
tanto a Promētheús, quanto a suo fratello Átlas.
Già
Hómēros ce lo presenta a sorreggere le
colonne che tengono la terra separata dal cielo:
|
|
...Átlas, dal cuore perverso, il quale del mare
tutti conosce gli abissi, regge le grandi colonne,
che terra e cielo sostengono da una parte e dall'altra... |
|
Hómēros: Odýsseia
[I: 52-54] |
Stando a
Hómēros, Átlas
sembra emergere da qualche abisso marino: non è ben chiaro
dove sia collocato. Un po' più preciso è Hēsíodos, il quale
afferma che Átlas si erga «ai
confini della terra», nell'estremo occidente, proprio davanti
al luogo dove abitano le ninfe della sera e del tramonto, le
Hesperídes.
|
Átlas d’ ouranòn
eurỳn échei kraters hyp’ anáŋkēs
peírasin en gaíēs, própar Hesperídōn
ligyphṓnōn,
hestēṑs kephal te kaì akamátēısi chéressin;
taútēn gár hoi moîran edássato mētíeta Zeús.
|
Átlas regge il vasto cielo, soggiacendo a dura
necessità,
ai confini della terra, davanti alle
Hesperídes dalla voce sonora
stando ritto, con la testa e le braccia instancabili:
tale sorte gli assegnò, infatti,
Zeús prudente. |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-]
|
 |
|
Atlas e Promētheús
(✍
±530 a.C.) |
Kylix laconico, da Cerveteri
Musei Vaticani, Roma (Italia) |
C'è dunque Átlas
condannato a sorreggere il cielo ai confini occidentali del
mondo, Promētheús
incatenato in quelli orientali. Sussiste una simmetria tra il destino dei due figli di
Iapetós. Ma se il mito di Átlas
ha una ragione cosmologica, allora forse anche quello di Promētheús
appartiene a uno stessa ordine di idee. Un'immagine dipinta
all'interno di un kylix
laconico mette uno di fronte all'altro
i due titanici fratelli, ritratti nelle condanne inflitte
loro da Zeús, l'uno legato
alla sua colonna, in posizione innaturale, i polsi e le
caviglie unite; l'altro con le ginocchia flesse sotto il peso
del cielo, che sostiene con le spalle e un tocco lievissimo
del palmo sinistro. Ciascuno è affiancato da un animale: l'aquila
infierisce
col becco sul petto di Promētheús,
mentre
un serpente guizza sollevando il capo alle spalle di Átlas.
E non è una serpe qualsiasi, ma
Ládōn, il drákōn hespérios, che
custodisce le mele d'oro nel giardino delle
Hesperídes.
Condannato a sostenere il cielo sulle sue spalle,
Átlas è un poderoso axis mundi vivente che
mantiene in essere la macchina del firmamento. Non sarà inutile ricordare che, secondo Eratosthénēs, il
serpente
Ládōn era stato catasterizzato nella
costellazione allora chiamata del Serpente [Óphis]
(Katasterismoí [3]),
divenuta in seguito del Dragone [Draco] (De
Astronomia [II, 3]). Tra il quarto e il terzo millennio, la stella
principale della costellazione, α Draconis (oggi Thuban, dall'arabo
ṯuʿbān «basilisco»), si trovava vicino al polo celeste. Dunque, se Átlas
rappresenta l'asse attorno al quale ruota il cielo, il serpente
Ládōn è la costellazione contro la quale sono
puntate le sue braccia. Queste note possono forse chiarire la relazione
tra Átlas e
Ládōn, ma non la ragione per cui la maggior
parte dei mitografi collochi il titán ad ovest e non, come sembrerebbe
logico, a nord, la direzione verso cui punta il polo celeste.
Non stupisce di trovare anche tradizioni
alternative. È proprio a nord che
Apollódōros pone il giardino
delle
Hesperídes e, di conseguenza,
il luogo dove Átlas sorregge il cielo, polemizzando
con gli altri mitografi.
Apollódōros è talmente convinto
della propria versione, da duplicare la catena africana dell'Atlante nella terra settentrionale degli
Hyperbóreoi:
|
[I pomi delle
Hesperídes] non si trovavano,
come alcuni hanno detto, in Libia, ma sull'Atlante tra gli
Hyperbóreoi, ed erano i doni che
G aveva fatto a Zeús
quando aveva sposato Hḗra. |
|
Apollódōros: Bibliothḗkē
[II: 5] |
Apollódōros ci fornisce delle precise
indicazioni astronomiche sulla collocazione di Átlas,
e ci chiediamo se sia possibile estendere quest'ordine di idee anche a
Promētheús.
Non potendo dare risposte, ci conviene forse smontare dal carro dell'astronomia per calcare i sentieri
non meno aerei del mito. Átlas e il suo drákōn hespérios
sembrano completare il mitema rappresentato da Promētheús
e dall'aetós kaukasíos. Ci si può chiedere quali relazioni mitiche o
simboliche sottendano le figurazioni dei due personaggi. Non è facile indovinare
le mitodinamiche che hanno fatto di Átlas e Promētheús
due gemelli speculari. Nonostante i nostri sforzi, i due titânes
rimangono tenacemente separati, ciascuno racchiuso nel suo mito privato.
Dobbiamo trovare un fil rouge che connetta l'uno
all'altro i due figli di Iapetós. Un sentiero che
possa portare dall'aquila al serpente, e un eroe deciso a percorrerlo.
| |
|
Prigionia |
Animale |
Caratteristica |
| Greci |
Promētheús
|
Esterna (colonna o rocce) |
Aquila |
Negativa |
| Átlas
|
Esterna (colonne del cielo) |
Serpente |
Indifferente |
| Scandinavi |
Loki |
Esterna (bastone) |
Aquila |
Negativa |
|
Sotterranea (rocce) |
Serpente |
Negativo |
|
Lupo |
Negativo |
| Georgiani |
Amirani |
Esterna (palo, albero, rocce) |
Cane alato |
Positivo/Negativo |
|
Sotterranea (palo) |
| Abxasi |
Abrysk’yl |
Sotterranea (palo) |
Cavallo alato |
Positivo |
| Circassi |
Teʒau |
Esterna (rocce) |
Aquila |
Negativo |
|
Sotterranea (palo) |
|
IL DIO-TUONO E IL
PROMETEO INCATENATO
 |
|
Þórr e Útgarðaloki
(✍
1888) |
|
Alfred Kappes (1850-1894) |
In uno dei più vivaci racconti conservati da Snorri, il
dio-tuono Þórr
si mette in viaggio, in compagnia dell'astuto
Loki e di altri compagni, alla
volta dello
Jǫtunheimr, il paese degli jǫtnar o giganti di
brina. Dopo molte peripezie, il gruppo arriva a
Útgarðr, luogo che, a giudicare dal nome (il «recinto
esterno»), si colloca oltre i confini del
Miðgarðr
(o «recinto centrale»), il mondo abitato dagli uomini. Signore della fortezza è il gigante
Útgarðaloki, il quale sfida
i suoi ospiti a varie gare di forza o di abilità.
Loki si cimenta con il gigante
Logi in una gara di mangiate, ma
viene tosto battuto perché
Logi è una fiamma viva: divora in
un lampo la sua parte di cibo, il piatto e persino il tavolo.
Þórr
viene sfidato a lottare contro una vecchia gigantessa, che in realtà è
Elli, la vecchiaia; a svuotare con un sorso un corno che però attinge
nell'oceano; ed a sollevare un gatto che è
Jǫrmungandr, il serpente che circonda il mondo; dato che le prove sono
«truccate», anch'egli non darà buona prova di sé.
(Gylfaginning
[45-47]).
Ora, la maggior parte degli studiosi è persuasa che
Loki sia tutt'uno con
Útgarðaloki, il «Loki dei
recinti esterni», nonostante che Snorri li tratti come fossero personaggi
distinti e li fa comparire insieme nella medesima scena. L'ipotesi è in parte giustificata da una grottesca vicenda che il
cronista danese Saxo Grammaticus (1150-1220), contemporaneo di Snorri, narra nel
suo Historia Danorum. I racconti di Saxo
sono fortemente evemerizzati: la mitologia è adattata alle necessità della
cronaca storica; cangiata in una narrazione ibrida, piatta, che non ha più né la
suggestione del mito, né la verosimiglianza della realtà. Ed è solo per via del
curioso diminutivo che riconosciamo in
Thorkillus una versione storicizzata dello stesso
dio Þórr.
Secondo Saxo, Thorkillus è un marinaio
islandese, agli ordini del re danese Gormo.
Sobillato dai suoi consiglieri, che in realtà vogliono la morte di
Thorkillus, re Gormo
lo invia in un pericolosissimo viaggio verso i confini del mondo, affinché
domandi al dio Utgarthilocus quale sarà la sua
dimora ultraterrena, dopo la morte. Thorkillus
naviga per giorni, finché la sua nave si ritrova ad avanzare sotto un cielo
privo di sole e di stelle, avvolto in una notte perpetua. Una volta esaurita la
legna, Thorkillus e i suoi compagni non possono più
accendere il fuoco, e sono costretti a consumare crudo il loro cibo; ciò provoca
nei marinai violenti malesseri. D'un tratto, essi vedono guizzare da lontano una
fiamma e, sbarcati in una «terra oltremondana» [extramundanum clima],
arrivano a un fuoco alimentato da due giganteschi aquili. Le strane
creature forniscono il fuoco a Thorkillus e lo
avvertono che dovrà navigare ancora quattro giorni prima di arrivare alla dimora
di Utgarthilocus. Thorkillus
si rimette in mare e, nel tempo stabilito, sbarca su una nuova isola,
brulla e dirupata. Il buio è pressoché totale e, accese delle fiaccole, gli
uomini penetrano all'interno di una caverna. Da ogni parte, si rilevano ai loro
occhi seggi di ferro, alternati da fitti grovigli di serpenti. Attraversato un
fiumiciattolo, gli uomini giungono in una sala tenebrosa e ripugnante...
|
Intra quod Utgarthilocus manus pedesque
immensis catenarum molibus oneratus
aspicitur, cuius olentes pili tam
magnitudine quam rigore corneas aequaverant
hastas. Quorum unum Thorkillus, adnitentibus
sociis, mento patientis excussum, quo
promptior fides suis haberetur operibus,
asservavit; statimque tanta foetoris vis ad
circumstantes manavit, ut nisi repressis
amiculo naribus respirare nequirent. |
Dentro quella sala si vedeva Utgarthilocus, con i
piedi e le mani carichi di enormi catene; i suoi peli maleodoranti erano simili,
per grandezza e durezza, a rami di corniolo. Con l'aiuto dei suoi compagni,
Thorkillus ne strappò uno a
Utgarthilocus, senza che questi opponesse la minima resistenza, e lo
conservò per ottenere una più immediata credibilità delle sue fatiche. Subito si
sparse tutt'intorno un fetore talmente acuto che, se non si fossero coperti il
naso con il mantello, non sarebbero stati capaci di respirare... |
|
Saxo Grammaticus:
Historia Danorum [VIII: xv, 8] |
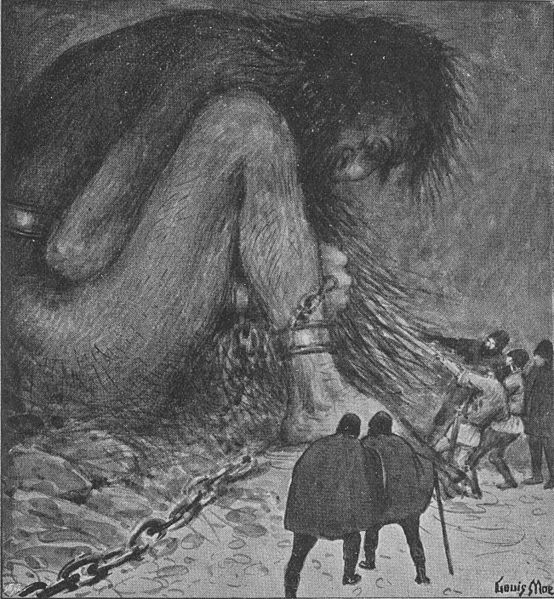 |
|
Thorkillus e Utgarthilocus
(✍
1898) |
|
Louis Moe (1857-1945) |
Thorkillus e i suoi compagni fuggono, mentre fitti
nuguli di serpenti lasciano piovere sopra di loro sputi velenosi: a chi
consumano un braccio, a chi staccano la testa, a chi bruciano gli occhi. I
marinai riescono a tornare alla nave e salpare. In quanto a
Thorkillus, è tale la ripugnanza che gli ha ispirato l'incontro con quel dio
pagano, puzzolente e incatenato, che si converte al cristianesimo...
Il racconto di Saxo Grammaticus, per quanto alterato, ha conservato – quasi dei
fossili viventi – sia il duplice tema del sequestro e della
riconquista del fuoco, sia la presenza dei due animali collegati ai miti
prometeici: l'aquila (che Saxo declina al maschile, aquilus), qui
trattata come un troll o gigante, e il serpente, moltiplicato in una legione di
velenosissimi rettili.
Confrontando il testo di Saxo con l'episodio mitico fornito da Snorri, si può
ipotizzare l'esistenza di un racconto ancora più antico nel quale
Þórr (o un suo equivalente)
arrivava nel luogo, ai confini del mondo, dove
Loki
giaceva incatenato. È molto probabile che questo luogo fosse proprio
Útgarðr, il «recinto esterno»,
posto fuori dal mondo abitato, così come il Caucaso rappresentava per i Greci
l'ultimo lembo disabitato della terra.
È possibile che, in questo contesto,
Loki
fosse appunto chiamato Útgarðaloki,
il «Loki del recinto esterno». Ma perché troviamo proprio
Þórr al cospetto di Loki
incatenato?
Nella vicenda descritta da Saxo, re Gormo è
divorato dalla curiosità di comprendere i fenomeni e i segreti della natura, e
invia Thorkillus nei luoghi più lontani del mondo
affinché soddisfi il suo desiderio di conoscenza. Mutatis mutandis, non
si può non pensare all'eroe greco per eccellenza, Hērakls,
che re Eurystheús spedisce in continui viaggi
dall'uno all'altro capo della terra, alla ricerca delle creature e degli oggetti
più favolosi. Inoltre, alla malevolenza dei consiglieri di
Gormo, che spingono il re a inviare Thorkillus
in un viaggio senza ritorno, corrisponde la segreta speranza di
Eurystheús, che Hērakls finisca per
venire ammazzato in qualche suo érgon, o «fatica». Le due situazioni, almeno
a livello narrativo, si equivalgono, e non si può escludere che Saxo si fosse
ispirato, in maniera più o meno esplicita, al mito greco. In realtà, il racconto
danese contiene un gran numero di corrispondenze al mitema del prometeo
incatenato, da far pensare che il «plagio» sia avvenuto in epoca assai più
antica, e che Saxo si sia limitato a intervenire solo a un livello successivo.
Uno degli érga più interessanti svolti da Hērakls
è l'undicesimo: quello relativo ai i pomi delle Hesperídes.
Questa «fatica» non è un semplice episodio nella sterminata biografia
dell'eroe, ma un racconto completo e complesso, che meriterebbe un apposito studio
monografico: ci limiteremo per ora a riferire i dati necessari per il
nostro studio.
Quando Eurystheús gli ordina di portargli i
favolosi pomi dell'immortalità, Hērakls
si mette subito in viaggio ma, non avendo alcuna idea di dove si trovi il giardino
delle Hesperídes, autentico mito nel mito, e si muove alla ricerca di qualcuno che possa
indicargli la strada. Dopo aver risalito i Balcani, attraversato l'Eridano (il
fiume Po) ed essere sceso in Libia, Hērakls
torna indietro verso l'Egitto e giunge in Arabia. A quel punto, tornato verso
nord, l'eroe solca il Mar Caspio – che la geografia mitica considera la sponda
orientale del fiume Ōkeanós –, ascende le vette del
Caucaso e qui scorge
Promētheús, stagliato contro la roccia, appesantito dalle catene. Con il
permesso di Zeús, Hērakls
uccide l'aquila con un colpo di freccia e rende la libertà al titán.
|
|
[Hērakls], dopo essere passato nel continente
antistante, sul Kaúkasos trafisse l'aquila, figlia di
Échidna e
Typhn, che rodeva il fegato di
Promētheús. Così liberò
Promētheús... |
|
Apollódōros:
Bibliothḗkē
[II: 11] |
 |
|
Athēnâ, Hēraklês, Átlas (✍
456 a.C.) |
Metopa dal Tempio di Zeús, Olympia.
Si noti la leggerezza con cui
Athēnâ aiuta Hēraklês a sostenere il
peso del cielo. |
Grato,
Promētheús fornisce ad Hērakls
tutte le dritte necessarie per portare a termine la sua impresa.
Gli rivela dove sia il giardino delle
Hesperídes, e anche come procurarsi le mele, protette dal
serpente Ládōn. L'eroe si rimette in
marcia, diretto a nord, verso la terra degli
Hyperbóreoi, e giunge al cospetto di
Átlas, il fratello di
Promētheús, immobile, gravato dal peso del cielo.
Seguendo i consigli di
Promētheús, Hērakls chiede ad
Átlas
di cogliere per lui le mele nel giardino; nel frattempo sosterrà il cielo in sua
vece. Átlas accetta, lieto di scrollarsi quel peso
cosmico dalle spalle. E mentre Hērakls
si carica dell'intera sfera celeste, il titán torna recando tre mele. A questo
punto, Átlas
pretende che Hērakls continui a reggere il cielo
al suo posto, mentre lui porterà le mele a Eurystheús.
Hērakls
finge di accettare, ma prega Átlas che sostenga il cielo
ancora per qualche minuto, lasciandogli il tempo di sistemarsi una benda attorno
al capo. Ingenuamente, Átlas depone a terra le mele
e riprende sulle spalle la sfera celeste. Ma Hērakls
raccoglie le mele e, lasciandolo lì, riprende la strada del ritorno.
Subito dopo aver riferito questa curiosa vicenda,
Apollódōros
aggiunge, quasi per un ripensamento, una variante meno interessante, ma
evidentemente non tanto «minore» da poter essere ignorata:
|
|
Altri tuttavia dicono che Hērakls non ebbe i pomi
da Átlas, ma che li colse egli stesso, dopo aver
ucciso il serpente [Ládōn] che li custodiva. |
|
Apollódōros:
Bibliothḗkē
[II: 11] |
Ed è proprio grazie allo scrupolo di
Apollódōros, se disponiamo del percorso che collega
Promētheús ad
Átlas, l'aquila al serpente. La composizione dei
titânes
incatenati e delle loro fiere (e sia
l'aetós kaukasíos che il drákōn hespérios
sono stati entrambi eliminati da Hērakls) ha
assunto una distribuzione simmetrica, e non può essere né un
caso, né una trovata di Apollódōros, ché
l'erudito mitografo non aveva gli strumenti di correlazione a cui
noi ci stiamo affidando.
Inoltre, il mito della mancata liberazione di
Átlas ricorda irresistibilmente le varianti caucasiche dove
Amirani chiede a un viandante di liberarlo dal
luogo dov'è incatenato, senza che costui vi riesca. È abbastanza curioso che,
sebbene il mito greco liberi
Promētheús – ed è l'unico dei nostri eroi incatenati a venire graziato –,
la condanna viene trasferita su suo fratello
Átlas, che continua a rimanere immobile al suo posto, a sorreggere il
cielo «ritto, con la testa e le braccia instancabili» [hestēṑs kephal te kaì
akamátēısi chéressin]
(Theogonía
[, ]).
Ci chiediamo cosa abbiano in comune Hērakls
e
Thorkillus (Þórr),
questi errabondi visitatori dei prometei incatenati. Ovvio, sono
due figure omologhe, gli esiti ellenico e germanico dell'antico dio-tuono
indoeuropeo. Inesausti viaggiatori,
Hērakls e
Þórr girano il mondo per
abbattere, a colpi delle loro armi funzionali, rispettivamente una clava e un
martello, i mostri e giganti che minacciano l'ordine cosmico. La loro affinità
era ben nota anche nel mondo classico: anche Tacitus li identifica
(Germania [9]). Appartengono al medesimo
mitema molti altri personaggi tratti da tutte le regioni del dominio
indoeuropeo, e possiamo citare l'anatolico
Tarḫunta, l'indiano Indra, il celtico
Taranis, il baltico Perknas/Pērkons,
lo slavo Perunŭ, e via dicendo,
tutti personaggi disegnati a partire da una comune figura mitologica, la cui
origine affonda nella più remota antichità.
Ma qual è esattamente il loro rapporto con il prometeo incatenato?
|
| UN'ORIGINE
INDOIRANICA? Fermiamoci qui, sulla cima del Gran Caucaso, come eracli affaticati, e
guardiamoci intorno. Ecco la «montagna delle
lingue», con il suo inestricabile viluppo di popoli, e i mille rivoli narrativi del campione incatenato: Amirani, Abrysk’yl, Teʒau Nesren... Dal Caucaso ci siamo rivolti dapprima ad est, verso la Grecia,
dove Promētheús è stato punito per aver tentato di
ingannare il re degli dèi; poi ci siamo spostati a nord, in Scandinavia, per fare
conoscenza con lo sgradevole Loki; e infine abbiamo
dato un'occhiata proprio qui, nell'Ossezia, dove
Syrdon ne starà sicuramente architettando un'altra delle sue. Promētheús, Loki,
Syrdon: tre
imprevedibili imbroglioni, ricchi di astuzie e di malizie.
Ma ora voltiamoci, e giriamo il nostro sguardo verso sud, dove,
all'ombra del monte Ararat, l'Armenia ha
custodito la cupa storia di Artawazd. E poi ancora
più a sud, dove s'innalzano i poderosi altopiani dell'Īrān. Laggiù
pulsa il cuore di una delle più potenti e organizzate nazioni della storia,
l'impero persiano. Achemenidi, Selelucidi, Parti, Sassanidi: per oltre due
millenni, l'ombra iranica non ha smesso di incombere sull'Armenia e sul
Caucaso, e anche sul Medio Oriente, e addirittura sulla Grecia. Paese dalla cultura raffinata, sofisticata in
tutte le sue espressioni letterarie e artistiche, profonda nelle speculazioni
religiose e filosofiche, l'Īrān ha influenzato il Caucaso – e in realtà tutto l'occidente – in
più modi di quanti si possano immaginare.
Com'è noto, Īrān e India affondano le loro radici in un comune retroterra
culturale, che è a sua volta uno dei rami della grande diaspora indoeuropea.
Nonostante la sua complessità e ricchezza, la tradizione indoiranica non si presenta
però così trasparente, così facilmente penetrabile alle
analisi degli studiosi. I testi più
antichi, quali il Ṛgveda o l'Avestā,
sono piuttosto criptici: si limitano ad accennare a questo o quel
mito nel corso di interminabili invocazioni, e gli studiosi sono costretti a interpretare
le loro laconiche allusioni
attraverso i dati forniti dalla letteratura più tarda, sempre diversamente
sviluppata, adattata, deformata. Aggiungiamo poi il singolare destino a
cui è andato incontro il pensiero mitico nei due paesi. L'India non ha smesso di
sviluppare la propria mitologia, sia in senso filosofico che religioso,
rielaborandola nelle Upaniṣad,
nei Brāhmaṇa e nella letteratura epica,
fino ad arrivare alla moderna «sommatoria» dell'Induismo. In Īrān, la riforma
religiosa operata da Zaraθuštra ha smontato e ricostruito
l'intero patrimonio mitologico secondo un sistema essenzialmente dualista, dove spazio e tempo
divengono i luoghi dialettici del confronto/scontro tra lo spirito del bene
Ahura Mazdāh e quello del male
Aŋra Mainyu. L'alterazione iranica è stata talmente
radicale che gli antichi dèi indoiranici (daēvā) sono stati
ribaltati in dèmoni nel
sistema zoroastriano: e come orribili devebi li abbiamo ritrovati nel Caucaso, a
combattere contro Amirani.
Sulla scolta dei primi studi indoeuropeistici, nell'Ottocento, gli studiosi si
affannarono a
cercare tracce di Promētheús nella mitologia
indiana, nell'indifferenza – o nell'aperta ostilità – dei classicisti. A furia
di rivoltare la sterminata letteratura sanscrita, finirono infine per trovare una
coppia di fratelli chiamati Manthu e
Pramanthu, subito considerati dei prototipi di Epimētheús e Promētheús
(Graves 1955). Senonché i due nomi compaiono in un'unica
fonte, che è una semplice genealogia:
|
madhoḥ sumanasi vīravratas |
Nel grembo di Sumanā, Madhu
generò Vīravrata. |
|
tato bhojāyāṁ
manthu-pramanthū jajñāte |
Nel grembo di Bhoja,
Vīravrata generò Manthu e
Pramanthu. |
|
manthoḥ satyāyāṁ bhauvanas |
Nel grembo di Satyā, Manthu
generò Bhauvana... |
|
Śrīmad Bhāgavatam [V: 15:
-] |
E non c'è davvero nulla che permetta di collegare questi
Manthu e Pramanthu ai
nostri Epimētheús e Promētheús,
se non una vaga rassomiglianza dei nomi e un semplice rapporto di fratellanza.
Sebbene questa si rivelasse una pista poco fruttuosa, gli indologi notarono
subito che, in sanscrito, pramantha è il nome dell'asticella verticale
del trapano da fuoco, la quale, sfregata contro un'esca, permette di accendere una
fiamma. L'immagine di Promētheús che porta il
fuoco, rubato agli dèi, nel cavo di una canna, assumeva d'un tratto nuovi
significati.
Nella seconda metà dell'Ottocento, il filologo Adalbert Kuhn (1812-1881),
iniziatore di una scuola di studi mitologici basati sulla filologia comparativa,
ipotizzò che proprio dal verbo sanscrito ma(n)thati, nel significato di
«predare», si fosse sviluppato il greco manthánō «imparare», visto come
istruzione compiuta appropriandosi del sapere altrui. Il nome di Promētheús
si sarebbe formato, secondo Kuhn, da una polisemia tra le parole sanscrite
pramātha «rapina» e pramantha «asticella del trapano da fuoco»
(Kuhn 1886). Sebbene avversatissima dai classicisti, questa ipotesi ebbe
vita lunga, tanto che, settant'anni dopo, nel suo lessico antico-indiano, l'indologo
Manfred Mayrhofer trovava «credibile» il collegamento tra il sanscrito
pra-math- (nel significato di «predare») e il greco Promētheús,
dorico Promatheús (Mayrhofer 1956). Il
mitologo-poeta Robert Graves non si faceva scrupolo di derivare direttamente
il greco dal sanscrito, affermando – in spregio a ogni verosimiglianza
glottologica – che il nome di Promētheús
«ebbe forse origine da un'errata interpretazione greca della parola sanscrita
pramantha, indicante la svastica o fiaccola che, si dice, Promētheús
avrebbe inventato» (Graves 1955). ①
In questo studio, pur non negando l'interesse della pseudo-etimologia Promētheús/pramantha,
preferiamo seguire piste diverse.
E notiamo subito che la mitologia iranica conosce un personaggio che condivide il fato di tutti i
prometei, quello di venire incatenato. È Ẓaḥḥāk, un
antico sovrano che, secondo la leggenda cantata da Ferdowsī nello
Šāhnāmeh o «Libro dei re» (composto tra il 977 e il 1010),
tiranneggiò l'Īrān per mille anni. Di origine araba, e
quindi con tutto il peso ideologico dell'ancora recente conquista della
Persia, Ẓaḥḥāk governava con
una ferocia e una crudeltà eccessive persino secondo i canoni dei satrapi orientali. Due orrendi
serpenti gli spuntavano dalle spalle e, per acquietarli, il re dava loro in
pasto, ogni giorno, il cervello di due ragazzi. Ẓaḥḥāk
venne poi sconfitto dall'eroe Fereydūn. Trascinato
tra le cime dell'Elborz, fu incatenato sulla loro vetta più alta, il monte Damāvand.
Ma questo sgradevole personaggio era già presente nell'Avestā
e nei più antichi libri sacri zoroastriani sotto il nome di
Aži Dahāka, dove era considerato una delle più
malvagie creature appartenenti alla schiera di Aŋra Mainyu.
|
ažīm dahākǝm
θrizafanǝm θrikamǝrǝδǝm
xṣvaš-aṣīm hazaṅrā-ýaoxštīm
ašaoǰaṅhǝm daēvīm druǰǝm
aγǝm gaēθāvyō drvaṇtǝm
ýãm ašaoǰastǝmãm druǰǝm
fraca kǝrǝṇta aṅrō mainyuš
aoi ýãm astvaitīm gaēθãm
mahrkāi aṣahe gaēθanãm. |
Aži Dahāka dalle tre teste, dalle tre
possenti mascelle, dai sei terrificanti occhi, dai mille sensi e dalle mille
capacità, una druǰ, un daēva mentitore, nemico dei nostri insediamenti,
un dèmone che il malvagio spirito Aŋra Mainyu aveva
creato come il più potenti tra le druǰ [contro il mondo materiale] per
distruggere i nostri insediamenti e trucidare i seguaci di
Aša! |
|
Avestā >
Yasna [9:
-] |
Descritto come un orribile tricefalo, Aži Dahāka
viene sconfitto dall'eroe
Θraētaona (Fereydūn). I libri
dell'Avestā non aggiungono altro sul
destino di questo sgradevole personaggio, e sono i testi pahlavici, composti più di mille
anni dopo, a confermare che
Aždahag (Ẓaḥḥāk)
venne effettivamente incatenato sul monte Damāvand da Frēdōn
(Fereydūn). Il mito pahlavico è pure completato con un degno finale
escatologico. Si dice che, all'inizio del millennio di Ušēdarmāh,
quando il tempo stabilito per la storia del il confronto tra gli spiriti del
bene e del male sarà ormai esaurito, Azdahāg
spezzerà le sue catene, nel tentativo di divorare il mondo, con tutte le sue
creature e l'intero genere umano. Secondo un testo apocalittico redatto tra il IX
e il X
secolo, sarà l'eroe Keresāsp (l'avestico
Kǝrǝsāspa), riportato in vita da Ōhrmazd
(Ahura Mazdāh), a scontrarsi con Azdahāg,
uccidendolo prima che distrugga l'universo (Zand ī
Wahman Yasn [9]).
In Scandinavia, Loki appare come un
personaggio ambiguo, adesso utile agli dèi, adesso
dannoso, ma la decisa negatività del suo ruolo si chiarisce soltanto nel
ragnarǫk, quando assume
un senso definitivo. L'Īrān, nel suo eccessivo dualismo, non è in
grado di gestire tali sfumature, e Aži Dahāka
non può che mostrarsi in ogni momento ciò che realmente è: un rappresentante della druǰ, unicamente
interessato alla distruzione della terra e del genere umano. È malvagio in ogni
momento, sebbene si scatenerà soltanto in un futuro apocalittico.
Questa tema escatologico è molto importante, per quanto andrebbe meglio
analizzato nel contesto delle idee zoroastriane del tempo e della storia. Può
avere influenzato le concezioni armena e caucasica del prometeo
incatenato, la cui liberazione segnerà l'abbattimento dell'ordine cosmico e la
fine del mondo come lo conosciamo, oppure il ristabilimento della situazione
primordiale.
Se l'India non conosce il mitema dell'incatenato, ha comunque una vicenda
analoga a quella greca della titanomachia. Ma
Deva e
Asura non sono
direttamente comparabili a
Titânes e
Olýmpioi. A dirla tutta, le relazioni
reciproche tra le due classi di divinità indiane sono non
ben
definibili. Nella tradizione vedica,
Deva e
Asura sono posti a un
medesimo livello, due gruppi di divinità ugualmente discesi
da
Prajāpati. Nel
Ṛgveda, la differenza è
funzionale: gli Asura
presiedono al principi morali e sociali (Varuṇa
è il guardiano della ṛta, l'ordine cosmico,
Aryaman dei matrimoni, etc.),
mentre i Deva presiedono
perlopiù alle forze e ai fenomeni naturali (Indra
personifica il tuono, Vāyu il
vento, Uṣas l'alba, etc.). È solo nelle speculazioni successive che
gli Asura acquistano
qualità negative. La tendenza si intravede già
nei Brāhmaṇa;
nella
Bhagavadgītā, gli
Asura vengono descritti
come esseri presuntuosi, rissosi e ignoranti; nei
Purāṇa
divengono del tutto malvagi, affini ai dèmoni. Nel corso della sterminata letteratura
indiana, la competizione tra
Deva e
Asura – definita in
sanscrito daivāsura – assume una moltitudine di aspetti
divergenti. Nei testi epici è descritta nei termini di uno
scontro apocalittico (Doniger 1975 | Panikkar 1977).
Abbiamo analizzato altrove la versione indiana della titanomachia ②.
Se ne accenniamo in questa sede, è soltanto perché, nei miti prometeici – tranne in quelli caucasici che fanno classe a sé – il
prometeo-imbroglione accede al pántheon provenendo dalla schiera nemica.
Prometheús è un titán,
Loki uno jǫtunn. Poiché ora siamo in India, ci aspettiamo di trovare un
imbroglione che arrivi dalla schiera degli asura.
Un caso emblematico potrebbe essere rappresentato da Viśvarūpa,
il figlio del divino architetto
Tvaṣṭṛ. È detto
Triśiras, il «tricefalo», in quanto –
proprio come Aži Dahāka
– è dotato di tre teste e, soprattutto, di tre bocche.
Il mito della sua uccisione, eseguita con il concorso di
Indra (ne vedremo altrove le particolarità),
viene narrata già in
Ṛgveda
[X, 8]. I
Brāhmaṇa sviluppano il suo mito in maniera
piuttosto interessante.
Nonostante sua madre sia di stirpe asura,
Viśvarūpa viene accolto tra i deva come sacerdote officiante [purohita]. Ed è
anche un sacerdote molto efficiente, che compie da solo il lavoro di tre, in
quanto con le tre teste canta, loda e recita contemporaneamente. Trovandoci in India, la capacità intellettiva, la mtis prometeica, viene
sostituita dall'esasperazione delle capacità sacerdotali. Ma anche
Viśvarūpa è un individuo astuto e
perverso, e ha il brutto vizio di speculare sulle offerte sacrificali. Elargisce pubblicamente ai deva la parte che loro assegnata, ma passa di nascosto ampie porzioni
agli asura. Insomma,
Viśvarūpa non solo detiene il medesimo ruolo assegnato a
Promētheús al banchetto di Mēkṓnē,
ma agisce sottobanco nella stessa maniera ingannevole e disonesta.
|
|
Pubblicamente [Viśvarūpa] promise una
porzione [del sacrificio] ai deva, ma in segreto agli asura, perché si
promette in segreto a colui che si preferisce. Indra
ebbe paura, perché il figlio di
Tvaṣṭṛ era figlio di una asura,
e perché era molto potente. Allora Indra disse: «È
demoniaco questo figlio di una asura, e parla in segreto a favore dei
dèmoni. Devo ucciderlo». E con la folgore tagliò le teste di
Viśvarūpa. |
|
Jaiminīya
Brahmaṇa [II, -] |
Il mito viene raccontato nei dettagli, e con molte interessanti variazioni, nel
Mahābhārata, dove dal corpo
abbattuto di
Viśvarūpa sorge il serpente
Vṛtra, deciso a distruggere Indra.
Secondo altri testi, è invece
Tvaṣṭṛ a creare questo
serpente... ma ora stiamo allontanandoci dal nostro tema.
Il problema, è come considerare
Viśvarūpa. Siamo arrivati a lui
attraverso la caratteristica della tricefalia, partendo da
Aži Dahāka. Detto questo, gli elementi che
Viśvarūpa condivide con il mitema
prometeico sono secondari (arrivo tardivo nel pántheon,
imbroglio nel sacrificio, accesa volontà di distruzione), e manca del tutto il tema
dell'incatenamento. Si può sicuramente parlare di analogie: difficile imbastire
omologie convincenti. Anche perché
Viśvarūpa/Triśiras
appartiene a buon diritto un altro mitema: quello del tricefalo.
Stiamo parlando di una classe ben nota di miti indoeuropei, incentrati dalla
lotta del dio-tuono, o di un suo sodale eroico, con un avversario tricefalo o
triplice. Al riguardo sono stati composti
studi piuttosto dettagliati, che non è ora il caso di approfondire ③. È dunque possibile che i
temi «prometeici» qui segnalati riguardo a
Viśvarūpa/Triśiras
siano soltanto delle
somiglianze accessorie, oppure elementi ereditati da personaggi più
antichi. Quali? Difficile dirlo. Si può pensare ad esempio all'asura Namuci,
la cui relazione con Indra ricorda il patto
di sangue tra Loki e Óðinn,
sebbene anche qui sia assente il tema dell'incatenamento.
Ma anche Aži Dahāka appartiene alla classe
dei tricefali: gli studiosi hanno sottolineato profonde differenze tra il suo
mito e quello di
Viśvarūpa/Triśiras
(si confronti Yašt [5: | 14: ] con
Ṛgveda
[X, 8, -])
(Benvéniste
~ Renou 1934 | Dumézil 1968).
Ma di questi tricefali indoiranici, Aži Dahāka
è il personaggio in cui i temi prometeici appaiono più evidenti, a partire dall'incatenamento fino
alla sua liberazione escatologica. Si noti che il personaggio era ben conosciuto
in Armenia nel V secolo: nella sua monumentale cronaca storica,
Movsēs Xorenac‘i fornisce sia la leggenda
persiana (straordinariamente vicina al racconto di Ferdowsī, sebbene precedente
di oltre mezzo millennio)
(Hayoc‘
Partmowt‘yown [I,
α-β]), sia la versione armena,
opportunamente storicizzata, dove
Aždahak è un sovrano medo che si allea con re Mec Tigran,
sposandone la sorella, ma complotta contro di lui e viene ucciso
(Hayoc‘
Partmowt‘yown
[I: 24-29]). Nella leggenda armena, però, il tema dell'incatenamento non
riguarda
Aždahak; come abbiamo visto, a venire incatenato sarà un
discendente dello stesso Tigran, il ribelle
principe Artawazd.
È piuttosto arduo definire tutti gli addentellati di questo complesso
gioco di miti. Tutto quello che possiamo sostenere è che, in qualche fase
nello sviluppo della mitologia indoiranica, il mitema del tricefalo è stato
caratterizzato da alcuni temi prometeici. Questi sono attestati in
Īrān; meno evidenti in India. Impossibile definire l'epoca e l'ordine
di tali sviluppi: l'esito iranico ha sicuramente influenzato il mondo armeno e caucasico,
sebbene in queste due aree siano rimaste profonde differenze: segno di
un'eredità più antica, o innovazioni recenti?
|
| IL TEMA ESCATOLOGICO A lungo rinviata, la liberazione di
Promētheús si realizza finalmente, nel mito greco, allorché l'eroe
Hērakls sale sui monti
del Caucaso, uccide l'aquila con un colpo di freccia e rende la libertà al
titán incatenato. Il mito, argomento della perduta tragedia
Promētheús Lyómenos di Aischýlos, è già
presente in Hēsíodos:
Tòn mèn ár’ Alkmḗnēs kallisphýrou álkimos hyiòs
Hērakléēs ékteine, kakḕn d’ apò noûson álalken
Iapetionídēı kaì elýsato dysphrosynáōn
ouk aékēti Zēnòs Olympíou hypsimédontos... |
La uccise [l'aquila] il prode figlio di
Alkmḗnē dalle belle caviglie,
Hērakls, che allontanò dalla sciagura
il figlio di Iapetós e lo liberò dai tormenti;
tutto questo non contro il volere di Zeús che alto
regna sull'Ólympos... |
|
Hēsíodos:
Theogonía [-] |
...e confermata, tra gli altri, da
Apollódōros:
|
|
[Hērakls], dopo essere passato nel continente
antistante, sul Caucaso trafisse l'aquila, figlia di
Échidna e Typhn,
che rodeva il fegato di
Promētheús. Così liberò
Promētheús... |
|
Apollódōros: Bibliothḗkē
[II: 11] |
Un frammento di Aischýlos afferma, esagerando, che
Promētheús era rimasto incatenato per trentamila anni;
Hyginus stabilisce, minimizzando, che le sue pene non durarono che trent'anni
(Fabulae
[54 | 144]). Ma tutte le
fonti classiche concordano che il titán venne liberato da
Hērakls (cfr. Diódōros Sikeliṓtēs
(Bibliothḗkē Historikḗ
[IV: 15, ]); Pausanías
(Periḗgēsis [V: 11,
]);
Hyginus (De Astronomia [II:
15]), etc.).
Non vi sono indicazioni di versioni alternative. Alcuni fonti,
ricordando che Zeús aveva decretato
che
Promētheús non sarebbe mai stato liberato dai ceppi,
aggiungono che il titán, per non infrangere la parola del
dio supremo, dovette da allora portare al dito un anello fatto
con il ferro delle proprie catene.
 |
|
Hērakls libera Promētheús (✍
610 a.C.) |
|
Cratere attico.
Museo Archeologico Nazionale, Atene (Grecia) |
Questa pacifica liberazione di
Promētheús è evidentemente un'innovazione del mito greco. Tutti gli
altri prometei qui esaminati sono infatti destinati a
rimanere incatenati. La loro liberazione, continuamente differita
secondo le modalità previste dai vari miti, è destinata ad
attuarsi solo alla fine del mondo. Come abbiamo visto, l'atteggiamento
dei fruitori del mito è piuttosto diverso caso per caso. Gli Abxasi attendono la liberazione di Abrysk’yl con
trepidazione: l'eroe sconfiggerà tutti i nemici dell'Abxasia e
ricondurrà il paese alla felice età dell'oro dei primordi;
gli Armeni pagani hanno un analogo atteggiamento nei
confronti di Artawazd, che
dovrà regnare su un mondo restaurato ai valori precristiani.
Questi due schemi vanno considerati, con ogni probabilità, ricostruiti secondo
il mitema nazionalista dell'eroe dormiente, estraneo all'ideologia del mito prometeico.
Riguardo ad Amirani, Georgiani e Svaneti
hanno un atteggiamento più ambiguo. Come ha notato Charachidzé, l'eroe desta la
simpatia e la partecipazione del popolo, il quale però si assicura che rimanga
ben legato nella sua grotta. I fabbri georgiani picchiano sulle loro
incudini ogni giovedì santo, in modo che le catene dell'eroe rimangano ben salde e lo tengano
imprigionato al suo posto. Secondo lo studioso franco-georgiano, la liberazione di Amirani
corrisponderebbe alla fine dell'ordine imposto dal dio supremo
Ḡmerṫi e al ritorno a uno stadio pre-civile,
prefigurato dall'ideologia propugnata dallo stesso Amirani:
un guerriero solitario in lotta contro qualsiasi forma di vita
(Charachidzé 1986¹).
L'incatenamento di
Promētheús, in Grecia, è legato al passaggio dell'umanità dallo stato primordiale al mondo così come lo conosciamo, voluto in questo caso da
Zeús come punizione per gli inganni di
Promētheús e il furto del fuoco, punizione ereditata da tutti gli esseri
umani ①. Nel mondo scandinavo, Loki
viene punito per aver ucciso Baldr,
dio della giustizia e della pace, e aver conseguentemente provocato il crollo
etico dell'umanità. Lo stato
del mondo che segue all'uccisione di
Baldr, e che prelude alla
catastrofe finale, è descritto dal poema eddico
Vǫluspá con parole e termini che
appartengono, in fondo, alla tradizione universale:
Bræðr munu berjask
ok at bǫnum verðask,
munu systrungar
sifjum spilla,
hart 's í heimi,
hórdómr mikill,
skeggǫld, skalmǫld,
skildir klofnir,
vindǫld, vargǫld,
áðr verǫld steypisk
mun engi maðr
ǫðrum þyrma. |
Si colpiranno i fratelli
e l'un l'altro si daranno la morte;
i cugini spezzeranno
i legami di parentela;
crudo è il mondo,
grande l'adulterio.
Tempo d'asce, tempo di spade,
gli scudi si fenderanno,
tempo di venti, tempo di lupi,
prima che il mondo crolli.
Neppure un uomo
un altro ne risparmierà. |
|
Ljóða Edda
> Vǫluspá [45] |
Il mondo scandinavo, che presenta un'escatologia piuttosto complessa, ha uno dei suoi motori proprio nella liberazione di
Loki dalla sua prigione. L'evento
finale, in questo sistema mitico, è il
ragnarǫk o
ragnarøkr, il «destino
[tramonto] delle potenze divine», termine tecnico per indicare la battaglia
escatologica che metterà fine tanto agli dèi quanto al mondo. Essa sarà
causata allorché, le potenze eversive, esiliate ai confini dello spazio, si
libereranno e attaccheranno l'ordine istituito e garantito dagli dèi. Il
principale nemico è Loki: è la sua liberazione dalla
prigione sotterranea a
segnare l'inizio del ragnarǫk.
Con lui vi sono i suoi due tremendi figli: il lupo
Fenrir e il serpente
Jǫrmungandr, i quali si
uniscono alla spaventosa armata degli
Jǫtnar, o giganti di brina, e
marceranno contro l'esercito degli dèi per l'ultima battaglia.
Le battaglie escatologiche, a cui accenna la
Vǫluspá, sono descritte in dettaglio da Snorri in
Gylfaginning
[51]. Il lupo Fenrir
ingoierà Óðinn, ma poi, allorché
minaccerà di divorare l'universo, verrà ucciso
dal dio
Víðarr.
Il serpente
Jǫrmungandr scuoterà le
acque dell'oceano, che inonderanno il mondo, sterminando l'umanità:
Þórr
scenderà a contrastarlo ma entrambi morranno nello scontro. In quanto a
Loki, dice Snorri, si batterà con
il dio
Heimdallr, e nessuno dei due
sopravvivrà. Per ultimo, giungerà
Surtr in testa all'armata dei
Múspells megir, i
giganti di fiamma provenienti dal
Múspellsheimr: nelle
fiamme ecpirotiche arderà l'intero universo.
Non è ora il caso di entrare nei dettagli di questo grandioso affresco:
dobbiamo sforzarci di seguire il filo prometeico. Il mito scandinavo è esplicito: la distruzione
finale è
propedeutica alla nascita di un nuovo mondo, al ristabilimento dell'età
dell'oro. Patrono di questa nuova età sarà proprio
Baldr, il figlio di
Óðinn di cui
Loki aveva causato la morte.
Esiliato nel regno di Hel per tutto
il corso della storia umana, egli ritornerà insieme al
cieco fratello Hǫðr, e stabilirà
un regno felice. Così Snorri descrive questo futuro stato edenico:
|
Upp skýtr jǫrðunni þá ór sænum ok er þá grǿn ok fǫgr, vaxa þá akrar ósánir.
[...]. Því næst koma þar Baldr ok Hǫðr frá Heljar, setjask þá allir samt ok
talask við ok minnask á rúnar sínar ok rǿða of tíðindi þau er fyrrum
hǫfðu verit, of Miðgarðsorm ok um Fenrisúlf. |
La terrà emergerà dal mare e sarà allora verde e bella. I campi cresceranno
senza esser stati seminati. [...]. Arriveranno anche
Baldr e
Hǫðr da
Hel,
allora tutti siederanno insieme e converseranno, ricorderanno la loro arcana
sapienza e parleranno degli avvenimenti accaduti prima, del
Miðgarðsormr e del
lupo Fenrir. |
|
|
Snorri:
Prose Edda
>
Gylfaginning [53] |
In Grecia, non troviamo nulla di tutto ciò, almeno in apparenza. Sebbene il mito esiodeo presenti un doppio passaggio di consegne nella regalità divina (da
Ouranós a Krónos,
quindi da Krónos a Zeús),
il regno di Zeús viene percepito come immutabile ed
eterno. In un passo,
Hēsíodos allude a un futuro crollo morale
dell'umanità, seguito dalla fine del mondo (Érga kaì
Hēmérai [-]), con parole quasi identiche a quelle della
vǫlva nordica, sebbene non vi sia alcun legame con il mito di
Promētheús, e soprattutto non venga mai messa in discussione la regalità di Zeús.
Se dunque, nel mondo nordico, la
liberazione di Loki è legata,
oltre che al motivo della fine del mondo, a un passaggio di consegne nella
suprema regalità, da
Óðinn a
Baldr, nel mondo greco
la regalità di Zeús sembra non subire scosse. Ma è
davvero così? La risposta, inaspettatamente, è no. Ed è
proprio Aischýlos a seminare questi
dubbi. Il suo
Promētheús, incatenato alle vette del Caucaso, così grida rivolto al
cielo:
È mḕn éti Zeús, kaíper authádēs phronn,
éstai tapeinós, hoîon exartýetai
gámon gameîn, hòs autòn ek tyrannídos
thrónōn t' áiston ekbaleî. patròs d' arà
Krónou tót' ḗdē pantels kranthḗsetai,
hḕn ekpítnōn ērâto dēnain thrónōn.
toinde móchthōn ektropḕn oudeìs then
dýnait' àn auti plḕn emoû deîxai saphs.
egṑ tád' oîda ch trópōi. pròs taûta nŷn
tharsn kathḗsthō toîs pedarsíois ktýpois
pistós, tinássōn t' en cheroîn pýrpnoun bélos.
oudèn gàr auti taût' eparkései tò mḕ ou
peseîn atímōs ptṓmat' ouk anaschetá.
toîon palaistḕn nŷn paraskeuázetai
ep' autòs hauti, dysmachṓtaton téras.
hòs dḕ keraunoû kreísson' heurḗsei phlóga,
bronts th' hyperbállonta karteròn ktýpon,
thalassían te gs tinákteiran nóson,
tríainan aichmḕn tḕn Poseidnos, skedâi.
ptaísas dè tide pròs kaki mathḗsetai
hóson tó t' árchein kaì tò douleúein dícha. |
Promētheús: «Eppure Zeús, anche se è superbo,
sarà meschino. Si prepara nozze
che lo rovesceranno dal suo trono,
l'annienteranno. E la maledizione
che Krónos gli andava rovinando
dal seggio antico, si farà in tutto vera.
Nessuno degli dèi può rivelargli
come sfuggire a questa sorte: io solo.
Io lo so, io so come. Riposi, allora,
forte del tuono di cui trema il cielo,
lanciando la sua folgore di fuoco.
Perché non basteranno tuono e folgore
quando cadrà per sempre e senza gloria.
Da sé ora si prepara un avversario
molto duro da vincere, un prodigio,
e la sua fiamma sarà più che una folgore,
la sua percossa sarà più che tuono,
e sperderà il funebre tridente
del mare, che agita la terra,
lancia di Poseidn: a questi mali
urterà Zeús, e allora imparerà
se servire è altra cosa che regnare». |
|
Aischýlos:
Promētheús
desmṓtēs [-] |
Ciò che
Promētheús, dal suo luogo di tortura, profetizza a
Zeús, è evidente. Anche il grande signore degli dèi è destinato ad essere
spodestato dal proprio figlio, un dio ancora più potente del padre, che però deve
ancora nascere. E l'unico che sa come evitare questa sventura è proprio lui,
Promētheús. Herms
arriva al
cospetto del titán incatenato e cerca di indurlo a rivelare qualcosa di
più su questa sibillina profezia, ma
Promētheús non si smuove, e così investe il nuovo arrivato:
Néon néoi krateîte kaì dokeîte dḕ
naíein apenth pérgam'. ouk ek tnd' egṑ
dissoùs tyránnous ekpesóntas ēisthómēn?
tríton dè tòn nŷn koiranoûnt' epópsomai
aíschista kaì táchista. mḗ tí soi dok
tarbeîn hypoptḗssein te toùs néous theoús?
polloû ge kaì toû pantòs elleípō. |
Promētheús: «[...] Siete signori nuovi, e vi pensate
di abitare la rocca dell'eterna
serenità: ma da quella rocca
ho sentito cadere due sovrani.
Il terzo lo vedrò crollare presto
e con più obbrobrio. Credi che io tremi,
che m'inginocchi innanzi ai nuovi dèi?
Come poco ci penso!» |
|
Aischýlos:
Promētheús
desmṓtēs [-] |
Di cosa sta parlando
Promētheús? Si rifiuta di svelare a Herms
(e a noi)
quel che conosce sul futuro re dell'universo. È probabile che questo enigma
venga sciolto da Aischýlos nelle successive tragedie del ciclo prometeico, le quali però sono
andate perdute. Il motivo è tuttavia ben attestato presso altri mitografi. Apollódōros
afferma quanto segue:
|
|
Alcuni dicono che, quando Zeús partì per sedurre
Téthis,
Promētheús lo avvisò che il figlio che avrebbe avuto da lei sarebbe
diventato il sovrano del cielo. |
|
Apollódōros: Bibliothḗkē
[III: 13, ] |
Questa Téthis era una delle
Nērēḯdes, figlie del dio
marino Nēreús. A seguito della
profezia di
Promētheús, Zeús rinuncia a unirsi a lei, ed
ella in seguito sposa il mortale Pelías:
loro figlio sarebbe stato l'eroe
Achilleús. Ora, può sembrar strano che
Promētheús, che
Aischýlos mostra così restio a
rivelare chi fosse il discendente destinato a spodestare
Zeús, sia
così facilmente disposto, in Apollódōros,
a rendere questo servigio al re degli dèi.
Il motivo è attestato in molte varianti, dove il medesimo oracolo viene
attribuito anche ad altri personaggi (Thémis, o
Prōteús),
ma il ruolo di
Promētheús riaffiora continuamente, fino a trovare
definitiva consacrazione nei mitografi più tardi. Leggiamo in Hyginus:
|
|
Era destino che il figlio della nereide Téthis
sarebbe stato più forte del padre. Solo
Promētheús conosceva questo segreto. Così, quando
Zeús fu preso dal desiderio di unirsi a lei,
Promētheús promise di rivelarglielo se fosse stato liberato dalle catene:
il patto fu giurato e allora
Promētheús ammonì Zeús ad astenersi da
Téthis, per evitare di dare alla luce un figlio più
forte di lui che l'avrebbe cacciato dal regno come lui aveva fatto con
Krónos. Così, Téthis
fu data in sposa a Pelías, figlio di
Aiakós, ed
Hērakls fu mandato a uccidere l'aquila che rodeva
il cuore di
Promētheús. Essa fu abbattuta, e
Promētheús venne liberato dal Caucaso dopo una prigionia di trent'anni. |
|
Hyginus: Fabulae
[54] |
Lo stesso racconto è riportato con alcune varianti, sempre da Hyginus, in De Astronomia [II: 4].
Loukianós lo utilizza come pretesto per un
dialogo scoppiettante di ironia, che riportiamo per intero:
|
|
Promētheús: «Liberami, Zeús: ho già patito
sofferenze terribili».
Zeús: «Liberarti, dici? Ma se dovrei farti mettere ceppi ancora più
pesanti e l'intero Caucaso in testa, con sedici avvoltoi che non solo ti
divorino il fegato, ma ti cavino anche agli occhi, in cambio delle belle
creature che ci hai plasmato, gli uomini, e dell'aver rubato il fuoco e creato
le donne! E dei raggiri che mi hai fatto nella distribuzione delle carni,
imbandendomi ossa rivestite di grasso e serbando per te le parti migliori, cosa
si dovrebbe dire?»
Promētheús: «Non ho dunque pagato un fio sufficiente, restando
inchiodato per tanto tempo al Caucaso e nutrendo col mio fegato l'aquila, il più
maledetto degli uccelli?»
Zeús: «Questa non è neanche una minima parte di ciò che devi soffrire».
Promētheús: «Eppure non mi libererai senza ricompensa, ma ti rivelerò una
cosa davvero importante, Zeús».
Zeús: «Tu mi vuoi abbindolare con dei bei discorsi,
Promētheús».
Promētheús: «E che vantaggio ne avrò? In futuro non ti scorderai
mica dov'è il
Caucaso, né ti mancheranno le catene, se verrò sorpreso a macchinare qualcosa».
Zeús: «Di' prima quale ricompensa così importante per noi pagherai».
Promētheús: «Se ti dirò lo scopo per cui adesso sei in viaggio, sarò
per te degno di fede anche quando ti predirò il resto?»
Zeús: «Come no?»
Promētheús: «Vai da Téthis per giacere con
lei».
Zeús: «Di questo sei a conoscenza: e che cosa accadrà in seguito? Mi
sembra che dirai qualcosa di importante».
Promētheús: «Non unirti alla figlia di Nēreús, Zeús.
Se resterà incinta di te, il figlio che darà alla luce ti farà le stesse cose
che tu hai fatto...»
Zeús: «Dici che sarò scacciato dal mio dominio?»
Promētheús: «Che non accada, Zeús. Se non
che l'unione che lei minaccia qualcosa del genere.
Zeús: «Tanti saluti a Téthis, allora. E in
quanto a te, grazie a queste notizie, che Hḗphaistos
ti liberi». |
|
Loukianós hò Samosateús:
Theṓn diálogoi [5] >
Promēthéōs kaì Diós |
Ciò che traspare da questo raffronto, è che il mito
prometeico, in Grecia, ha rielaborato il rapporto tra la
liberazione del titán e la fine del mondo.
L'incatenamento del prometeo è, dovunque, garanzia della
continuità del mondo che noi conosciamo. Alla sua liberazione,
corrisponde la fine dell'ordine cosmico e il ristabilimento del
tempo primordiale. Quest'ultimo è caratterizzato dal ritorno a
uno stato che potremo chiamare «di natura», e quindi coincidente
con la fine
della società umana, con le sue necessità del lavoro e del
matrimonio. Si tratta di quello che, in gergo
religioso-filosofico, più che mitologico, è definito come «apocatastasi»:
ritorno allo stato originario.
Poiché è il dio supremo a garantire l'attuale stato delle cose, l'apocatastasi
è possibile solo abbattendo il suo dominio. Ciò è visto, in molte tradizioni,
come un ulteriore passaggio di consegne della suprema regalità. In Scandinavia,
Loki ha sia la funzione di esiliare
agli inferi il futuro re dell'universo, ma anche quella di sgombrare il campo
per il suo ritorno, causando la fine del mondo e la caduta degli dèi. Il
pensiero teologico greco, che pone l'autorità di Zeús
come stabile ed eterna, ha invece rielaborato questo mito, eliminando in primis
ogni idea di un futuro ristabilimento dell'età aurea sotto gli auspici di un
futuro sovrano.
Mentre
Loki causa la morte del figlio di
Óðinn,
Promētheús impedisce la nascita del figlio di Zeús.
Assassinio e aborto sono, ai fini del processo mitico, rielaborazioni dello
stesso concetto. Nell'elaborazione dei due miti, tuttavia, il rapporto di
causa/effetto è praticamente rovesciato, e con effetti contrapposti: il misfatto
di
Loki produce il suo incatenamento,
l'avvertimento di
Promētheús la sua liberazione. D'altra parte, mentre la futura
liberazione di
Loki produce la fine del mondo e
del regno di
Óðinn, la liberazione di
Promētheús, espressa come evento mitico concluso, ha prodotto
l'attuale stabilità del mondo e la continuazione indefinita del regno di Zeús.
|
| CONCLUSIONE PROVVISORIA Ed eccoci arrivati alla fine di questa
vertiginosa sarabanda di prometei.
Dovunque ci è parso di udire frammenti sempre uguali e sempre diversi di una
medesima, perduta sinfonia. Abbiamo seguito molte piste e ognuna non ha fatto
che dividersi in sempre nuovi sentieri. Alcuni li abbiamo seguiti, altri li
abbiamo dovuti tralasciare: per quanto affascinanti, ci avrebbero
irrimediabilmente portato fuori strada. Più volte abbiamo forzato quella cautela che lo studio
della mitologia richiede a chi cerchi di dipanarne i fili: il rischio è di
lasciare prendere dalla vertigine delle affinità e di mettere tutto in
correlazione con tutto, fino a perdere di vista il rigore necessario per
evidenziare le relazioni davvero significative.
Abbiamo esposto una visione abbastanza variegata dei molti esiti del mito del
prometeo incatenato. L'estrema varietà e vastità della materia, oltre alla
fondata possibilità che il nostro materiale non sia esaustivo,
soprattutto sul versante caucasico, rendono difficile arrivare a delle conclusioni definitive.
Quanto segue è da intendere come un'ipotesi di lavoro, peraltro modificabile o
migliorabile qualora sovvengano nuovi dati o nuove idee, o vengano rilevati degli errori.
Uno sguardo generale del dossier prometeico mostra due classi di
elaborazione, che potremmo definire, in maniera generale, indoeuropea e
caucasica.
- Elaborazione indoeuropea (EI).
Attestata in Grecia (Promētheús), Scandinavia (Loki),
Ossezia (Syrdon).
Il prometeo è un
imbroglione: un personaggio astuto, anarchico, deciso a
sfidare l'autorità e l'ordine divino. Il mito comune, sotteso a queste tre
aree, sembra svolgersi in modo simile a questo:
- Origine. Un imbroglione, associato ai nemici degli dèi, viene accolto
nel pántheon.
Vicenda particolare. Un animale viene abbattuto per un banchetto.
L'imbroglione è chiamato a fare la parti. La cottura non può essere
portata a termine perché qualcuno sequestra o rende inoperante il fuoco.
L'imbroglione parte a recuperare il fuoco.
- Incatenamento. L'imbroglione viene punito e incatenato in un luogo posto tra il
cielo e la terra e/o in una caverna.
Liberazione. La liberazione dell'imbroglione è collegata a un motivo
escatologico: il personaggio è destinato a liberarsi
alla fine del mondo, in uno schema di successione nella regalità universale
e di ritorno dell'età aurea.
- Elaborazione caucasica (EC).
Attestata nel Caucaso, presso Georgiani (Amirani) Abxasi (Abryskʼyl)
e Circassi (Teʒau, Nesren);
escludiamo qui la versione armena.
Il prometeo è un campione: un guerriero invincibile,
superbo, che sfida dio in combattimento. Il mito comune, sotteso
all'area caucasica, si svolge in modo simile a questo:
- Vicenda particolare. Il campione percorre una via di combattimenti
contro nemici umani e soprannaturali sempre più forti, accrescendo il
proprio valore e le proprie capacità guerriere. Giunto al massimo del suo
valore, il campione sfida l'autorità del dio supremo.
- Incatenamento. Il campione viene incatenato in una caverna, e/o
sulla cima di montagne altissime, in un luogo posto tra il cielo e la terra.
Liberazione. La liberazione del campione è collegata a un motivo
escatologico: il personaggio è destinato a liberarsi
alla fine del mondo, in uno schema di distruzione o restaurazione.
Le due classi di elaborazione sono differenti innanzitutto nella psicologia
del personaggio, che è un imbroglione nella EI, ma un campione
nella EC. Divergono poi nella vicenda generale (punto A). A un
mito specifico, che nella EI comprende un inganno nella spartizione di
un animale, con sequestro e rielaborazione del fuoco, le EC sostituiscono
una carriera eroica, il cui disegno appare di impronta nazionalista nella versione abxasica,
ma è per lo più tratto dal mito indoiranico del dio-tuono in quella georgiana.
Nell'una e nell'altra classe, rimane il motivo finale della sfida all'autorità
del dio supremo, sebbene virata funzionalmente: sul piano dell'intelligenza
nella EI, della forza guerriera nella EC.
Le due classi di elaborazione coincidono invece nei temi dell'incatenamento
e della liberazione escatologica (punto B). È questo il nucleo
centrale del mitema prometeico, a cui dobbiamo ora cercare di trovare
un'interpretazione storica.
L'ampia diffusione geografica (Grecia, Ossezia, Scandinavia), mostra
l'antichità della EI, la quale è stata probabilmente diffusa in luoghi
tanto lontani insieme alla diaspora indoeuropea. D'altra parte, la EC è
assai più concentrata geograficamente, ma non per questo è da considerarsi più
recente. Poiché il tema B
(incatenamento e liberazione escatologica) presenta schemi
strettamente confrontabili nelle due elaborazioni, dobbiamo presumere una sua diffusione
nell'una o nell'altra direzione. Ma in quale? (a) Caucaso →
Indoeuropei, o (b) Indoeuropei → Caucaso?
(a) Caucaso → Indoeuropei. Se il tema B
fosse originario del Caucaso, il suo passaggio al mondo indoeuropeo dovrebbe
essersi svolto ben prima della diaspora indoeuropea, il ché ci
ricondurrebbe senza alcun dubbio a un'epoca antichissima. Questa ipotesi implica anche una
vicinanza geografica tra proto-caucasici e proto-indoeuropei.
(b) Indoeuropei → Caucaso. Il passaggio inverso comporta meno problemi, vista la
compattezza geografica dell'area caucasica. In tal caso, il tema B
può essere arrivato nel Caucaso dall'una e/o dall'altra di due direzioni: da
nord, insieme agli Sciti, Sarmati, Alani, Osseti; ovvero da sud, dal mondo
iranico.
Il Caucaso ha certamente assorbito dei complessi mitici di origine indoeuropea,
in particolare alcuni miti relativi alla carriera del dio-tuono.
È assai probabile che siano arrivati dall'Īrān e/o dall'Armenia (pur
senza escludere la mediazione di Alani, Sciti e Sarmati). Infatti:
- Īrān. Aži Dahāka è un personaggio
piuttosto stratificato, in cui si fondono sia il mitema del tricefalo che il
tema del prometeo incatenato. Ben conosciuto in Armenia, sia nella versione
persiana che in quella locale, questo mito è sicuramente strabordato anche nel
Caucaso.
- L'Armenia conosce sia il tema del tricefalo (Aždahāk)
che quello del prometeo incatenato fino alla fine del mondo (Artawazd).
Entrambi i racconti sono arrivati a noi nella versione evemerizzata di Movsēs
Korenacʻi, dove i temi mitologici sono stati adattati alla necessaria
verosimiglianza della cronaca storica. È ragionevole presumere che
nell'antichità il racconto fosse mitico a tutti gli effetti.
Il tema caucasico dell'incatenamento del campione fino a un futuro
escatologico potrebbe essere arrivato nel Caucaso sia dall'Īrān che
dall'Armenia. Un'influenza iranica è evidente nello stesso mito di
Amirani. L'episodio della lotta contro il dev
tricefalo
Baqʻbaqʻ, le cui teste mozzate generano
tre mostruosi serpenti, o vešapʻebi, è evidentemente derivata
dalla figura di Aži
Dahāka, nelle sue varie evoluzioni letterarie (il tricefalo avestico;
il dèmone pehlevico che genera nuguli di serpenti; il re persiano con i
serpenti che crescono dalle spalle); ma si può anche pensare al tricefalo
indiano
Viśvarūpa
dal cui cadavere nasce il serpente
Vṛtra. (Il motivo di
Vṛtra che ingoia Indra,
non attestato in Īrān, è presente nel mito di
Amirani).
Detto questo, il racconto georgiano tiene ben separati i personaggi del
tricefalo (Baqʻbaqʻ) e dell'incatenato (Amirani),
segno di un'ideologia che tendeva ad identificare
Amirani nell'avversario del tricefalo e non nel tricefalo stesso. Non dimentichiamo che i popoli caucasici
non sono indoeuropei, e quindi non ragionano secondo le categorie funzionali
indoeuropee. Nel mondo indoiranico – e indoeuropeo in generale –
l'avversario del tricefalo è di solito un personaggio di seconda funzione, un
guerriero legato alla sfera del dio-tuono, se non il dio-tuono stesso. Ciò
spiega perché
i Georgiani lo sentissero assai vicino alla loro sensibilità eroica che non il tricefalo
stesso.
E sebbene in origine il prometeo fosse un personaggio ben distinto dal dio-tuono,
i Georgiani finirono per cucirgli addosso l'episodio dell'abbattimento del tricefalo. Nulla di cui stupirsi se, nell'elaborazione del tema prometeico,
la sfida al dio supremo sia slittata dalla prima alla seconda funzione, ovvero dal campo dell'intelligenza a quello della
forza guerriera.
Rimane il fatto che i Georgiani, a differenza degli iraniani, non
confondono mai il tricefalo e l'incatenato. La medesima situazione sussiste
in Armenia, dove i due ruoli sono affidati a personaggi distinti,
rispettivamente Aždahāk e
Artawazd. È dunque assai probabile che i due miti
siano arrivati in Georgia separatamente o già separati. Quindi: o per tramite
armeno, o in una versione indoiranica più antica di quelle attestate in
letteratura.
L'EC del campione incatenato dovranno quindi essere considerate
varianti locali del mitema indoeuropeo, inserite negli ambiti mitologici dei
popoli caucasici e opportunamente adattati alla loro ideologia guerriera.
L'EI dell'imbroglione incatenato è sparsa in un ambiente più vasto: in Ossezia, in Grecia, in
Scandinavia. Versioni analoghe sono presenti anche in Īrān e, forse, in India.
Le differenze sono più marcate, forse perché più antiche, o forse perché la
distanza geografica e le influenze di substrato hanno loro permesso di
divergere maggiormente.
Tentiamo di costruire uno schema per evidenziare le possibili correlazioni tra
quanto abbiamo scoperto confrontando gli esiti scandinavo, greco e ossete, da
noi considerati omologhi; teniamo conto solo accessoriamente e con prudenza
delle versioni iranica e indiana, forse soltanto analoghe, in quanto possono avere assorbito e
conservato motivi omologhi.
- Un personaggio appartenente alla schiera dei nemici degli dèi (asura,
titán, jǫtunn, etc.), entra a far parte del pántheon. Il prometeo in questione ha un carattere generalmente
negativo, con sfumature che possono cangiare da una sorta di astuzia
capricciosa (Promētheús,
Syrdon) a una malvagità senza limiti (Aži Dahāka).
- Una volta entrato nel pántheon, il prometeo imbroglia sulla
spartizione delle offerte sacrificali, o sulla divisione del cibo,
danneggiando coloro che lo hanno accolto. Questo mito è legato al
tema del sequestro e della riconquista del fuoco, presente
in Grecia, in Ossezia e in Scandinavia (il tema manca del tutto nel mondo indoiranico).
- L'intenzione del prometeo è eversiva: intende scardinare l'ordine cosmico e mettere in dubbio, se non
rovesciare, l'autorità imposta dagli dèi.
- Il prometeo viene incatenato (all'axis mundi?) e relegato ai
confini dello spazio. Animali come aquile e serpenti sono legati alla
sua sorte, secondo modalità diverse.
- Il prometeo riceve la visita del dio-tuono.
- In un futuro escatologico, il prometeo si libererà dalle sue catene, deciso a
distruggere il mondo, e dovrà essere abbattuto. Intanto
ha messo in moto un meccanismo che porterà alla distruzione
dell'universo e all'apocatastasi finale, con ristabilimento dell'età
aurea. Questo motivo è presente in tutti gli esiti indoeuropei, con le
seguenti eccezioni: in India
fa parte di una cosmologia ciclica, e non è legato a personaggi
specifici; in Grecia è stato alterato secondo modalità caratteristiche.
In uno schema siffatto, l'innovazione più netta risulta proprio quella
presente nella mitologia ellenica. Mentre i prometei indoeuropei sono
essenzialmente personaggi eversivi, il Promētheús ellenico, nel suo impeto di ribellione
contro l'autorità costituita, si rivela una figura positiva, eretta a
difesa del genere umano. Peraltro Promētheús è
anche considerato creatore degli uomini: un motivo caratteristico della
Grecia, che non troviamo in altri luoghi del dominio indoeuropeo. Questa visione
di un Promētheús filantropo, fondata soprattutto da Aischýlos, ha
reso difficile agli studiosi associarlo a tutta una categoria di dèmoni, giganti e
anti-dèi che devono venire eliminati o incatenati per impedire loro di
distruggere l'ordine cosmico.
A che cosa si deve questo rovesciamento? A nostro parere, al fatto che il mito greco
ha risentito
di una forte influenza medio-orientale, mesopotamica in particolare, dove la figura di
Zeús ha assorbito parte del mito di Enlil
«nemico degli uomini». Per contrasto, Promētheús ha assorbito la mitologia di
Enki, il dio della sapienza, il difensore degli
uomini, e diviene dunque
il creatore e l'amico del genere umano. Questa interprætatio babylonica
di Promētheús era probabilmente giustificata
sia dai tratti di astuzia e conoscenza che caratterizzavano entrambi i
personaggi, sia dalla faccia tosta con la quale entrambi sfidavano l'ordine
imposto dal dio supremo. Non siamo sicuri se mettere nel mazzo anche un comune
ruolo di eroi culturali, inventori di tecniche e strumenti, che
Promētheús potrebbe aver tratto da
Enki. Il risultato è che l'hýbris di
Promētheús assume in Grecia un senso etico, e
il suo incatenamento viene composto contro la giustizia.
L'ordine imposto dagli dèi, in Mesopotamia, era visto come un'imposizione indifferente al destino umano, e l'unico tipo di
rapporto tra uomini e dèi non era di natura etica, ma quasi di schiavitù. È
proprio grazie a Promētheús se il rapporto tra uomini
e dèi, in Grecia (e in tutto l'occidente) si è poi trasformato in una relazione
contrattuale.
Questo studio lascia molte domande aperte, a cui speriamo di poter fornire
qualche ipotesi in futuro. Tra di esse:
- L'ambivalenza tra incatenamento sotterraneo e incatenamento aereo. Quasi
tutti i personaggi riescono a realizzare in qualche modo entrambe le modalità.
Sono semplici varianti di un medesimo tema, oppure miti separati?
- Il significato dell'aquila e del serpente, e la relazione tra loro.
- Il rapporto tra Promētheús ed
Átlas. Duplicazione di un medesimo personaggio... o
qualcosa che non sappiamo?
- La funzione del dio-tuono nel mito prometeico. Perché proprio
Thorkillus ed Hērakls
fanno visita ai prometei incatenati? Si può forse pensare a una relazione con il
mito indoiranico del tricefalo, abbattuto dal un esito del dio tuono, come
Θraētaona o Indra?
|
|