|
ỺYFR TALIESIN |
| LVI |
|
Canu y byd bychan |
|
Canto per il piccolo mondo |
|
|
|
|
ỺYFR TALIESIN |
|
LVI |
|
Canu y byd bychan |
|
Canto del piccolo mondo |
|
|
|
LA COMPOSIZIONE La composizione
Canu y
byd bychan,
è un breve poema di 22 versi contenuto nel Ỻyfr Taliesin
(nlw Peniarth,
ms. 2, prima metà
del xiv
sec.), al folius 38 (pagina 80). Il titolo è
riportato in inchiostro rosso sul lato destro dell'incipit:
<Kanu ybyt bychā>. Il
Canu y
byd bychan
(«Canto del piccolo mondo») è una composizione erudita,
di carattere gnomico-sapienziale, incentrata sulla
questione cosmologica di chi o cosa tenga sospeso il
mondo nel vuoto dello spazio. L'argomento viene
introdotto attraverso una serie di domande retoriche in
cui il poeta s'interroga sull'apparente fragilità del
kósmos. Alle domande non segue però un'immediata
risposta, bensì una serie di tre esclamazioni introdotte
dalla formula Byd mor yỽ...: «il mondo,
quant'è effimero!» [12],
«...meraviglioso!» [15],
«...straordinario!» [17], a
ribadire la sorpresa del poeta di fronte al mistero
della permanenza e della solidità della Terra. Una
risposta complessiva ai vari dilemmi postulati nella
composizione, viene data solo negli ultimi quattro versi:
sono i quattro evangelisti, Matteo, Giovanni, Luca e
Marco a sostenere il mondo con la grazia dello Spirito.
Il redattore del manoscritto del Ỻyfr Taliesin
ha posto il
Canu y byd bychan subito dopo il
Canu y byd maỽr
(«Canto del grande mondo»), associando tra loro i
due poemi anche grazie l'artificiosa complementarietà
dei titoli che gli ha attribuito. Entrambi svolgono
infatti argomenti cosmologici, sebbene con diversi
intenti: nel poema precedente (il
Canu y
byd maỽr) la struttura del kósmos
viene messa in relazione con la fisiologia umana; nel
presente (il
Canu y byd bychan), la solidità del mondo
fa parte di un progetto universale di salvezza.
A differenza del
Canu y byd maỽr,
che negli ultimi versi cita
Taliesin come suo compositore, il
Canu y
byd bychan non reca alcuna indicazione in
tal senso. Ciò nonostante, l'edizione del
Myvyrian Archaiology of
Wales, conclude postponendo alla composizione la
dicitura, assente nel manoscritto, «Taliesin a'i cant»
(Myfyr ~ Pughe 1801-1807).
Tale indicazione deve essere stata presa sul serio da
alcuni dei primi interpreti, ad esempio da David William
Nash, che ne riporta la traduzione «Taliesin
sung this», ponendola subito dopo il verso
[18]. Egli ritiene infatti
che gli ultimi quattro versi, dove vengono citati gli
evangelisti, non appartengano alla tradizione
talgesiniana originale, ma siano stati aggiunti da una
diversa mano per ragioni apologetiche
(Nash 1868). Tale ipotesi è
però da scartare, in quanto, come vedremo ora, la
presenza degli evangelisti nell'ambito di questa
composizione fa parte di una tradizione
poetico-sapienziale assai ben attestata nella
letteratura tardo-latina e medievale.
John Gwenogvryn Evans, nella sua traduzione del Ỻyfr Taliesin,
ignora questo canto, insieme ad altri di natura
teologica, assegnandolo al secondo o terzo quarto del
xiii
secolo (Evans 1915). |
|
UN INNO ALLA STABILITÀ
DELLA TERRA La questione del «sostegno del mondo»
è un mitema assai diffuso nei miti di tutto il mondo, e
sul quale nel corso della storia si sono accumulate
immagini fantasiose e bizzarre. Senza andare troppo
lontano, è stato notato come il
Canu y byd bychan si inserisca in un
genere letterario assai diffuso nel Medioevo, e del
quale sono stati rilevati un buon numero di paralleli.
Sebbene il presente testo sia composto di un certo
numero di domande a cui si dà risposta soltanto alla
fine, le affinità più strette sono state rinvenute in
alcuni dei cosiddetti Ioca monachorum, scritti in
Gallia a partire dai secoli
VI-VII,
consistenti in una serie serrata di domande e risposte su
argomenti sapienziali e religiosi. Il testo
più antico è l'Altercatio
Adriani et Epictiti, dove leggiamo:
|
Quid sustinet caelum? — Terra
Quid sustinet terra? — Aqua
Qui sustinet aqua? — Petra
Quid sustinet petra? — Quattuor animalia habentes alas, hoc sunt Marcus,
Matheus, Lucas et Iohannes.
Qui sustinet quattuor animalia? — Abyssus.
Qui sustinet abyssum? — Arbor qui ante initium mundi ad radice positus est et
omnia continet; ipse est Dominus Deus noster. |
|
|
Altercatio Adriani Augusti et Epicteti philosophi [12-19] |
Si conoscono di questo testo numerose versioni,
anche in lingue diverse dal latino; sono attestati paralleli in provenzale,
in serbo (Slovo o nebesi i
o zemli), in bulgaro, e in medio-inglese
(The wyse chylde of thre yere old). È pure
conosciuta una versione gallese del
xvi
secolo. Se nell'Altercatio
latina
è l'albero primordiale, esplicita metafora della
presenza divina, a fungere da
sostegno finale e definitivo all'universo, il
Canu y byd bychan, forse con maggior
raffinatezza, conclude la serie al livello dei
quattro evangelisti, che reggono il mondo con la
grazia dello spirito. Questa soluzione manca nell'Altercatio
latina,
ma è presente, ad esempio, nella traduzione
provenzale, dove l'albero cosmico è sostenuto «am
lo comandamen de nostre senhor Ihesu Christz et am
la gracia del sant esperitz»
(Köhler 1879-1880, Suchier
1955, Haycock 2007).
Un interessante punto di distacco tra il
Canu y byd bychan e l'Altercatio
è che nel testo non sono gli evangelisti a
sostenere il mondo ma in realtà i quattro tetramorfi
alati, ovvero gli esseri angelici in forma di uomo, leone, toro e aquila che,
sebbene dopo molte indecisioni iniziali, hanno finito
per simboleggiarli. Le immagini dei tetramorfi risalgono
ai
kǝrûḇîm, gli angeli che
precedono la visione del carro divino in Yǝḥẹzqêl,
esseri con quattro ali e i piedi simili a zoccoli d'un
bue, lucenti quali bronzo fuso; davanti in aspetto
umano, a destra di leone, di bue a sinistra e infine
d'aquila (Yǝḥẹzqêl [1: 4-24]).
I tetramorfi ricompaiono nell'Apokálypsis
di Giovanni, dove sono chiamati zṓıdia, in latino
animalia, sono pieni d'occhi, davanti e di
dietro, e circondano il trono divino. Questa volta però
il loro aspetto è singolo: «il primo di essi è simile a
un leone, il secondo è simile a un vitello, il terzo ha
il volto che sembra d'un uomo e il quarto è simile a
un'aquila che vola» (Apokálypsis
[4, 6-9]).
L'associazione tra i tetramorfi e gli evangelisti risale
ai primi Padri della Chiesa: Irenaeus, vescovo di Lione,
è forse il primo autore a parlare di un «vangelo
quadriforme» costituito dai quattro testi canonici, a
loro volta con i quattro zṓıdia/animalia
giovannei (Adversus
haereses). E sebbene la precisa correlazione
tra i quattro tetramorfi e gli evangelisti sarà soggetto
a molte indecisioni e ripensamenti, alla fine l'uomo, il
leone, il vitello e l'aquila finiranno per simboleggiare
rispettivamente Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Il
dettaglio dei tetramorfi è particolarmente
significativo, nel nostro contesto, per il fatto che le
più antiche rappresentazioni cosmologiche –
rintracciabili ad esempio in Mesopotamia, Egitto, e Grecia –
sembrano porre un gruppo di immagini zoomorfe
compatibili con i zṓıdia/animalia (soprattutto
il toro e il leone, ma anche l'aquila e il serpente), a guardia delle
porte da cui il sole sorge o tramonta. Immagini simili
appaiono fortemente associate quelle degli angeli
guardiani delle porte del cingulus mundi,
presenti tanto nella cosmologia islamica tanto in quella
giudaico-cristiana (cfr.
Apokálypsis [7, 1]).
Alla base delle immagini dei tetramorfi vi è dunque il
mitema dei quattro geni guardiani posti ai quattro
angoli del mondo (che non coincidono con i punti
cardinali, ma con le porte solstiziali attravesro le
quali il sole sorge e tramonta). Traslati, nelle figure
degli evangelisti, come «pilastri» della Chiesa,
nondimeno essi hanno conservato la loro antica funzione
di custodi della stabilità della Terra. |
|
|
|
|
|
|
Lezione dal
ms. del Ỻyfr Taliesin |
|
80:6
80:7
80:8
80:9
80:10
80:11
80:12
80:13
80:14
80:15
80:16 |
|
Kanu
in ꟊeneis kanaf. byt vn
ybyt bychā
ꝺyꝺ mỽyaf. lliaỽſ abỽyllaf ac abꝛꝺe
raf. kyfarcaf y veirꝺ byt pꝛyt nam
ꝺyweit
py ꟊyneil ybyt. na syrt
yneiſſywyt. Neur
byt bei syrtei. py aryt ꟊỽyꝺei. Pỽy
aeꟊoꟊy
nalei. Byt moꝛ yỽ aꝺuant. pan syrt
yn
ꝺiuant etwa ynꟊeuꟊant. Byt moꝛ yỽ
ryfeꝺ.
na syrt yn vn weꝺ. Byt moꝛ yỽ oꝺit.
moꝛ
vaỽꝛ yt letrit. Joannes. Mateuſ.
Lucas. a
Marcuſ. ỽy aꟊyneil y byt trỽy rat
yr yſpꝛyt. |
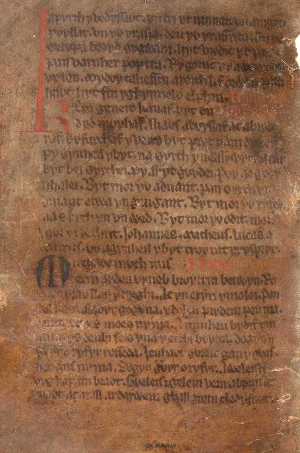 |
| Kanu y byt bychan |
Pagina dal Ỻyfr
Taliesin
nlw Peniarth, ms. 2. folius 38 (p. 80) |
|
|
|
|
|
|
Canu y byd
bychan |
Canto del
piccolo mondo |
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 |
|
Cein geneis
canaf
bed un ddydd mỽyhaf.
Ỻiaỽs a bỽyỻaf
ac a bryderaf.
Cyfarchaf y feirdd byd.
pryd nam dyỽëid
py gynheil y byd.
Na syrch yn eisyỽyd?
Neur byd pei syrchei
py ar yt gỽyddei?
Pỽy ae gogynhalei?
Byd mor yỽ adfant
pan syrch yn difant.
Etỽa yn geugant,
byd mor yỽ rhyfedd
na syrch yn unỽedd.
byd mor yỽ odid
mor faỽr yt ỻethrid.
Johannes, Matheus,
Lucas a Marcus.
Ỽy a gynheil y byd
trỽy rhad yr Yspryd. |
Abilmente ho
cantato e canterò
fino al giorno più grande.
Molto rifletto
e mi tormento.
Mi rivolgerò ai bardi della terra
finché non mi direte
che cosa sostiene il mondo.
Perché non cade nel nulla?
O, se il mondo cadesse,
su cosa cadrebbe?
Chi lo sosterrebbe?
Com'è effimero il mondo,
pencolante sull'abisso!
Ma ancora, in verità,
com'è straordinario il mondo
che nondimeno non crolla!
Com'è meraviglioso il mondo,
[che] così tanto riluce!
Giovanni, Matteo,
Luca e Marco:
loro sostengono il mondo
con la grazia dello Spirito. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỺYFR TALIESIN |
|
LVI |
|
The
Song of
the Little World |
|
English Translations |
|
|
|
|
|
|
The Song of the Little World |
|
Translation of William Forbes
Skene |
|
|
The Little Song of the World |
|
Translation of David
William Nash |
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 |
|
The beautiful I sing of, I will sing.
The world one day more.
Much I reason,
and I meditate.
I will address the bards of the
world,
since it is not told me
what supports the world,
that it falls not into vacancy.
Or if the world should fall,
on what would it fall?
Who would uphold it?
The world, how it comes again,
when it falls in decay,
again in the enclosing circle.
The world, how wonderful it is,
that it falls not at once.
The world, how peculiar it is,
so great was it trampled on.
Johannes, Mattheus,
Lucas, and Marcus,
they sustain the world
through the grace of the Spirit. |
The song I have
sung, I sing
of the world one day more.
Much I reason,
and anxiously consider.
I address those who are Bards,
seeing that it is not told me
what sustains the world,
that it does not fall upon the
stars:
or, if it were to fall,
upon what would it fall,
who would sustain it?
The world, great its desctruction,
when it shall fall into decay;
yet it is certain (to do so).
The world, great is the wonder
that it does not fall on one side.
The world, great its perfection,
very great its motionless condition.
Taliesin
sung this.
[John and Matthew,
Luke and Mark,
it is they who uphold the world
through the grace of the Holy
Spirit.] |
|
|
|
|
Traduzioni: [Download]▼ |
|
|
|
NOTE
1 <ein
ꟊeneis kanaf> | Cein geneis
canaf.
- L'aggettivo
cein vuol dire «bello, eccellente, raffinato»,
mentre geneis e canaf
sono due voci del verbo del verbo canu,
«cantare», prima persona singolare: rispettivamente
indicativo perfetto e presente, quest'ultimo con
valore di futuro. Da qui la diretta traduzione di
William Forbes Skene, che considera sostantivato
l'aggettivo e giustappone due periodi principali: «The
beautiful I sing of, I will sing»
(Skene 1868). David
William Nash introduce invece una relativa: «The song I have
sung, I sing»
(Nash 1868). Secondo
Marged Haycock, l'aggettivo cein è usato
avverbialmente: «I have sung skilfully, [and] i
shall sing»
(Haycock 2007). Lezione
che seguiamo volentieri.
2 <byt
vnꝺyꝺ mỽyaf>
| bed un ddydd mỽyhaf.
- Sia Skene e Nash traducono questa verso come «(of)
the world one day more», facendone l'oggetto del
«cantare» del verso precedente.
(Skene 1868 | Nash 1868).
Tale traduzione presenta tuttavia due problemi:
inanzitutto il verbo canu non può avere come
oggetto diretto l'argomento del «cantare» ma
richiederebbe una proposizione, nella forma canu
am o canu y (Haycock
2007);
inoltre mỽyhaf è superlativo di maỽr,
«grande», non avverbio. La Haycock tenta di
risolvere emendando byd, «mondo», in
bed, «fino»: «until the greatest single
Day» (Haycock 2007).
Il riferimento è ad
Apokálypsis [8: 2],
dove il «grande giorno» è il giorno del Giudizio.
4 <ac
abꝛꝺeraf>
| ac a bryderaf
- Il verbo bryderaf esprime l'atto del
meditare in termini gravi e preoccupati, può venire
tradotto con «essere in ansia per, esitare, temere,
pentirsi».
8 <na
syrt yneiſſywyt> | Na syrch yn eisyỽyd
- Il termine <eissyỽyt>, eisyỽyd, è
corradicale con il latino exiguitas, ed ha
per significati principali «mancanza, assenza,
bisogno, necessità, indigenza». La traduzione con
«vuoto», efficace ma moderna, è stata già sostenuta
da Skene: «that it falls not into vacancy»
(Skene 1868), e oggi
ripresa in modo assai raffinato dalla Haycock: «so
that it does not fall into oblivion?»
(Haycock 2007).
Riportiamo per curiosità la sorprendente traduzione
di Nash: «that it does not fall upon the
stars»
(Nash 1868).
12 <Byt
moꝛ yỽ aꝺuant> | Byd mor yỽ adfant
- Il gallese adfant come
sostantivo vuol dire «evanescenza, vacuità»; come
aggettivo «incerto, transiente, vano», ma anche
«triste». La sintassi di questo verso presenta la
formula mor («come, quanto») + copula, che,
seguita da un aggettivo, assume il senso di
«quant'è...!», «com'è...!». La Haycock traduce
quindi «how futile is the world»
(Haycock 2007). Skene,
d'accordo con la costruzione, traduce tuttavia
l'aggettivo con un verbo: «The world, how it comes again»
(Skene 1868). Nash
emenda mor («come, quanto») con maỽr
(«grande»), ma la sua traduzione ha un suo senso: «The world, great its desctruction»
(Nash 1868). La
medesima sintassi ritornerà ai vv.
[14] e
[17].
13 <pan
syrt ynꝺiuant> | pan syrch yn difant
- Il sostantivo gallese difant
può significare «perdizione, dissoluzione,
annientamento», ma anche «vuoto, abisso». Il primo
significato è reso dai traduttori storici
«when it
(shall) falls in decay»
(Skene 1868 | Nash 1868).
La Haycock sottolinea l'ambiguità del verso: «that
falls into the void/perdition» (Haycock
2007).
Il significato preciso del verso dipende dal senso
che diamo a pan, «quando, al tempo che, non
appena, nel caso che». Il senso dei vv.
[12-13] sembra essere
dunque: «quant'è effimero il mondo, sempre sul punto
di cadere nell'abisso».
14 <Byt
moꝛ yỽ ryfeꝺ> | byd mor yỽ rhyfedd.
- Sebbene questo verso ripeta la medesima sintassi
del precedente v. [12],
rimane di significato piuttosto ambiguo a causa
delle sfumature dell'aggettivo rhyfedd,
che se nel suo significato principale può essere
inteso come «straordinario, sorprendente,
meraviglioso», anche nel senso di «grande, immenso
eccessivo», dall'altro può acquisire il senso di
«strano, bizzarro, grottesco». Analizzando
l'ermeneutica di questo singolo verso, si porterebbe
a ipotizzare una soluzione semplice e immediata
quale «il mondo, quant'è meraviglioso!». Aggettivo
che, nel senso medievale del termine, non escludeva
affatto il grottesco e il bizzarro. Ma vi è il
sospetto che il significato preciso del verso possa
dipendere dal suo contesto e dal modo in cui è
legato ai versi vicini e la mancanza di una
punteggiatura non aiuta. La soluzione più probabile
è che il senso di questo verso si completi con il
successivo v. [15],
dove si attesta che in fondo il mondo non è
destinato a crollare «nello stesso modo» (cioè nel
modo sopra descritto). Non il mondo, dunque, ma
questo fatto potrebbe essere considerato
«meraviglioso» o, per meglio dire, «sorprendente».
Il senso di tutto il passo sembra essere:
«nonostante il mondo sia effimero, soggetto alla
perdizione e sospeso sul vuoto, non è meraviglioso
che non crolli?». Così sembrano interpretare i
traduttori: «The world, how wonderful it is, that
it falls not at once»
(Skene 1868); «The world, great is the wonder
that it does not fall on one side»
(sempre
emendando mor con maỽr)
(Nash 1868). La Haycock
si stacca, sebbene di poco: «how strange is the
world that it does not fall in the same way» (Haycock
2007).
18 <moꝛ vaỽꝛ
yt letrit> | mor faỽr yt ỻethrid.
- Verso particolarmente tormentato a causa della
cattiva qualità del manoscritto. Il
Myvyrian Archaiology of
Wales, ad esempio, leggeva l'ultima
parola del verso come <ſetrit>, cioè sethrid,
«calpestato»
(Myfyr ~ Pughe 1801-1807),
da cui la traduzione di Skene: «so great was it
trampled on»
(Skene 1868). E sebbene
anche Nash accolga la medesima lezione, traduce in
maniera eccessivamente libera: «very
great its motionless condition»
(sempre
emendando mor con maỽr)
(Nash 1868). La Haycock
legge invece la parola come <letrit>, ỻethrid,
indicativo presente, terza persona singolare, del
verbo ỻathru, «brillare»: «how greatly
does it shine» (Haycock
2007).
|
 |
 |
Llyfr Taliesin
by W.F. Skene.
±500 kb |
Llyfr Taliesin
by D.W. Nash.
±500 kb |
Download
Il Ỻyfr Taliesin, tradotto in italiano da Valeria
Muscarà sulle versioni inglesi di William Forbes Skene (1868) e David
William Nash (1868). I due files verranno
aggiornati man mano che verranno aggiunte altre composizioni del Corpus Talgesinianum.
Per il disclaimer, fare riferimento alla pagina
Avviso.
|
Bibliografia
-
BENOZZO 1998. Poeti della marea.
Testi bardici gallesi dal
vi al
x secolo, a
cura di Francesco Benozzo. In «In forma di parole»,
xviii, 2. Bologna, 1998.
-
EVANS 1910. Facsimile & Text of
the Book of Taliessin, a cura di John
Gwenogvryn Evans. Tremban, Llanbedrog 1910.
-
EVANS 1915. Poems from the Book
of Taliessin, cura e traduzione di John
Gwenogvryn Evans. Tremban, Llanbedrog 1915.
-
HAYCOCK 2007. Legendary Poems from
the
Book of Taliesin, a cura di Marged Haycock.
CMCS, Aberystwyth 2007.
-
HAYCOCK 2013. Prophecies from the
Book of Taliesin, a cura di Marged Haycock.
CMCS, Aberystwyth 2013.
-
KÖHLER, Reinhold Köhler, Taliesin's
Little World, in «Revue Celtique», 4, Paris
1879-1880.
-
MacCULLOCH 1988. John A. MacCulloch,
The Religion of Ancient Celts.
Edimburgh 1911. → John A. MacCulloch,
La religione degli antichi Celti. Vicenza
1998.
-
MORGANWG 1862. Edward Williams [Iolo Morganwg],
Barddas. A Collection of
original Documents, illustrative of the Theology, Wisdom
and Usages of the Bardo-druidic System of the Isle of
Britain (2 volls.), a cura di John Williams
ab Ithel (Welsh Manuscripts Society). D.J. Roderick,
London 1862-1874.
-
MORRIS-JONES 1918. Sir John Morris-Jones, Taliesin. In «Y
Cymmrodor», XXVIII. Society of
Cymmrodorion, London 1918.
-
MYFYR ~ PUGHE 1801-1807. Owen Jones [Owain Myfyr], William
Owen Pughe, Myvyrian
Archaiology of Wales (3 volls.)Gwyneddigion
Society / Cymdeithas y Gwyneddigion, London 1801-1807.
-
NASH 1868. David William Nash,
Taliesin; or, the Bards and Druids of Britain.
John Russel Smith, London 1868.
-
PUGHE 1832. William Owen Pughe,
Dictionary of Welsh Language, explained in English
(2 volls.). E. Williams, London 1803; Thomas Gee, London
1849.
- SKENE 1868. William
Forbes Skene, Four Ancient
Books of Wales (2 volls.). Edmonston &
Douglas, Edinburgh 1868.
- STEPHENS ~ EVANS¹ 1849.
Thomas Stephens, Daniel Silvans Evans,
The literature of the Kymry; being
a critical essay on the history of the language and
literature of Wales during the twelfth and two
succeeding centuries, containing numerous specimens of
ancient Welsh poetry in the original and accompanied
with English translations. Longmans, London
1849.
- SUCHIER 1955. Das
mittelateinische Gespräch Adrian und Epictitus nebst
verwandten Texten (Joca Monachorum), a cura
di Walther Suchier, in «Gesellschaft für romanische
Literatur», 24, Tübingen 1955.
|
|
BIBLIOGRAFIA ► |
|
|
|
Biblioteca -
Guglielmo da
Baskerville.
Area Celtica -
Óengus Óc. |
Traduzioni
dall'inglese di
Valeria Muscarà.
Confronto sul
testo gallese di
Valeria Muscarà,
in
collaborazione
con
Dario Giansanti.
Si ringrazia
Colin Parmar
per i
preziosi
suggerimenti. |
|
 |
 |
|
|
Creazione pagina: 20.05.2015
Ultima modifica:
18.01.2019 |
=======
18.01.2019
>>>>>>> 5cbd8780b9b44688f09d997adca8edbccad1f622
|
|
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati |
|