|
EPICA ANTICO-INGLESE |
|
[DĒOR] |
|
[IL LAMENTO DI DĒOR] |
|
|
|
|
Titolo (informale) |
Dēor
«Il lamento di Dēor» |
|
Genere |
Poema storico |
|
Lingua |
Antico inglese |
|
Epoca
|
Composizione:
Redazione: |
|
< 950
X secolo |
|
|
Manoscritti
|
Exeter, Exeter Cathedral Library ms. 3501, ff. 100-100 |
|
|
|
|
|
IL POEMA
Il poemetto di 42 versi allitteranti non rimati noto come
Dēor (presumibilmente dal nome dell'autore,
come ci viene suggerito al v. 37), giuntoci nell'unica redazione dell'Exeter
Book, sui folii 100a-100b da una data difficilmente individuabile (si
pensa comunque a prima del 950) rappresenta uno dei massimi esempi di poesia
antico-inglese, andandosi a inserire in particolare nei filoni elegiaco ed
eroico. Il poema ci racconta della sorte sfortunata di uno scop (lo
scaldo anglosassone) di nome Dēor, il quale, perso
il favore del suo signore, si ritrova a vagare esule, augurandosi che i suoi
dolori possano svanire e paragonando il suo destino a quello di alcuni
personaggi molto rilevanti, che ci permettono di ascrivere il poema al genere
eroico.
Se infatti l'apparente intento dell'autore è quello di
consolare un lettore sofferente e allo stesso tempo lamentare la propria sorte
sventurata, egli lo fa portando a esempio diverse figure fortemente consolidate
nell'ambito della poesia epico-eroica germanica: troviamo infatti il leggendario
fabbro Ƿēland (presente anche in
Bēoƿulf e Ƿaldere
oltre che nella Vǫlundarkviða della
Ljóða Edda) e la
moglie/vittima Beadohild, il crudele
Eormanrīc e un non meglio identificato
Ðēodrīc (forse Teoderico I di Austrasia o il re dei
goti d'Italia).
Nonostante l'abile connubio tra i due generi, ciò che rende
questo poema così importante è senza ombra di dubbio l'atipico utilizzo di un
ritornello (þæs oferēode, þisses sƿā mæg, «quello è passato, possa questo
allo stesso modo»), il quale dà un senso di regolarità al testo poetico, privo
di strofe di uguale lunghezza, e le cui interpretazioni tendono generalmente
verso un intento di tipo pratico, come un ottimistico consiglio erede del genere
della consolatio.
Il ritornello permette inoltre di suddividere il poema in sei
sezioni (o cinque, come vedremo) che tratteremo più approfonditamente nelle
note, ma che per ora possiamo così elencare:
I-II. le sventure di Ƿēland e di
Beadohild, le quali possono essere unite poiché
facenti parte dello stesso mito;
III. le sventure di Mǣðhild e del Gēata
(unici personaggi di difficile identificazione);
IV. le sventure subite o inflitte da Ðēodrīc;
V. le sventure patite dai sudditi di Eormanrīc;
VI. considerazioni generali sulla sventura e lamentatio.
Poiché nonostante la presenza di un'immagine tipica della
poesia scaldica (le serpi intese come spade) il lessico è quello tipico della
poesia antico-inglese, non è chiaro se i numerosi riferimenti a miti e
personaggi presenti in buona parte della poesia nordica siano da intendere come
frutto di influssi scandinavi o come elementi facenti parte della tradizione
narrativa germanica in generale. |
IL MANOSCRITTO
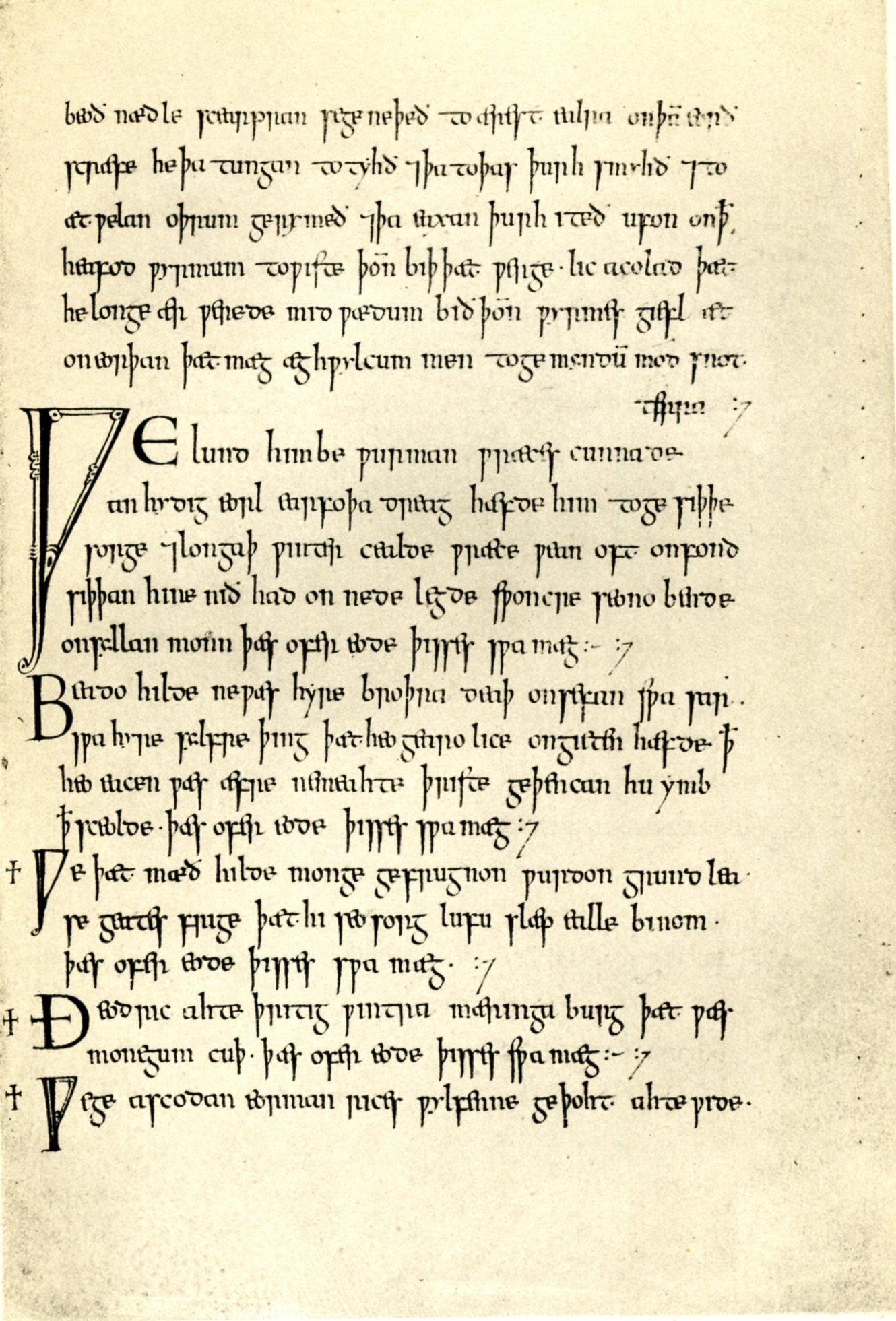 |
| Exeter Book |
ms. 3501, folium
100,
Exeter, Cathedral Library |
Come già detto, il carme ci è
noto attraverso l'unica copia contenuta nell'Exeter Book (Exeter,
Cathedral Library, ms. 3501), il più voluminoso ed eterogeneo tra i quattro
principali codici poetici redatti in antico-inglese (Junius XI, Exeter
Book, Vercelli Book e Cotton Vitellius A xv), il quale
conserva, nonostante alcune lacunae, 34 poemi e 95 indovinelli metrici.
La redazione può essere datata al
975 ca. (Francini 2017), e si pensa che essa sia avvenuta
per opera di un'unica mano. Il volume, donato alla cattedrale da Leofric (morto
nel 1072), primo vescovo di Exeter, viene descritto, nella lista delle donazioni
da lui elargite, come i mycel englisc boc be gehƿilcum þingum on leoðƿisan
geworht («un grande libro inglese su opere poetiche riguardo cose di ogni
tipo»). Il codice è composto da 131 folii, numerati da 1 a 130 a partire
dal secondo foglio. Il codice vero e proprio, così come fu donato da Leofric
nell'XI secolo, è compreso nei folii 8-130, in quanto, in un dato momento
nella sua storia, furono integrati otto fogli aggiuntivi, i quali contengono
documenti legali e vari registri in latino e inglese, scritti da una mano del
XII secolo. Come già detto, il manoscritto ci è giunto in condizioni tutto
sommato buone, nonostante alcune lacunae visibili già a partire dal fol.
8a, raschiato con un coltello. Battaglia, nel descrivere la struttura del
codice, parla di «una sorta di antologia scolastica analoga a un celebre
manoscritto del sec. XI di autori latini […] custodito a Cambridge (University
Library, ms. Gg. 5.35)»
(Battaglia 2016). In effetti, ciò che colpisce di
questo manoscritto, oltre alla sua notevole dimensione, è proprio l'eterogeneità
delle tipologie dei componimenti ivi contenuti, in quanto al suo interno
troviamo lunghi componimenti incentrati sulla figura di Gesù (Crīst,
I-III, generalmente attribuiti a Cyneƿulf), testi di natura agiografica (Juliana,
Gūðlāc A e
B), altri con finalità didattiche
(Anima e corpo, II), i già citati enigmi e,
infine, testi appartenenti a un genere equivocamente etichettato come «elegie
pagane», di cui fa parte proprio il nostro poemetto. Questi componimenti (Errante,
Navigante, Poemetto rimato,
Ƿulf ed Eadƿacer, Lamento
della moglie, Rassegnazione A e
B,
Dēor, Ƿīdsīð,
Messaggio del
marito e Rovina) sono
riflessioni sulla precarietà dell'esistenza incentrate sul tema della privazione
(sia essa della patria, della fama, della famiglia o della felicità in
generale), le quali si sviluppano attraverso un continuo paragone «prima –
adesso» allo scopo di sottolineare la provvisorietà di ogni cosa terrena e
invitare così a una riflessione che può essere sia religiosa, sia laica e
filosofica. |
|
LA QUESTIONE DELL'ORALITÀ Come è ben noto, fino
all'avvento del cristianesimo (ma sarebbe più opportuno dire «fino alle singole
conversioni al cristianesimo»), le culture germaniche sono state culture a
oralità primaria, ossia affidavano alla tradizione orale le loro leggi, i loro
costumi, la loro «storiografia» e, soprattutto, le loro leggende. Leggende che,
spesso e volentieri, andavano mescolandosi con la realtà storica, producendo
racconti mitici che, col passaggio da oralità a scrittura, sono stati
massimamente rappresentati dal fenomeno letterario delle saghe scandinave e, per
esempio, dalla lunga e nutrita tradizione della materia nibelungico-volsungica.
In questi testi non è strano incontrare eroi inventati e divinità insieme a
personaggi la cui reale esistenza è più che assodata (Attila, Teoderico, la
stirpe burgunda etc.). Il poemetto che prendiamo in esame non è da meno e, anzi,
costituisce un documento di fondamentale importanza. L'autore dimostra infatti
di conoscere bene quelle leggende che sono alla base della narrativa germanica,
così come conosce bene la storia «ufficiale», o per lo meno i racconti che da
quella sono stati originati. Se infatti la conoscenza da parte dell'autore di
Dēor dell'opera di Severino Boezio (De
consolatione philosophiae), così spesso e a ragione chiamata in
causa, non è dimostrata da riferimenti precisi, quella delle vicende di Ƿēland
(leggenda) e di quelle di Teoderico (realtà) è ben visibile e assodata. Allora
come mai, ci si potrebbe chiedere, l'autore si sofferma così brevemente sulle
singole vicende? La risposta più probabile è che egli sapesse che gli eventi cui
faceva riferimento erano già parte della cultura orale anglosassone, cosa resa
evidente (se accettiamo la proposta di Malone) dalla sezione su
Mæđhild e il Gēata, che ci sono noti solo
attraverso questo componimento. Che bisogno aveva il nostro scop di
proporre nuovamente la vicenda del fabbro imprigionato, o dell'esilio di
Teoderico? Il pubblico le conosceva già bene, non era quello lo scopo del
componimento. La lunga tradizione orale ha dunque permesso al poeta di creare
immagini tanto vaghe quanto efficaci, perfette per trasmettere il messaggio di
fondo del poema e confermare ancora una volta la «validità» di quelle storie,
vere colonne portanti della cultura popolare germanica. |
|
LA TRADUZIONE La seguente traduzione del
Lamento di Dēor e le relative
note sono state realizzate da Giorgio Lucarelli, il quale si è avvalso
dell'ausilio del testo edito da Kemp Malone per la Metheuen's Old English
Library e di quello edito da W.S.Mackie per The Early English Text Society.
Per quanto riguarda lo studio della lingua, il traduttore si è affidato
all'ottimo manuale (A guide to Old English) di Bruce Mitchell e Fred C.
Robinson, completo di una dettagliata introduzione alla linguistica
anglosassone, di una selezione di brani celebri e di un utile glossario (Mitchell
~ Robinson 2012). Per maggiori dettagli sul lessico, si consiglia
caldamente di consultare il dizionario online Bosworth-Toller. <http://bosworth.ff.cuni.cz/>.
|
|
|
|
| | |
|
| | [DĒOR] |
[IL LAMENTO DI DĒOR] |
| | | | |
|
| 1 | Ƿēlund him be ƿurm{a} ƿrǣces cunnade |
Ƿēland stesso presso le serpi conobbe l'agonia, |
 |
| 2 | anhȳdig eorl, earfoþa drēag, | l'uomo deciso soffrì sventure, |
|
| 3 | hæfde him tō gesīþþe sorge ond longaþ, | ebbe per compagni dolore e anelito, |
|
| 4 | ƿintercealde
ƿræce, ƿēan oft onfond | miseria invernale. Trovò spesso afflizione |
|
| 5 | siþþan hine Nīðhād on nēde legde | da quando
Nīðhād pose catene su di lui, |
 |
| 6 | sƿoncre seonobende on syllan monn. | flessibili lacci sull'uomo migliore. |
 |
| 7 | Þæs oferēode, þisses
sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |
 |
| 8 | Beadohilde ne
ƿæs hyre brōþra dēaþ |
Beadohild non fu per la morte dei suoi fratelli |
 |
| 9 | on sefan sƿā sār sƿā hyre sylfre þing, | in cuor suo così addolorata come per la sua stessa condizione, |
|
| 10 | þæt hēo gearolīce ongieten hæfde | che chiaramente realizzò |
|
| 11 | þæt hēo ēacen
ƿæs; ǣfre ne meahte | di essere incinta. Non avrebbe mai potuto |
 |
| 12 | þrīste geþencan hū ymb þæt sceolde. | accettare con risolutezza il destino. |
|
| 13 | Þæs oferēode, þisses
sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |
|
| 14 | Ƿē þæt Mǣðhilde monge gefrugnon | Molti di noi hanno saputo di quella
Mǣðhild. |
 |
| 15 | ƿurdon grundlēase Gēates frīge, | Divenne sconfinata la passione del
gēata, | |
| 16 | þæt hi{m} sēo sorglufu slǣp ealle binōm. | tanto che il doloroso amore lo privò del tutto del sonno. |
|
| 17 | Þæs oferēode, þisses
sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |
|
| 18 | Ðēodrīc āhte þrītig
ƿintra | Ðēodrīc ebbe per trenta inverni |
 |
| 19 | Mǣringa burg; þæt
ƿæs mongegum cūþ. | il forte dei Mǣring; questo fu saputo da molti. |
 |
| 20 | Þæs oferēode, þisses
sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |
|
| 21 | Ƿē geāscodan Eormanrīces | Abbiamo saputo dei pensieri crudeli |
|
| 22 | ƿylfenne geþōht; āhte
ƿīde folc | di Eormanrīc. Resse in largo il popolo |
 |
| 23 | Gotena rīces. Þæt
ƿæs grim cyning. | del regno dei Gotan. Egli fu un re truce. |
|
| 24 | Sæt secg monig sorgum gebunden | Molti uomini sedettero incatenati al dolore |
|
| 25 | ƿēan on ƿēnan, ƿȳscte geneahhe | in attesa di sventura, desiderarono incessantemente |
|
| 26 | þæt þæs cynerīces ofercumen
ƿǣre. | che fosse rovesciato quel regno. |
|
| 27 | Þæs oferēode, þisses
sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |
|
| 28 | Siteð sorgcearig sǣlum bidǣled, | Siede l'affranto privato delle gioie, |
|
| 29 | on sefan sƿeorceð, sylfum þinceð | si incupisce nel cuore, gli sembra |
|
| 30 | þæt sȳ endelēas earfoða dæl. | che la moltitudine dei suoi guai sia senza fine. |
|
| 31 | Mæg þonne geþencan þæt geond þās
ƿoruld | Può allora pensare che attraverso questo mondo |
|
| 32 | ƿītig dryhten ƿendeþ geneahhe, | il saggio Signore si muove costantemente, |
|
| 33 | eorle monegum āre gescēaƿað | a molti uomini mostra l'onore |
|
| 34 | ƿislīcne blǣd, sumum
ƿēana dǣl. | e una fama certa, ad alcuni [invece] un gran numero di pene. |
|
| 35 | Þæt ic bī mē sylfum secgan
ƿille | Questo voglio dire riguardo a me stesso, |
|
| 36 | þæt ic hƿīle
ƿæs Heodeninga scop | che per lungo tempo fui poeta degli
Heodening, |
 |
| 37 | dryhtne dȳre. Mē
ƿæs Dēor noma; | caro al signore. Il mio nome era
Dēor. |
 |
| 38 | āhte ic fela
ƿintra folgað tilne, | Per molti inverni ebbi un buon ufficio |
|
| 39 | holdne hlāford oþ þæt Heorrenda
nū | e un buon signore, finché ora
Heorrenda, |
 |
| 40 | lēoðcræftig monn londryht geþāh | uomo abile nel canto, ha ricevuto i beni |
|
| 41 | þæt mē eorla hlēo ǣr gesealde. | che il protettore degli uomini una volta diede a me. |
|
| 42 | Þæs oferēode, þisses
sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
NOTE
vv. 1-7
1 —
Ƿēland: leggendario fabbro della
mitologia germanica, la cui storia di prigionia e vendetta è qui riportata a
esempio. Citato nel
Bēoƿulf e nella
Þiðrekssaga, il personaggio è centrale nella
Vǫlundarkviða della
Ljóða Edda. È anche raffigurato sul Cofanetto Franks.
 |
| Particolare dal Franks Casket |
Scrigno anglosassone in
osso di balena (VIII sec.). British Museum, Londra.
Il particolare sulla sinistra rappresenta re
Niðhad di fronte al fabbro
Ƿēland. |
|
Vista completa del cofanetto: [QUI]
✦ |
— be ƿurman: da noi
tradotto «presso le serpi»: non è chiaro se l'espressione sia un riferimento al
pozzo dei serpenti, noto supplizio dell'epica anglosassone e norrena, oppure sia
da intendere come heiti per «spade», immagine tipica della poesia
scaldica, forse originata dalla tendenza dei fabbri germanici ad adornare le
else delle spade con immagini serpentiformi. In realtà, Giulia Mazzuoli Porru
(1996) rifiuta entrambe le soluzioni proposte da Kemp Malone, l'una per la sua
illogicità, l'altra per la sua artificiosità (Malone 1933),
e propone quindi ti intendere «presso le serpi» come metafora per «presso i
tormenti» (Porru 1996). 
5 —
Niðhad: malvagio regnante della tradizione germanica, nemesi di
Ƿēland, facente parte della sua
leggenda e citato nelle stesse opere. 
6 — seonobende: da
noi tradotto come «lacci»; se analizzato alla lettera è in realtà un riferimento
ai tendini che Niðhad fece tagliare a
Ƿēland per costringerlo in prigionia.

7 — þisses
sƿā mæg: il noto refrain, diversamente interpretato in chiave
talvolta ottimistica talaltra fatalmente pessimistica, ha suscitato più di un
interrogativo a causa della presenza dei due genitivi þæs e þisses,
ormai generalmente interpretati come genitivi di pertinenza o di relazione.

vv. 8-13
8 —
Beadohild, anche lei protagonista della leggenda di
Ƿēland ed elemento di congiunzione tra
le prime due sezioni del poemetto, è la principessa figlia di
Niðhad e, a seconda delle versioni, vittima della
vendetta di
Ƿēland o sua futura moglie.

11 — Il figlio cui fa
riferimento il poeta è probabilmente Vitige, re degli Ostrogoti dal 536 al 540
d.C. 
vv. 14-17
14-15 —
Mǣðhild e il Gēata
rappresentano una nota crux del poema. Difficilmente individuabili
all'interno dei maggiori componimenti germanici, sono stati accostati da Kemp
Malone alla coppia Magnild e
Gaute di alcune ballate scandinave tardomedievali (Malone
1933). Anche in questo caso, l'opinione della Porru si discosta da quella
di Malone, proponendo quindi una versione più vicina al manoscritto, mæð
Hilde, «l'oltraggio di Hilde», e interpretandola come un riferimento alla
nota leggenda germanica del rapimento della valchiria
Hilldr e della battaglia sempiterna che ne consegue, citata nella
Ragnarsdrápa di Bragi Boddason, nel poemetto
Háttalykill e nella
Sǫrlaþattr, contenuta nel codice Flateyjarbók.

vv. 18-20
18 —
Đeodric: non è chiaro se stia parlando di Teoderico,
re degli Ostrogoti, ovvero il Þjóðrékr protagonista
della Þiðrekssaga af Bern, o, come proposto
da Malone, Teoderico di Austrasia, erede della dinastia merovingia
(Malone 1933). 
19 — Mǣring: vista
l'interpretazione di Malone si potrebbe pensare che venga chiamata in causa la
dinastia dei Merovingi; in realtà lo stesso Malone spiega come ciò non sia
fonologicamente e semanticamente corretto (Malone 1933).
Pertanto, conosciamo soltanto il loro nome e quello del loro signore.

vv. 21-27
22 — Eormanrīc:
"Ermanarico", re ostrogoto e noto tiranno della tradizione germanica (latino
Ermanaricus; gotico *Aírmanareiks; norreno Jǫrmunrekr), citato
negativamente già a partire dai Getica di
Jordanes e la cui reputazione è sopravvissuta nella
Þiðrekssaga, nel Bēoƿulf e nel
Ƿīdsīð. 
vv. 28-42
In questa sesta e ultima sezione il poeta ci propone quelle che potremmo
definire considerazioni generali sul concetto di sventura (ovvero che la buona
sorte, qui identificata con la benedizione divina, non si sofferma mai troppo a
lungo sulle stesse persone e, se in un primo momento, alle une mostra la gioia e
alle altre il dolore, può improvvisamente ribaltare tale condizione) e
finalmente arriva a parlare della sua vicenda, fornendoci importanti
informazioni: il proprio nome, quello del suo rivale e quello della dinastia da
lui un tempo servita.
36 — Heodening:
leggendaria dinastia della tradizione orale anglosassone e protagonista della
Hjaðningavíg norrena, il cui discendente più
noto è Heoden del quale, però, non viene qui
narrata la vicenda. 
37 —
Dēor: scop citato solo nel presente poema,
il cui nome, come quello dell'autore del Ƿīdsīð,
è un nome parlante che significa «coraggioso», in riferimento all'intento di
consolatio del poema.

39 —
Heorrenda: scop che con il suo talento
prende il posto dell'autore a corte e lo costringe all'esilio. Troviamo un
corrispettivo Hôrant nella
Kudrun medioaltotedesca e un antico islandese
Hjarrandi, il quale, però, nella versione
scandinava del mito, non è un bardo bensì padre di Heðinn
(Heoden). Da notare come
Hjarrandi sia anche uno degli heiti di Óðinn.

|
|
Bibliografia
- BATTAGLIA 2016. Marco Battaglia, Medioevo volgare
germanico, Pisa University Press, Pisa 2016.
- BATTAGLIA 2017. Le civiltà letterarie del Medioevo
germanico, a cura di Marco Battaglia, Carocci, Roma 2017.
- BROWN ~ CRAMPTON ~ ROBINSON 1986. Modes of
interpretation in Old English Literature, a cura di Phillis Rugg
Brown, Georgia Ronan Crampton e Fred C. Robinson, University of Toronto Press,
Toronto 1986.
- FRANCINI 2017. Marusca Francini, La letteratura
Anglosassone, in Battaglia 2017, pp.
137-275.
- KRAPP ~ DONNIE 1936. The Exeter Book, a
cura di George Philip Krapp e Elliott Van Kirk Donnie, Morningside Heights:
Columbia University Press, New York 1936.
- MALONE 1933. Deor, a cura di Kemp Malone, Metheuen's Old English
Library, London 1933.
- MITCHELL ~ ROBINSON 2012. Bruce Mitchell, Fred C. Robinson,
A guide to Old English (8th Edition),
Wiley-Blackwell, Hoboken 2012.
- PORRU 1996. Dēor. Poemetto antico-inglese (VIII
secolo), rilettura del testo, a cura di Giulia Mazzuoli Porru,
Giardini Editori, Pisa, 1996.
|
| BIBLIOGRAFIA ► |
|
|
|
Archivio:
Biblioteca - Guglielmo da Baskerville
Sezione: Fonti - Nabū-kudurri-uṣur
Area: Germanica - Brynhilldr |
|
Introduzione, traduzione e note di Giorgio Lucarelli. |
|
 |
 |

|
|
|
Creazione pagina: 05.03.2018
Ultima modifica:
25.12.2018 |
|
|
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati |
|