|
PREFAZIONE
Cos'è il mito?
«Il vero, il quale, col volger degli anni
e col cangiare di lingue e di costumi
ci pervenne ricoverto di falso.»
Gian Battista Vico
Dopo aver dedicato diverse notti alla stesura e alla pubblicazione dei
primi quattro volumi dei Racconti senza tempo, è giunto per me il momento
di chiudere questa parentesi letteraria che mi ha portato a ripercorrere un
sentiero già tracciato durante l'infanzia (la mia e quella di una ancora giovane
umanità), assieme ai miei pochi ma affezionati lettori.
Un sentiero che mi ha fatto riscoprire gioie, intrighi, fantasie, misteri
e passioni di una fanciullezza evidente-mente mai sopita e che ho voluto
condividere in empatia con l'io bambino di altre persone; il fatto, poi, che
questo piccolo esperimento letterario sia servito anche per soste-nere un
progetto di solidarietà a beneficio dei bambini più sfortunati è servito solo ad
incoraggiarmi a completare questo lavoro.
E così, ancora una volta, dopo una giornata di duro lavoro e dopo aver
condiviso la serata con i miei cari (in compagnia dell'inseparabile «favola» per
i bambini), mi accingo a trascorrere le ore notturne assieme ai grandi del
passato, come un «novello» Machiavelli: «Venuta la sera, mi ritorno a casa ed
entro nel mio scrittoio; e in sull'uscio mi spoglio quella veste cotidiana,
piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito
condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro
ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch'io nacqui per
lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle
loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro
hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi
sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro» (Lettera XI a Francesco
Vettori).
Ad aiutarmi in questo arduo compito sono stati gli oltre trent'anni
trascorsi in compagnia dei miti, che hanno certamente contribuito ad avere
dimestichezza con la materia, e i miei due figli: la loro curiosità e la
continua richiesta di favole mi hanno «costretto» a scrivere in modo semplice,
affinché le storie potessero essere fruite anche da loro.
Con la speranza che questo ulteriore tentativo di ridare nuova linfa alle
favole antiche possa essere utile alle generazioni presenti e future.
Daniele Bello
Novembre 2011
...a chi mi vuole bene. |
|
I
ERACLE
Eroe e semidio
PROLOGO
Perseo e la Medusa
 |
| Perseo e Medusa |
Benvenuto Cellini, bronzo (1546/1554)
Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze (Italia) |
 i
fu un tempo in cui, nell'Ellade (antico nome della Grecia),
nacque e prosperò una città nel cuore del Peloponneso, tra
le più antiche fondate dai Pelasgi, i primi abitanti del
Mediterraneo. i
fu un tempo in cui, nell'Ellade (antico nome della Grecia),
nacque e prosperò una città nel cuore del Peloponneso, tra
le più antiche fondate dai Pelasgi, i primi abitanti del
Mediterraneo.
Questa città viene citata nelle fonti antiche come la
potente Argo; secondo la leggenda, il suo nome deriva
direttamente da quello del suo mitico fondatore, il quale
diede inizio ad una dinastia destinata a durare per nove
generazioni; i primi reggitori di quello che fu forse il
primo centro urbano dell'intera Grecia appartengono ad un
passato così remoto che persino gli studiosi più meticolosi
si limitano appena a citare i nomi di Inaco,
Foroneo, Gelanore e tanti altri sovrani di cui si
sa in realtà ben poco.
Sui primi re di Argo, tuttavia, esiste una storia che non
posso fare a meno di raccontarvi, prima ancora di entrare
nel vivo delle imprese del nostro eroe.
Si narra, infatti, che il nobile Danao, figlio di
Belo ①, avesse deciso di riparare proprio in Argo
assieme alle sue cinquanta figlie (dette, appunto, le
Danaidi) per sfuggire alle persecuzioni di suo fratello
Egitto. Quest'ultimo, infatti, aveva ereditato dal
padre e dall'avo Epafo le corone della Libia e
dell'Egitto e, geloso del suo potere, voleva eliminare tutti
i suoi parenti più stretti vedendo in loro una potenziale
minaccia per il suo trono.
Danao, come si è detto, riparò in Argo proprio quando si era
ormai estinta la linea di discendenza della vecchia dinastia
locale; date le sue nobili origini (era nipote in linea
retta di Poseidon, il dio del mare), venne acclamato
come sovrano dagli Argivi.
Il perfido Egitto, tuttavia, non cessò di tormentare il
fratello; il potente sovrano giunse in Grecia con la sua
flotta, accompagnato dai suoi cinquanta figli e minacciò di
assediare Argo e di raderla al suolo, se Danao non avesse
accettato le sue condizioni: ciascuno dei suoi cinquanta
figli si sarebbero maritato con una delle Danaidi; in tal
modo, Egitto pensava di assicurarsi la successione del regno
di Argo alla morte del fratello ②.
Impotente a fronteggiare l'immane esercito del bellicoso
fratello, Danao dovette acconsentire alle odiose nozze. Gli
storici dei tempi antichi rabbrividiscono tuttora a
raccontare la terribile vendetta che concepirono le Danaidi,
la quali trucidarono i loro mariti durante la prima notte di
nozze ③: tutte, tranne Ipermnestra, l'unica ad essere
legata da un sentimento di vero amore con il marito Linceo:
e fu grazie a loro che la dinastia dei reggitori di Argo
poté continuare, più forte e solida di prima.
Essi infatti generarono Abante, che estese la sua
sovranità a tutta la regione che, da allora, prende il nome
di Argolide; questi era un guerriero così temibile che
riusciva a terrorizzare i nemici anche solo mostrando le
proprie armi custodite nel palazzo.
Abante ebbe due gemelli: Acrisio e Preto. I
due fratelli non si amavano ed erano sempre in lotta fra di
loro: si narra che i due avessero iniziato a battersi
addirittura sin da quando si trovavano ancora nel grembo
materno.
Preto e Acrisio, eredi del regno dell'Argolide, si
disputarono a lungo il diritto di cingere la corona, sino a
quando si giunse alla spartizione del regno: Acrisio ottenne
il trono di Argo, mentre Preto ebbe la sovranità di Tirinto.
Non contento di avere ottenuto la signoria di Argo, Acrisio
temeva di continuo per le sorti del suo regno anche perché,
avendo avuto dalla moglie una sola figlia femmina, la bella
Danae, non sapeva a chi avrebbe trasmesso il titolo
alla sua morte, essendo privo di eredi maschi.
Acrisio si rivolse al famoso oracolo di Delfi per avere lumi
sul suo futuro, ma la sacerdotessa di Apollo lo raggelò:
ella infatti predisse che Danae avrebbe avuto un figlio
maschio, ma che questi sarebbe stato destinato un giorno ad
uccidere il nonno materno.
Terrorizzato dal terribile vaticinio della Pizia, la
sacerdotessa di Apollo portavoce della saggezza del dio,
Acrisio decise di rinchiudere la figlia in una torre ben
fortificata, con porte di bronzo guardate da cani
ferocissimi; solo una nutrice poteva avere accesso ai suoi
appartamenti: qualsiasi contatto con persone di sesso
maschile era rigorosamente proibito.
Acrisio pensava, in questo modo, di poter eludere il destino
che gli era stato prospettato, ma si ingannava: il Fato,
potere arcano cui neppure gli dei possono sottrarsi, stava
già filando il corso della sua vita.
Alcuni mesi dopo, infatti, nonostante conducesse una triste
vita da prigioniera, Danae concepì un figlio, cui venne dato
il nome di Perseo. Si racconta che fu lo stesso padre
di tutti gli dei, il possente Zeus, ad invaghirsi della
bella figlia del re di Argo; trasformatosi in una pioggia
d'oro, il dio del fulmine e del tuono penetrò attraverso le
finestre della torre in cui era rinchiusa la incolpevole
fanciulla, riuscendo così a sedurla.
Quando Acrisio scoprì che la figlia aveva messo al mondo un
figlio maschio, concepì una terribile vendetta: fece
chiudere Danae e il nipote in una cassa di legno che mise su
un'imbarcazione da lasciare alla deriva.
Il «lamento di Danae», che nella sua pur terribile
disgrazia tenta di tranquillizzare il figlio con una dolce
nenia, è stato reso immortale dal poeta greco Simonide, che
citiamo integralmente nella traduzione di Salvatore
Quasimodo:
Quando nell'arca regale l'impeto del
vento
e l'acqua agitata la trascinarono al largo,
Danae con sgomento, piangendo, distese amorosa
le mani su Perseo e disse: — O figlio,
qual pena soffro! Il tuo cuore non sa;
e profondamente tu dormi
così raccolto in questa notte senza luce di cielo,
nel buio del legno serrato da chiodi di rame.
E l'onda lunga dell'acqua che passa
sul tuo capo, non odi; né il rombo
dell'aria: nella rossa
vestina di lana, giaci; reclinato
al sonno del tuo bel viso.
Se tu sapessi ciò che è da temere,
il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce.
Ma io prego: tu riposa, o figlio, e quiete
abbia il mare; ed il male senza fine,
riposi. Un mutamento
avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre;
e qualunque parola temeraria
io urli, perdonami,
la ragione m'abbandona.
La piccola imbarcazione navigò al largo per ore ed ore
ma, miracolosamente, non fece naufragio e così la cassa
venne gettata sulla riva dell'isola di Serifo, che fa parte
dell'arcipelago delle Cicladi.
Fu un pescatore di nome Ditti, fratello del
tiranno dell'isola Polidette, a notare lamenti e
vagiti provenienti da una misteriosa cassa all'interno di
una barca che si era arenata sulle rive sabbiose della
spiaggia.
Ditti aprì la cassa e vi trovò Perseo e la madre ancora
vivi, nonostante quel viaggio infernale in balia dei flutti;
il pescatore li rifocillò e li ospitò nella sua casa, sino a
quando non ripresero del tutto le forze.
Un evento così eccezionale e miracoloso fece ovviamente
il giro dell'isola in poco tempo; il tiranno Polidette,
commosso per la tragedia scampata dei due naufraghi, offrì
loro alloggio ed ospitalità all'interno della sua reggia.
Gli anni passarono in fretta: Perseo divenne un giovane
bello, forte e valoroso, mentre la madre Danae rimaneva una
donna assai affascinante anche con la maturità, tanto da
accendere nel re Polidette una insana passione.
Il tiranno cercava in tutti i modi di convincere la donna
a sposarlo, ma Danae, il cui unico pensiero era per il
figlio Perseo, non ricambiava l'amore del sovrano
dell'isola.
Polidette concepì allora un piano diabolico per
sbarazzarsi del figlio di Danae: sparse in giro la voce che
per il bene del suo regno avrebbe preso in moglie una nobile
delle isole vicine e convocò nobili e cortigiani (tra cui lo
stesso Perseo) per dare l'annuncio ufficiale.
Perseo, mortificato perché non era in grado di fare un
regalo di nozze al re, affermò che avrebbe procurato a
Polidette qualunque dono avesse chiesto. Il re dell'isola,
astutamente, espresse il desiderio di ricevere in dono per
le sue nozze la testa della Medusa.
Per capire meglio quanto fosse astrusa la richiesta del re
Polidette, è opportuno spiegare meglio che tipo di creatura
fosse la Medusa, la più terribile delle Gorgoni.
Figlie delle divinità marine Forco e Ceto, le Gorgoni (Steno,
Euriale e Medusa) avevano un aspetto
mostruoso: il loro corpo era ricoperto di scaglie come
quelle dei rettili e avevano serpenti vivi al posto dei
capelli; esse, inoltre, avevano il potere di pietrificare
chiunque avesse la sfortuna di incrociare il loro sguardo.
Mentre Steno ed Euriale avevano il dono dell'immortalità,
Medusa era invece mortale e poteva essere uccisa.
Affrontare la Medusa significava quindi andare incontro a
morte certa: il malefico potere della Gorgone aveva già
trasformato in duri sassi molti valenti eroi. Ma Perseo si
era impegnato di fronte al re e a tutti i dignitari
dell'isola: c'era in gioco il suo onore, ormai, per cui il
ragazzo mai e poi mai si sarebbe tirato indietro; l'ardore
giovanile e un po' incosciente rischiava tuttavia di essere
fatale al figlio di Danae.
Per fortuna, vennero in soccorso del giovane Perseo due
tra le divinità solitamente più vicine agli eroi impavidi e
coraggiosi: Hermes e la vergine Pallade Atena.
Hermes prestò al giovane rampollo della casata di Argo i
suoi calzari alati, per consentirgli di spostarsi in volo
anche per grandi distanze, e l'elmo di Ade, che
rendeva invisibile chiunque lo indossasse.
La dea Atena, invece, gli donò uno scudo lucido come un
specchio, raccomandando all'eroe di non guardare mai Medusa
dritto negli occhi, ma solo attraverso il riflesso di quello
scudo: in tal modo, Perseo sarebbe stato immune dal tremendo
potere della Gorgone.
Altri oggetti magici erano tuttavia necessari a Perseo
per poter compiere la sua impresa: una falce di diamante per
riuscire a decapitare il mostro e una sacca magica per
riporre la testa recisa. Tali oggetti, però, erano custoditi
dalle Ninfe dello Stige, le quali dimoravano in luogo
sconosciuto ai molti e noto unicamente a delle sinistre
creature di cui pochi parlavano senza rabbrividire per la
paura: le Graie.
Figlie anch'esse delle divinità marine Forco e Ceto (e
quindi sorelle delle Gorgoni), le tre Graie Enio,
Deino e Pefredo erano vecchie, decrepite e
avvizzite sin dalla nascita; esse inoltre avevano un solo
occhio e un solo dente in comune, che si passavano tra di
loro a turno.
Grazie ai calzari alati e alla guida di Hermes, Perseo
raggiunse senza difficoltà la dimora delle tristi e
malinconiche Graie, che si trovava ai confini del mondo
conosciuto, là dove il Titano Atlante reggeva la volta del
cielo per ordine del sovrano dell'universo.
Giunto alfine alla meta, il giovane figlio di Danae pensò
bene di nascondersi alla vista di quelle creature tanto
solitarie e pericolose, per cui si acquattò con cura in
attesa del momento in cui una delle Graie avrebbe passato
l'unico occhio e l'unico dente ad una delle sorelle.
Perseo, astutamente, aspettò con pazienza l'attimo fatale
e riuscì a ghermire con l'audacia che è propria solo dei
coraggiosi e degli sfrontati quegli strumenti così vitali
per la sopravvivenza di quelle antiche creature.
Il nipote di Acrisio minacciò di portarsi via il dente e
l'occhio se le Graie non gli avessero rivelato dove poter
trovare le Ninfe dello Stige; prive dei loro organi vitali,
le figlie di Forco e Ceto non avevano scelta se non rivelare
quanto era stato loro richiesto.
Perseo non ebbe alcuna difficoltà a raggiungere le Ninfe
dello Stige, le quali furono molto impressionate dal
carattere di quel giovane tanto sicuro di sé che, protetto
dagli dei, ambiva ad uccidere addirittura la terribile
Medusa: grazie alla mediazione dello scaltro ed affabile
Hermes, messaggero degli dei, esse gli consegnarono senza
esitare la falce di diamante e la bisaccia che il figlio di
Danae aveva richiesto.
Perseo si diresse quindi verso la terra degli Iperborei,
una popolazione che abitava nelle fredde regioni
dell'estremo Nord, ben oltre i limiti del mondo conosciuto,
ai confini più estremi del grande mare Oceano (un enorme
fiume che, secondo gli antichi, circondava le terre
emerse).
Il paesaggio di Iperborea era dominato da un'atmosfera di
squallore e di grande desolazione, che invitava chiunque vi
mettesse piede per la prima volta alla tristezza e alla
malinconia: la terra e la vegetazione erano ammantati da una
cappa uniforme di grigio; quel paese non era allietato né da
colori né da suoni armoniosi. Eppure quella era la patria
delle Gorgoni e solo lì Perseo avrebbe potuto tentare
l'impresa che sembrava a tutti impossibile: uccidere la
Medusa.
Il figlio di Danae si inoltrò in una foresta oscura,
dagli alberi antichissimi che sembravano osservarlo con aria
di cupa disapprovazione; come un sinistro monito per i
pavidi e gli incoscienti, il bosco era infestato da statue
in pietra di uomini e donne con un'espressione di terrore o
di vivo stupore in viso: Perseo non ci mise molto a capire
che quelle erano le sfortunate vittime che avevano
incrociato lo sguardo delle Gorgoni.
Perseo comprese che la sua meta era ormai vicina quando
cominciò a udire il sibilo dei serpenti posti sul capo di
quelle orribili creature. Resosi invisibile grazie all'elmo
di Ade, il figlio di Danae avanzava camminando a ritroso,
senza mai guardare nella direzione da cui proveniva il
mortale richiamo dei rettili posti sul capo delle Gorgoni.
Passo dopo passo, lentamente, Perseo si avvicinava sempre
di più alla tana di Medusa e delle sue orribili sorelle, con
l'ausilio del riflesso dello scudo di Atena.
Quando fu abbastanza vicino ai tre mostri, Perseo si
accorse che le Gorgoni stavano dormendo; l'eroe comprese che
un'occasione simile non si sarebbe presentata di nuovo. Il
figlio di Danae non ebbe esitazioni: afferrato il falcetto
magico che gli avevano dato le ninfe stigee, tagliò di netto
il collo della Medusa avendo cura di non incrociare mai il
suo sguardo con quello delle malefiche creature.
Come per incanto, dal sangue della Medusa scaturirono due
magiche creature: il gigante Crisaore (che gli annali
ricordano come il «Guerriero dalla spada d'oro») e uno
splendido cavallo alato dal manto bianco. Perseo sollevò la
pesante testa del mostro e la mise nella sua bisaccia, poi
balzò in groppa a quella creatura meravigliosa, cui diede il
nome di Pegaso, per allontanarsi il più presto
possibile da quel luogo tanto sinistro (le altre due Gorgoni,
Steno ed Euriale, in fondo potevano svegliarsi da un momento
all'altro…); da quel giorno i due sarebbero diventati
inseparabili.
Nel viaggio di ritorno verso l'isola di Serifo, Perseo si
trovò a passare nei pressi dei luoghi in cui il Titano
Atlante reggeva la volta del cielo sulle sue spalle. ④
Non si sa bene quale sia stato il motivo occasionale che
fece scoppiare un forte litigio tra i due (forse il figlio
di Danae rinfacciò al gigante che non aveva voluto aiutarlo
nell'impresa): fatto sta che il Titano, irritato, tentò di
calpestare come un insetto il giovane Perseo, il quale tirò
fuori dalla bisaccia la testa micidiale della Medusa e
trasformò Atlante in una montagna .
 |
| Perseo e Andromeda |
Affresco romano da Pompei (±50/79)
Museo Archeologico Nazionale, Napoli (Italia) |
Mentre sorvolava il continente africano, di fronte a
Perseo si parò uno spettacolo raccapricciante.
Una bellissima fanciulla, di nome Andromeda, era
incatenata ad uno scoglio, in attesa di essere divorata da
un mostro marino.
Andromeda era figlia di Cefeo, re d'Etiopia, e di
Cassiopea, la quale aveva attirato su di sé e
sull'intero popolo l'ira degli dei in quanto aveva osato
affermare che sua figlia superava in bellezza le Nereidi.
Tale manifestazione di superbia aveva oltraggiato sia le
ninfe del mare che il dio Poseidon: dopo aver
funestato le coste con una terribile mareggiata, il dio dei
flutti marini aveva inviato un orribile mostro (il Ketos),
che terrorizzava gli abitanti facendone strage.
Il re Cefeo, consultato un oracolo, venne a sapere che
l'unico modo per placare l'ira divina era quello di immolare
la propria figlia facendola divorare dal mostro marino.
Quando Perseo giunse nei pressi della costa etiope in
groppa a Pegaso ⑤, la povera Andromeda era ormai rassegnata
alla sua terribile sorte.
La descrizione del mostro è mirabilmente descritta dal
poeta Ludovico Ariosto, che narra un episodio analogo nel
suo poema:
Ecco apparir lo smisurato mostro
mezzo ascoso nell'onda, e mezzo sorto.
Come sospinto suol da Bore o d'Ostro
venir lungo navilio a prender porto,
così ne viene, al cibo che l'è mostro,
la bestia orrenda; e l'intervallo è corto.
La donna è mezza morta di paura,
né per conforto altrui si rassicura.
Orlando
Furioso [X, 100]
Il figlio di Danae, inorridito per l'orribile sorte cui
era destinata la povera fanciulla, balzò addosso al Ketos e
ingaggiò una battaglia terribile.
Perseo non fece alcuna fatica a uccidere il mostro marino
che doveva divorare Andromeda, grazie al terrificante potere
della testa di Medusa. L'uccisione del mostro fu tuttavia
ben poca cosa, a paragone di quel che successe subito dopo:
durante i festeggiamenti per la salvezza della figlia del
re, giunse alla reggia un vecchio pretendente alla mano di
Andromeda, Fineo, accompagnato da uomini armati,
pronto a tutto pur di averla. Fu Cassiopea, che non gradiva
Perseo come genero, a dare il segnale della battaglia.
L'eroe, per difendersi, estrasse ancora una volta la testa
di Medusa ottenendo l'effetto voluto: Cassiopea divenne una
statua inerte come del resto tutti quelli che avevano
assalito Perseo per ucciderlo.
Perseo montò quindi in groppa a Pegaso assieme alla
moglie Andromeda e fece rotta verso l'isola di Serifo.
Giunto nella sua patria adottiva, il giovane eroe scoprì che
Polidette, lungi dal voler prendere moglie, aveva tentato in
tutti i modi di sedurre Danae, con le buone o con le
cattive, tanto è vero che la sventurata madre di Perseo era
stata costretta a nascondersi presso un tempio, per trovare
rifugio.
| TABELLA n. 1 |
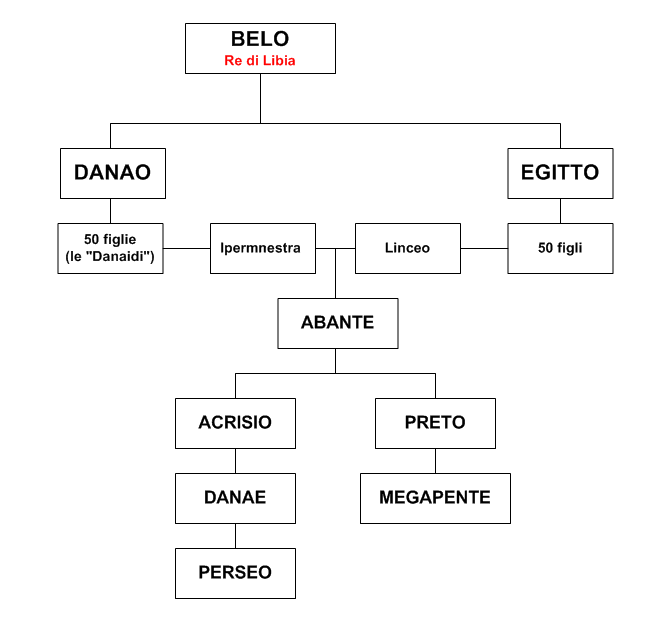 |
| |
| RE DI ARGO E DI MICENE |
Perseo si avviò alla reggia di Polidette e, giunto al
palazzo, esibì il suo dono di nozze, pietrificando il re di
Serifo e tutto il suo seguito con la testa della Gorgone.
Perseo consegnò allora al padre adottivo Ditti il potere
sull'isola di Serifo. Restituì poi i sandali, la bisaccia e
l'elmo di Ade ad Hermes. Questi li rese alle loro legittime
padrone, mentre Atena poneva la testa di Medusa in mezzo al
proprio scudo.
Alcuni anni dopo, Perseo volle ritornare alla terra natia
e decise di mettersi in viaggio verso la città di Argo,
insieme alla moglie Andromeda e alla madre Danae.
L'ormai vecchio re Acrisio venne a sapere dell'imminente
arrivo del nipote e, temendo la morte che l'oracolo gli
aveva predetto, fuggì nella città di Larissa, nel paese dei
Pelasgi.
Perseo non si rassegnò tanto facilmente e non si diede
pace sino quando non raggiunse il nonno per rassicurarlo che
non gli serbava più rancore.
Il destino, tuttavia, continuava implacabile a tessere le
sue trame: durante dei giochi ginnici organizzati nella
città di Larissa, infatti, Perseo si cimentò nella gara del
lancio del disco: il Fato volle che un vento improvviso finì
per deviare proprio il disco lanciato dal figlio di Danae,
andando a colpire accidentalmente il vecchio Acrisio, che
morì sul colpo. Il cupo presagio, che per anni aveva
funestato la famiglia reale di Argo, si era quindi avverato.
Pieno di dolore, Perseo tributò onori funebri al nonno e
lo fece seppellire fuori dalla città di Larissa. Anche se
per diritto ereditario egli era destinato a succedere sul
trono di Argo, il figlio di Danae non se la sentì di essere
il sovrano di quella città e propose allo zio Preto
(ovvero, secondo alcuni, a suo cugino Megapente), re
di Tirinto, di scambiarsi i regni. ⑥
| ① |
Figlio di Poseidon ed antico re
dell' Egitto e della Libia. |
| ② |
Queste vicende sono l'argomento
di una tragedia di Eschilo, Le
Supplici. |
| ③ |
Le Danaidi scontano ancora il
loro terribile delitto nel Tartaro, il luogo scuro
dell'oltretomba secondo gli Elleni; esse sono
condannate, infatti, a riempire continuamente con delle
brocche d'acqua un pozzo senza fondo. |
| ④ |
Ancora oggi la catena montuosa
del Marocco porta il nome del Titano pietrificato dalla
testa di Medusa. Per l'incoerenza di cui solo i miti
sono capaci, va comunque ricordato che un discendente di
Perseo, il grande Eracle, si troverà a chiedere l'aiuto
di Atlante per cercare le mele d'oro delle Esperidi e lo
troverà nel pieno delle forze; evidentemente, il litigio
non era stato così feroce oppure… il potere della
Gorgone non era poi tanto spaventoso! |
| ⑤ |
Che Perseo sia partito in groppa
a Pegaso è la versione ufficializzata dall'arte
rinascimentale e dalle trasposizioni cinematografiche;
le fonti classiche ritengono in realtà che Perseo sia
partito in volo utilizzando i sandali alati fornitigli
da Hermes. |
| ⑥ |
Sulle dinastie di Argo e Tirinto
è forse opportuno spendere qualche parola in più; si
racconta, infatti, che fu Perseo a fondare la città di
Micene e che la dinastia dei Perseidi regnò su Micene e
Tirinto per diverse generazioni prima di estinguersi a
seguito di una faida tra Euristeo e i figli di Eracle,
consentendo l'ascesa al trono degli Atridi (Parte I,
capitolo 5).
Il re di Argo, Preto, si sposò con la moglie del re di
Licia da cui ebbe tre figlie (le «Pretidi») e un figlio,
Megapente, di cui si è già fatto cenno.
Il mito racconta che le Pretidi impazzirono per avere
offeso la dea Hera (ovvero, secondo alcuni, il dio
Dioniso), per cui lasciarono la casa paterna per
dirigersi verso i monti in preda a terribili urla,
trascinando con loro anche altre donne argive. Preso
dalla disperazione, Preto promise qualsiasi cosa, anche
una porzione del suo regno, a chi fosse riuscito a
guarire le sue figlie. Intervenne a questo punto il
profeta Melampo, che riuscì a guarire la Pretidi ma
pretese in cambio un terzo del regno per sé ed un altro
terzo per il fratello Biante.
Il territorio di Argo si divise così in tre parti, rette
da diverse dinastie; della situazione di oggettiva
debolezza del regno approfittò Agamennone, re di Micene,
il quale rese i reggitori di Argo suoi vassalli.
La più famosa delle dinastie della città fu senz'altro
quella fondata da Biante: egli infatti generò Talao, il
quale a sua volta trasmise la corona al figlio Adrasto,
famoso eroe della guerra dei «Sette contro Tebe»; non
avendo avuto un erede maschio che gli sopravvivesse,
quest'ultimo trasmise la corona a Diomede (figlio di suo
genero Tideo), eroe della guerra di Troia. |
.
La nascita e la giovinezza di Eracle
 a
leggenda del mitico Eracle, l'eroe più popolare della
mitologia greca, inizia con la storia della casa reale di
Micene, una delle città più importanti di tutta l'Ellade
durante l'età eroica. a
leggenda del mitico Eracle, l'eroe più popolare della
mitologia greca, inizia con la storia della casa reale di
Micene, una delle città più importanti di tutta l'Ellade
durante l'età eroica.
La nobile città dell'Argolide era stata infatti fondata da
Perseo, l'eroe figlio di Danae famoso per aver ucciso la
terribile Medusa. Altre fonti riportano invece che a
costituire il primo nucleo di quella che era destinata ad
essere una prospera comunità fu Miceneo, che diede il
proprio nome al borgo, mentre a Perseo doveva attribuirsi la
costruzione delle mura.
Il trono di Micene passò quindi ad Elettrione, figlio di
Perseo, il quale aveva una figlia di smisurata bellezza
chiamata Alcmena; di lei si invaghì il cugino Anfitrione ①,
che decise quindi di prenderla in moglie.
I due sposi vennero tuttavia presto condannati all'esilio
poiché Anfitrione aveva ucciso per un malaugurato incidente
il suocero Elettrione; il fratello del defunto re, Stenelo,
non volle sentire ragioni e, dopo aver conquistato il trono
di Micene, allontanò quei parenti così scomodi per una
eventuale successione.
Trovato rifugio presso la città di Tebe, i due sposi
riuscirono a riottenere, almeno in parte, la serenità
perduta; non passò molto tempo, tuttavia, prima che il buon
Anfitrione venisse nuovamente coinvolto in una impresa
guerresca.
A questo punto, entra in gioco nella nostra storia
nientemeno che il padre di tutti gli dei dell'Olimpo, il
sommo Zeus, che si innamorò perdutamente della bella
Alcmena.
| TABELLA n. 2 |
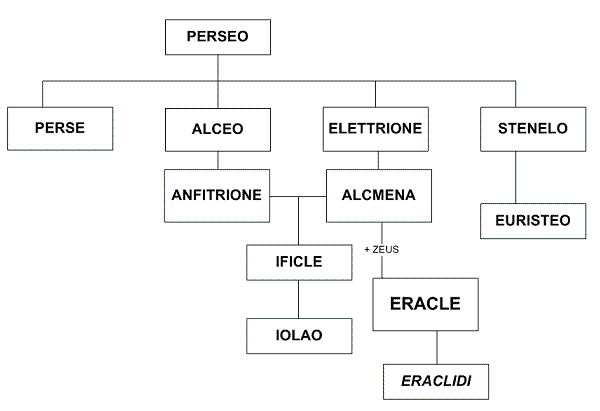 |
| |
| I DISCENDENTI DI PERSEO |
Durante l'assenza di Anfitrione, Zeus prese le sembianze del
marito di Alcmena per poterla sedurre e fece in modo che la
notte durasse ben tre volte di più; ad accompagnare il padre
in questa sua ennesima scorribanda nelle terre dei mortali
fu il dio Hermes, che aveva preso l'aspetto del servo di
Anfitrione, Sosia. ②
Quando Anfitrione – rientrato dalla guerra e ignaro di tutto
– tornò a Tebe, egli si unì alla propria sposa. Tempo dopo,
Alcmena scoprì di essere incinta: per una di quelle alchimie
che solo i miti riescono a spiegare senza entrare in
contraddizione, la figlia di Elettrione partorì due gemelli:
Eracle (figlio di Zeus) ed Ificle (figlio di Anfitrione).
 |
| Eracle strangola i serpenti |
Affresco romano (±60/79)
Casa dei Vettii, Pompei (Italia) |
A questo punto la nostra storia si complica ulteriormente
poiché il grande Zeus, presagendo un grande futuro per il
suo discendente, prima ancora che Eracle nascesse aveva
dichiarato che il prossimo erede dei Perseidi sarebbe stato
destinato ad avere una posizione di supremazia su tutta la
casata.
Il dio del tuono e del fulmine non aveva evidentemente
tenuto in considerazione la gelosia di sua moglie Hera che,
per vendicarsi dell'ennesima infedeltà del marito, ritardò
il parto di Alcmena ed accelerò nel contempo quello di
Nicippe, moglie di Stenelo e zio di Alcmena. Il figlio del
re di Micene, Euristeo, nacque pertanto prima di Eracle e a
lui dovettero porgere omaggio tutti i Perseidi.
Non contenta di ciò, la dea Hera cercò di uccidere il
rampollo di Zeus ed Alcmena, mettendo due serpenti velenosi
nella culla dove dormivano i due gemelli Eracle ed Ificle;
lo stratagemma si rivelò inutile: quando il piccolo Eracle
si svegliò, egli con molta naturalezza afferrò i due rettili
strangolandoli a mezz'aria…
Zeus capì dunque che suo figlio sarebbe stato perseguitato
per sempre dall'ira della regina dei cieli, sua consorte;
per consentire al suo rampollo di beneficiare della divina
protezione, il padre di tutti gli dei ordinò al fedele
Hermes di avvicinare il piccolo Eracle al seno di Hera,
mentre la dea dormiva. Il bambino succhiò così il latte
della dea che, essendo divino, infuse nel figlio di Alcmena
una energia sovrumana che l'avrebbe reso invincibile.
La dea Hera si svegliò a causa di un morso del piccolo
Eracle ed ebbe un moto di terrore, facendo cadere dal suo
seno una piccola parte del suo latte e dando origine alla
Via Lattea.
Anfitrione, avendo compreso l'origine divina del bambino,
non risparmiò alcuna cura nell'allevare quel figlio
adottivo. Egli convocò da ogni angolo della Grecia i più
rinomati maestri: il centauro Chirone, il grande arciere
Eurito, il principe dei ladri Autolico e Castore, l'illustre
discendente della famiglia reale di Sparta.
Il giovane Eracle apprezzò grandemente gli insegnamenti dei
suoi maestri, ma non si mostrò altrettanto diligente
nell'apprendere l'arte della musica; si narra, infatti, che
un giorno il suo precettore Lino, discendente del divino
Apollo, rimproverò aspramente il suo discepolo per la sua
inettitudine a suonare la lira; Eracle, di carattere
piuttosto focoso, non riuscì a trattenere la propria forza e
inconsapevolmente colpì con la lira il maestro, che cadde
morto a causa dell'urto.
A causa di ciò Anfitrione fu costretto a mandare il figlio
adottivo tra i guardiani delle sue greggi, nei pressi del
monte Citerone, sino all'età di diciotto anni. Si narra che,
proprio mentre era intento a pascolare gli armenti, il
giovane Eracle affrontò un leone che faceva stragi di pecore
e lo uccise: da quel giorno, egli volle vestirsi unicamente
con la pelle del leone che egli aveva così valorosamente
sconfitto.
Sempre durante il suo esilio forzato presso i pastori, il
figlio di Alcmena incontrò un giorno due donne affascinanti,
ognuna delle quali lo invitava a seguirla; la prima, di
aspetto florido e stupendamente vestita, rappresentava il
piacere e mostrava al giovane un sentiero idilliaco e facile
da percorrere; la seconda donna, invece, simboleggiava il
dovere e avrebbe condotto l'eroe presso un sentiero sassoso
ed irto di terribili difficoltà. Eracle, benché affascinato
dalle tentazioni del piacere, preferì seguire la via della
responsabilità, segnando tutta la sua vita al servizio dei
più deboli..
| ① |
Anfitrione era infatti figlio di
Alceo e quindi nipote in linea diretta di Perseo. |
| ② |
Da allora, usiamo il termine
«Sosia» per indicare chiunque abbia le stesse sembianze
di un'altra persona. Le vicende narrate ispirarono una
divertente commedia degli equivoci (Amphitruo) al
poeta latino Plauto. |
| ③ |
L'eroe era noto nel mondo
ellenico anche come l'Alcide, dal nome del nonno Alceo. |
.
Érga, le dodici fatiche di Eracle
 a
fama di Eracle è nota ai posteri principalmente per le
celebri Dodici Fatiche. Secondo una prima versione del mito,
egli – giunto in età adulta – dovette prestare omaggio al re Euristeo a causa del suo diritto di primogenitura; quest'ultimo,
ispirato dalla dea Hera, gli avrebbe imposto ogni anno delle
imprese impossibili per cercare di sbarazzarsene e
soddisfare così la sete di vendetta della regina degli dèi. a
fama di Eracle è nota ai posteri principalmente per le
celebri Dodici Fatiche. Secondo una prima versione del mito,
egli – giunto in età adulta – dovette prestare omaggio al re Euristeo a causa del suo diritto di primogenitura; quest'ultimo,
ispirato dalla dea Hera, gli avrebbe imposto ogni anno delle
imprese impossibili per cercare di sbarazzarsene e
soddisfare così la sete di vendetta della regina degli dèi.
Secondo altri cantori, invece, Eracle – dopo avere sconfitto
in battaglia gli abitanti di Orcomeno ①, nemici storici di
Tebe – prese in sposa Megara (figlia del re tebano
Creonte), da cui ebbe otto figli.
La terribile dea Hera, tuttavia, sconvolse la mente
dell'eroe e questi, in preda alla follia, uccise con le sue
mani la moglie e i figli ②.
Una volta tornato in sé e resosi conto dell'accaduto, Eracle
aveva meditato il suicidio per porre fine alle proprie
sofferenze; fu Teseo ③, il giovane erede al trono di Atene,
a farlo desistere dal suo gesto disperato e a consigliargli
di recarsi presso l'oracolo di Delfi. La sacerdotessa del
dio Apollo consigliò al figlio di Alcmena di mettersi al
servizio del figlio di Stenelo per purificarsi.
Anche se le fonti divergono sulla causa dei servigi al re
Euristeo, tutti concordano sul fatto che Eracle dovette
compiere le dodici imprese impostegli dal re di Micene, che
gli valsero fama imperitura e che andremo sia pur brevemente
a raccontare.
i. Il Leone di Nemea
 a
prima fatica imposta ad Eracle fu l'uccisione di un
terribile leone, figlio di Tifone e di Echidna
③, che terrorizzava tutta l'Argolide. a
prima fatica imposta ad Eracle fu l'uccisione di un
terribile leone, figlio di Tifone e di Echidna
③, che terrorizzava tutta l'Argolide.
Il leone viveva in una grotta nei pressi della piana di
Nemea, che si estende sotto il monte Apesas, attraverso il
quale passa la strada che conduce da Argo a Tirinto.
Si narra che Eracle si mise in viaggio e si fermò nella
città di Cleone, dove venne ospitato dal re Molorco,
da tempo in lutto poiché il leone aveva ucciso suo figlio;
il re era intenzionato a sacrificare un ariete in onore
dell'ospite ma l'Alcide chiese di aspettare ancora trenta
giorni: se, in questo lasso di tempo, Eracle fosse riuscito
nell'impresa di uccidere la belva di Nemea, allora il
sacrificio sarebbe stato fatto in onore di Zeus Liberatore.
Quando Eracle rintracciò la grotta dove viveva la belva
mostruosa, egli bloccò uno dei varchi della tana per
spingere il leone ad uscire; quindi, tentò di colpirla con
il proprio arco ma la creatura era invulnerabile, per cui
non venne nemmeno scalfita dalle frecce.
L'eroe sradicò allora un enorme ulivo usandolo come clava,
ma anche questo tentativo fu inutile. Eracle afferrò allora
il leone e riuscì a strangolarlo a mezz'aria; l'eroe tornò
dal re Molorco, portando sul dorso la carcassa della belva,
che venne poi condotta festosamente alla presenza di
Euristeo.
Il re di Micene fu talmente spaventato dalla vista del leone
(anche se ormai defunto) che in seguitò proibì ad Eracle di
entrare in città con le sue prede; successivamente, egli si
fece preparare e collocare sotto terra un enorme vaso di
bronzo, dove nascondersi tutte le volte in cui l'Alcide
giungeva in città al termine di una della sue fatiche.
 |
| Eracle e il Leone di Nemea |
Stamnos a figure rosse, Atene (±550/540 a.C.)
University of Pennsylvania Museum, Filadelfia (USA) |
ii. L'Idra di Lerna
 l
re di Micene chiese quindi al figlio di Alcmena di sgominare
un enorme drago (figlio anch'esso di Tifone e di Echidna),
che infestava la palude di Lerna, presso la sorgente Amimone
(in Argolide). l
re di Micene chiese quindi al figlio di Alcmena di sgominare
un enorme drago (figlio anch'esso di Tifone e di Echidna),
che infestava la palude di Lerna, presso la sorgente Amimone
(in Argolide).
Questo mostro aveva sette teste a forma di serpente (o nove,
secondo altre versioni del mito), di cui una immortale:
divorava qualunque essere vivente gli capitasse a tiro,
impestava l'aria e rendeva la terra sterile.
Eracle giunse con il proprio carro presso la tana dell'idra,
accompagnato dal nipote Iolao (figlio di suo fratello
Ificle); stanato il mostro con delle frecce infuocate, il
figlio di Alcmena cominciò a recidere le teste del mostro
con la propria spada ma ad ogni colpo dell'eroe in luogo
della testa mozzata ne ricrescevano due…
L'eroe ebbe però una geniale intuizione; con l'aiuto di
Iolao, egli fece bruciare i colli dell'idra prima che le
teste potessero crescere; l'ultima testa (quella immortale)
venne infine schiacciata sotto un gigantesco masso. In
questo modo Eracle riuscì a sconfiggere l'orrida creatura e
a liberare la palude di Lerna; l'eroe intinse quindi nel
sangue dell'idra le proprie frecce, che in tal modo
avrebbero causato ferite inguaribili e mortali.
 |
| Eracle e l'Idra di Lerna |
Hydria a figure nere, Cere (±525 a.C.)
Getty Villa, Los Angeles, California (USA) |
iii. La cerva di Cerinea
 a
terza fatica di Eracle fu la cattura di un animale sacro
alla dea Artemide. Nei pressi della regione di Cerinea, in
Arcadia, viveva una splendida cerva dalle corna d'oro e
dagli zoccoli di bronzo (o d'argento, secondo un'altra
variante del mito) che fuggiva senza mai fermarsi incantando
chi la inseguiva e trascinandolo in paesi da cui non avrebbe
più fatto ritorno; narrano le leggende che in origine
l'animale fosse una compagna della dea Artemide, trasformata
poi in cerva per punizione avendo accettato di essere
sedotta da Zeus. a
terza fatica di Eracle fu la cattura di un animale sacro
alla dea Artemide. Nei pressi della regione di Cerinea, in
Arcadia, viveva una splendida cerva dalle corna d'oro e
dagli zoccoli di bronzo (o d'argento, secondo un'altra
variante del mito) che fuggiva senza mai fermarsi incantando
chi la inseguiva e trascinandolo in paesi da cui non avrebbe
più fatto ritorno; narrano le leggende che in origine
l'animale fosse una compagna della dea Artemide, trasformata
poi in cerva per punizione avendo accettato di essere
sedotta da Zeus.
Eracle non poteva assolutamente ucciderla né ferirla, poiché
essa era un animale sacro, e quindi l'eroe si limitò ad
inseguirla. La frenetica corsa durò circa un anno; l'eroe
raggiunse quindi la cerva in un bosco sacro posto
nell'angolo più settentrionale del mare Adriatico, nella
penisola d'Istria, dove viveva il popolo degli Iperborei ④.
Secondo una versione del mito, Eracle catturò l'animale
mentre tentava di guadare un fiume; secondo altri, non
essendo riuscito a raggiungerla, l'eroe ferì leggermente
l'agile cerva con un dardo, per poi caricarsela sulle spalle
e condurla a Micene.
Lungo la strada del ritorno, Eracle incontrò Apollo ed
Artemide, infuriati per la ferita arrecata ad un animale
sacro agli dei: l'eroe riuscì tuttavia a placare le ire
divine e ad ottenere il permesso di portare la cerva ad
Euristeo. Quindi, l'animale venne liberato e tornò a correre
libero nelle foreste.
 |
| Eracle e la cerva di Cerinea |
Amphora a figure nere, Vulci (±540/530 a.C.)
British Museum, London (Gran Bretagna) |
iv. Il cinghiale d'Erimanto
 a
quarta impresa di Eracle fu quella di catturare un feroce
cinghiale selvatico che devastava le alture di Erimanto,
poste tra la regione dell'Acaia e quella dell'Elide. a
quarta impresa di Eracle fu quella di catturare un feroce
cinghiale selvatico che devastava le alture di Erimanto,
poste tra la regione dell'Acaia e quella dell'Elide.
L'eroe attraversò l'Arcadia e giunse quindi nella valle
dell'Alfeo, dove abitavano i Centauri, esseri selvaggi
abitanti dei boschi al cui corpo di cavallo a quattro zampe
era attaccato un tronco umano ⑤.
Lungo la strada che l'avrebbe portato a Erimanto, Eracle
incontrò un centauro di nome Folo, che decise di imbandire
un banchetto in suo onore.
Poiché, durante il pasto, venne versato del vino, alcuni
centauri raggiunsero la tana di Folo; dal momento che tali
creature non reggevano l'effetto inebriante del liquido
rosso, il simposio degenerò in una rissa, che costrinse
Eracle a fare uso delle sue frecce avvelenate. Nello scontro
che ne seguì, morì accidentalmente lo stesso Folo e venne
ferito gravemente anche il famoso Chirone, precettore dei
più grandi eroi del passato ⑥.
Eracle proseguì quindi il suo viaggio verso il monte
Erimanto, dove riuscì a far uscire il cinghiale dalla sua
tana spingendolo sulle alture coperte di neve; dopo un
serrato inseguimento, l'eroe riuscì a catturare l'animale
legandolo con corde robuste e a portarlo vivo a Micene.
Quando Euristeo vide Eracle con il mostruoso animale
selvatico sulle spalle, egli ne fu talmente spaventato che
andò a rinchiudersi, per la paura, dentro il vaso di bronzo
che si era fatto costruire (secondo altri racconti, il re di
Micene andò a nascondersi… dentro una botte!). Secondo una
versione del mito, dopo aver compiuto questa fatica, Eracle
si unì – sia pure per un breve periodo – alla impresa degli
Argonauti, di cui parleremo più diffusamente nel Capitolo
III.
 |
| Eracle, Euristeo e il cinghiale di Erimanto |
Amphora attica a figure nere (±540/520 a.C.)
University Museum, University of Mississippi, Oxford, Mississippi (USA) |
v. Gli uccelli della palude di Stinfalo
 a
quinta prova per Eracle fu quella di eliminare dei mostruosi
uccelli che devastavano la zona adiacente alla palude di
Stinfalo, nell'angolo nord-orientale dell'Arcadia. a
quinta prova per Eracle fu quella di eliminare dei mostruosi
uccelli che devastavano la zona adiacente alla palude di
Stinfalo, nell'angolo nord-orientale dell'Arcadia.
Questi micidiali volatili avevano penne, ali, artigli e
becco di bronzo; uccidevano lanciando le loro penne come
frecce e si nutrivano di carne umana. Tali mostruosi esseri
erano stati allevati da Ares ed erano così numerosi che,
quando prendevano il volo, oscuravano il cielo.
La palude degli uccelli Stinfalidi emanava un odore
nauseabondo a causa dei cadaveri di coloro che avevano
tentato di affrontarli.
Eracle (su consiglio, pare, della dea Atena) salì su di
un'altura presso il margine della palude e agitò un sonaglio
di bronzo; il rumore spaventò gli uccelli facendoli volare
via e rendendoli quindi facilmente raggiungibili dalle
frecce avvelenate dell'eroe.
I pochi uccelli che riuscirono a sfuggire ai dardi di Eracle
ripararono nell'isola di Ares, vicino alla Colchide, dove
vennero affrontati e sconfitti dagli Argonauti.
 |
| Eracle e gli uccelli di Stinfalo |
Amphora etrusca a figure nere, Vulci
(±540/530 a.C.)
British Museum, London (Gran Bretagna) |
vi. Le stalle di Augia
 e
stalle di Augia, figlio di Helios e re dell'Elide, non erano
mai state ripulite dal letame ed erano circa trent'anni che
vi si accumulavano escrementi al loro interno. Euristeo
ordinò dunque ad Eracle di recarsi nell'Elide e ripulire in
un solo giorno le stalle del re Augia. e
stalle di Augia, figlio di Helios e re dell'Elide, non erano
mai state ripulite dal letame ed erano circa trent'anni che
vi si accumulavano escrementi al loro interno. Euristeo
ordinò dunque ad Eracle di recarsi nell'Elide e ripulire in
un solo giorno le stalle del re Augia.
L'eroe, recatosi presso il sovrano, ricevette da questi una
proposta: se fosse riuscito a compiere una fatica simile
avrebbe ricevuto in cambio metà delle sue ricchezze.
Eracle deviò le acque dei fiumi Alfeo e Peneo, riversandole
all'interno delle stalle che furono quindi totalmente
ripulite.
L'Alcide tornò da Augia, il quale – avendo appreso che
l'impresa era stata imposta ad Eracle da Euristeo - non
volle però rispettare i patti; il re di Elide intentò un
processo contro Eracle prendendo quali testimoni tutti i
principi suoi figli. Tutti testimoniarono a favore del
padre, con l'eccezione di Fileo; adirato, Augia, scacciò dal
regno suo figlio, insieme all'eroe. Quest'ultimo, prima di
andarsene, giurò che si sarebbe presto vendicato sul re e
sui suoi figli.
Durante il viaggio di ritorno, Eracle difese la giovane
figlia di Dessameno, re di Oleno, dalle grinfie del centauro
Eurizione, che venne sconfitto ed ucciso dall'eroe.
vii. Le cavalle di Diomede
 iomede,
figlio del dio Ares (da non confondere con l'eroe omerico),
era un sovrano dei Bistoni, una popolazione della Tracia,
famoso per la sua crudeltà, il quale allevava cavalle che
nutriva con carne umana (dapprima, gli dava in pasto i
soldati caduti in battaglia; in seguito, anche gli
sventurati ospiti che venivano invitati a corte); si
trattava, ovviamente di animali molto particolari, che
alcuni vogliono imparentati con le Arpie, le Erinni o
addirittura le Gorgoni. Euristeo ordinò ad Eracle di portare
a Micene le Cavalle della Morte, senza però rivelargli le
terribili abitudini alimentari delle giumente. iomede,
figlio del dio Ares (da non confondere con l'eroe omerico),
era un sovrano dei Bistoni, una popolazione della Tracia,
famoso per la sua crudeltà, il quale allevava cavalle che
nutriva con carne umana (dapprima, gli dava in pasto i
soldati caduti in battaglia; in seguito, anche gli
sventurati ospiti che venivano invitati a corte); si
trattava, ovviamente di animali molto particolari, che
alcuni vogliono imparentati con le Arpie, le Erinni o
addirittura le Gorgoni. Euristeo ordinò ad Eracle di portare
a Micene le Cavalle della Morte, senza però rivelargli le
terribili abitudini alimentari delle giumente.
Eracle si mise in marcia e giunse in Tessaglia e
precisamente a Fere, dove regnava il re Admeto (che l'eroe
aveva già avuto modo di conoscere durante la spedizione
degli Argonauti).
Il re di Fere accolse l'Alcide con tutti gli onori anche se
aveva sofferto da poco un gravissimo lutto: la morte della
moglie, la bella e saggia Alcesti.
Tempo addietro, infatti, Admeto era stato colpito da una
grave malattia che l'avrebbe condotto presto al decesso;
impietosito per la sorte di un sovrano così giusto, il dio
Apollo cercò di intercedere per lui presso la dea della
Morte, la terribile Thanatos; il dio del sole e delle arti,
infatti, era stato a lungo al servizio di Admeto come
pastore in un periodo in cui era stato costretto a vagare
come un comune mortale sulla terra per aver disobbedito al
volere del padre Zeus.
Thanatos aveva ceduto, in parte, alle preghiere di Apollo e
concesse di salvare il re di Fere solo se qualcuno si fosse
offerto di morire in sua vece. Né il padre né la madre del
re (benché anziani), né alcuno dei sudditi di Fere avevano
tuttavia accettato di sacrificare la loro vita per Admeto,
tranne la moglie Alcesti.
La bella sovrana, quindi, aveva cominciato a deperire di
giorno in giorno (mentre il marito riprendeva le forze) ed
era deceduta poco prima dell'arrivo di Eracle.
L'eroe, ignaro dell'accaduto, chiese ospitalità ad Admeto e
cominciò a mangiare in abbondanza e a gozzovigliare, mentre
gli abitanti e i servitori della casa piangevano nelle
proprie stanze la tragica perdita della regina.
Uno dei servi, indignato per tale comportamento, rimproverò
l'ospite per la propria maleducazione raccontandogli tutto
l'accaduto. Vergognatosi per il proprio atteggiamento,
Eracle giurò sullo Stige di ripagare l'ospitalità
dell'amico.
L'Alcide si recò presso la tomba di Alcesti e, poco prima
che Tanathos ne ghermisse l'anima per portarla nel regno
dell'oltretomba, affrontò la dea della morte in un feroce
corpo a corpo, al termine del quale la bella regina di Fere
venne strappata dagli dei inferi e ricondotta nel mondo dei
vivi ⑦.
Eracle proseguì quindi il viaggio verso la Tracia in
compagnia di un gruppo di compagni, tra i quali figurava un
certo Abdero.
L'Alcide ingaggiò una furiosa battaglia con il terribile
Diomede e, mentre teneva occupato quest'ultimo, ordinò ai
suoi di prendere le cavalle. Abdero, che per primo tentò di
catturarle, venne divorato dalle mostruose giumente.
Furente, Eracle sconfisse Diomede e lo costrinse a
condividere il destino delle sue vittime: anche lui divenne
così il pasto delle cavalle ⑧.
In onore del defunto amico Abdero, Eracle fondò nel luogo
della morte del compagno una città (Àbdera), che in età
storica divenne la patria di illustri filosofi.
Durante il viaggio di ritorno in patria, l'eroe dovette
affrontare in un duello combattuto su carri da guerra
Cicno, figlio di Ares, un brigante sanguinario deciso ad
edificare un tempio al padre con le ossa degli stranieri che
passavano per il suo territorio; secondo la maggior parte
dei narratori, Cicno fu ucciso da Eracle, mentre altri
sostengono che Zeus in persona separò i due contendenti ⑨.
Tornato da Euristeo, l'Alcide sfoggiò le mitiche cavalle ma
il sovrano, terrorizzato, ordinò che venissero portate via.
viii. Il Toro di Creta
 uristeo
ordinò ad Eracle di catturare un toro, che in quel tempo
devastava il territorio di Creta. uristeo
ordinò ad Eracle di catturare un toro, che in quel tempo
devastava il territorio di Creta.
Minosse, il sovrano dell'isola, era particolarmente devoto a
Poseidone, il dio del mare, cui aveva promesso di offrire in
sacrificio un toro; si narra, a questo punto, che lo stesso
nume facesse sorgere dai flutti marini un animale dalla
bellezza incomparabile. Il sovrano ne fu talmente ammirato
che decise di sacrificare un altro toro e di tenersi quello
splendido esemplare.
La vendetta del dio del mare non si fece attendere: la bella
Pasifae (moglie di Minosse), infatti, venne posseduta da un
immondo desiderio nei confronti del toro emerso dalle onde;
per placare il suo ardore, la regina chiese all'artigiano
più famoso dell'isola, l'abilissimo Dedalo, di costruirle
una mucca di legno dove nascondersi; quello stratagemma
consentì a Pasifae di ingannare il toro e di sedurlo.
Da quella folle ed insana passione amorosa nacque una
creatura deforme ed atroce, cui venne dato il nome di
Minotauro: il corpo gigantesco era quello di un uomo, la
testa enorme era quella di un toro; si nutriva di carne
umana ed emetteva terrificanti muggiti ⑩.
Il genitore del terribile mostro scorrazzava libero per
l'isola di Creta, devastando il territorio e terrorizzando
gli abitanti.
Eracle acciuffò la belva, richiudendola in una rete, e la
portò ad Euristeo, il quale ordinò di liberarla. Il toro
giunse quindi nella piana di Maratona, nell'Attica, dove
venne nuovamente catturato da Teseo.
 |
| Eracle e il toro di Creta |
Amphora etrusca a figure nere, Vulci (±510 a.C.)
Staatliche Antikensammlungen, München (Germania) |
ix. Il cinto di Ippolita
 u
richiesta di una delle figlie di Euristeo, Eracle dovette
recarsi presso le Amazzoni a prendere possesso della
splendida cintura della loro regina Ippolita, figlia
di Ares. u
richiesta di una delle figlie di Euristeo, Eracle dovette
recarsi presso le Amazzoni a prendere possesso della
splendida cintura della loro regina Ippolita, figlia
di Ares.
Eracle, in compagnia di un gruppo di eroi (tra i quali
figurava anche Teseo), si imbarcò quindi alla volta di
Temiscira, posta alla foce del fiume Termodonte, nella parte
orientale del Ponto Eusino (il Mar Nero): qui, secondo la
tradizione, dimorava la regina delle Amazzoni, una stirpe di
temibili donne guerriere che lasciavano in vita soltanto le
figlie femmine e che si amputavano la mammella destra per
non essere impedite nel tiro con l'arco, specialità in cui
erano maestre.
Giunti a Temiscira, gli eroi vennero accolti calorosamente
da Ippolita, disposta a cedere pacificamente il proprio
cinto.
La dea Hera, tuttavia, architettò uno stratagemma per non
rendere la vita facile all'eroe: dapprima fece addormentare
Zeus con l'aiuto di Hypnos, il dio del sonno; poi
prese le sembianze di una amazzone e sobillò le donne
guerriere, inducendole a credere che Eracle fosse giunto per
rapire la loro regina.
Ne nacque una tremenda battaglia, al termine della quale le
Amazzoni furono sconfitte e la loro regina fatta prigioniera
da Teseo: dalla loro unione nacque un figlio, Ippolito,
futuro seguace devoto della dea Artemide.
Quando Zeus si risvegliò dal sonno cui era stato indotto, si
adirò con la moglie Hera per il suo stratagemma e, per
punizione, la sospese in aria legata ad una corda d'oro, con
due incudini ai piedi; il dio Hypnos riuscì invece a
scamparla riparando presso la madre Notte.
Durante il viaggio di ritorno, con il prezioso cinto ben
conservato, Eracle e i suoi uomini giunsero presso la città
di Troia, dove un terribile mostro marino inviato da
Poseidone devastava la popolazione; un oracolo aveva
predetto che solo offrendo in sacrificio la principessa
Esione poteva essere placata l'ira del dio del mare.
Eracle si offrì di affrontare la terribile creatura in
cambio di una pariglia dei bellissimi cavalli del re
Laomedonte; il sovrano, pur di salvare la figlia, accettò.
L'Alcide si scontrò con il mostro (un pesce gigantesco) e lo
uccise. Laomedonte, tuttavia, non rispettò i patti,
scatenando così l'ira dell'eroe, che giurò di vendicarsi non
appena finite le sue dodici fatiche.
 |
| Eracle contro le Amazzoni |
Amphora attica a figure nere (±520 a.C.)
Metropolitan Museum of Art, New York (USA) |
x - I buoi di Gerione
La decima fatica di Eracle fu quella di catturare i
leggendari buoi di Gerione; quest'ultimo era un
mostro dall'aspetto terrificante; figlio di Calliroe, una
delle ninfe oceanine, e di Crisaore (il «guerriero dalla
spada d'oro», nato dal sangue di Medusa che sgorgò quando
venne decapitata da Perseo), l'orrenda creatura aveva tre
gambe e tre tronchi, da cui si protendevano tre teste e tre
paia di braccia.
Il gigante aveva posto come custodi delle sue mandrie un
mostruoso cane, Ortro, figlio di Tifone e di Echidna,
e il terribile vaccaro Eurizione, figlio di Ares.
I possedimenti di Gerione erano posti agli estremi confini
della terra allora conosciuta, ragion per cui Eracle si
imbarcò da Pilo e raggiunse i confini del mondo; ivi piantò
due colonne, le cosiddette «Colonne d'Ercole», come monito
futuro per l'umanità affinché nessuno dovesse più
oltrepassarle ⑪.
Mentre attraversava le colonne, l'Alcide chiese aiuto a
Helios, il dio del Sole, per giungere alle terre di Gerione;
di fronte al rifiuto del nume, Eracle si infuriò e giunse a
scagliare le sue frecce contro il cocente disco solare. Il
dio, ammirato per il suo coraggio, gli consentì di usare il
suo battello d'oro a forma di coppa per raggiungere il
nemico; l'eroe dovette addirittura minacciare il dio Oceano,
che aveva sollevato i suoi flutti, per proseguire il
viaggio.
Giunto nell'isola di Erizia, Eracle affrontò Gerione, Ortro
ed Eurizione, che vennero sconfitti dai terribili colpi
dell'Alcide; l'eroe non esitò a colpire persino la dea Hera,
accorsa in aiuto del mostro contro l'odiato figliastro.
Dopo essersi impossessato delle mandrie, Eracle partì alla
volta di Micene; durante il viaggio di ritorno, egli
percorse la penisola italica; giunto in Tirrenia, l'eroe si
imbatté nel gigante Caco, che esalava fumo e fiamme
dalle fauci. Questi rubò le bestie migliori della mandria
approfittando del sonno di Eracle e, per non lasciare tracce
del furto, trascinò per la coda gli animali verso la caverna
che gli serviva da rifugio.
Ingannato dal trucco del gigante, Eracle si era ormai
rassegnato a dare gli animali per dispersi quando sentì il
muggito delle bestie dal fondo di una spelonca. Per
liberarli, Eracle dovette rimuovere un macigno che faceva da
soffitto alla grotta ed affrontare il mostro, che venne
stritolato dalla spaventosa morsa dell'Alcide e poi
scaraventato giù da una rupe ⑫.
Giunto nella punta meridionale della penisola, Eracle
dovette inseguire una parte degli armenti che a nuoto
avevano raggiunto la Sicilia (una parte dei buoi venne
divorata dalla terribile Scilla); qui si scontrò con
il despota Erice e lo uccise; il luogo di sepoltura del
tiranno diede il nome all'omonima cittadina.
Una volta sbarcato in Grecia, Eracle dovette affrontare
Neleo, re di Pilo (che tentò anche di rubargli gli armenti),
e il gigante Alcione; inoltre, Hera mandò contro le mandrie
un tafano che causò la loro dispersione. Eracle le inseguì
freneticamente sino a catturarle di nuovo e riuscì alfine a
portare le bestie sane e salve in patria, dove Euristeo le
offrì in sacrificio alla stessa dea Hera.
 |
| Eracle contro Gerione |
Amphora a figure nere (±540 a.C.)
Musée du Louvre, Paris (Francia) |
xi. I pomi delle Esperidi
Ad Eracle venne quindi ordinato di prendere tre mele dal
giardino delle Esperidi; un tale fantastico sito prendeva il
nome da quattro ninfe, figlie della Notte (ovvero,
secondo taluni, del titano Atlante e della ninfa
Esperide; taluni sostengono invece che fossero figlie di
Zeus e di Temi), che abitavano il giardino assieme al drago
Ladone dalle cento teste, il custode del luogo sacro:
si narra, infatti, che il giardino fosse il regalo di nozze
che la dea Terra aveva fatto a Zeus ed Hera per il loro
matrimonio: gli alberi che germogliavano producevano frutti
d'oro.
Nessuno sapeva in quale remoto angolo della Terra si
trovasse il giardino delle Esperidi. Eracle cercò dapprima
di trovarlo nelle zone più sperdute della penisola ellenica,
ma non ebbe fortuna.
Quindi si recò nella penisola italica, dove presso il fiume
Eridano incontrò le splendide ninfe del luogo; esse
furono liete di dargli consigli e gli dissero di recarsi
presso il dio marino Nereo (ovvero, secondo altri,
Proteo), che conosceva tale segreto.
Eracle sorprese la divinità dei flutti mentre questi dormiva
e lo strinse saldamente, così come gli avevano detto le
ninfe, nonostante questi cercasse di sfuggirgli utilizzando
i suoi poteri di metamorfosi. Alla fine, il vecchio del mare
si arrese e acconsentì a soddisfare le richieste di Eracle,
indicandogli la strada per raggiungere l'isola dove si
trovava il giardino delle Esperidi.
Durante il viaggio l'Alcide ottenne poi altre informazioni
da Prometeo, che da lunghi anni si trovava incatenato ed
esposto alle torture di un'aquila che gli rodeva il fegato.
Con il consenso del padre Zeus, Eracle uccise il rapace e
liberò il Titano. Prometeo gli consigliò di cercare suo
fratello Atlante, padre delle Esperidi, e di far cogliere a
lui stesso i preziosi frutti d'oro.
Giunto nel continente africano, Eracle attraversò l'Egitto,
dove incappò nel re Busiride. Poiché, anni prima,
quella terra era stata devastata da una terribile carestia,
un indovino aveva profetizzato che l'ira degli dei poteva
essere placata soltanto con il sacrificio di uomini nati in
altre terre. Busiride aveva compiuto il primo sacrificio
trucidando il malcapitato indovino e, da allora, ogni anno
uno straniero era vittima di questo crudele rito.
Eracle stesso venne catturato, ma riuscì a spezzare le
catene e ad uccidere il re sullo stesso altare utilizzato
per il sacrificio, sotto lo sguardo terrorizzato della
popolazione ⑬.
In seguito, l'Alcide si scontrò con un avversario ancora più
temibile, il gigante Anteo, figlio di Gea, che
sfidava tutti i malcapitati che incontrava in un duello
all'ultimo sangue ⑭. Come figlio della dea-terra, il gigante
era in grado di riprendere tutte le sue forze ogni volta
che, messo al tappeto, egli veniva a contatto con il
terreno. L'eroe trovò il modo di impedire all'avversario di
servirsi di questo vantaggio tenendolo in alto con le
poderose braccia e strangolandolo così a mezz'aria.
Dopo un lungo viaggio, l'Alcide raggiunse finalmente il
gigante Atlante, il quale reggeva sulle sue poderose spalle
la volta del cielo. Eracle si offrì di sostituirlo nel
gravoso compito per qualche tempo, se questi avesse
acconsentito a raccogliere per lui le mele d'oro dal
giardino delle Esperidi; il Titano acconsentì ⑮.
Quando Atlante fece ritorno con i frutti rubati, non avendo
nessuna intenzione di riprendere l'immane fardello di
reggere il firmamento, cercò di lasciarne per sempre la
responsabilità ad Eracle offrendosi di recapitare egli
stesso le mele ad Euristeo.
L'Alcide, fingendosi onorato del delicato incarico, chiese
ad Atlante di riprendere solo per un momento la volta
celeste sulle spalle, in modo da consentirgli di intrecciare
una stuoia che ne alleggerisse la pressione sulla schiena.
Il gigante riprese il fardello, ma prima che potesse
rendersi conto di essere stato giocato con i suoi stessi
mezzi il furbo Eracle era già fuggito, portando con sé il
bottino delle mele d'oro.
 |
| Eracle nel giardino delle Esperidi |
Hydria attica a figure rosse (IV a.C.)
Metropolitan Museum, New York (USA) |
xii. La cattura di Cerbero
Euristeo scelse, come ultima prova, un'impresa che sembrava
impossibile per qualsiasi mortale: catturare Cerbero, lo
spaventoso cane a tre teste (figlio di Tifone ed Echidna),
posto a guardia dell'oltretomba: «fiera crudele e diversa,
con tre gole carinamente latra sopra la gente che quivi è
sommersa» .
L'Alcide si preparò a questa prova con un pellegrinaggio
presso Eleusi, dove venne iniziato ai misteri per
purificarsi; quindi, sotto la guida di Hermes, egli giunse
al Tenaro, la punta meridionale del Peloponneso, e si
addentrò in una buia spelonca che conduceva ad una delle
porte dell'Ade.
Per giungere nell'oltretomba era necessario attraversare il
fiume Acheronte; l'eroe si fece traghettare dal nocchiero
dei morti, Caronte; giunto nell'Ade, Eracle vide le ombre
dei trapassati e i terribili mostri che infestavano questa
tetra regione; tra tutti gli spiriti, solo la Medusa osò
affrontarlo: l'Alcide stava già per colpirla con la spada,
quando Hermes gli fermò la mano, ricordandogli che le
creature dell'Ade sono solo dei fantasmi.
Ad avvicinarsi ad Eracle fu l'ombra di Meleagro, celebre
eroe dell'epopea del cinghiale calidonio, il quale pregò
l'eroe di proteggere, una volta tornato nel mondo dei vivi,
la sorella Deianira.
Eracle giunse finalmente davanti al trono dei due sovrani
dell'oltretomba: Ades e Persefone. Il sovrano degli inferi,
conoscendo personalmente il coraggio e l'ardore dell'Alcide,
acconsentì a consegnargli il cane Cerbero, a patto però che
Eracle riuscisse a domarlo con le sole mani, senza fare uso
di armi.
Il figlio di Alcmena si recò di nuovo presso il fiume
Acheronte, dove dimorava il terribile cane a tre teste: dopo
una strenua lotta, il mostruoso figlio di Tifone e Echidna
fu costretto ad arrendersi quando Eracle riuscì a serrargli
tra le potenti braccia la base dei tre colli. Cerbero tentò
di colpirlo con la coda, ma alla fine dovette arrendersi e
si lasciò incatenare ⑯.
Presso le porte del palazzo di Ades, Eracle trovò due
prigionieri, che riconobbe molto presto: erano Teseo, suo
compagno in svariate avventure, e il suo amico Piritoo,
il re dei Lapiti. Entrambi erano scesi nel mondo sotterraneo
per rapire Persefone, ma erano stati scoperti e condannati a
restare seduti per l'eternità sulla pietra dell'oblio.
L'eroe riuscì a salvare Teseo ma, quando si apprestò a
recuperare anche Piritoo, fu costretto ad allontanarsi per
colpa di un terribile terremoto.
Eracle rivide la luce del sole nei pressi di Trezene, nella
regione dell'Attica, e di qui prese la via verso Micene.
Euristeo, vedendo l'eroe tornare con il mostro infernale
sulle spalle, si sentì morire per la paura e ordinò che
Cerbero venisse rimandato negli inferi.
Il re di Micene, avendo constatato che l'eroico cugino era
uscito vincitore da tutte le prove che gli aveva imposto, si
diede per vinto e lo liberò dalla sua prigionia.
 |
| Eracle, Euristeo e Cerbero |
Hydria etrusca a figure nere, da Cere (VI
sec. a.C.)
Musée du Louvre, Paris (Francia) |
| ① |
Durante la guerra contro i Mini,
della stirpe di Orcomeno, si dice fosse deceduto lo
stesso Anfitrione, padre adottivo di Eracle. |
| ② |
Le vicende narrate diedero
spunto ad Euripide per la tragedia
Eracle furente. Secondo il poeta greco,
tuttavia, la follia e gli efferati omicidi di Eracle
ebbero luogo al termine delle dodici fatiche. |
| ③ |
Racconti senza tempo,
Vol. I, pp. 22-39. |
| ④ |
Gli abitanti della penisola in
epoca storica, i Veneti, chiamarono questa regione Rezia. |
| ⑤ |
Secondo la tradizione, i
Centauri erano figli di Issione, il re dei Lapiti, e di
Nefele (la «nuvola»); il sovrano aveva ospitato presso
la sua reggia Zeus ed Hera ed aveva concepito una
morbosa passione per la regina degli dei. Zeus, allora,
creò con la nebbia una immagine della moglie (Nefele);
Issione la sedusse e con essa generò un essere metà uomo
e metà cavallo. Per tale oltraggio (Issione era pur
sempre convinto di avere sedotto Hera), Zeus scagliò il
re dei Lapiti nel Tartaro. |
| ⑥ |
Secondo una versione del mito,
il Centauro era immortale per cui fu costretto a
languire sino a quando non chiese a Zeus la grazia di
poter morire in luogo del tormentato Prometeo, il Titano
incatenato sui monti del Caucaso per aver sottratto il
fuoco dall'Olimpo; allora soltanto Chirone spirò e
Prometeo venne liberato, dopo che Eracle – con il
consenso del padre Zeus – uccise l'aquila che gli
divorava continuamente il fegato. |
| ⑦ |
Secondo un'altra versione, egli
scese nel regno dei morti e raccontò ad Ade e alla sua
sposa Persefone la struggente storia di Alcesti. I due
sovrani, commossi, concessero all'eroe di ricondurre la
donna nel mondo dei vivi. Queste vicende ispirarono ad
Euripide la tragedia Alcesti. |
| ⑧ |
Secondo la leggenda, Bucefalo,
il cavallo di Alessandro Magno discendeva da tali
giumente. |
| ⑨ |
Alcuni mitografi collocano
questo duello durante l'undicesima fatica. |
| ⑩ |
Il Minotauro venne ucciso dal
prode Teseo; v. Racconti senza tempo, Vol. I, pp. 22-39. |
| ⑪ |
Sono tradizionalmente
identificate con lo stretto di Gibilterra. Recentemente,
il giornalista Sergio Frau ha invece proposto di
collocarle nello stretto di Sicilia, ma solo al fine di
identificare la Sardegna con Atlantide: cfr. FRAU, Le
Colonne d'Ercole, Roma, Nur Neon srl, 2002. |
| ⑫ |
Come si legge nell'Eneide,
la leggenda di Eracle e Caco viene narrata dal re
Evandro ad Enea. |
| ⑬ |
Secondo un'altra versione del
mito, lo scontro con Busiride sarebbe avvenuto nel corso
del viaggio verso le terre di Gerione, durante la decima
fatica. |
| ⑭ |
Secondo un'altra versione del
mito, la lotta contro Anteo sarebbe avvenuta, anche in
questo caso, durante la decima fatica. |
| ⑮ |
Alcuni poeti riferiscono che
Atlante si sarebbe inizialmente rifiutato di cogliere le
mele per paura del drago Ladone; a questo punto, Eracle
avrebbe incoccato una freccia uccidendo il mostro con un
solo colpo, convincendo così il titano a compiere
l'impresa. Ma questo episodio appare «eccessivo» anche
per un ingenuo affabulatore come il vostro Autore… |
| ⑯ |
Alcuni poeti riferiscono che
Atlante si sarebbe inizialmente rifiutato di cogliere le
mele per paura del drago Ladone; a questo punto, Eracle
avrebbe incoccato una freccia uccidendo il mostro con un
solo colpo, convincendo così il titano a compiere
l'impresa. Ma questo episodio appare «eccessivo» anche
per un ingenuo affabulatore come il vostro Autore… |
.
Párerga, le ultime imprese di Eracle
 l
termine delle sue dodici fatiche, Eracle aveva così
riconquistato la sua libertà e acquisito il titolo di
Callinico («dalla bella vittoria»). l
termine delle sue dodici fatiche, Eracle aveva così
riconquistato la sua libertà e acquisito il titolo di
Callinico («dalla bella vittoria»).
L'eroe decise allora di trovarsi una nuova compagna e si
invaghì di Iole, figlia di Eurito, re di Ecalia (suo
maestro di tiro con l'arco in gioventù). Il rinomato arciere
offriva la figlia in sposa a chi lo avesse superato nella
sua specialità. Eracle partecipò alla contesa e sconfisse il
suo antico maestro nel tiro con l'arco; Eurito cercò
tuttavia di impedire il matrimonio tra la sua adorata figlia
e un uomo che non aveva esitato ad uccidere la propria
moglie.
Tra i figli del re il solo Ifito prese le parti
dell'eroe, da lui grandemente stimato; dal canto suo Eracle,
quando si vide negare la sposa regolarmente conquistata,
andò su tutte le furie.
Accadde intanto che certi buoi appartenenti ad Eurito
venissero rubati; il re di Ecalia fece credere a tutti che
il furto fosse stato commesso dall'Alcide per screditarlo:
Ifito non accettò nemmeno allora l'ipotesi che l'amico
potesse aver compiuto un'azione così meschina: unitosi ad
Eracle, si mise sulle tracce del vero responsabile
dell'azione.
Durante il viaggio, però, Eracle venne nuovamente posseduto
dal flagello della collera, la maledizione lanciatagli dalla
matrigna Hera, e fece pagare al giovane lo sgarbo di Eurito
scagliandolo giù da una torre. Quando ritornò in sé e si
accorse di aver ucciso un amico, l'Alcide cadde in una
profonda prostrazione.
Eracle aveva commesso uno degli atti più spregevoli, secondo
la morale ellenica, avendo ucciso un ospite ed un amico.
Nessuno voleva compiere per lui il rito di purificazione
tanto che l'Alcide decise di andare a Delfi per avere la
punizione per il suo delitto.
La Pizia (la sacerdotessa di Apollo), tuttavia, non aveva
alcuna intenzione di riceverlo e di ascoltarlo: di nuovo in
preda alla rabbia, Eracle riportò lo scompiglio nel tempio,
impadronendosi del tripode sacro ad Apollo e minacciando di
compiere il rito da sé.
Lo stesso dio Apollo scese giù dall'Olimpo e decise di
affrontare Eracle. Lo scontro fu tanto cruento, che Zeus fu
costretto ad intervenire, separando i duellanti e imponendo
alla Pizia di riferire a Eracle come potesse purificarsi
dall'omicidio di Ifito e dalla profanazione dell'oracolo.
Sotto la guida di Hermes, Eracle si imbarcò verso l'Asia e
si fece vendere come schiavo; venne acquistato per tre
talenti da Onfale, regina della Lidia. Ella
capì ben presto di che schiatta fosse il figlio di Alcmena e
pensò di utilizzarlo come compagno di vita invece che come
servitore.
Sotto il suo comando, Eracle liberò la regione dai
Cercopi, dei ladri che potevano anche assumere l'aspetto
di scimmie e che importunavano i viandanti della zona;
l'eroe riuscì a catturarli e a legarli con i piedi ad un
bastone, trascinandoli come secchi; ma i due si mostrarono
talmente bizzarri e simpatici (facendo anche sconce
allusioni al fondoschiena abbronzato dell'Alcide), che
Eracle alla fine li liberò sorridendo. ①
Durante la sua schiavitù presso Onfale, Eracle uccise anche
il brigante Sileo, che catturava i viaggiatori e li
uccideva dopo averli obbligati a lavorare nella sua vigna;
stessa sorte toccò a Litierse della Frigia, detto il
«mietitore» per la sua trista fama di tagliatore di teste.
Il lusso e gli agi della vita orientale riuscirono in
qualche modo a rammollire l'eroe, che divenne il passatempo
preferito di Onfale; la regina era solita giocare con la
clava e la pelle di leone di Eracle e si divertiva a
vestirlo con abiti femminili e ad impiegarlo nella filatura
della lana.
Dopo tre anni trascorsi in questo modo, l'Alcide decise di
dire addio a questa vita così poco adatta a un eroe come lui
e lasciò per sempre Onfale e la sua corte.
Eracle decise di vendicarsi su coloro che, durante la
schiavitù presso Euristeo, avevano trasgredito i patti
stabiliti. A Tirinto, l'eroe radunò un drappello di compagni
eroici (tra i quali figuravano Iolao, Peleo e
Telamone) per muovere guerra contro Laomedonte, il re
troiano che non aveva voluto riconoscere all'eroe il giusto
compenso per aver salvato la figlia Esione.
L'esercito di Eracle sconfisse il re di Troia e trucidò il
sovrano e i suoi figli maschi, risparmiando solo Esione e il
piccolo Podarce, che venne riscattato dalla sorella. ②
Esione andò in sposa a Telamone e dalla loro unione nacque
Teucro, destinato a diventare un valoroso guerriero ed un
abile arciere. Podarce, invece, decise di cambiare il suo
nome in Priamo (che significa appunto il
«riscattato») e rifondò la città di Troia, portandola
all'antico splendore.
La vendetta personale dell'eroe non era ancora conclusa; vi
era infatti un altro fedifrago da punire: Augia. Questi
venne sconfitto ed ucciso insieme a tutto il suo esercito e
ad i suoi alleati (tra cui il fratello Attore); i
suoi domini vennero ceduti al figlio Fileo, l'unico che
aveva difeso Eracle in presenza del padre.
Eracle invase anche il territorio dell'Elide per vendicarsi
di Neleo, re di Pilo, che aveva tentato di sottrargli i buoi
di Gerione e – si narra - non aveva voluto purificarlo dopo
l'uccisione di Ifito. Il sovrano venne ucciso insieme ai
suoi figli: unico sopravvissuto della famiglia reale fu
Nestore, che si trovava lontano dalla propria patria ed
ereditò quindi il regno paterno.
Stessa sorte toccò ad Ippocoonte, re di Sparta; Eracle lo
sconfisse e mise sul trono il fratello Tindaro, destinato a
divenire il padre adottivo di Elena (la donna che fu
l'origine della famosa guerra di Troia).
Durante queste imprese, Eracle si invaghì della sacerdotessa
Auge, figlia del suo compagno ed alleato Cefeo, dalla quale
ebbe Telefo, futuro re della Misia.
Eracle giunse quindi in Calidonia, una regione dell'Etolia,
per riferire a Deianira, figlia del re Oineo, il messaggio
che il fratello Meleagro le inviava dal regno dei morti.
Eracle, che già sapeva della bellezza della fanciulla, si
innamorò di lei e la portò con sé come sposa, dopo un'ardua
contesa con un rivale, il dio fluviale Acheloo.
 |
| Eracle e il dio fluviale Acheloo |
Stamnos etrusca a figure rosse, da Cere
(530/500 a.C.)
British Museum, London (Gran Bretagna) |
I due decisero di trasferirsi a Trachis, in Tessaglia, per
vivere lì insieme. Giunti di fronte ad un corso d'acqua in
piena, Eracle e la sua nuova moglie incontrarono il centauro
Nesso, che si offrì di traghettarli sulla riva opposta
portandoli sulla schiena.
Eracle, dopo aver gettato sull'altra riva la clava e la
pelle di leone, si tuffò a nuotare agilmente nel fiume in
piena, affidando la sposa alle cure di Nesso.
Il centauro si era infiammato dalla bellezza della donna e,
una volta giunto sull'altra sponda del fiume, tentò di
rapirla; Eracle sentì le grida della moglie e con una delle
sue frecce avvelenate trafisse Nesso in pieno petto.
Negli spasimi del dolore, il centauro suggerì a Deianira di
inzuppare un vestito nel suo sangue; se un domani l'eroe
avesse portato la camicia intrisa con quel liquido, Eracle
non si sarebbe più innamorato di nessuna altra donna.
Deianira venne così condotta a casa dell'Alcide: il
matrimonio venne allietato da ben otto figli, tra cui
Illo.
In seguito, Eracle mosse guerra nei confronti di Eurito,
maestro d'arco e trasgressore dei patti poiché non aveva
voluto cedere in sposa sua figlia al prode figlio di Alcmena
(secondo un decreto dell'Oracolo di Dodona, questa era
destinata ad essere l'ultima impresa di Eracle).
Eracle uccise Eurito e portò con sé numerosi prigionieri,
tra cui la bella Iole; presa dalla gelosia, Deianira decise
di mettere in pratica l'incantesimo che le aveva rivelato il
centauro. La figlia di Oineo inviò ad Eracle un vestito
immerso nel sangue di Nesso, che l'eroe indossò per
celebrare i riti di ringraziamento per la vittoria.
Non appena il fuoco acceso sull'altare ebbe riscaldato il
veleno con cui era intriso, il vestito cominciò a bruciare
la pelle dell'Alcide, che non riusciva in alcun modo a
strapparsi l'indumento di dosso.
Con le sue ultime forze, Eracle sradicò alcuni alberi e
costruì una pira funebre per porre fine alle sue sofferenze;
una volta preparato il rogo, né suo figlio Illo né il nipote
Iolao ebbero però il coraggio di accenderlo, Eracle fu
costretto a chiedere ad un pastore di nome Peante di dare
fuoco alla legna. Questi ubbidì e l'eroe gli donò le sue
armi, che si renderanno molto utili, durante la guerra di
Troia, al figlio Filottete.
Indossata la pelle di leone che non lo aveva mai abbandonato
l'Alcide salì sul rogo e spirò: con la morte dell'eroe ad
opera del sangue di Nesso si avverò la profezia di un
oracolo, che prevedeva la fine di Eracle ad opera di un uomo
morto. ③
Iolao, dopo aver osservato tale prodigio, costruì un tempio
in onore dello zio, mentre Illo, su ordine dello stesso Eracle, sposò Iole. Deianira, quando seppe ciò che era
successo, in preda ai sensi di colpa si uccise.
La storia dell'eroe più amato dagli antichi Elleni non
poteva non avere un lieto fine: mentre Eracle periva nelle
fiamme della pira Zeus prelevò il corpo del figlio e lo
condusse nell'Olimpo, accogliendolo tra le divinità; il
nobile discendente di Perseo, vincitore di aspre battaglie,
si riconciliò con Hera ed ebbe in sposa Ebe, coppiera degli
dei e dea dell'eterna giovinezza.
 |
| Eracle presentato da Ebe a Zeus |
Kylix attica a figure nere (± 560 a.C.)
British Museum, London (Gran Bretagna) |
Qui si chiude la nostra sia pur breve carrellata di tutte
le imprese del grande Eracle, che i Latini conosceranno con
il nome di Ercole. Noi aggiungeremo solamente che, dopo la
morte dell'eroe, si scatenò un'aspra faida tra Euristeo e i
discendenti di Eracle (detti, appunto, Eraclidi); si
narra che Iolao e Illo guidarono i figli dell'Alcide alla
riscossa contro il tiranno, cui venne tagliata la testa; una
ormai anziana Alcmena fece scempio del cadavere dell'odiato
nemico. La dinastia dei Perseidi si estinse a Micene; un
oracolo predisse che la corona dovesse essere affidata ad un
discendente di Pelope: tale onore spettò ad Atreo, padre di
Agamennone e Menelao (futuri protagonisti della guerra di
Troia).
| ① |
Non fu altrettanto pronto allo spirito
il sommo Zeus, che di fronte all'ironia dei Cercopi si adirò
trasformandoli definitivamente in scimmie. |
| ② |
Anche il giovane Titone, figlio di
Laomedonte, scampò alla morte, perché venne reso immortale
grazie all'intervento di Eos, l'Aurora, sua amante. |
| ③ |
La morte di Eracle ispirò a Sofocle la
tragedia Le Trachinie. |
|
|
II
I SETTE CONTRO TEBE
La turpe saga dei Labdacidi
Le leggende che ruotano attorno alla famiglia reale
tebana sono sicuramente tra le più fosche di tutta la
mitologia greca (pari solamente a quella degli Atridi, di
cui si è già avuto modo di parlare ), tanto che Dante
Alighieri nell'inveire contro Pisa, colpevole della morte
atroce per fame e per stenti del conte Ugolino e della sua
famiglia, la definisce «novella Tebe» ①. Il nostro racconto
prosegue pertanto con le imprese di Cadmo, principe di Tiro,
e con le sciagure che si abbatterono sui suoi discendenti ②.
.
Il ratto di Europa
 anto
tempo fa, nella terra dei Cananei prosperava una città che i
nostri antenati chiamarono Tiro, la quale dominava la
regione della Fenicia; il loro re, Agenore ③, pur
essendo stato allietato da ben tre figli maschi, Cadmo,
Fenice e Cilice, stravedeva per l'unica figlia
femmina, alla quale aveva dato il nome di Europa. anto
tempo fa, nella terra dei Cananei prosperava una città che i
nostri antenati chiamarono Tiro, la quale dominava la
regione della Fenicia; il loro re, Agenore ③, pur
essendo stato allietato da ben tre figli maschi, Cadmo,
Fenice e Cilice, stravedeva per l'unica figlia
femmina, alla quale aveva dato il nome di Europa.
 |
| Europa rapita dal toro |
Kylix crater a figure nere, da Paestum (± 340 a.C.)
The J. Paul Getty Museum, Malibu, California (USA) |
La bellissima fanciulla, pur ancora in tenera età, era
talmente bella da suscitare l'ardore e la passione di uomini
e dei. Il caso volle (ma siamo proprio sicuri che si tratti
di un caso, anche questa volta?) che ad invaghirsi della
bella Europa fosse il dio del tuono e del fulmine, il sommo
ma non proprio fedele ed integerrimo Zeus.
Il padre di tutti gli dei, per sedurre la donna amata,
ricorse per l'ennesima volta allo strumento della
metamorfosi, come già avvenuto in passato per Danae, la
genitrice di Perseo, e come avverrà per Leda (futura madre
di Elena e dei Dioscuri) ; prese le sembianze di un toro,
Zeus si avvicinò alle spiagge di Tiro, dove Europa e le sue
ancelle si erano recate per giocare.
La bella fanciulla fu l'unica a non fuggire impaurita di
fronte a quello splendido animale dal manto bianco; ci volle
poco, ai due, per prendere confidenza e ci volle ancor meno
perché Europa saltasse in groppa a quell'aitante toro.
A questo punto, il superbo animale cominciò a galoppare a
filo d'acqua e attraversò il Mar Mediterraneo sino a
giungere nell'isola di Creta; qui Zeus riprese le sue vere
sembianze e si unì in amore con Europa; dalla loro unione
nacquero tre figli: Minosse, Sarpedone e
Radamanto.
| TABELLA n. 3 |
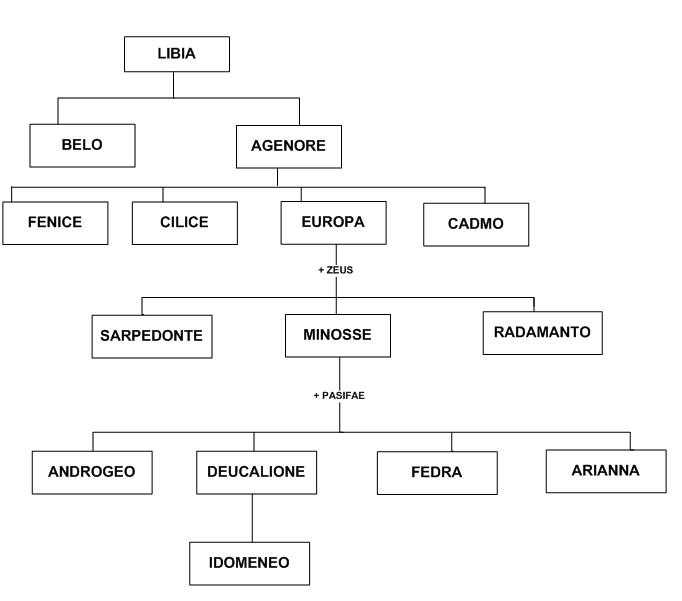 |
| |
| EUROPA E I SUOI DISCENDENTI |
Successivamente Asterio, signore di Creta, si
innamorò di Europa e la sposò; non avendo eredi, egli adottò
i figli di Zeus.
La prole di Europa ebbe un destino glorioso: Sarpedone
emigrò in Asia Minore e diventò re della Licia; Radamanto
fissò tutta la legislazione dell'isola e, alla sua morte,
venne chiamato ad essere giudice dell'Ade; Minosse, invece,
ereditò il trono del padre adottivo, che poi trasmise al
figlio Deucalione e al nipote Idomeneo, che
partecipò alla guerra di Troia.
| ① |
Dante Alighieri,
Inferno [XXXIII, 89]. |
| ② |
Le fonti principali cui l'Autore
ha attinto sono: Ovidio,
Metamorfosi. Utet, Torino, 2005. Apollodoro,
I miti greci;
Mondadori, Milano 2010. |
| ③ |
Agenore vantava origine divine;
era infatti figlio del dio del mare Poseidone e di
Libia, una fanciulla che discendeva direttamente da
Zeus. |
.
La ricerca di Cadmo
 opo
la scomparsa di Europa, il padre Agenore si adirò con i suoi
figli e li costrinse a mettersi alla ricerca dell'amata
fanciulla, ordinandogli di non tornare più a casa se non
dopo averla trovata. Partirono alla sua ricerca anche la
madre Telefassa e il loro fedele amico Taso,
figlio di Poseidone. opo
la scomparsa di Europa, il padre Agenore si adirò con i suoi
figli e li costrinse a mettersi alla ricerca dell'amata
fanciulla, ordinandogli di non tornare più a casa se non
dopo averla trovata. Partirono alla sua ricerca anche la
madre Telefassa e il loro fedele amico Taso,
figlio di Poseidone.
I figli di Agenore partirono con un piccolo seguito di
compagni e cercarono la sorella perduta ovunque, senza
tuttavia riuscire ad avere la minima notizia di lei, dopo la
sua scomparsa; poiché era stato loro proibito di tornare a
casa senza Europa, essi continuarono a peregrinare ancora
per molto tempo, sino a quando non furono sopraffatti dalla
rassegnazione.
Per primo, Fenice decise di stabilirsi nella terra che da
lui prese poi il nome di Fenicia; Cilice si fermò invece in
Asia Minore e decise di abitare nella regione che egli
chiamò Cilicia. Cadmo e e Telefassa, invece, giunsero
in Tracia insieme a Taso, il quale colonizzò poi un'isola
vicina fondando una città.
Quando Telefassa morì, Cadmo la seppellì e decise di
proseguire il suo viaggio verso il luogo più sacro di tutta
l'antichità: l'oracolo di Delfi, dove il dio Apollo parlava
per bocca della sua sacerdotessa, la Pizia. I vaticini del
nume furono chiari (circostanza, questa, per la verità
piuttosto insolita): egli disse a Cadmo di non cercare più
sua sorella Europa, ma di seguire invece il cammino di una
vacca e di fondare una città là dove l'animale si sarebbe
fermato, stendendosi a terra.
Cadmo si mise in viaggio e incontrò una mucca nei pascoli di
Pelagone: fedele alla profezia di Apollo, egli si mise
a seguirla sino a quando l'animale non si stese a terra, in
un luogo imprecisato nella regione della Beozia. Cadmo pensò
allora di sacrificare l'animale agli dei e mandò alcuni dei
suoi compagni ad attingere acqua ad una fonte, per iniziare
il rito.
A guardia della sorgente, tuttavia, montava la guardia un
terribile drago, che uccise senza pietà tutti i compagni di
Cadmo. Egli allora, infuriato, si infiltrò nel boschetto
presso il quale sorgeva la fonte ed affrontò il mostro: il
figlio di Agenore conficcò la sua lancia nel fianco del
drago così profondamente da far sgorgare un fiotto di denso
sangue scuro. L'orrida bestia cercò di scagliarsi addosso a
Cadmo, ma questi non indietreggiò, colpendo con tutta la sua
forza le fauci terrificanti, fino a che non riuscì ad
affondare la spada nella gola del drago, inchiodandolo al
tronco di una quercia.
Cadmo rivolse allora una preghiera accorata agli dei,
chiedendo che cosa dovesse fare ora che aveva perduto tutti
i suoi compagni: come avrebbe potuto fondare una città da
solo? Intervenne a questo punto in suo aiuto Atena, che gli
consigliò di seminare i denti del mostro ucciso.
Il figlio di Agenore si prestò ad eseguire quello strano
rituale; con grande stupore, egli notò che dai denti
piantati stavano balzando fuori dalla terra, come arbusti,
degli uomini armati: di lì a poco, essi cominciarono a
guardarsi tra di loro con aria ostile e vennero a battaglia.
Dopo un'aspra lotta, solamente cinque dei guerrieri erano
sopravvissuti e avrebbero continuato a combattere sino alla
morte se Cadmo non si fosse frapposto tra di loro per
mettere pace: assieme ai cinque uomini d'arme, cui venne
dato il nome di Sparti, il figlio di Agenore fondò
una città.
Cadmo divenne il primo sovrano della nuova comunità della
Beozia , mentre gli Sparti (Echione, Udeo,
Ctonio, Iperenore e Peloro) furono i
progenitori della nobiltà tebana.
 |
| Cadmo e il drago |
Krater a figure rosse, da Paestum (350-340 a.C.)
Musée du Louvre, Paris (Francia) |
.
La famiglia reale della Cadmea
 uando
Cadmo divenne re di Tebe, egli si unì in matrimonio con la
bellissima Armonia, figlia di Ares e Afrodite. Sembra
che tutti gli dei dell'Olimpo, per l'occasione, lasciassero
la loro dimora celeste per celebrare, al suono degli inni
sacri, la sacra unione tra i due sposi, nella regione che
tutti ormai avevano cominciato a chiamare Cadmea ①; per
l'occasione, il re regalò alla moglie un peplo ed una
collana lavorata dal dio Efesto. uando
Cadmo divenne re di Tebe, egli si unì in matrimonio con la
bellissima Armonia, figlia di Ares e Afrodite. Sembra
che tutti gli dei dell'Olimpo, per l'occasione, lasciassero
la loro dimora celeste per celebrare, al suono degli inni
sacri, la sacra unione tra i due sposi, nella regione che
tutti ormai avevano cominciato a chiamare Cadmea ①; per
l'occasione, il re regalò alla moglie un peplo ed una
collana lavorata dal dio Efesto.
Le nozze tra Cadmo ed Armonia vennero allietate da cinque
figli: quattro femmine (Autonoe, Ino,
Semele e Agave) e un maschio, Polidoro; la
sorte, tuttavia, non fu benigna con la prole dei reali.
Autonoe, infatti, andò in sposa al nobile Aristeo
(figlio di Apollo) ed ebbe un figlio, cui venne dato il nome
di Atteone; questi divenne ben presto un famoso
cacciatore, ma perì miseramente, sbranato dai suoi stessi
cani; si narra, infatti, che il figlio di Autonoe avesse
visto accidentalmente Artemide mentre faceva il bagno; la
dea, sdegnata, lo trasformò in cervo e provocò una furia
rabbiosa nella muta dei cani che accompagnava lo sventurato
cacciatore; gli animali, non riconoscendo il loro padrone,
lo divorarono.
Ino si unì in matrimonio con Atamante ②, re di
Orcomeno, mentre Agave sposò Echione (uno degli Sparti), da
cui ebbe un figlio maschio cui vene dato il nome di
Penteo.
| TABELLA n. 4 |
 |
| |
| EUROPA E I SUOI DISCENDENTI |
La bella Semele, invece, fece innamorare di sé il padre di
tutti gli dei, Zeus dalla folgore fiammeggiante, che non si
fece scrupoli nel sedurla e ingannare ancora una volta la
moglie Hera.
Furiosa per l'ennesimo tradimento, la regina dei cieli prese
le sembianze di una mortale e si presentò a Semele,
consigliandole di chiedere al suo spasimante di rivelarsi in
tutto il suo splendore; quando l'ignara figlia di Cadmo si
incontrò con il focoso amante, si fece promettere da Zeus
che avrebbe esaudito qualsiasi desiderio ella avesse
espresso. Il figlio di Crono acconsentì e Semele gli chiese
di manifestarsi allo stesso modo in cui il dio si univa in
amore alla dea Hera. Zeus non potè rifiutare e si rivelò nel
pieno del suo fulgore: la figlia di Cadmo morì incenerita,
ma il padre di tutti gli dei riuscì a salvare il bambino di
sette mesi che la fanciulla portava in grembo e se lo cucì
all'interno della coscia.
Trascorso il tempo debito, Zeus partorì un figlio, cui venne
dato il nome di Dioniso, e lo affidò al dio Hermes;
questi lo portò a Ino e Atamante, convincendoli ad
allevarlo. La dea Hera, ancora furente per il tradimento del
marito, rivolse la sua ira nei confronti del bambino e dei
suoi genitori adottivi, che vennero quindi colpiti dalla
follia: Atamante diede la caccia al suo figlio maggiore,
Learco, scambiandolo per un cervo, e lo uccise; poi
gettò l'altro figlio Melicerte in mare, per lo
strazio della madre che si gettò in acqua per salvarlo ed
annegò (si tramanda che proprio in onore di queste vittime
vennero istituiti in Ellade i Giochi Istmici) ③.
Per nascondere Dioniso dalla rabbia della dea Hera, Zeus lo
trasformò in un capretto, che Hermes condusse in Asia; ma
anche lì il giovane figlio di Semele venne funestato dalla
follia che gli aveva scagliato la regina degli dei e fu
costretto a vagare, ramingo, per l'Egitto e per la Siria
prima di giungere in Frigia, dove la dea Rea Cibele lo
purificò e gli insegnò i riti di iniziazione collegati al
culto della Grande Madre (più tardi noti nel mondo ellenico
come i «Misteri»).
Una volta recuperato il senno, Dioniso scoprì il segreto
della vite, della vendemmia e del vino; percorse in lungo e
in largo l'India, l'Asia e la Tracia e, nel suo peregrinare,
si creò un grosso seguito di adepti; spiccavano in
particolare gruppi di donne che già cominciavano a definirsi
sue sacerdotesse: le Menadi e le Baccanti, che
seguivano il carro di Dioniso in preda a frenesia estatica
ed invasate dal furore e dall'ebbrezza; il corteo era in
genere accompagnato anche da belve feroci, da Satiri
e da Sileni (esseri mitici, raffigurati come esseri
umani barbuti con caratteristiche animali: avevano infatti
le corna, la coda e le zampe di capra).
Attraversata la Tracia, Dioniso fece ritorno nella Cadmea,
dove costrinse tutte le donne ad abbandonare le loro case e
a compiere sul monte Citerone i riti misterici, in
preda all'ebbrezza.
All'epoca, un ormai anziano Cadmo aveva lasciato il suo
trono al nipote Penteo ④; inorridito dal carattere
orgiastico dei rituali collegati al culto in onore del
cugino Dioniso, il figlio di Agave e di Echione cercò in
tutti i modi di impedire tali cerimonie.
Salito sul Citerone, Penteo cercò di spiare le Baccanti, ma
venne scoperto dalle sacerdotesse invasate, capeggiate da
sua madre Agave. Le donne, in preda alla follia, lo fecero a
pezzi, credendolo una belva feroce, e conficcarono la sua
testa su un ramo di tirso; troppo tardi, esse compresero il
loro tragico errore ⑤.
Dioniso si congedò dagli abitanti della Cadmea,
proclamandosi una divinità e continuando il suo peregrinare
in giro per il mondo, in attesa di essere accolto
nell'Olimpo dal padre Zeus.
Dopo questi tragici eventi, Cadmo e Armonia decisero di
lasciare la città e, su consiglio di un oracolo, si recarono
nel paese degli Illiri, dove il figlio di Agenore venne
acclamato come sovrano dalla popolazione locale; in punto di
morte, Cadmo ed Armonia vennero trasformati in serpenti e
poi accolti da Zeus nei Campi Elisi (luogo nel quale
dimoravano dopo la morte le anime di coloro che erano amati
dagli dèi).
A quel punto ascese al trono Polidoro, figlio di Cadmo, il
quale sposò Nitteide (figlia di Nitteo e
nipote di Ctonio, uno degli Sparti), che gli diede un figlio
maschio di nome Labdaco; questi succedette al trono
paterno in tenera età, ragion per cui la reggenza venne
assicurata durante i primi anni dal nonno Nitteo.
Del regno di Labdaco si sa ben poco, in verità: si racconta
che il giovane sovrano mosse guerra agli Ateniesi per una
questione di confini e che morì straziato dalle Baccanti,
avendo tentato anche lui (come Penteo) di opporsi ai riti
dionisiaci; poiché suo figlio Laio alla morte del
padre aveva solamente un anno, il trono venne usurpato da
Lico, fratello di Nitteo .
| ① |
A quanto apprendiamo dai miti
greci, in una sola altra circostanza gli dei si
presentarono alle nozze di un mortale; e ciò fu in
occasione delle nozze di Teti e Peleo, i genitori del
prode Achille. |
| ② |
Atamante si era legato
precedentemente alla dea Nefele, da cui aveva avuto due
figli (Frisso ed Elle); della loro sorte
si parlerà più diffusamente nel capitolo III, dedicato
all'impresa degli Argonauti. |
| ③ |
Secondo Ovidio, la dea Afrodite
(madre di Armonia e quindi nonna di Ino) ottenne da
Poseidone di accogliere madre e figlia tra gli dei
marini, dando a Ino il nome di Leucotòe ed a Melicerte
quello di Palèmone (Portùnno, a Roma). Atamante venne
invece mutato in un fiume. Dante Alighieri segue quasi
pedissequamente la versione ovidiana nell'Inferno: «Nel
tempo che Iunone era corrucciata per Semelè contra 'l
sangue tebano, come mostrò una e altra fiata, Atamante
divenne tanto insano, che veggendo la moglie con due
figli andar carcata da ciascuna mano, gridò: «Tendiam le
reti, sì ch'io pigli la leonessa e' leoncini al
varco»
(Inferno [XXX, 1-8]). |
| ④ |
Secondo altre versioni del mito,
prima di salire al trono Penteo spodestò lo zio
Polidoro. |
| ⑤ |
Queste vicende ispirarono ad
Euripide uno dei suoi capolavori: la tragedia
Le Baccanti. |
| ⑥ |
Appartiene forse a questo
periodo l'esilio di Anfitrione, durante il quale venne
concepito l'eroe Eracle; divenuto più grande, l'eroe
guidò i Cadmei contro la città di Orcomeno. L'assenza di
Eracle a causa delle sue dodici fatiche favorì invece la
odiosa tirannide di Lico. Ma la cronologia mitologica è
tutt'altro che chiara, visto che nelle leggende che
ruotano attorno al figlio di Alcmena il sovrano beota
viene a volte identificato con Creonte, di cui si
parlerà in seguito. |
.
La reggenza degli Sparti
 l
periodo di interregno, nel quale i figli di Cadmo persero il
trono, va raccontato compiutamente anche se le fonti a
nostra disposizione sono in realtà molto confuse. l
periodo di interregno, nel quale i figli di Cadmo persero il
trono, va raccontato compiutamente anche se le fonti a
nostra disposizione sono in realtà molto confuse.
Come si è avuto modo di vedere sopra, dopo la morte di
Penteo cominciarono ad avere un certo ascendente sulla
famiglia reale due discendenti degli Sparti: Nitteo e Lico,
legati da profonda amicizia con il figlio di Agave ①.
Nitteo era il padre di una bellissima fanciulla di nome
Antiope: questa era così seducente da far sorgere una
irrefrenabile passione in Zeus, che si unì in amore con lei;
quando rimase incinta, il padre scacciò Antiope e la
fanciulla fu costretta a rifugiarsi da Epopeo, re di
Sicione. Disperato, il vecchio Nitteo morì di
crepacuore, non prima di aver incaricato il fratello Lico di
punire la figlia.
Lico mosse guerra a Sicione e la occupò, uccise Epopeo e
portò con sè Antiope come prigioniera; egli fece inoltre
abbandonare i due gemelli che la figlia di Nitteo aveva
generato dalla sua unione con Zeus. Non contento della sua
impresa, il discendente degli Sparti prese il potere in
Cadmea, approfittando della giovanissima età del legittimo
erede al trono; ben presto, Lico trasformò il suo potere in
una vera e propria tirannide, che egli esercitò per più di
venti anni; a farne le spese fu soprattutto la nipote
Antiope, che venne trattata come una schiava e costretta a
subire le angherie dello zio e di sua moglie Dirce.
Ma la storia dei regnanti della Beozia è ben lungi
dall'essere completata; occorre infatti sapere che i due
figli di Antiope, abbandonati lungo la strada per trovare
morte certa, vennero raccolti ed allevati da un mandriano,
che li adottò come figli e li chiamò Zeto e
Anfione.
Crescendo, Zeto cominciò ad occuparsi del bestiame, mentre
Anfione divenne maestro nella citarodia, l'arte di suonare
la cetra che gli aveva donato Hermes.
Un giorno, Antiope riuscì a liberarsi dalla schiavitù e a
fuggire, trovando rifugio ed ospitalità (manco a dirlo…)
proprio nella capanna dove abitavano i suoi figli. Ci
vollero solo pochi istanti affinché i due gemelli
riconoscessero la loro madre biologica e apprendessero delle
loro vere origini.
Zeto ed Anfione partirono verso la città, portando con loro
un buon numero di seguaci: essi uccisero Lico e
suppliziarono Dirce legandola ad un toro selvaggio. I due
fratelli presero quindi il potere ed esiliarono Laio, che
trovò rifugio alla corte di Pelope (figlio di Tantalo), nel
Peloponneso.
Si narra che Zeto ed Anfione divennero due sovrani molto
amati dalla popolazione; a loro si deve, in particolare, la
costruzione delle famose mura della città, con le celebri
sette porte; secondo la versione di alcuni poeti, le pietre
utilizzate per le fortificazioni si muovevano da sole
seguendo il suono della lira di Anfione.
Zeto prese in moglie una bellissima donna di nome Tebe,
da cui prese il nome la città; Anfione sposò invece Niobe,
figlia di Tantalo, che gli diede ben quattordici figli
(sette maschi e sette femmine ②); del loro triste fato
dovremo ora occuparci.
Fiera di avere una così bella discendenza, un giorno Niobe
si vantò di essere una madre più felice della stessa Leto
(madre di Apollo ed Artemide) e che a lei, piuttosto che ai
numi, dovessere essere tributati onori divini. Dimenticava,
la misera figlia di Tantalo, che gli dèi ricordano tutte le
offese e raramente le perdonano.
| TABELLA n. 5 |
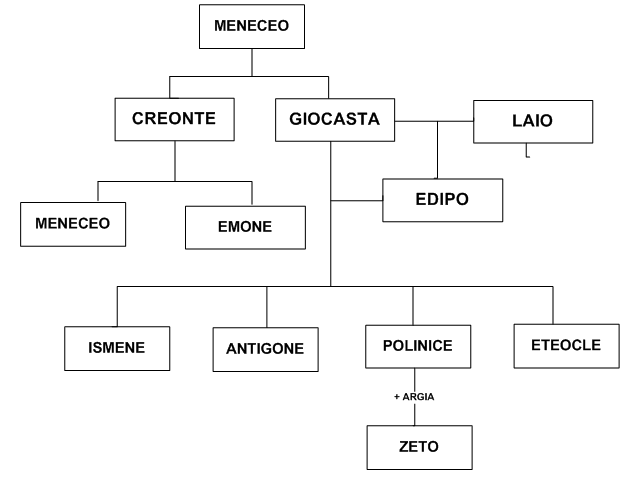 |
| |
| SPARTI E LABDACIDI |
Apollo ed Artemide incoccarono i loro archi magici, con i
quali erano in grado di infliggere una morte istantanea agli
sventurati colpiti dai loro dardi: tutte le femmine vennero
uccise nel palazzo reale dalle frecce di Artemide e tutti i
maschi furono vittima delle frecce di Apollo mentre erano a
caccia sul monte Citerone.
Disperata, Niobe lasciò Tebe e si rifugiò da suo padre
Tantalo; qui la donna implorò gli dei e Zeus, per pietà, la
trasformò in pietra (da quella roccia, da quel giorno
scorrono incessantemente le lacrime della madre sventurata).
Dopo questi tragici eventi, Anfione morì e lo scettro passò
nuovamente nelle mani dei discendenti di Cadmo.
| ① |
Altre fonti riferiscono che
Nitteo e Lico non sarebbero stati discendenti degli
Sparti ma del dio Poseidone. |
| ② |
Abbiamo seguito la versione di
Apollodoro: Esiodo, invece, dice che Niobe ebbe dieci
maschi e dieci femmine, Erodoto cita due figli e tre
figlie; Omero parla invece di sei maschi e sei femmine. |
.
La dinastia dei Labdacidi
 aio
tornò dall'esilio ed ascese al trono di Tebe; egli prese in
moglie Giocasta, figlia di Meneceo (un altro rampollo della
nobiltà locale) ①. aio
tornò dall'esilio ed ascese al trono di Tebe; egli prese in
moglie Giocasta, figlia di Meneceo (un altro rampollo della
nobiltà locale) ①.
Un oracolo aveva avvertito Laio di non generare figli,
perché se avesse mai avuto un erede questi avrebbe causato
la morte del padre; non si esclude che, in questo modo, la
divinità intendesse punire il re di Tebe per avere rapito,
in gioventù, Crisippo, un giovinetto di cui si era
invaghito. Fatto sta che Laio decise, in un momento di
ubriachezza, di unirsi alla moglie, che per volontà divina
rimase incinta.
Terrorizzato per via dei presagi dell'oracolo, Laio diede
ordine di abbandonare il neonato sul monte Citerone dopo
avergli legato le caviglie, orribilmente trafitte con uno
spillone.
Il bambino venne così esposto sui monti, destinato a morte
certa; tuttavia, il caso volle (ma fu veramente il caso?)
che a trovarlo fossero i mandriani di Polibo, il re
di Corinto, i quali lo portarono al cospetto della
famiglia reale.
Il sovrano, ancora privo di una discendenza, d'accordo con
sua moglie Peribea decise di adottarlo; il fanciullo
venne chiamato Edipo, che nell'antica lingua degli
Elleni significa «quello dai piedi gonfi».
Il giovane Edipo, pur se afflitto sempre dalla disgrazia dei
suoi piedi deformi, crebbe forte e vigoroso e superava in
prestanza tutti i suoi coetanei: un triste giorno, tuttavia,
egli venne a lite con un rampollo della nobiltà di Corinto
che, per invidia, lo apostrofò chiamandolo bastardo. Il
ragazzo ne chiese ragione a Polibo e Peribea, i quali gli
fornirono risposte estremamente evasive.
Divorato dal demone del dubbio, Edipo si recò a Delfi, per
interrogare la Pizia sulle sue origini; la sacerdotessa del
dio Apollo diede una risposta che terrorizzò il figlio
adottivo dei re di Corinto: l'oracolo impose al questuante
di non tornare mai più nella sua terra patria, altrimenti
avrebbe ucciso suo padre e si sarebbe unito in amore con sua
madre.
Edipo – ritenendo che i suoi veri genitori fossero Polibo e
Peribea – decise di non tornare a Corinto ma di percorrere
la penisola ellenica in direzione opposta; arrivato nella
regione della Focide con il suo carro, giunse ad un
crocevia e si fermò perché un altro carro gli sbarrava la
strada; l'altro viaggiatore e il suo araldo, in modo
piuttosto arrogante, gli fecero cenno di cedere la strada
per far passare, ma l'orgoglioso Edipo non obbedì e rimase
fermo.
L'araldo, infuriato, si avvicinò a Edipo e gli uccise uno
dei cavalli; l'uomo dai piedi deformi, preso da un feroce
attacco di rabbia, scese dal suo carro e venne alle mani con
i due viandanti; nello scontro, i due sconosciuti ebbero la
peggio e vennero uccisi. Ignorava, l'infelice Edipo, di
avere appena ucciso suo padre Laio e il suo servo
Polifonte.
La notizia della morte del sovrano gettò lo sconforto a Tebe;
a quel punto, assunse la reggenza Creonte, fratello
di Giocasta e figlio di Meneceo.
In questo periodo, la città venne sconvolta da un ancor più
grave flagello: la Sfinge; figlia di Echidna e di
Tifeo, l'orribile creatura aveva un volto di donna con il
corpo di un leone e le ali di uccello. Le Muse le avevano
insegnato un enigma che il mostro, stando seduta sul monte
Ficio, poneva a tutti i viandanti.
Il quesito che la Sfinge poneva ai malcapitati abitanti
della Beozia è talmente famoso che non può non essere
citato: «Qual è l'animale che al mattino cammina a quattro
zampe, a mezzogiorno con due e la sera con tre?». Gli
sventurati che non riuscivano a risolvere l'enigma venivano
divorati dalla figlia di Tifeo.
Poiché i Tebani avevano ascoltato un oracolo, secondo il
quale si sarebbero liberati della Sfinge solo quando
avessero risolto il suo enigma, Creonte fece diffondere un
bando: chiunque fosse riuscito a trovare la risposta al
terribile quesito, avrebbe ottenuto il regno di Tebe e la
vedova di Laio in sposa.
Per puro caso, a passare da quelle parti e ad incontrare la
Sfinge fu proprio Edipo, che riuscì a trovare la soluzione;
il famigerato animale altri non era che «l'uomo», che da
piccolo si muove a quattro zampe, da grande è in posizione
eretta e si appoggia ad un bastone in vecchiaia. La Sfinge,
umiliata dall'ingegno di Edipo, si gettò da una rupe e morì.
 |
| Edipo e la Sfinge |
Kylix attico a figure rosse (±470 a.C.)
Musei Vaticani (Museo Gregoriano Etrusco), Roma (Città del Vaticano) |
Edipo giunse a Tebe, accolto da una folla festante: egli
ottenne così il regno e, inconsapevolmente, si unì in
matrimonio con la regina Giocasta, sua madre.
Dall'unione di Edipo e Giocasta nacquero due figli maschi,
Eteocle e Polinice, e due femmine: Antigone
e Ismene.
| TABELLA n. 6 |
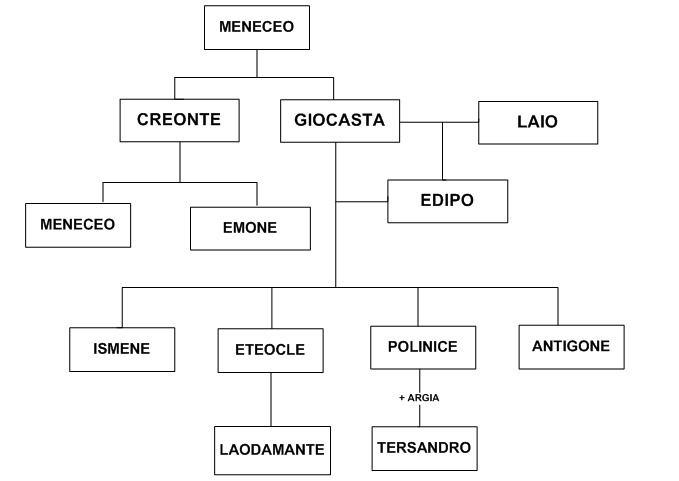 |
| |
| I DISCENDENTI DI EDIPO |
Il regno di Edipo fu contraddistinto da un lungo periodo di
pace e prosperità: i sinistri presagi della Pizia, tuttavia,
erano destinati ancora una volta a sconvolgere le vite della
casa reale di Tebe, già funestata da molte disgrazie ③.
Una terribile pestilenza, infatti, cominciò a devastare la
capitale della Beozia; il nobile Creonte venne quindi
inviato a consultare ancora una volta l'oracolo di Delfi per
per conoscere le cause dell'epidemia. Il fratello di
Giocasta riferì che la Pizia aveva sentenziato che Tebe era
contaminata, poiché l'omicida di Laio era rimasto ancora
impunito.
Edipo, a questo punto, interrogò l'indovino Tiresia
affinché gli svelasse l'identità dell'assassino, ma questi
si rifiutò di rispondere provocando una esplosione d'ira del
sovrano.
La regina Giocasta, a questo punto, cercò di calmare il
sovrano rammentandogli quante volte gli oracoli si fossero
dimostrati fallaci: allo stesso Laio era stato profetizzato
che sarebbe stato ucciso da suo figlio; in verità, il
vecchio re era morto per via di alcuni banditi incontrati
sulla strada per Delfi.
Edipo venne sconvolto da queste rivelazioni, rammentando a
sua volta di avere ucciso uno sconosciuto ad un crocevia,
non molto lontano da Delfi. Preoccupati dal turbamento del
sovrano, servi e cortigiani gli consigliarono di non trarre
conclusioni affrettate e raccogliere prima le testimonianze
di chi aveva assistito all'assassinio di Laio.
Giunse nel frattempo un messo da Corinto, che annunciò la
morte del re Polibo di Corinto, di cui Edipo era unico
erede: il re di Tebe, pur rattristato dalla notizia, fu
sollevato nell'apprendere che non era stato lui a causare la
morte del padre, come aveva profetizzato il dio Apollo; il
messaggero, tuttavia, riferì candidamente che Edipo non era
il vero figlio di Polibo, ma era stato adottato; un pastore
della casa di Laio lo aveva raccolto dal monte Citerone e
portato a Corinto.
Edipo, a questo punto, convocò il servo di Laio e cominciò
ad interrogarlo; questi ammise di aver ricevuto l'ordine di
esporre un bambino dalle caviglie forate ma, avendone pietà,
aveva preferito consegnarlo ai servi del re Polibo.
Avendo compreso l'orribile verità (di essere cioè il figlio
di Laio e di avere sposato la madre), Edipo impazzì per la
vergogna; Giocasta, umiliata, si impiccò, mentre il re di
Tebe si trafisse gli occhi con le fibbie del vestito della
moglie.
Il monologo di Edipo, che brancola cieco nel palazzo
reale di Tebe, è un capolavoro della letteratura universale:
Oh nozze, a me deste la vita
e fecondaste poi lo stesso seme
onde alla luce vennero insieme
padri, figli, fratelli, incestuosa stirpe,
e figlie e mogli e madri e quanti orrori
più sozzi mai fra i mortali si scorsero.
Sofocle:
Edipo re [I,
-]
④
Il figlio di Laio venne scacciato da Tebe, accompagnato
dalle sue figlie femmine (Antigone ed Ismene), che non
vollero abbandonare il padre, ormai cieco e ripudiato da
tutti; nessun conforto gli venne invece dal cognato Creonte
e dai suoi figli; fu per questo motivo che Edipo lanciò una
maledizione contro i suoi discendenti maschi, colpevoli di
avergli negato il suo aiuto nella triste circostanza
dell'esilio.
Amaro fu il commento degli anziani di Tebe nel constatare
la disgrazia di Edipo:
Or vedete, o Tebani, questo Edipo […]
in qual baratro è piombato di terribile sciagura.
Or mirando questo giorno luttuoso non far stima
che beato sia alcuno dei mortali,
se prima scevro d'ogni orrido male
non sia giunto al dì fatale.
Sofocle:
Edipo re [I,
-]
④
Edipo giunse quindi a Colono, in Attica, presso il
recinto sacro delle Eumenidi; lì si fermò come supplice, con
l'ospitalità di Teseo, e poco tempo dopo morì .
| ① |
Le fonti sulle origini di
Meneceo sono incerte; alcuni ritengono che egli
discendesse dagli Sparti, mentre altri autori ne fanno
il nipote in linea diretta del re Penteo. |
| ② |
Si potrebbe obiettare che il
quesito non fosse poi così difficile. In effetti, la
popolazione della Beozia era famosa in tutto il mondo
ellenico per una profonda tradizione religiosa, non
fosse altro per la presenza dell'oracolo di Delfi;
appartenevano infatti a questa regione i poeti Esiodo e
Pindaro, caratterizzati da una forte pietas.
Tuttavia, essi avevano una nomea (alimentata dai loro
vicini e rivali Ateniesi) di persone poco intelligenti,
tanto è vero che ancora oggi il termine «beota» è
sinonimo di individuo piuttosto ingenuo e sciocco. |
| ③ |
Il dramma di Edipo è oggetto
della tragedia Edipo re
di Sofocle, capolavoro indiscusso del teatro greco. |
| ④ |
Traduzione di A. Romagnoli. |
.
I sette contro Tebe
 li
Dopo l'esilio del padre Edipo, il diritto a succedergli sul
trono spettava ai suoi discendenti Eteocle e Polinice, i
quali si accordarono per regnare un anno ciascuno. li
Dopo l'esilio del padre Edipo, il diritto a succedergli sul
trono spettava ai suoi discendenti Eteocle e Polinice, i
quali si accordarono per regnare un anno ciascuno.
La brama di potere, tuttavia, portò ancora una volta alla
rovina i reggitori di Tebe; trascorso il suo anno di regno,
infatti, Eteocle si rifiutò cedere lo scettro al fratello.
Polinice, bandito da Tebe, giunse nell'Argolide portando con
sé solamente la collana e il peplo che Cadmo aveva donato
alla moglie Armonia come regalo di nozze.
A quell'epoca regnava nella regione Adrasto, figlio di
Talao, che accolse Polinice a palazzo come ospite;
quella stessa notte, tuttavia, il figlio di Edipo venne alle
mani con un altro ospite della corte di Argo: Tideo,
figlio di Oineo, esule da Calidone.
Destato da quell'improvviso strepito, Adrasto accorse e separò
i due contendenti; a quel punto, egli si ricordò di un
oracolo che gli aveva detto di «aggiogare le figlie ad un
cinghiale e ad un leone»; gli emblemi dei due esuli
portavano incisi, rispettivamente, la testa di un cinghiale
e quella di un leone, ragion per cui il re dell'Argolide li
scelse come generi.
Tideo si unì in matrimonio con una delle figlie di Adrasto,
Deipile, mentre Polinice ebbe in sposa l'altra figlia
Argia; ad entrambi i parenti acquisiti, Adrasto promise
che li avrebbe reinsediati nella loro patria.
Il re dell'Argolide decise di intraprendere per prima una
spedizione contro Tebe e radunò tutti i capi argivi; uno di
essi, Anfiarao figlio di Oicleo, si mostrò
molto riluttante a partecipare alla guerra e tentò di
scoraggiare anche gli altri condottieri: egli era infatti un
indovino e aveva in qualche modo presagito che sarebbe
perito nell'assedio.
Per convincere Anfiarao a partecipare alla guerra, Polinice
avvicinò Erifile, moglie dell'indovino, e le regalò la
collana di Armonia, pregandola di persuadere suo marito ad
unirsi alla spedizione.
Tempo addietro, infatti, Anfiarao aveva avuto una lite con
Adrasto ed Erifile li aveva riconciliati; in quell'occasione,
l'indovino aveva giurato, in caso di future divergenze, di
rimettersi sempre alla moglie per ogni decisione. Erifile,
corrotta dal dono di Polinice, convinse il marito a
intraprendere la spedizione contro Tebe.
Adrasto radunò un esercito con sette comandanti (uno per
ciascuna delle porte di Tebe) e partì per la guerra. I
comandanti erano: Adrasto, figlio di Talao; Anfiarao, figlio
di Oicleo; Capaneo, figlio di Ipponoo;
Ippomedonte, figlio di Aristomaco; Polinice,
figlio di Edipo; Tideo, figlio di Oineo; Partenopeo, figlio
di Melanione ⑤.
 |
| I Sette contro Tebe |
Amphora (?) attica a figure rosse (±470/460 a.C.)
Christie's, New York (USA) |
Giunti a Nemea, dove regnava Licurgo, i Sette cercarono
dell'acqua; ad indicare loro la strada per una sorgente fu
la nutrice del piccolo Ofelte, rampollo del re; il bambino,
lasciato incustodito mentre la donna mostrava la fonte ai
soldati, fu però ucciso da un serpente. Gli uomini di
Adrasto, ritornando dalla fonte, schiacciarono il rettile e
seppellirono il bambino. In onore del piccolo defunto, i
Sette istituirono i Giochi Nemei, destinati ad avere
importanza anche in epoca storica.
Quando giunsero al monte Citerone, gli Argivi inviarono
Tideo come ambasciatore da Eteocle, per invitarlo a lasciare
il regno a Polinice, secondo gli accordi; ma questi rifiutò
sdegnato.
Gli Argivi si armarono e si avvicinarono alle mura della
città; ciascun comandante si pose davanti a una delle sette
porte. Anche Eteocle armò i Cadmei e dispose altrettanti
condottieri davanti alle porte.
I Tebani chiesero all'indovino Tiresia di rivelare loro come
sconfiggere i nemici; questi predisse che gli assediati
avrebbero conquistato la vittoria se Meneceo, figlio di
Creonte, si fosse offerto in sacrificio al dio Ares; sentito
il responso, il giovane si tagliò la gola davanti alle porte
di Tebe.
Iniziata la battaglia, i Cadmei furono ricacciati indietro:
Capaneo stava per scalare le mura di Tebe, ma ebbe l'ardire
di pronunciare espressioni ingiuriose nei confronti degli
dei, per cui Zeus lo incenerì senza pietà.
La battaglia andava ormai da molto tempo e i morti erano già
numerosi, per cui entrambi gli eserciti decisero di affidare
le sorti della guerra ad un duello tra Eteocle e Polinice; i
due fratelli, però, si uccisero a vicenda lasciando
irrisolto il problema dell'esito della contesa.
Di nuovo si riaccese un'aspra battaglia, nel corso della
quale venne ucciso Partenopeo, uno dei sette condottieri
venuti da Argo.
Melanippo, il più giovane dei condottieri tebani, sfidò
Tideo e lo colpì mortalmente al ventre; mentre il figlio di
Oineo giaceva ormai in fin di vita, la dea Atena –
impressionata dal suo valore e dal suo coraggio – ottenne
dal padre Zeus il privilegio di portargli un filtro, che
l'avrebbe reso immortale.
Anfiarao odiava Tideo dato che, contro il suo parere, aveva
convinto gli Argivi a far guerra contro Tebe; avendo
presagito l'intervento divino, egli tagliò la testa di
Melanippo e la lanciò al figlio di Oineo; questi la afferrò
e divorò il cervello del nemico. Quando vide la scena, Atena
ne fu inorridita e lasciò morire il suo protetto.
Di lì a poco i Tebani lanciarono l'ultima, decisa offensiva;
gli assedianti fuggirono in rotta: non uno dei Sette riuscì
a tornare vivo in patria, tranne Adrasto che fuggì in groppa
al suo cavallo Arione. Anfiarao scappò lungo il fiume Ismeno
e stava per essere colpito alla schiena da una lancia, ma
Zeus lanciò un fulmine e spaccò la terra; l'indovino venne
inghiottito insieme al suo carro e al suo auriga.
Creonte prese nuovamente il potere a Tebe: come primo atto
d'imperio, egli lasciò insepolti i cadaveri degli Argivi,
proibendo a chiunque di sotterrarli (anche a Polinice, che
sino all'ultimo aveva agito come nemico della città, vennero
negati gli onori della sepoltura).
Adrasto giunse ad Atene, si rifugiò presso l'Altare della
Pietà e, preso in mano il bastone dei supplici, implorò che
i suoi morti venissero tumulati. Gli Ateniesi allora
combatterono insieme a Teseo contro i Tebani e riuscirono ad
ottenere i corpi degli Argivi affinché i loro familiari
potessero seppellirli.
Antigone, una delle figlie di Edipo, riuscì invece ad
eseguire di nascosto il rituale della sepoltura sul fratello
Polinice, ma venne scoperta dalle guardie di Creonte. Il
vecchio despota condannò a morte senza alcuna pietà la
nipote, colpevole di aver violato le leggi della sua città;
invano, Antigone rivendicava l'esistenza di leggi non
scritte, come quelle sulla pietas nei confronti dei propri
cari defunti: la figlia di Edipo venne sepolta viva in una
tomba ⑥.
La famiglia reale di Tebe venne funestata da una ulteriore
tragedia: Emone, figlio di Creonte, essendo stato promesso
ad Antigone preferì suicidarsi piuttosto che sopravvivere
all'amata.
Creonte rimase così solo e abbandonato da tutti, chiuso
nella sua odiosa e solitaria tirannide.
| ① |
Le fonti sulle origini di
Meneceo sono incerte; alcuni ritengono che egli
discendesse dagli Sparti, mentre altri autori ne fanno
il nipote in linea diretta del re Penteo. |
| ② |
Si potrebbe obiettare che il
quesito non fosse poi così difficile. In effetti, la
popolazione della Beozia era famosa in tutto il mondo
ellenico per una profonda tradizione religiosa, non
fosse altro per la presenza dell'oracolo di Delfi;
appartenevano infatti a questa regione i poeti Esiodo e
Pindaro, caratterizzati da una forte pietas.
Tuttavia, essi avevano una nomea (alimentata dai loro
vicini e rivali Ateniesi) di persone poco intelligenti,
tanto è vero che ancora oggi il termine «beota» è
sinonimo di individuo piuttoso ingenuo e sciocco. |
| ③ |
Il dramma di Edipo è oggetto
della tragedia Edipo re
di Sofocle, capolavoro indiscusso del teatro greco. |
| ④ |
Traduzione di A. Romagnoli. |
| ⑤ |
Alcuni autori non comprendono
nell'elenco dei sette Tideo e Polinice e vi aggiungono
invece Eteoclo e Mecisteo. |
| ⑥ |
L'eroismo della figlia di Edipo
ispirò a Sofocle un'altra tragedia:
Antigone. |
.
Gli Epigoni
 ieci
anni dopo la guerra dei Sette contro Tebe i figli dei
guerrieri caduti (denominati gli Epigoni) decisero di
muovere nuovamente battaglia alla Cadmea per vendicare la
morte dei loro padri. ieci
anni dopo la guerra dei Sette contro Tebe i figli dei
guerrieri caduti (denominati gli Epigoni) decisero di
muovere nuovamente battaglia alla Cadmea per vendicare la
morte dei loro padri.
Essi, prima di dare inizio alla spedizione consultarono
l'oracolo di Delfi e il dio profetizzò che gli assedianti
avrebbero vinto la guerra solo se si fossero messi sotto il
comando di Alcmeone, figlio di Anfiarao.
Alcmeone, in verità, non aveva nessuna intenzione di
mettersi a capo della spedizione; acconsentì solo su
pressione della madre, poiché Tersandro, figlio di
Polinice, donò a Erifile il peplo di Armonia e la donna
convinse i suoi figli a combattere ①.
Gli Epigoni si misero quindi in marcia contro Tebe; secondo
la tradizione, i condottieri alla guida dell'impresa furono:
Alcmeone e Anfiloco, figli di Anfiarao; Egialeo,
figlio di Adrasto (l'unico, in verità, a sopravvivere alla
spedizione dei Sette tra gli Argivi); Diomede, figlio
di Tideo; Promaco, figlio di Partenopeo; Stenelo,
figlio di Capaneo; Tersandro, figlio di Polinice;
Eurialo, figlio di Mecisteo.
Gli invasori dapprima saccheggiarono i villaggi del contado;
poi, i Tebani avanzarono sotto il comando di Laodamante,
figlio di Eteocle, che era succeduto a Creonte.
I Cadmei combatterono valorosamente (il loro sovrano uccise
in duello Egialeo), ma quando Alcmeone uccise il re
Laodamante i Tebani fuggirono verso le mura. Tiresia
consigliò di inviare agli Argivi un messaggero per trattare
la resa e di fuggire: i Cadmei allora inviarono un araldo ai
nemici, caricarono donne e bambini sui carri e si
allontanarono dalla città (durante la fuga, Tiresia bevve
dalla sorgente chiamata Tilfussa e ne morì); i Tebani
viaggiarono a lungo, poi costruirono la città di Estiea
e vi si stabilirono.
Gli Argivi, quando si accorsero della fuga dei Tebani,
entrarono in città, raccolsero il bottino e rasero al suolo
le mura. Una parte del bottino di guerra (compresa Manto,
la figlia di Tiresia) venne mandata a Delfi come dono ad
Apollo ②.
Tersandro divenne così il nuovo re di Tebe; tempo dopo, egli
venne chiamato a dare il suo contributo nella guerra di
Troia, alla quale partecipò trovandovi la morte.
Finisce così la triste e sanguinosa saga dei discendenti di
Cadmo: uno dei racconti più turpi e raccapriccianti mai
concepiti dalla memoria dell'uomo, ma anche una delle fonti
di ispirazione più prolifiche ed appassionanti per artisti,
poeti e drammaturgi da oltre tremila anni.
| ① |
Dopo la spedizione, quando
Alcmeone venne a sapere che Erifile si era di nuovo
lasciata corrompere anche a suo danno, si indignò ancora
di più nei confronti della madre e su consiglio
dell'oracolo di Apollo la uccise. Da allora le Erinni
del matricidio lo perseguitarono e Alcmeone, in preda
alla follia, fuggì di regione in regione sino a quando
non giunse alle sorgenti dell'Acheloo, dove il fiume lo
purificò e gli diede in sposa sua figlia Calliroe.
Alcmeone colonizzò la terra che l'Acheloo aveva formato
con la sua corrente, e vi si stabilì. |
| ② |
Il sacco di Tebe da parte degli
Epigoni è documentato anche dall'archeologia. |
|
|
III
IL VELLO D'ORO
L'impresa degli Argonauti
La saga degli Argonauti è una delle più antiche
leggende della mitologia greca; le loro imprese sono citate
dapprima nei poemi omerici e in quelli esiodei, per venire
poi narrate in numerose opere dell'antichità classica. Gli
eruditi citano un componimento attribuito al leggendario
Orfeo, andato perduto; a noi moderni sono giunte le
Argonautiche del poeta greco
Apollonio Rodio (che costituirà per noi la principale fonte
di ispirazione per la narrazione) e l'Argonautica
di Valerio Flacco. Numerose citazioni sono presenti anche
nei carmi di Pindaro, nei tragici greci, nelle
Metamorfosi di Ovidio e
nelle opere di Apollodoro e Igino.
.
Frisso ed Elle
 a
storia degli Argonauti, narrata da poeti e cantori di tutte
le epoche, è strettamente legata alla leggenda del Vello
d'Oro, che rappresenta così l'antefatto di quanto andremo a
raccontare. a
storia degli Argonauti, narrata da poeti e cantori di tutte
le epoche, è strettamente legata alla leggenda del Vello
d'Oro, che rappresenta così l'antefatto di quanto andremo a
raccontare.
Occorre sapere che tra tutti i figli di Eolo ① vi fu
Atamante, che regnò in Beozia e si unì in matrimonio con la
dea Nefele (la «Nuvola»), da cui ebbe un figlio
maschio, Frisso, ed una figlia femmina, Elle.
 |
| Frisso ed Elle |
Affresco romano, Masseria di Cuomo (Insula Occidentalis
VI, 17), Pompei (45/79).
Museo Archeologico Nazionale, Napoli (Italia) |
In seguito, tuttavia, il sovrano sposò Ino, figlia di Cadmo,
che gli generò Learco e Melicerte; come
spesso capita nella favolistica antica e moderna, la
matrigna concepì un odio profondo nei confronti dei figli di
primo letto del marito e cercò di disfarsi della prole di Nefele.
La perfida Ino convinse così le donne della Beozia a far
seccare tutti i semi di frumento e la terra, quell'anno, non
diede il consueto raccolto di grano.
Atamante inviò allora a Delfi una sua delegazione, per
chiedere al dio Apollo come allontanare la carestia, ma Ino
convinse i messaggeri a riferire un falso responso: e così
al figlio di Eolo venne riferito che la terra sarebbe
tornata fertile solamente se Frisso fosse stato immolato.
Il re udì il responso e ne fu agghiacciato; non potendo
esimersi dai suoi doveri di sovrano e messo sotto pressione
anche dagli abitanti della regione, disperati per la
carestia, egli acconsentì a portare suo figlio all'altare
dei sacrifici.
Poco prima della celebrazione del rito, tuttavia, Nefele
inviò un ariete alato, dal vello d'oro (dono di Hermes) ②,
per salvare il fanciullo; Frisso ed Elle vi montarono sopra
e l'animale si librò in cielo, superando terre e mari.
Quando l'ariete giunse sopra il tratto che separa l'Europa
dall'Asia Minore, nei pressi del Chersoneso (corrispondente
a quelli che oggi vengono chiamati gli Stretti del Bosforo e
dei Dardanelli), Elle cadde negli abissi delle onde ed
annegò in quel braccio di mare, che da allora venne chiamato
Ellesponto.
Frisso invece raggiunse la Colchide, una terra ad oriente
del Ponto Eusino (il Mar Nero) dove regnava Eete,
figlio di Helios nonché fratello della maga Circe e di Pasifae, futura moglie di Minosse.
Eete lo accolse con benevolenza e gli diede in sposa una
delle sue figlie, Calciope. Frisso allora sacrificò
l'ariete a Zeus protettore degli esuli e regalò il Vello
d'Oro al suocero, il quale lo appese ad una quercia in un
bosco sacro ad Ares, guardato a vista da un drago.
Di Ino ed Atamante, va aggiunto solamente che essi verranno
colpiti dall'ira della dea Hera per aver allevato Dioniso,
figlio di Zeus e Semele; la regina degli dei condusse alla
follia il discendente di Eolo, che uccise il figlio Learco e
costrinse la moglie Ino e l'altro figlio Melicerte a
gettarsi in mare; bandito dalla Beozia, Atamante su
consiglio dell'oracolo di Apollo riparò in una regione ai
confini dell'Ellade, che da lui prese il nome di Atamanzia.
| ① |
Figlio di Elleno e nipote
di Deucalione, fu il capostipite di una delle
stirpi elleniche (gli Eoli, appunto). |
| ② |
Secondo altre versioni, ad
inviare l'ariete fu Hera per affetto nei confronti di
Nefele; le due dee, infatti, si somigliavano come due
gocce d'acqua. |
.
La stirpe reale di Iolco
 a
nostra storia si sposta quindi in Tessaglia, nella regione
nord-orientale della Grecia, patria originaria degli Eoli.
Un altro dei figli di Eolo, infatti, fu Creteo che
sposò la nipote Tiro (figlia del fratello Salmoneo)
ed ebbe tre figli: Esone, Ferete ed
Amitaone; egli adottò anche i due gemelli che la moglie
aveva avuto da una relazione con il dio Poseidone: Pelia
e Neleo. a
nostra storia si sposta quindi in Tessaglia, nella regione
nord-orientale della Grecia, patria originaria degli Eoli.
Un altro dei figli di Eolo, infatti, fu Creteo che
sposò la nipote Tiro (figlia del fratello Salmoneo)
ed ebbe tre figli: Esone, Ferete ed
Amitaone; egli adottò anche i due gemelli che la moglie
aveva avuto da una relazione con il dio Poseidone: Pelia
e Neleo.
Creteo fondò la città di Iolco e ne divenne il sovrano,
facendola diventare in breve tempo un centro fiorente; alla
sua morte, lo scettro sarebbe spettato legittimamente al suo
primogenito Esone, ma questi venne spodestato dal
fratellastro Pelia.
Il nuovo sovrano regnò incontrastato per diversi anni ma,
quando consultò un oracolo, gli venne profetizzato di
guardarsi da un uomo con un solo calzare; il dio Apollo,
inoltre, vaticinò che Pelia sarebbe stato ucciso da un
discendente di Eolo.
Per questo motivo, il re di Iolco fece sterminare od
esiliare chiunque avesse un rapporto di discendenza con il
suo progenitore, ma risparmiò Esone perché era molto amato
dalla loro madre comune.
Esone nel frattempo ebbe un figlio cui venne dato il nome di
Diomede; per evitare l'ira di Pelia, il bambino fu
segretamente trasportato fuori dal palazzo e affidato alle
cure del centauro Chirone, che lo allevò e gli cambiò il
nome in Giasone.
Un bel giorno, nella città di Iolco si tenne un grande
sacrificio in onore di Poseidone; molti erano i partecipanti
e tra di loro c'era anche Giasone che, per assistere al
rito, si era recato in città e, nell'attraversare il fiume
Anauro, aveva perso un sandalo nella corrente. Vi è
chi sostiene che Giasone avesse perso la calzatura aiutando
una vecchia ad attraversare le acque fangose del fiume:
sotto le vesti di quella povera donna si nascondeva in
realtà la dea Hera, che da quel giorno divenne la
protettrice del figlio di Esone.
Quando Pelia vide lo sconosciuto, si ricordò del responso
del dio; egli si avvicinò a Giasone e gli chiese: «Se tu
avessi il potere e ti venisse rivelato da un oracolo che uno
dei cittadini ti ucciderà, che cosa faresti?». Forse per
caso o forse perché ispirato dagli dei, il figlio di Esone
così rispose: «Lo manderei alla ricerca del Vello d'Oro!».
Subito Pelia approfittò delle parole del giovane e gli
ordinò di andare a cercare quell'oggetto tanto prezioso: il
figlio di Poseidone narrò di essere tormentato dall'ombra di
Frisso, a cui mai era stata data degna sepoltura. Pelia
aggiunse che, secondo un oracolo, la terra tessalica sarebbe
rimasta sterile sino a quando non fosse stato riportato in
patria il vello, custode dell'anima di Frisso.
Solo quel punto, Giasone riconobbe nel suo interlocutore il
re usurpatore e pretese il trono; Pelia promise così al
figlio di Esone che, se questi avesse accettato l'incarico,
gli avrebbe restituito la corona qualora fosse ritornato
vittorioso dalla sua impresa.
.
Gli Argonauti
 er
questa missione, Giasone chiese l'aiuto di Argo,
figlio di Frisso; questi, su ispirazione di Atena, costruì
una nave a cinquanta ordini di remi, che venne chiamata con
il nome del suo costruttore. Atena stessa adattò alla prua
una polena di legno parlante, fatta con una delle querce
sacre di Dodona. er
questa missione, Giasone chiese l'aiuto di Argo,
figlio di Frisso; questi, su ispirazione di Atena, costruì
una nave a cinquanta ordini di remi, che venne chiamata con
il nome del suo costruttore. Atena stessa adattò alla prua
una polena di legno parlante, fatta con una delle querce
sacre di Dodona.
Giasone inviò quindi araldi in tutte le terre vicine
chiedendo agli uomini più valorosi dell'Ellade di
partecipare all'impresa. Molti furono gli eroi che si
unirono alla spedizione cui venne dato il nome di
Argonauti: per non fare torto a nessuno lasciamo
direttamente la parola al poeta Apollonio Rodio, che li
enumera uno ad uno:
«Io voglio qui dire la stirpe degli eroi ed il nome e
i lunghi viaggi per mare, e tutte quante le imprese che essi
compirono nel loro errare. Siano le Muse ministre del canto.
Primo fra tutti ricorderemo Orfeo, che un tempo
Calliope, unita al trace Eagro, secondo quanto si dice,
partorì presso il monte Pimpleo. Narrano che egli ammaliasse
col suono dei canti le dure rocce dei monti e le correnti
dei fiumi.
Subito accorse Asterione, a cui diede la vita Comete:
abitava presso le acque del vorticoso Apidano, a Piresia,
nei pressi del monte Filleo, là dove, venendo da molto
lontano, s'incontrano e uniscono insieme il grande Apidano e
l'Enipeo.
Venne dopo di loro da Larisa il figlio di Elato, Polifemo,
che quand'era più giovane aveva lottato assieme ai forti
Lapiti, al tempo che i Lapiti erano in guerra contro i
Centauri: gli s'appesantivano già le membra, ma gli restava
un cuore guerriero come in passato.
Né molto tempo rimase a Filace lo zio materno di Giasone,
Ificlo: Esone infatti aveva sposato sua sorella Alcimede,
figlia di Filaco, e la parentela lo spinse a unirsi anche
lui alla schiera d'eroi.
E Admeto, signore di Fere ricca di greggi, neppure
rimase colà, ai piedi del Calcodonio.
Non rimasero ad Alope i ricchissimi figli di Ermes, Erito
ed Echione, abili, esperti d'inganni; e terzo con
loro, quand'erano pronti a partire, s'aggiunse l'altro
fratello, Etalide: a lui diede la vita, presso l'Anfrisso,
Eupolemea di Ftiotide, figlia di Mirmidone, agli altri
Antianira figlia di Menete.
E venne, lasciando la ricca Girtone, Corono, figlio
di Ceneo, un prode guerriero, ma non migliore del padre.
E venne anche Mopso Titaresio, che più di tutti gli
altri il figlio di Leto istruì nella scienza di trarre
presagi.
Venne Euridamante, figlio di Ctimeno, il quale
abitava Ctimene, città dei Dolopi, presso il lago Siniade.
Attore poi mandò da Opunte il figlio Menezio, perché
partisse in compagnia dei nobili eroi.
Seguirono Eurizione ed il possente Eribote: di
Teleonte era figlio il glorioso Eribote, Eurizione di Iro.
E terzo venne con loro Oileo, che fra tutti spiccava
per il suo coraggio, esperto nell'inseguire i nemici dopo
averne spezzato le file.
E dall'Eubea venne Canto, che Caneto, figlio d'Abante,
mandò, compiacendo il suo desiderio: ma non doveva più
tornare indietro a Cerinto, perché il suo destino, suo e di
Mopso, l'eroe esperto dei vaticini, fu di ricevere morte,
errando in terra di Libia.
Si unirono a lui Clizio e Ifito, signori di
Ecalia, figli del terribile Eurito, al quale Apollo
saettante donò l'arco, ma quello non trasse profitto dal
dono, perché anzi di sua volontà osò sfidare il dio
donatore.
E vennero anche i figli di Eaco, ma non insieme e non dallo
stesso luogo; fuggiti lontano da Egina, giacché per errore
uccisero il loro fratello Foco, Telamone abitava
nell'isola di Salamina, Peleo aveva posto lontano la
sua casa, nella fertile Ftia.
E venne anche dalla Cecropia il fortissimo Bute,
figlio del prode Teleonte, e il valoroso Falero. Ma
Teseo, che era il più grande fra tutti i figli di Eretteo,
una catena invisibile lo tratteneva sotto la terra del
Tenaro, poiché aveva seguito per un'inutile strada Piritoo.
Entrambi avrebbero reso più facile a tutti l'impresa.
Tifi, figlio di Agnia, lasciò la terra tespia di Sife:
era abilissimo nel sapere già prima i flutti del vasto mare,
abilissimo nel sapere le tempeste di vento, nel guidare la
rotta guardando al sole e alle stelle.
Dopo di loro venne Fliante, dalla città di Aretira;
vennero poi da Argo Talao ed Areo, i due figli
di Biante, il forte Leodoco e il nipote di Eolo,
Melampo.
Non possiamo dire che il cuore magnanimo e forte di
Eracle abbia deluso il desiderio di Giasone: quando ebbe
notizia dell'adunanza di eroi, era tornato allora ad Argo
portando con sé il cinghiale che pascolava presso la grande
palude Erimanzia; entrò appena nella piazza della città di
Micene e, contro il volere di Euristeo, si mise in cammino.
Andava in sua compagnia il giovinetto Ila, il suo
valoroso scudiero; portava le frecce e custodiva il suo
arco.
Dopo di lui venne Nauplio, discendente del nobile
Danao. Fu ultimo Idmone, tra quanti abitavano Argo, e
venne, pure sapendo dagli uccelli il proprio destino, per
non perdere nulla della sua fama gloriosa tra il popolo.
L'Etolide Leda mandò da Sparta il valoroso Polluce e
Castore, esperto di cavalli dai piedi veloci: li
generò in una doglia sola dentro la casa di Tindaro, e li
ebbe carissimi.
I figli di Afareo, il tracotante Ida e Linceo,
giunsero dalla terra di Arena, entrambi superbi del loro
immenso vigore, ma Linceo si distingueva per la vista
acutissima.
Con loro si mise anche in cammino Priclimeno, figlio
di Neleo, il più anziano dei figli che nacquero a Pilo da
Neleo; il dio Poseidone gli diede una forza infinita e il
potere di mutarsi in ciò che voleva, nella stretta della
battaglia.
E dall'Arcadia vennero Amfidamante e Cefeo,
che abitavano Tegea: un terzo eroe li seguiva, Anceo:
lo mandò insieme ai due il padre Licurgo.
E venne Augia, che la fama diceva figlio del Sole;
regnava sugli Elei, orgoglioso della sua ricchezza, ma forte
era il desiderio di vedere la terra dei Colchi.
Asterio e Anfione, i due figli di Iperasio,
vennero da Pellene d'Acaia.
Giunse dopo di loro, lasciando il Tenaro, Eufemo, il
più veloce di tutti. Quest'uomo correva anche sopra le onde
azzurre del mare, e non immergeva i rapidi piedi, bagnava
soltanto la punta, e da sé lo portava la liquida via.
Vennero i due figli del dio Poseidone: Ergino dalla
città dell'illustre Mileto; l'altro, il superbo Anceo,
da Partenia.
Anche il figlio di Oineo si mosse da Calidone e raggiunse
gli eroi, il forte Meleagro, e con lui Laocoonte,
fratello di Oineo per parte di padre.
Lo zio materno lo accompagnò per la stessa strada, Ificlo,
figlio di Testio, esperto nel giavellotto.
Venne con lui Palemonio, figlio di Lerno Olenio di
nome, ma generato da Efesto.
Dalla Focide venne Ifito, figlio di Naubolo, figlio
di Ornito.
Giunsero poi Zete e Calais, i due figli di
Borea. Levandosi, entrambi scuotevano alle tempie ed ai
piedi, dall'una parte e dall'altra, grande stupore a
vedersi, ali nere lucenti di scaglie dorate, e sul dorso,
dalla cima del capo e da ambo i lati del collo, s'agitavano
ai soffi del vento le nere splendide chiome.
Non volle restare nella casa del padre neppure Acasto,
figlio del re Pelia, né Argo, operaio di Atena, ma
l'uno e l'altro andarono a unirsi allo stuolo d'eroi. Tanti
compagni si radunarono dunque attorno a Giasone».
A comando della spedizione fu inizialmente proposto Eracle,
ma il semidio rifiutò e propose la candidatura di Giasone
che, benché giovane, aveva organizzato l'impresa.
Appena la nave ebbe preso il largo, gli Argonauti
sacrificarono due buoi ad Apollo; alcuni degli eroi,
inebriati e resi violenti dalle libagioni, stavano per
venire alle mani e avrebbero così compromesso l'esito del
viaggio, ma Orfeo placò gli animi dei compagni con il dolce
suono della sua lira.
| ① |
Altre fonti (Apollodoro)
riferiscono che alla spedizione parteciparono Tifi,
figlio di Agnio, che tenne il timone della nave; Orfeo,
figlio di Eagro; Zete e Calaide, figli di Borea; Castore
e Polideuce, figli di Zeus; Telamone e Peleo, figli di
Eaco; Eracle, figlio di Zeus; Teseo, figlio di Egeo; Ida
e Linceo, figli di Afareo; Anfiarao, figlio di Oicleo;
Ceneo, figlio di Corono; Palemone, figlio di Efesto o di
Etolo; Cefeo, figlio di Aleo; Laerte, figlio di Arcisio
e futuro padre di Odisseo (Ulisse); Autolico, figlio di
Ermes; Atalanta, figlia di Scheneo; Menezio, figlio di
Attore; Attore, figlio di Ippaso; Admeto, figlio di
Ferete; Acasto, figlio di Pelia; Eurito, figlio di
Ermes; Meleagro, figlio di Eneo; Anceo, figlio di
Licurgo; Eufemo, figlio di Poseidone; Peante, figlio di
Taumaco; Bute, figlio di Teleone; Fano e Stafilo, figli
di Dioniso; Ergino, figlio di Poseidone; Periclimeno,
figlio di Neleo; Augia, figlio di Elio; Ificlo, figlio
di Testio; Argo, figlio di Frisso; Eurialo, figlio di
Mecisteo; Penelo, figlio di Ippalmo; Leito, figlio di
Alettore; Ifito, figlio di Naubolo; Ascalafo e Ialmeno,
figli di Ares; Asterio, figlio di Comete; Polifemo,
figlio di Elato. |
.
Il viaggio verso la Colchide
 iasone
prese il comando della nave Argo e gli eroi si misero in
viaggio, guidati dall'accorta prudenza dell'abile Tifi e
allietati dal canto di Orfeo. iasone
prese il comando della nave Argo e gli eroi si misero in
viaggio, guidati dall'accorta prudenza dell'abile Tifi e
allietati dal canto di Orfeo.
Gli eroi sbarcarono quindi a Lemno, un'isola governata da
sole donne: tempo addietro, infatti, tutti gli uomini di
quella terra avevano ripudiato le mogli legittime per unirsi
alle loro schiave, che rapivano sulle coste della Tracia;
furiose, le consorti massacrarono tutti i loro padri e i
mariti; solamente la regina Ipsipile aveva
risparmiato in segreto il suo genitore.
Quando gli Argonauti sbarcarono nell'isola rimasta in potere
delle donne, essi vennero accolti con tutti gli onori: le
donne vollero unirsi in amore con quegli eroi venuti da
lontano, per concepire una nobile discendenza.
Ipsipile arrivò ad offrire a Giasone il trono di Lemno: il
figlio di Esone rifiutò, ma non disdegnò l'ospitalità che
veniva offerta a lui ed ai suoi compagni. Tra i lussi, i
banchetti e le mollezze, gli Argonauti stavano per perdere
il loro spirito guerriero per cui Eracle dovette
rimproverarli aspramente per convincerli a riprendere il
viaggio.
Dopo aver lasciato Lemno, i compagni si diressero verso il
paese dei Dolioni, dove regnava re Cizico, che
li accolse con ospitalità.
In quella terra, tuttavia, vivevano anche dei terribili
giganti con sei braccia, figli della dea Terra, che all'alba
del nuovo giorno attaccarono il gruppo di eroi; gli
Argonauti non si fecero sorprendere e, a colpi di arco e
lancia, fecero strage di quei mostri; particolarmente letali
furono le frecce di Eracle, intrise del veleno dell'Idra di
Lerna.
Durante la notte la nave Argo riprese il mare ma fu
investita dal vento contrario; senza rendersene conto, gli
eroi partiti alla ricerca del Vello d'Oro si ritrovarono di
nuovo sulla costa dei Dolioni. Questi ultimi, avendo
scambiato la nave per una imbarcazione nemica, attaccarono
gli Argonauti; vi fu un'aspra battaglia nel buio della
notte, senza che le due parti si riconoscessero. Quando
sorse l'alba e tutti si accorsero di quanto era successo (lo
stesso re Cizico era morto nello scontro), un'angoscia
infinita si impadronì dei Dolioni e dei loro ospiti; per tre
giorni interi, essi piansero e si tagliarono i capelli, poi
seppellirono il re Cizico con grandi onori.
 |
| Itinerario degli Argonauti |
Dopo i funerali gli Argonauti ripartirono: poiché vi era
bonaccia, si dovette procedere a remi: per navigare più in
fretta, nacque una gara tra tutti i nobili eroi a chi
resistesse di più (Eracle arrivò addirittura a spezzare il
suo remo).
Giunti nella Misia, l'equipaggio della nave Argo decise
di fare una sosta: Eracle si allontanò per cercare un albero
adatto per costruire un nuovo remo. Accadde tuttavia che
Ila, il ragazzo amato dall'Alcide, nell'andare a prendere
acqua a una fonte venne rapito dalle Ninfe per la sua grande
bellezza. Polifemo udì il ragazzo che gridava aiuto, brandì
la spada e corse a cercarlo; poi incontrò Eracle, gli riferì
ciò che aveva sentito e insieme si misero alla ricerca di
Ila.
Nessuno dei tre poté far ritorno quella notte e il
mattino seguente la giornata si presentava così ventilata
che Giasone decise di fare vela senza i compagni perduti.
Inutili furono le proteste di alcuni degli Argonauti (tra
cui Telamone), così come i tentativi di convincere Tifi a
cambiare rotta: il figlio di Esone, sostenuto da Calais e
Zete, fu irremovibile ①.
Lasciata la Misia, gli Argonauti giunsero al paese dei
Bebrici, dove sedeva sul trono il re Amico, figlio di
Poseidone. Era un uomo forte ma violento, che sfidava tutti
gli stranieri che passavano di là a una gara di pugilato,
uccidendoli tutti.
La sfida di Amico venne raccolta da Polluce, uno dei
Dioscuri, che colpì il suo avversario sopra l'orecchio
frantumandogli l'osso; il re cadde in ginocchio per il
dolore ed in un istante perse la vita; i Bebrici allora
assalirono il figlio di Zeus e di Leda, ma i suoi nobili
compagni strapparono le armi ai nemici e li misero in fuga.
Il viaggio condusse quindi la nave Argo sulla spiaggia di
Salmidesso dove abitava Fineo, un indovino reso cieco
dal dio Apollo perché aveva osato rivelare con esattezza il
sacro pensiero di Zeus. Per dargli maggiore tormento, gli
dei funestavano lo sventurato vaticinatore con le Arpie,
delle terribili creature alate che piombavano giù dal cielo
a rubare qualsiasi cibo Fineo tentasse di ingerire: quel
poco che gli veniva lasciato, si impregnava di un odore
talmente ripugnante che nessuno avrebbe osato anche solo
accostare la bocca.
Gli Argonauti volevano sapere da Fineo la rotta giusta
per il loro viaggio; il profeta promise di rivelare tutto, a
patto che lo liberassero dalle Arpie. Allora gli eroi
prepararono una tavola imbandita: subito i mostri alati si
precipitarono giù con orribili strida e rubarono tutto il
cibo. Come le videro, Zete e Calais, i figli alati di Borea,
brandirono la spada e inseguirono le Arpie attraverso il
cielo sino a quando non intervenne Iride, la
messaggera degli dei, che assicurò che Fineo non sarebbe
stato più tormentato da quei mostri.
L'indovino rivelò così agli Argonauti come affrontare il
viaggio e li mise in guardia dalle rupi Simplegadi,
che avrebbero incontrato in mare. Queste due enormi rocce,
mosse dalla violenza del vento, si scontravano una contro
l'altra, impedendo il passaggio via mare: erano sempre
avvolte dalla nebbia e da fragore immenso e neppure gli
uccelli riuscivano ad attraversarle.
Fineo consigliò agli Argonauti di far volare una colomba
in mezzo alle due rupi: se l'avessero vista in salvo, anche
loro potevano arrischiarsi a passare; ma se quella non ce
l'avesse fatta, era meglio evitare ogni tentativo.
Gli Argonauti ripresero il mare; quando furono ormai
vicini alle Simplegadi, liberarono da prua una colomba e
quella riuscì a volare dall'altra parte; gli Argonauti
allora aspettarono che le rocce si riaprissero e poi,
remando a tutta forza, superarono il passaggio ②.
La nave Argo giunse nell'isola di Mariandine, dove il re
Lico (da sempre nemico acerrimo dei Bebrici) accolse con
gioia gli eroi. Qui morì l'indovino Idmone, ferito da un
cinghiale; morì anche Tifi, il timoniere: Anceo prese il suo
posto alla guida della nave ③.
Gli Argonauti attraversarono quindi il capo ed il porto
delle Amazzoni, quindi arrivarono davanti alla piccola isola
di Dia, sacra ad Ares. Uno stormo di uccelli sacri al dio
della guerra ④ si levò da quel luogo infausto e attaccò la
nave; queste creature combattevano scagliando le proprie
piume acuminate sui loro nemici; una di esse colpì Oileo,
che rimase ferito alla spalla.
Gli Argonauti si ricordarono allora dei consigli di Fineo
e di come questi avesse riferito dell'avversione di questi
animali al rumore: indossati gli elmi dispersero lo stormo
rivolgendo agli uccelli urla possenti. Metà degli uomini si
diede a remare mentre gli altri li proteggevano sollevando
gli scudi, sino a quando la nave non trovò un punto per
attraccare.
Qui, al cospetto degli Argonauti, apparvero dei
naufraghi: erano i figli del defunto Frisso, partiti alla
volta di Orcomeno per reclamare parte dell'eredità del loro
avo Atamante. Gli Argonauti furono ben lieti di aiutarli e
rifocillarli e chiesero loro sostegno nella loro impresa di
riportare in Ellade il Vello d'Oro; i nipoti di Nefele
promisero di perorare la causa degli eroi davanti al re
della Colchide.
| ① |
|
| ② |
Da allora le Simplegadi sono
ferme: era destino, infatti, che, se una nave fosse
riuscita ad attraversarle, quelle rupi sarebbero rimaste
immobili per sempre. |
| ③ |
Giunti in Paflagonia, Giasone
scelse tre nuovi membri degli Argonauti: i fratelli
Deileonte, Autolico e Flogio, vecchi amici di Eracle. |
| ④ |
Secondo alcuni, tali creature
erano della stessa stirpe degli uccelli Stinfalidi. |
.
La conquista del Vello d'Oro
 |
| Medea sul suo carro trainato da serpenti |
Krater lucano a figure rosse (IV sec. a.C.)
Cleveland Museum of Art, Cleveland (USA) |
 li
Argonauti giunsero finalmente nella Colchide, al margine
orientale del Ponto Eusino, e qui il figlio di Esone
dichiarò ai suoi compagni di volersi recare personalmente
alla corte del re Eete per chiedere al sovrano se era
disponibile a consegnare amichevolmente il Vello; solamente
in caso di rifiuto, gli Argonauti avrebbero attaccato
battaglia. li
Argonauti giunsero finalmente nella Colchide, al margine
orientale del Ponto Eusino, e qui il figlio di Esone
dichiarò ai suoi compagni di volersi recare personalmente
alla corte del re Eete per chiedere al sovrano se era
disponibile a consegnare amichevolmente il Vello; solamente
in caso di rifiuto, gli Argonauti avrebbero attaccato
battaglia.
Si formò così una delegazione composta da Giasone, Telamone
e Augia (fratellastro di Eete),
unitamente ai figli di Frisso; il gruppo avanzò attraverso
un altopiano denominato il Circeo, dove si presentò ai
visitatori il macabro spettacolo di cadaveri esposti sulle
cime dei salici (l'usanza del luogo riservava la sepoltura
alle sole donne, mentre i corpi dei maschi erano lasciati
alla mercé degli uccelli).
Il gruppo di eroi giunse infine al palazzo reale, dove venne
accolto da Calciope (moglie del defunto Frisso), che
ringraziò Giasone per aver salvato i suoi figli, e Medea,
un'altra delle figlie di Eete.
Giunse infine il sovrano che, quando venne a sapere dello
scopo per cui erano giunti gli Argonauti, si infuriò e
ordinò agli stranieri di far ritorno nella loro terra di
origine.
Il figlio di Esone rispose con pacatezza e nobiltà d'animo,
ragion per cui Eete non se la sentì di opporre nuovamente un
netto rifiuto: egli pertanto promise che avrebbe consegnato
il Vello d'Oro a condizione che Giasone aggiogasse
all'aratro due tori dagli zoccoli di bronzo (i due animali,
dono di Efesto, erano enormi, selvaggi e spiravano fuoco
dalla bocca), seminando poi sul terreno i denti del drago
ucciso da Cadmo.
Nell'udire le condizioni Giasone rabbrividì, ma in suo aiuto
intervenne il favore degli dei: Eros, spinto dalla
madre Afrodite (in combutta con Hera e Pallade Atena)
ispirò in Medea una travolgente passione verso l'eroe di Iolco ①.
La figlia di Eete era una maga potentissima: ella decise di
aiutare Giasone a conquistare il Vello d'Oro, a patto che il
giovane giurasse di sposarla e di portarla con sé in Ellade ②.
Giasone giurò e Medea gli diede un farmaco magico, con il
quale avrebbe dovuto spalmare la spada, la lancia e anche il
suo stesso corpo, prima di affrontare i tori: per un giorno
intero questo farmaco lo avrebbe reso invulnerabile al ferro
e al fuoco. Poi gli rivelò che, nel seminare i denti di
drago, dalla terra sarebbero spuntati degli uomini in armi;
per sopravvivere alla loro furia guerresca, Giasone avrebbe
dovuto gettare in mezzo delle pietre: gli uomini allora
avrebbero cominciato a guerreggiare e ad uccidersi tra di
loro.
Giasone spalmò su di sé l'unguento magico, andò nel bosco
sacro del tempio ed aggiogò i tori, nonostante questi lo
tormentassero con un fiume di fuoco. Poi seminò i denti di
drago e dai solchi della terra spuntarono i giganti «e la
piana di Ares, l'uccisore di uomini, fu irta di solidi
scudi, di lance, di elmi brillanti»; quando li vide, il
figlio di Esone scagliò delle pietre contro quei guerrieri,
che cominciarono a combattere uno contro l'altro; dopo
un'aspra lotta, Giasone ebbe vita facile ad uccidere i pochi
superstiti, stremati dalla fatica.
Nonostante il giovane fosse riuscito a superare la prova,
Eete rifiutò di dargli il Vello d'Oro e anzi tramò per
bruciare la nave Argo e uccidere tutto l'equipaggio. Ma
prima che il re della Colchide potesse mettere in atto il
suo piano, Medea nottetempo andò da Giasone, lo condusse al
bosco di Ares e con i suoi filtri magici fece addormentare
il drago che stava di guardia.
...Il
serpente
stregato dall'incantesimo scioglieva la lunga spina
dalle spire nate dal suolo, e allungava i suoi infiniti
anelli, così come quando sul mare in bonaccia
si rovescia un'onda scura, muta, senza frastuono;
ma tuttavia teneva alzata l'orribile testa,
bramoso di avvolgere entrambi
nelle mascelle mortali.
Medea intinse un ramo di ginepro,
tagliato da poco, nella mistura,
e sparse il filtro possente sopra i suoi occhi,
pronunciando le formule: lo circondò l'odore
del filtro e lo addormentò .
Apollonio
Rodio:
Argonautiche [IV, -]
④
 |
| Giasone rigurgitato dal serpente, al cospetto di
Atena |
Coppa a figure rosse, da Cerveteri (480/470 a.C.)
Musei Vaticani (Museo Gregoriano Etrusco), Roma (Città del Vaticano) |
Così Giasone poté impossessarsi del Vello e salire sulla
nave Argo, per la gioia di tutti i suoi compagni di
avventura, che si misero ai remi per lasciare la Colchide.
| ① |
La passione amorosa e i dubbi di
Medea sono descritti dai versi di Apollonio Rodio: «Me
infelice, tra quali sventure mi trovo! Da ogni parte il
mio cuore non ha che angoscia e impotenza. Nessun
rimedio alla pena, alla fiamma ferma che brucia»
(Argonautiche [III,
-]). |
| ② |
«Alla malora il pudore e la
fama, e lui, salvo per mio volere, se ne vada via
illeso, dove il suo cuore desidera. Ma io il giorno
stesso, quando avrà compiuta la prova, morrò appendendo
il mio collo al soffitto, o bevendo il veleno che
distrugge la vita» (Argonautiche
[III, -]). |
.
La rotta per il ritorno
 uando
Eete si accorse dell'inganno, fece armare la sua flotta e si
gettò all'inseguimento degli stranieri. uando
Eete si accorse dell'inganno, fece armare la sua flotta e si
gettò all'inseguimento degli stranieri.
A questo punto, i mitografi ci danno due versioni diverse di
quanto accadde: secondo Apollodoro, Medea aveva portato con
sé il fratellastro Apsirto come ostaggio e, vedendo
che il padre stava per raggiungerli, lo uccise senza pietà
facendolo a pezzi e gettandone i resti in mare. Eete,
inorridito, costrinse le navi inseguitrici a fermarsi per
recuperare i brandelli del figlio dilaniato. Secondo altri
autori (Apollonio Rodio), invece, Apsirto inseguì Giasone
per ordine di suo padre e li raggiunse presso un'isola sacra
ad Artemide; qui il giovane venne colpito alle spalle da
Giasone ed ucciso a tradimento.
Fatto sta che gli abitanti della Colchide rallentarono il
loro inseguimento consentendo agli Argonauti di prendere il
largo. I Colchi tuttavia non desistettero ma si
organizzarono in gruppi e iniziarono le ricerche su rotte
diverse.
Fra i mitografi antichi e moderni non vi è accordo sulla
rotta intrapresa da Giasone e dai suoi compagni per il
ritorno: alcuni affermano che la nave risalì la corrente
dell'Istro (Danubio), per poi giungere nel mare Adriatico
attraverso l'Eridano (l'odierno fiume Po).
Altri ancora raccontano che, risalito il Danubio, gli
Argonauti entrarono nel fiume Eridano; di là entrarono nel
profondo corso del Rodano ①. Usciti dal fiume, giunsero alle
rive del mare, passando incolumi per volere di Hera in mezzo
ai mille popoli dei Celti e dei Liguri.
Zeus, infuriato per l'assassinio di Apsirto, scatenò una
tremenda tempesta; la polena della nave allora profetizzò
che l'ira di Zeus non sarebbe cessata sino a quando gli
Argonauti non si fossero diretti in Ausonia, dove Circe li
avrebbe purificati.
Gli Argonauti costeggiarono la Tirrenia e giunsero
nell'isola di Eea, dove si presentarono supplici a Circe
(zia di Medea) e furono mondati dal terribile crimine
commesso. Attraversarono poi le isole delle Sirene e fu
Orfeo a trattenere gli Argonauti, intonando un canto ancor
più bello di quello delle creature incantatrici; solo Bute
si gettò per raggiungerle, ma Afrodite lo rapì e lo portò
con sè. Superate le Sirene, la nave incontrò Scilla e
Cariddi e le Rocce Vaganti, sopra le quali si vedevano
fiamme infinite e colonne di fumo.
La nave Argo giunse in Trinacria (l'odierna Sicilia), dove
pascolavano le mandrie sacre al dio Helios, e quindi a
Corcira, l'isola dei Feaci, dove gli eroi vennero accolti
dal re Alcinoo e dalla regina Arete.
Un gruppo dei Colchi che inseguiva gli Argonauti, nel
frattempo, raggiunse l'isola e reclamò la restituzione di
Medea e del Vello d'Oro.
Il re Alcinoo rispose che se la fanciulla si era già unita a
Giasone era giusto che stesse con lui; se invece era ancora
vergine, l'avrebbe riconsegnata al padre. Arete, la sposa di
Alcinoo, di nascosto dal marito, si ingegnò per far sposare
Medea con Giasone nottetempo così che i Colchi non potessero
accampare diritti di alcun genere.
Ripreso il viaggio, gli Argonauti naufragarono sulla costa
libica poi raggiunsero Creta, dove faceva buona guardia
Talos, la sentinella di bronzo opera del dio Efesto.
L'automa, non appena avvistò la nave, iniziò a bersagliare
l'equipaggio con pietre, ma Medea ingannò il mostro e lo
addormentò con una pozione. La strega si avvicinò poi al
gigante e tolse il chiodo che turava la sua unica vena,
facendolo morire dissanguato. Dopo aver sostato per una
notte, gli Argonauti arrivarono a Egina per attingere acqua,
poi fecero rotta per la Tessaglia.
| ① |
Risulta evidente che le
conoscenze geografiche dei Greci del III secolo a.C.
sulla parte occidentale del Mediterraneo fossero ancora
approssimative. |
.
Giasone e Medea
 li
Argonauti giunsero finalmente a Iolco, dopo aver navigato in
tutto quattro mesi. Nel frattempo, re Pelia, non immaginando
che gli eroi sarebbero mai ritornati, aveva tramato per
uccidere Esone. Quando Giasone arrivò e consegnò il Vello
d'Oro, egli poté solo constatare che il malvagio zio gli
aveva massacrato tutta la famiglia. li
Argonauti giunsero finalmente a Iolco, dopo aver navigato in
tutto quattro mesi. Nel frattempo, re Pelia, non immaginando
che gli eroi sarebbero mai ritornati, aveva tramato per
uccidere Esone. Quando Giasone arrivò e consegnò il Vello
d'Oro, egli poté solo constatare che il malvagio zio gli
aveva massacrato tutta la famiglia.
Fu Medea, ancora una volta, ad inventare un modo per far
pagare a Pelia le sue colpe; la maga andò alla reggia di
Pelia e convinse le figlie a tagliare a pezzi il padre e a
farlo bollire, promettendo che con i suoi filtri l'avrebbe
fatto tornare giovane; ne diede anche una valida prova
facendo a pezzi un ariete, che ritornò un agnellino.
Ormai convinte, le ragazze smembrarono il padre ed
iniziarono il rituale magico; quando esse constatarono che
Pelia era ormai morto e che non sarebbe affatto risorto, era
troppo tardi: al segnale convenuto, gli Argonauti erano
entrati a Iolco prendendo possesso della città.
La popolazione fu tuttavia inorridita per l'orribile morte
del loro sovrano; Giasone, allora, preferì rinunciare al
trono in favore del cugino Acasto (figlio di Pelia), che
aveva partecipato alla spedizione verso la Colchide.
| TABELLA n. 7 |
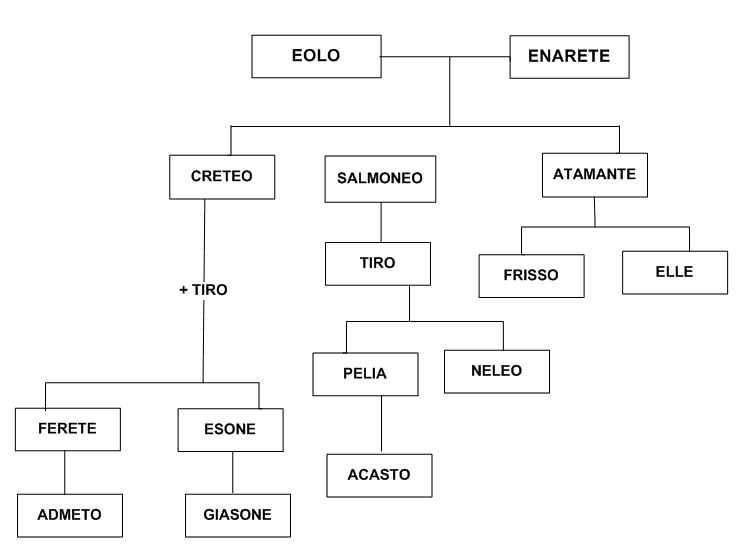 |
| |
| LA STIRPE DI EOLO |
Giasone e Medea vennero banditi da Iolco ed andarono in
esilio a Corinto, dove vissero tranquillamente per dieci
anni sino a quando Creonte, il re della città, non
propose a Giasone un matrimonio con sua figlia Glauce
(che alcuni mitografi chiamano anche Creusa); il
figlio di Esone ripudiò Medea per sposare la principessa,
dimenticando l'antica passione e quanto egli doveva, nel
successo della sua impresa, all'amore della giovane maga.
Medea chiamò a testimoni gli dei nel nome dei quali Giasone
le aveva giurato fedeltà e lo accusò di ingratitudine; la
maga concepì quindi una terribile vendetta : ella inviò in
dono alla sposa novella un peplo intriso di veleni: non
appena la giovane l'ebbe indossato, subito morì consumata da
un fuoco violento e con lei il padre, che tentava di
aiutarla.
Non contenta di questo atroce delitto, per soddisfare la sua
ira ella trucidò barbaramente i figli che aveva avuto da
Giasone; poi salì sul carro di Helios, trainato da draghi
alati, e fuggì ad Atene, dove divenne l'amante del re Egeo e
gli partorì un figlio, cui venne dato il nome di Medo.
In seguito, avendo macchinato contro la vita di Teseo, erede
al trono di Atene, ella fu bandita dalla città e andò in
esilio insieme al figlio. Medea tornò allora nella Colchide,
da suo padre Eete (secondo alcune fonti, ella aiutò il padre
a riprendersi il trono, che gli era stato sottratto dal
fratello Perse).
E Giasone? Disperato per la perdita della novella sposa e
dei figli, egli condusse il resto della sua vita solo e
malinconico, anche se alcune fonti riportano che, con
l'aiuto di Peleo, egli avrebbe riconquistato il trono di
Iolco.
Sta di fatto che il figlio di Esone, avendo disatteso la
promessa di fedeltà fatta a Medea, perse i favori della dea
Hera e visse il resto della sua vita solo e infelice. Si
narra che egli trascorresse spesso i giorni e le notti
vicino alla ormai fatiscente Argo, che gli ricordava le
antiche glorie e le avventure del passato; mentre egli
dormiva sulla poppa della nave, una notte la nave cedette e
l'eroe rimase ucciso all'istante: malinconica fine, che
spesso perseguita i grandi eroi del passato.
| ① |
Gli eventi narrati ispirarono ad
Euripide la famosa tragedia
Medea. Anche il latino Seneca dedicò alla
figura di Medea un'opera teatrale. |
Termina così, con l'infelice sorte di
Giasone, la saga degli Argonauti; molti dei reduci
dall'impresa parteciparono anche alla cattura del cinghiale
calidonio, una fiera che terrorizzava gli abitanti dell'Etolia.
L'animale venne ucciso da Meleagro, figlio di Oineo e
fratello di Deianira. Al di fuori di tali epopee gli
Argonauti si incontrarono ancora e non furono mai episodi
pacifici: i Dioscuri Castore e Polluce si scontrarono con i
loro cugini Ida e Linceo, uccidendosi a vicenda (sopravvisse
il solo Polluce); Eracle si scontrò invece con Augia e Neleo,
come si è visto nel Capitolo I. Altri membri della
spedizione, da ultimo, fu-rono ricordati anche come i
genitori di valorosi combattenti che parteciparono alla
guerra di Troia: è il caso di Peleo, Laerte, Oileo e
Telamone.
|
|
IV
IL MASTINO DI CULANN
Il furore dell'animo celtico
La mitologia celtica è ricca di storie avvincenti,
ispirate ad un forte senso del fantastico e del
soprannaturale. Purtroppo, poco è rimasto di questo immenso
patrimonio poiché i Celti raramente facevano uso della
scrittura per tramandare le loro epopee; inoltre, una certa
avversione della civiltà classico-cristiana nei confronti
della cultura celtica ha fatto sì che gran parte di questa
tradizione sia andata perduta. Fortunatamente, alcuni testi
medievali sono sopravvissuti all'erosione del tempo e ci
consentono di avere oggi una visione, sia pur parziale, di
queste leggende (molti tópoi della letteratura e
della favolistica moderna sono ancora oggi permeati da
elementi risalenti al folclore dei Celti). Oltre alle
leggende legate alla storia dell'isola, particolarmente
famosi sono il ciclo feniano e il ciclo dell'Ulster; quest'ultimo
è dominato dalla figura di Cú Chulainn ①, la cui
epopea è tratta principalmente dal racconto
Táin Bó Cúilnge (XII
sec. d.C.) . ②
.
La nascita di Sétanta
 |
| Cú Chulainn (✍
1916) |
| Stephen Reid (1873-1948), illustrazione. |
 siste
un'isola, che i moderni chiamano Irlanda ma che gli antichi
invocavano con il nome di Ériu, che per secoli
mantenne la propria indipendenza dal resto d'Europa e in cui
vennero mantenute il carattere, le tradizioni ③ e le memorie
ancestrali degli antichi Celti; in questa terra, baciata
dall'amore per la musica e per le favole, visse un tempo un
eroe chiamato Cú Chulainn, della cui forza e del cui
coraggio nessuno osò mai dubitare. siste
un'isola, che i moderni chiamano Irlanda ma che gli antichi
invocavano con il nome di Ériu, che per secoli
mantenne la propria indipendenza dal resto d'Europa e in cui
vennero mantenute il carattere, le tradizioni ③ e le memorie
ancestrali degli antichi Celti; in questa terra, baciata
dall'amore per la musica e per le favole, visse un tempo un
eroe chiamato Cú Chulainn, della cui forza e del cui
coraggio nessuno osò mai dubitare.
A quell'epoca l'Irlanda era divisa in cinque province (Laigin,
Múmu, Connacht, Ulaid e Míde ④), ciascuna delle quali era
governata da un proprio re: gli irlandesi riconoscevano
tuttavia una autorità superiore ad uno di questi sovrani,
cui spettava il titolo di ard rí (re supremo); in
genere tale onore spettava a un rampollo della dinastia del
Míde o dell'Ulaid.
Le saghe irlandesi di cui Cú Chulainn è protagonista sono
ambientate nella regione dell'Ulster, in un'epoca
imprecisata che comunque precede di alcuni secoli l'era
cristiana; a quel tempo regnava dalla sua dimora di Emain
Macha, re Conchobar mac Nessa.
Questi era diventato sovrano grazie all'astuzia della madre
Ness che aveva acconsentito a farsi sposare da re Fergus
mac Róich,
purché quest'ultimo cedesse a Conchobar il trono per un
anno.
Il re acconsentì: il governo del figliastro, tuttavia, fu
talmente saggio e prospero che alla fine dell'anno il popolo
acclamò Conchobar come sovrano e Fergus, che in realtà amava
più i combattimenti e la caccia che i doveri derivanti dal
trono, acconsentì a mettersi da parte.
Durante il regno di Conchobar avvennero alcuni fatti
straordinari: narrano infatti i bardi dell'epoca che un
giorno la bella Deichtine, sorella ed auriga del
sovrano, avesse accompagnato il fratello ed il suo seguito
in una battuta di caccia.
Poiché era giunto l'imbrunire e la neve impediva agli Ulaid
di proseguire, essi trovarono rifugio presso una casa nella
piana di Brug; durante la notte, l'anfitrione annunciò che
sua moglie stava per partorire; Deichtine aiutò la donna e
di lì a poco nacque un bel maschietto.
La mattina dopo, gli Ulaid si svegliarono nella piana: la
casa ed i suoi abitanti erano scomparsi, tranne il neonato;
Deichtine decise così di adottarlo, ma il piccolo ben presto
si ammalò e morì.
Sconvolta dalla disperazione, ella proruppe in un pianto
disperato, per cui una delle sue ancelle le porse una
bevanda in una coppa di rame per lenire il dolore: una
minuscola creatura le scivolò in bocca mentre beveva. Quella
notte, il dio Lug apparve in sogno a Deichtine e le
rivelò che era lui il misterioso padrone della casa nella
piana di Brug e che quella notte le aveva messo un figlio
nel grembo. Al suo risveglio, Deichtine scoprì di essere
effettivamente in attesa di un figlio.
Tale gravidanza era tuttavia fonte di pettegolezzi tra i
nobili degli Ulaid, alcuni dei quali malignavano che
Conchobar fosse solito coricarsi con la sorella; umiliata
dalle dicerie, Deichtine disse di aver abortito; tempo dopo,
la sorella del sovrano si unì in matrimonio con il nobile
Soailte e si presentò a lui «vergine ed intatta». Da
questa unione legittima nacque un figlio, cui venne dato il
nome di Sétanta. Nessuno, tuttavia, fu mai in grado
di stabilire chi fosse il vero padre del bambino, per cui in
seguito si disse che era stato concepito tre volte: egli
venne allevato in casa del poeta Amergin e di sua
moglie Finnchem (sorella di Deichtine e di Conchobar),
che gli fece da balia ⑤.
| ① |
La pronuncia esatta è:
Cuhulign [ku:xʊlɪnʲ]; la seconda «u» è intermedia
tra la o e la u (come la oo inglese di good). |
| ② |
Per approfondimenti, si vedano:
T.W. Rolleston, I miti celtici (Rolleston 1911),
la Saga irlandese di Cú Chulainn
(Agrati ~ Magini 1982²) e
Saghe e racconti dell'antica Irlanda
(Agrati ~ Magini 1993). Due
interessanti rielaborazioni letterarie, I guerrieri
del Ramo Rosso, di Morgan Llywelyn (Llywelyn 1989),
e, tra saggio e romanzo, Agenzia Senzatempo. Viaggio
irreale nell'Irlanda Celtica di Dario Giansanti e
Claudia Maschio (Giansanti ~ Maschio 2010). |
| ③ |
Particolarmente affascinante era
il calendario celtico, che si basava su un computo
complesso, regolato sia dal ciclo solare che da quello
lunare. Il ciclo solare scandiva l'anno in due periodi,
segnate dalla festa di Samain e di Beltain;
queste due fasi principali erano ulteriormente divise in
due parti uguali, segnate dalle festività minori di
Lugnasad e Imbolc. Nella festa di Samain
(il primo novembre) aveva inizio la parte oscura
dell'anno: le porte degli inferi si aprivano e gli
spiriti dei morti tornavano a vagare nel mondo terreno.
Il primo maggio incominciava invece la parte luminosa
dell'anno, con la festa di Beltain che
significava «fuoco di Bel». Il primo agosto era la volta
della festa di Lugnasad in cui si festeggiava la
mietitura e il nuovo raccolto, celebrando la fertilità
della terra, dedicata al dio Lug. Il primo febbraio si
celebrava invece Imbolc (letteralmente «latte di
pecora») che era una festa di purificazione e rinascita,
in cui si celebrava la dea madre e si festeggiava la
nascita degli agnelli. Durante la celebrazione il latte
veniva versato copiosamente sulla terra a simboleggiare
la fertilità. |
| ④ |
Nell'ortografia anglo-irlandese,
le province vengono denominate rispettivamente Leinster,
Munster, Connaught, Ulster e Meath. |
| ⑤ |
Nell'antica Irlanda, era costume
che un rampollo di una schiatta nobile venisse allevato
presso un'altra famiglia (in genere, di lignaggio più
alto); ciò creava un legame tra il fanciullo e la
famiglia adottiva di importanza quasi pari a quella
della famiglia biologica. |
.
Il mastino di Culann
 |
| Cú Chulainn (✍
1916) |
| Stephen Reid (1873-1948), illustrazione. |
 ncora
bambino, Sétanta chiese alla madre di unirsi alla banda di
giovani che venivano istruiti alla corte di Emain Macha:
diventati adulti, essi andavano a costituire l'ordine del
Ramo Rosso, i guerrieri scelti del sovrano. ncora
bambino, Sétanta chiese alla madre di unirsi alla banda di
giovani che venivano istruiti alla corte di Emain Macha:
diventati adulti, essi andavano a costituire l'ordine del
Ramo Rosso, i guerrieri scelti del sovrano.
Nonostante i timori di Deichtine, il piccolo si mise in
cammino e giunse ad Emain, dove si unì ai ragazzi senza
chiedere - come era tradizione - la loro protezione; i
giovani irlandesi presero tale atteggiamento come una sfida
e lo attaccarono; Sétanta venne così posseduto per la prima
volta dal ríastrad ①, una esplosione di rabbia che lo
rendeva invincibile, e riuscì a sconfiggerli tutti quanti da
solo. La rissa venne sedata solo con l'intervento di re
Conchobar, ma il piccolo guerriero pretese che fossero gli
altri ragazzi a mettersi sotto la sua protezione.
Una volta ammesso alla corte del re degli Ulaid, il giovane
Sétanta si rese famoso per un episodio che gli valse il nome
che avrebbe portato per sempre: Culann il fabbro,
infatti, invitò re Conchobar ad un banchetto; prima di
andare il re si fermò al campo di gioco per osservare i
ragazzi giocare a hurling ②. Impressionato dalla
prestazione del nipote, egli lo invitò a seguirlo al
convito; il giovane promise così di raggiungerlo al termine
della partita.
Conchobar raggiunse così la dimora di Culann ma dimenticò di
riferire dell'imminente arrivo di Sétanta; il fabbro così
non mise la catena al suo feroce cane da guardia e lo lasciò
libero. ③
Quando Sétanta giunse al banchetto, venne aggredito
dall'enorme bestia; il giovane si difese a mani nude,
afferrò il cane alla gola con una mano e al dorso con
l'altra, quindi lo sbattè contro un menhir sino a
quando l'animale non giacque esanime.
Gli Ulaid, avendo udito il rumore di una lotta feroce,
accorsero solo per constatare il decesso del cane da
guardia; Culann era disperato per la morte del fedele
animale, ma Sétanta promise di risarcirlo, allevando un
cucciolo del cane sino a renderlo in grado di fare il
guardiano; sino ad allora, il giovane avrebbe preso il posto
dell'animale a guardia della casa del fabbro. Il druido
Cathbad sentenziò allora che da quel momento il nome del
ragazzo sarebbe stato Cú Chulainn (il «mastino di Culann»).
| ① |
Ríastrad o ríastartha.
Letteralmente: «l'atto di contorcersi, distorsione»
(Aa.Vv. 1990). Per
questo è tradotto come «furia» o «spasmo torcente». |
| ② |
Sport nazionale irlandese,
simile all'hockey su prato. |
| ③ |
L'antico cane da caccia e da
guardia celtico era piuttosto simile al nostro alsaziano,
e di taglia assai robusta. Veniva impiegato dai Romani
come cane da guerra o per combattere contro altre belve
nelle arene. Moderni tentativi di ricrearne la razza
hanno portato all'odierno Irish Wolfhound, l'imponente
«cane da lupi» irlandese. |
.
Ríastrad
 |
| Cú Chulainn avanza in battaglia
(✍
1916) |
| Joseph Christian Leyendecker (1874-1951), illustrazione. |
 oiché
un giorno Cú Chulainn aveva udito Cathbad dire che chiunque
avesse imbracciato le armi entro il tramonto avrebbe avuto
gloria eterna, egli pretese dal re di essere insignito di
tale onore. Nessuna delle armi che gli vennero date,
tuttavia, erano adatte alla sua forza, tranne quelle dello
stesso sovrano. I druidi profetizzarono che alla vita
gloriosa dell'eroe si sarebbe accompagnata una morte
precoce. oiché
un giorno Cú Chulainn aveva udito Cathbad dire che chiunque
avesse imbracciato le armi entro il tramonto avrebbe avuto
gloria eterna, egli pretese dal re di essere insignito di
tale onore. Nessuna delle armi che gli vennero date,
tuttavia, erano adatte alla sua forza, tranne quelle dello
stesso sovrano. I druidi profetizzarono che alla vita
gloriosa dell'eroe si sarebbe accompagnata una morte
precoce.
Ben presto Cú Chulainn cominciò a conquistarsi la fama di un
guerriero forte e coraggioso: nel pieno del combattimento,
egli era spesso posseduto dal ríastrad, che lo
trasformava in una creatura spaventosa e multiforme, come
non se n'erano mai viste:
«Dalla testa ai piedi ogni suo organo si agitava come un
albero in un'alluvione o un ramo nella corrente. Il suo
corpo eseguiva una furiosa giravolta nella sua pelle, tanto
che piedi e gambe si giravano all'indietro, portando davanti
talloni e polpacci; le tempie finivano sulla nuca; un occhio
sprofondava nel cranio, mentre l'altro cadeva fuori dalla
sua orbita penzolante. La bocca si distorceva sino a toccare
le orecchie e la faccia si ritirava dalle mascelle sino a
scoprire la gola: dalle fauci colava tanta schiuma che
pareva la lana di una pecora di tre anni. I polmoni e il
fegato sembravano voler uscire dalla bocca attraverso la
gola, mentre i capelli si facevano contorti e spinosi come
un ginepraio e si allargavano come la chioma di un albero.» ①
In questa forma mostruosa, egli terrorizzò molti guerrieri
nemici, alcuni dei quali caddero morti alla sola vista di Cú
Chulainn in preda al parossismo.
L'unico modo per interrompere la frenesia guerriera
dell'eroe venne scoperto dalla nobile Mugain, che una
volta guidò fuori dalla città le donne di Emain con i seni
scoperti: a quel punto Cú Chulainn aveva distolto lo
sguardo, turbato, e gli uomini dell'Ulaid riuscirono a
gettarlo in una botte di acqua fredda, che esplose a causa
del calore del corpo del guerriero; quindi, l'eroe venne
gettato in una seconda tinozza d'acqua e infine in una
terza, sino a quando egli non riprese finalmente il suo
aspetto normale.
| ① |
Cfr. S.J. O'Grady, History of Ireland:
Critical and Philosophical (O'Grady
1881). |
.
La conquista di Emer
 |
| Cú Chulainn ed Emer (✍
1916) |
| Stephen Reid (1873-1948), illustrazione. |
 er
il giovane Cú Chulainn venne quindi il tempo di prendere
moglie: egli si invaghì di Emer, figlia di Forgall;
poiché la famiglia di lei non gradiva questa unione, al
figlio di Deichtine venne richiesto (prima di unirsi in
matrimonio) di compiere altre gesta eroiche e, a tale scopo,
di andare nella terra di Alba (in Scozia) per essere
addestrato dalla famosa donna-guerriero Scáthach;
Forgall sperava in tal modo che il giovane rimanesse ucciso
durante il duro addestramento; Cú Chulainn accettò la sfida,
ma nel frattempo la famiglia di Emer offrì la figlia in
sposa a Lugaid, un re del Munster. er
il giovane Cú Chulainn venne quindi il tempo di prendere
moglie: egli si invaghì di Emer, figlia di Forgall;
poiché la famiglia di lei non gradiva questa unione, al
figlio di Deichtine venne richiesto (prima di unirsi in
matrimonio) di compiere altre gesta eroiche e, a tale scopo,
di andare nella terra di Alba (in Scozia) per essere
addestrato dalla famosa donna-guerriero Scáthach;
Forgall sperava in tal modo che il giovane rimanesse ucciso
durante il duro addestramento; Cú Chulainn accettò la sfida,
ma nel frattempo la famiglia di Emer offrì la figlia in
sposa a Lugaid, un re del Munster.
Scáthach insegnò al giovane guerriero tutte le arti del
combattimento e l'uso della Gaí Bulga, una terribile
lancia piena di punte che poteva essere estratta dal corpo
della vittima solo lacerandone la carne. In questo periodo,
il suo compagno di addestramento era Fer Diad, che divenne
in breve il suo migliore amico nonché fratello adottivo.
Durante questo periodo Scáthach affrontò in battaglia la sua
nemica e rivale Aífe; il prode Cú Chulainn si gettò
nella mischia e affrontò la donna guerriera in un duello
senza esclusione di colpi; alla fine, facendo uso sia della
forza che dell'astuzia, il figlio di Deichtine ebbe la
meglio ed Aífe si arrese; Cú Chulainn le risparmiò la vita a
condizione che ella stipulasse una pace duratura con
Scáthach. Aífe acconsentì e divenne anche, per un certo
periodo, l'amante del «mastino di Culann».
Quando Cú Chulainn lasciò la terra di Alba, Aífe aspettava
un figlio da lui: il guerriero si accomiatò dalla donna
donandole un anello, raccomandandole che suo figlio doveva
chiamarsi Conlaí e che avrebbe potuto recarsi presso
Emain Macha quando fosse divenuto grande abbastanza da
riuscire ad infilare il monile. Cú Chulainn disse anche che
suo figlio non avrebbe dovuto mai rivelare il proprio nome
ad alcuno ①, mai cedere il passo, mai rifiutare uno scontro…
Il mastino di Culann tornò in Irlanda, dove però gli venne
ancora una volta rifiutata la mano di Emer; allora Cú
Chulainn cinse d'assedio la fortezza di Forgall e, con soli
tre colpi, uccise ben ventiquattro uomini; lo stesso Forgall
perì nell'assedio, precipitando dai suoi bastioni; Emer
venne così conquistata e divenne l'amata moglie del
guerriero irlandese sino a quando questi non morì.
Anni dopo, Conlaí venne in Irlanda alla ricerca del padre e
raggiunse gli Ulaid presso una spiaggia: i guerrieri del
Ramo Rosso gli chiesero chi fosse, ma questi rifiutò di dire
il proprio nome.
Gli uomini dell'Ulaid, offesi da tanta insolenza, lo
sfidarono a duello, ma Conlaí tenne testa ad uno ad uno a
tutti i guerrieri che lo sfidarono.
A quel punto, a salvare l'onore degli Ulaid dovette
intervenire Cú Chulainn, che al termine di un combattimento
serrato riuscì ad avere ragione del ragazzo facendo uso
della Gái Bulga. Troppo tardi, il figlio di Deichtine
scoprì di aver colpito mortalmente il suo erede; il senso
dell'onore e l'orgoglio dei guerrieri irlandesi avevano
costretto padre e figlio ad una lotta all'ultimo sangue.
Poco prima di spirare, Conlaí chiede di poter conoscere il
nome di tutti i guerrieri del Ramo Rosso, che si
avvicinarono a lui rendendogli omaggio; per il figlio di Cú
Chulainn venne preparata una tomba con tutti gli onori ed
eretta una stele.
| ① |
Nell'antica Irlanda rivelare il
proprio nome era un segno di deferenza. |
.
La parte del campione
 'assegnazione
della «parte del campione» era un rituale assai noto nella
cultura celtica; in occasione di solenni banchetti, l'onore
di tagliare la carne arrostita e di tenere per sé le parti
più pregiate era riservato a quello che veniva riconosciuto
essere il migliore tra i guerrieri. 'assegnazione
della «parte del campione» era un rituale assai noto nella
cultura celtica; in occasione di solenni banchetti, l'onore
di tagliare la carne arrostita e di tenere per sé le parti
più pregiate era riservato a quello che veniva riconosciuto
essere il migliore tra i guerrieri.
La tradizione, apparentemente innocua, poteva tuttavia
diventare estremamente pericolosa se a partecipare al
banchetto erano clan differenti, a volte divisi tra di loro
da antiche inimicizie o rivalità. In tali casi, ciascuno dei
guerrieri più valorosi reclamava per sé l'onore di poter
tagliare la carne, sostenuto dagli uomini del suo seguito:
non di rado, dalle vanterie e dalle schermaglie si passava
direttamente alle vie di fatto e il banchetto degenerava in
una feroce rissa.
Tra il popolo degli Ulaid, vi erano tre eroi (Cú Chulainn,
Conall Cernach, il «trionfatore», e Lóegaire
Búadach, il «vittorioso») in grado di aspirare alla
parte del campione.
Un giorno il vecchio Brícriu Nemthenga, «lingua
velenosa», incitò i tre guerrieri a competere tra di loro
per stabilire, una volta per tutte, a chi toccasse la
portata migliore nei banchetti.
Vennero così organizzate delle prove di forza e coraggio fra
i tre eroi per decidere chi fosse il migliore, ma nessuna di
esse risultò decisiva; il re Conchobar cominciava a
preoccuparsi, perché gli animi si stavano scaldando un po'
troppo per i suoi gusti e gli Ulaid non potevano permettersi
il lusso di perdere uno dei loro tre guerrieri più valorosi
per una faida intestina.
Alla fine toccò a Cú Roí mac Dáire, un terribile e
spaventoso gigante nativo del Múmu, risolvere la situazione.
Cú Roí fece visita alla corte degli Ulaid travestito da
villano: «Aveva un aspetto pauroso e terribile; portava
sulla pelle un indumento di cuoio ed era avvolto in un
mantello scuro… ognuno dei suoi occhi gialli era grande
quanto un paiolo per cuocere un bue».
Brandendo un enorme scure, il gigante sfidò ciascuno dei tre
eroi a decapitarlo, ma ad una condizione: chiunque avesse
osato tagliargli la testa, in caso di fallimento si sarebbe
sottoposto allo stesso trattamento il giorno dopo.
Lóegaire il Vittorioso prese allora in mano la scure
del gigante (che mise tranquillamente la testa sul ceppo) e
vibrò un terribile colpo. La testa di Cú Roí rotolò sino ai
piedi del focolare.
Grande fu la meraviglia quando il gigante si rialzò, anche
se decapitato: raccolse la testa e la scure e, pur grondante
di sangue, lasciò la dimora degli Ulaid.
La sera seguente Cú Roí tornò a reclamare il suo diritto di
mozzare la testa di Lóegaire, che tuttavia non si fece
vedere. Allora il gigante legò al medesimo patto Conall il
Trionfatore, il quale riuscì a staccare di netto la testa
del suo avversario; ancora una volta, tuttavia, Cú Roí
raccolse tranquillamente la sua testa e se ne andò senza
problemi. Anche Conall, al pari di Lóegaire, non tenne fede
alla parola data e non si presentò al banchetto degli Ulaid
la sera dopo.
Cú Roí cominciò allora a schernire Cú Chulainn, sfidandolo a
compiere quello che i suoi rivali non erano riusciti a
portare a termine; preso dall'ira, il guerriero irlandese si
avventò sul gigante e gli assestò un colpo che sembrava
fatale; la testa andò a sbattere contro le travi del tetto
della dimora degli Ulaid e cadde a terra; Cú Chulainn diede
un ulteriore colpo di scure alla testa e la fece in pezzi.
Nonostante questo, ancora una volta il terribile mostro
travestito da villano riuscì a rialzarsi…
La sera dopo, tutti i guerrieri erano assai rattristati e
avevano già cominciato ad intonare il lamento funebre per Cú
Chulainn; questi rispettò la parola data e si presentò al
banchetto per offrire il collo all'ascia del gigante.
Cú Roí alzò la scure e si preparò a vibrare il colpo
mortale; il sibilo dell'arma affilata era simile allo
stormire degli alberi di una foresta in una notte di vento.
Il gigante abbassò quindi la scure sul collo del coraggioso
guerriero, ma con la lama rivolta verso l'alto; quindi
esclamò: «Alzati, Cú Chulainn! Tra tutti i guerrieri dell'Ulaid
e di Eriu nessuno ti è pari per coraggio, abilità e onore.
Tu sei il primo eroe dell'Irlanda e nessuno potrà
contenderti la parte del campione». Da quel giorno, la fama
del grande Cú Chulainn non venne mai più messa in
discussione e fu celebrata da tutti i bardi dell'isola ①.
.
La razzia del bestiame di Cúailnge
 'impresa
più famosa di Cú Chulainn fu la difesa dell'Ulaid
dall'invasione dell'esercito del Connacht, narrata nel
Táin Bó Cúailnge. 'impresa
più famosa di Cú Chulainn fu la difesa dell'Ulaid
dall'invasione dell'esercito del Connacht, narrata nel
Táin Bó Cúailnge.
A quell'epoca, infatti, il re Conchobar aveva subito la
defezione di molti guerrieri del Ramo Rosso, che non avevano
perdonato al sovrano la sua crudeltà nei confronti della
bella Derdriu e dei figli di Uisliu.
Tempo addietro, il re dell'Ulaid si era invaghito di una
nobile fanciulla, di nome Derdriu, ma la bella giovinetta
(pur promessa al sovrano) era stata preda di una passione
irrefrenabile nei confronti di Noísiu mac Uislenn, ed
era fuggita con lui.
Il re Conchobar aveva finto di aver perdonato la sgarbo di
Derdriu e Noisiu e li aveva convocati presso la sua corte
per riconciliarsi con loro; poi, con l'inganno, il sovrano
dell'Ulaid aveva ordinato il massacro di tutti i figli di
Uisliu e del loro seguito; la bella Derdriu, piuttosto che
sottostare all'umiliazione di divenire sposa di Conchobar,
aveva preferito suicidarsi.
 |
| La regina Medb (✍
1911) |
| Joseph Christian Leyendecker (1874-1951), illustrazione. |
Parte dei guerrieri del Ramo Rosso, tra cui Fergus mac Róich,
non poterono tollerare una così grave violazione dei doveri
dell'ospitalità e preferirono mettersi al servizio di Medb e
Ailill, signori del Connacht.
I due sovrani della provincia nord-occidentale dell'Irlanda,
galvanizzati dall'indebolimento del nemico, organizzarono
l'invasione dell'Ulaid per depredare il magnifico toro Donn
Cúailnge, il «Bruno della regione di Cúailnge».
Gli Ulaid non riuscirono a fronteggiare le forze
dell'invasore perché vittime di una maledizione, per la
quale è opportuno spendere qualche parola in più.
Dopo la fondazione di Emain Macha, infatti, un ricco
contadino dell'Ulaid si era vantato presso il sovrano che
sua moglie Macha era in grado di correre più veloce
dei cavalli del re. Sdegnato, il re degli Ulaid volle
mettere alla prova in una gara di corsa la giovane donna;
ella chiese di essere esonerata da una tale sfida, poiché
era sul punto di partorire ma il re e tutta la folla, nella
loro selvaggia brama di divertimento, non vollero sentire
ragioni.
Macha si cimentò nella corsa contro i cavalli e riuscì a
vincere, ma nel tagliare il traguardo lanciò un grido
lacerante e partorì due gemelli. Ella lanciò quindi una
maledizione: nei momenti di maggior bisogno, tutti i
guerrieri dell'Ulaid avrebbero sofferto dei dolori del parto
per cinque giorni e quattro notti.
Quando l'esercito del Connacht invase il territorio dell'Ulaid,
tutti i guerrieri del Ramo Rosso tranne Cú Chulainn erano
inabili a causa della maledizione di Macha. Toccò quindi al
più grande guerriero degli Ulaid fronteggiare da solo
l'avanzata dell'esercito nemico, già euforico per i primi
successi ottenuti e per il bottino delle scorrerie.
Cú Chulainn, per nulla turbato all'idea di dover
fronteggiare l'armata del Connacht, sradicò una quercia, vi
incise sopra in alfabeto ogam ① una iscrizione e la
lasciò in segno di sfida sulla cima di una pietra infissa
sul terreno: «Nessuno oltrepassi questo punto finché un uomo
non riuscirà a scagliare questa pastoia con una mano» ②.
L'esercito invasore aggirò l'ostacolo e continuò ad
avanzare; il figlio di Deichtine allora attese gli uomini
che erano stati inviati in avanscoperta dal nemico e li
uccise in un agguato; egli pose quindi le loro teste mozzate
sulle quattro punte di un tronco, che venne conficcato come
monito nel mezzo di un torrente.
Dopo aver fiaccato in questo modo il morale delle truppe del
Connacht, Cú Chulainn fece strage dei nemici nel corso di
varie imboscate; centinaia di guerrieri vennero uccisi dalla
terribile fionda del mastino di Culann.
I condottieri del Connacht invocarono il diritto a sfidare
ogni giorno a duello Cú Chulainn; per giorni e giorni, il
campione degli Ulaid sfidò ogni volta a singolar tenzone un
guerriero nemico presso un guado, abbattendo uno dopo
l'altro i duellanti del Connacht.
Nel corso di queste sfide, si avvicinò all'eroe irlandese
una bellissima fanciulla, che gli si offrì, venendo però
respinta: la donna altri non era che la dea Mórrígan
che, furiosa per essere stata rifiutata, attaccò a più
riprese Cú Chulainn sotto forma di vari animali durante i
suoi duelli.
Dopo un combattimento particolarmente duro Cú Chulainn
giacque ferito e solo l'intervento del dio Lùg, che si
rivelò all'eroe come suo padre, riuscì a salvarlo dalla
morte. Il mastino di Culann si risvegliò da un sonno
ristoratore, che aveva lenito le sue ferite, solo per
scoprire che i ragazzi dell'Ulaid (immuni dalla maledizione
di Macha in quanto ancora imberbi) avevano attaccato le
truppe nemiche, venendone massacrati. Cú Chulainn ebbe una
nuova crisi ríastrad, la più terribile, e attaccò l'esercito
del Connacht, uccidendo centinaia di nemici.
Medb e Ailill inviarono quindi il nobile Fergus ad
affrontare Cú Chulainn; questi accettò di cedere il passo al
vecchio compagno d'armi, ma solo con l'impegno da parte
dello stesso Fergus di ricambiare a sua volta il favore
all'occasione successiva.
Cú Chulainn non potè esimersi invece dall'affrontare Fer
Diad, suo migliore amico e fratello adottivo, in un duello
estenuante che durò ben tre giorni e che si risolse solo
quando il campione degli Ulaid fece ricorso alla lancia
Gái Bulga.
Finalmente gli uomini dell'Ulaid si destarono dal loro
torpore magico e si prepararono quindi al contrattacco.
Nella battaglia finale, Cú Chulainn stette inizialmente in
disparte, guarendo le sue ferite, finché non vide avanzare
Fergus, che brandiva la sua spada invincibile, la mitica
Caladbolg. Il mastino di Culann entrò allora nella
mischia ed affrontò Fergus, chiedendogli di mantenere la
parola data e di abbandonare il terreno.
Le forze del Connacht furono infine costrette a ritirarsi,
con pochi uomini supersiti e con un magro bottino, tra cui
il toro Donn Cúailnge (che era stato il motivo scatenante
della invasione dell'Ulaid): per ironia della sorte, il
mitico animale, una volta condotto nella parte
nord-occidentale dell'isola, venne preso da un moto di
rabbia e tornò nella sua provincia di origine, dove – dopo
aver massacrato donne e fanciulli – il cuore gli scoppiò nel
petto come una noce.
Nel panico della ritirata, Cú Chulainn penetrò lo
sbarramento avversario ed arrivò a catturare la regina Medb,
risparmiandole la vita e concedendole la libertà solo perché
riteneva pur sempre indegno uccidere una donna.
| ① |
Primitivo sistema di scrittura,
sviluppato in Irlanda nei primi secoli dell'era
cristiana e utilizzato per iscrizioni commemora-tive o
tombali. È costituito da una serie di linee incise sui
due lati di uno spigolo di pietra o di una assicella di
legno (Giansanti ~ Maschio 2010). |
| ② |
Cú Chulainn aveva così imposto
una geis, vale a dire un vincolo o proibizione:
la sua violazione, nella tradizione irlandese,
comportava gravi conseguenze come la perdita dell'onore
o addirittura la morte. Le geisa si presentavano
di volta in volta come regole sociali legate al rango
della persona ovvero interdizioni imposte da druidi,
poeti satirici o altri soggetti dotati di poteri magici.
(Giansanti ~ Maschio 2010) |
.
La morte di Cú Culainn
 |
|
Cú Chulainn morente (✍
1911) |
|
Oliver Sheppard (1865-1941), scultura. |
General Post Office / Ard-Oifig an Phoist
Dublin / Baile Átha Cliath (Irlanda) |
 opo
la razzia del bestiame di Cúailnge, gli Ulaid si vendicarono
contro il Connacht e i suoi alleati e attaccarono a più
riprese i re delle quattro province; poiché Cú Chulainn era
sempre in prima fila negli scontri, questi si attirò l'odio
di molti. opo
la razzia del bestiame di Cúailnge, gli Ulaid si vendicarono
contro il Connacht e i suoi alleati e attaccarono a più
riprese i re delle quattro province; poiché Cú Chulainn era
sempre in prima fila negli scontri, questi si attirò l'odio
di molti.
La regina del Connacht Medb cospirò con Lugaid,
figlio di Cú Roí e principe del Mumu, per liberarsi una
volta per tutte del mastino di Culann.
Il destino di Cú Chulainn venne segnato nel momento in cui
egli violò i suoi geisa, i divieti i sacrali per lui
stabiliti: al guerriero degli Ulaid era infatti inibito di
mangiare carne di cane, ma nel contempo egli era tenuto ad
accettare sempre la sacra ospitalità che gli veniva data.
Quando a Cú Chulainn venne offerto da una vecchia megera un
pasto a base proprio di carne di cane, egli non potè
esimersi dal violare un geis, rimanendo così
indebolito ed esposto al pericolo mortale.
Lugaid fabbricò tre lance magiche ed aveva profetizzato che
sotto i colpi di ognuna sarebbe caduto un re: con la prima
egli uccise Láeg, fedele amico di Cú Chulainn e da molti
considerato il re degli aurighi; con la seconda uccise il
destriero del figlio di Deichtine, il migliore di tutti i
cavalli. Con la terza, infine, venne colpito a morte il
mastino di Culann.
Lugaid, per sfregio, tagliò la testa del nemico ucciso, ma
così facendo la mano di Cú Chulainn si aprì, la sua spada
cadde e tagliò la mano del figlio di Cú Roí.
Fu Conall Cernach a vendicare la morte dell'amico guerriero,
affrontando ed uccidendo Lugaid in duello.
Il corpo del campione degli Ulaid venne quindi portato ad
Emain Macha, dove venne pianto dalle sue genti. Ma nessun
canto fu così straziante e commovente come quello della
moglie Emer.
Si spezzi questo
cuore che l'ha amato,
non dimentichi l'orecchio la sua voce,
versi sangue l'occhio che lo ha ammirato,
il mondo finirà nel dolore ora che lui è morto.
Mai più ci incontreremo un altro giorno,
Grigio, Grigio di Macha!
Il «ciclo feniano» è invece dominato dalla figura di Finn
mac Cumaill, che ad un valore ed un coraggio senza pari
univa anche la saggezza del salmone della sapienza: durante
la giovinezza, infatti, egli era stato addestrato dal poeta
e druido Finn Éces, che dopo sette anni era riuscito
a catturare un pesce miracoloso e chiese quindi a Finn mac
Cumaill di arrostirlo (chi ne avesse mangiato per primo,
avrebbe avuto accesso ad un sapere senza pari); durante la
cottura, il guerriero si scottò il pollice ed istintivamente
si portò il dito alla bocca, ereditando in questo modo i
poteri del salmone. Da allora, Finn acquisì la conoscenza
suprema: gli bastava mordicchiarsi il pollice per
comprendere tutto.
Finn mac Cumaill divenne il capo delle Fíanna, una
compagnia di guerrieri seminomadi che scorrazzavano in
Irlanda, insofferenti delle autorità; egli contribuì a dare
ai feniani un rigoroso codice d'onore e li unì in un patto di fedeltà assoluta al Re Supremo dell'isola.
Finn mac Cumaill fu anche il padre del famoso guerriero e poeta
Oísin («Piccolo cervo»), che venne celebrato in epoca
romantica da James Macpherson: i suoi
Canti di Ossian
costituirono una delle letture fondamentali per la
sensibilità poetica del XIX secolo.
|
|
V
SIGURÐR
L'ammazzadraghi
Sigurðr (noto anche in Germania come
Sigfried) è l'eroe nazionale della mitologia nordica;
delle sue gesta esistono testimonianze già nell'Edda
poetica, una delle opere più antiche della
poesia scandinava, risalente all'Alto Medioevo. La storia
venne poi rielaborata nella Saga
dei Vǫlsunghi e nell'Edda
di Snorri, componimenti in prosa di epoca più
tarda ma sempre riconducibili alla cultura nordica. Della
leggenda si impadronì la cultura germanica e anglo-sassone;
il Bēowulf contiene un
riferimento esplicito alla storia di Sigurðr, nella quale
l'impresa della lotta contro il drago è attribuita al padre
Sigmundr; nel XIII sec. d.C. la materia venne
rielaborata da un anonimo scrittore tedesco, autore del
Canto dei Nibelunghi;
nonostante l'opera appartenga ad un periodo relativamente
recente rispetto alla genesi del mito, essa mantiene un
forte carattere arcaicizzante, soprattutto nella prima
parte, e conserva intatta la genuinità dell'eroe
protagonista. Le vicende che andremo a narrare non
mancheranno di dare ispirazione anche in epoche più recenti,
soprattutto con l'imporsi della sensibilità del
Romanticismo: citiamo tra tutte la maestosa opera musicale
di Richard Wagner, L'anello del Nibelungo. Nel secolo
scorso, anche un giovane J.R.R. Tolkien dedicò un poemetto
alle gesta di Sigurðr, pubblicato solo di recente ①. Nel
mettere per iscritto questo mito intramontabile, si terrà
conto prevalentemente della versione scandinava della
leggenda, salvo poi citare alcuni passi di altri poemi,
laddove contengano spunti narrativi più interessanti.
.
Il guidrigildo di
Ótter
 |
| Óðinn il Viandante (✍
1911) |
|
Arthur Rackham (1867-1939) |
 elle
epoche antiche, quando i numi si recavano presso le dimore
dei mortali per conoscere il mondo, il padre di tutti gli
dèi Óðinn stava passeggiando nel Miðgarðr ②
assieme al fratello Hǿnir e al subdolo Loki,
il signore degli inganni. elle
epoche antiche, quando i numi si recavano presso le dimore
dei mortali per conoscere il mondo, il padre di tutti gli
dèi Óðinn stava passeggiando nel Miðgarðr ②
assieme al fratello Hǿnir e al subdolo Loki,
il signore degli inganni.
Essi stavano camminando lungo la riva di un fiume e giunsero
sino ad una cascata presso la quale vi era una lontra che
stava mangiando un salmone appena pescato.
I tre dei erano piuttosto affamati, ragion per cui Loki
sollevò una pietra e la tirò colpendo in testa entrambi gli
animali.
I numi portarono con sé le prede e si misero in cammino,
giungendo presso una fattoria abitata dal potente
Hreiðmarr, noto usufruitore di magia; qui, essi chiesero
ospitalità per la notte e, affermando di avere provviste
sufficienti a sfamare tutti, esibirono il salmone e la
lontra.
Il fattore, alla vista dei due animali, chiamò i suoi due
figli Fáfnir e Reginn, i quali piombarono
addosso ai tre dei e li legarono; i numi vennero accusati di
omicidio, avendo essi ucciso Ótter, il terzo figlio
di Hreiðmarr; quest'ultimo, infatti, era dotato della
capacità della metamorfosi e amava spesso mutare forma e
andare a caccia presso la cascata.
Per avere salva la vita, gli dei dovettero pagare un
guidrigildo ③: la lontra venne scuoiata e Hreiðmarr affermò
che ci sarebbe stata riconciliazione solo se i numi fossero
stati in grado di ricoprirla tutta di oro rosso.
Loki venne così liberato ed inviato a procurarsi l'oro:
questi giunse presso un nano che si chiamava Andvari
e che era famoso per essere il possessore di grandi
ricchezze.
Il signore degli inganni riuscì a catturare il nano mentre
si procurava il cibo in forma di luccio (il dono di cambiare
forma era, evidentemente, piuttosto diffuso tra gli
antichi…); come prezzo per la vita e la libertà, Andvari
dovette consegnare tutto l'oro che possedeva.
Quando giunsero alla sua tana nella roccia, il nano consegnò
i suoi tesori ma cercò di trattenere per sé un piccolo
anello d'oro; Loki se ne avvide e gli ingiunse di consegnare
anche quell'oggetto prezioso.
Andvari pregò il dio di lasciargli il monile perché grazie a
quell'oggetto avrebbe di nuovo potuto accrescere le sue
ricchezze, ma Loki intascò l'anello e rispose con asprezza
che da quel momento in poi il nano non avrebbe dovuto
possedere neppure una moneta.
Andvari allora maledisse il suo tesoro e proclamò che quel
monile sarebbe stata la rovina di chiunque l'avesse
posseduto.
Loki tornò quindi da Hreiðmarr e mostrò a Óðinn l'anello
maledetto: questi lo trovò molto bello e lo tolse dal
mucchio; quindi, i tre dei si apprestarono a ricoprire la
pelle della lontra con l'oro trafugato. Il fattore constatò
che l'animale non era stato totalmente ricoperto perché
spuntava ancora un baffo, per cui Óðinn dovette tirar fuori
il gioiello di Andvari per nascondere i peli; da quel
giorno, presso i popoli del nord l'oro viene declamato dai
poeti anche come «il guidrigildo della lontra».
La maledizione del nano, intanto, cominciò a sortire i suoi
primi effetti: i figli di Hreiðmarr, infatti, pretesero dal
padre una parte delle ricchezze ma questi rifiutò
decisamente; i due fratelli allora concepirono un piano
malvagio e così uccisero senza pietà il loro genitore, per
impadronirsi del tesoro di Andvari.
In seguito, la discordia si impadronì anche dei discendenti
di Hreiðmarr, che vennero a lite non intendendo spartire
l'oro in parti uguali. Alla fine, Fáfnir minacciò il
fratello, ingiungendogli di lasciare la terra natia se non
voleva raggiungere il padre nel regno dei morti; Reginn,
essendo il meno forte e il meno coraggioso della stirpe,
preferì andare in esilio.
Fáfnir, che condivideva con il fratello defunto il dono di
cambiare forma, portò con sé l'oro nel Gnítaheiðr (la «piana
dei detriti»), dove si preparò una tana; quindi, si
trasformò in un enorme drago e lì giacque a perenne guardia
delle enormi ricchezze, che già gli antichi cominciavano a
chiamare come «il Tesoro del Nibelungo» ④.
| ① |
Per approfondimenti si rimanda
all'Edda
di Snorri (Isnardi
1975), alla Saga dei
Vǫlsunghi (Meli 1997),
al Bēowulf
(Koch 1987) e al
Canto dei Nibelunghi
(Amoretti 1962). Per la
saggistica, ai Miti nordici di Gianna Chiesa
Isnardi (Isnardi 1991). Per
una interessante rielaborazone del mito nibelungico alla
Leggenda di Sigurd e Gudrún di J.R.R. Tolkien
(Tolkien 2009). |
| ② |
Antico nome nordico per
designare il mondo degli uomini; il significato
letterale è «Recinto di mezzo». |
| ③ |
Nel diritto delle popolazioni
nordiche e germaniche, il guidrigildo era un modo per
espiare un delitto (in genere, un omicidio) e consisteva
nel pagamento di una somma di denaro o di altri beni di
valore; in tal modo, il reo si riconciliava con la parte
offesa o con i suoi eredi, evitando lunghe e sanguinose
faide |
| ④ |
Letteralmente, il termine
Niflungar, «Nibelunghi», significa «abitanti
dell'oscurità» ovvero «esseri della nebbia» e si
riferisce probabilmente agli Elfi Oscuri (i Nani), i
primi custodi del tesoro; in seguito, tale appellativo
venne esteso a tutti i possessori dell'oro di Andvari
sino a divenire un epiteto del popolo dei Burgundi. |
.
I Vǫlsunghi
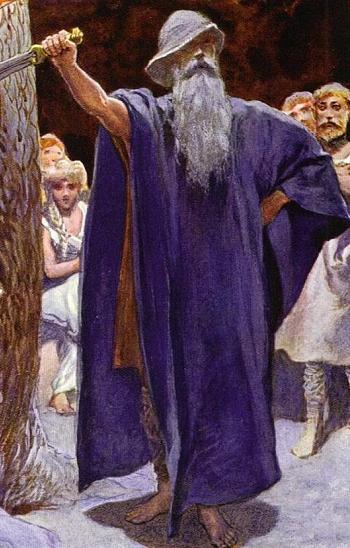 |
| Óðinn conficca la spada nel melo (✍
1905) |
| Emil Doepler der Jüngere (1855-1922) |
| MUSEO: [Doepler.
Walhall]► |
 a
nostra storia si sposta ora in un altro remoto angolo della
Scandinavia, dove visse il grande re Vǫlsungr, figlio
di Rerir e nipote di Sigi. a
nostra storia si sposta ora in un altro remoto angolo della
Scandinavia, dove visse il grande re Vǫlsungr, figlio
di Rerir e nipote di Sigi.
Questo sovrano venne allietato dalla nascita di ben dieci
figli maschi e di una bellissima figlia, cui venne dato il
nome di Signý.
Accadde dunque che a chiedere la figlia di Vǫlsungr in sposa
fosse un re di nome Siggeir, famoso per il suo potere
e la sua ricchezza ma anche per la sua crudeltà; il
matrimonio parve comunque buono alla famiglia dei Vǫlsunghi,
per cui esso venne celebrato con tutti gli onori.
Durante i festeggiamenti, giunse uno sconosciuto con un
occhio solo, coperto da un mantello senza maniche, a piedi
nudi e con calzoni di lino: sul capo aveva un cappello, che
ne nascondeva a stento il viso ①; costui teneva in mano una
spada e avanzò fino ad un albero di melo che si trovava
all'interno della reggia di Vǫlsungr: quindi conficcò l'arma
nel tronco ed esclamò: «Colui che sarà capace di estrarre
questa spada l'avrà in dono da me ed egli stesso confermerà
di non avere mai avuto tra le mani una lama migliore».
Tutti provarono ad impadronirsi dell'arma, ma solamente il
primogenito di Vǫlsungr riuscì ad estrarla: questi era
Sigmundr, un guerriero destinato ad un futuro glorioso.
Dopo i festeggiamenti, Siggeir portò con sé la sposa nei
suoi possedimenti, ma invitò i Vǫlsunghi a raggiungere la
sua corte in capo a tre mesi.
Al tempo stabilito, Vǫlsungr e i suoi raggiunsero le terre
del genero; essi vennero attaccati durante una imboscata
ordita da malvagio Siggeir: il re venne ucciso e i suoi
figli vennero incatenati nella foresta per essere divorati
dai lupi.
Il destino, tuttavia, volle che a salvarsi da questo
terribile supplizio fosse Sigmundr, il quale visse a lungo
nella foresta, rifocillato dall'infelice sorella, sempre in
attesa di realizzare la sua vendetta. Quando riprese del
tutto le forze, egli giunse alla corte di Siggeir e vi
appiccò il fuoco, causando la morte dell'odiato cognato e di
tutto il suo seguito; anche Signý, tuttavia, perì nel rogo
che aveva provocato.
In seguito, Sigmundr tornò nelle sue terre e si riprese il
trono del padre, che era stato usurpato da un traditore;
egli rimase a governare il suo regno per molti anni e venne
a lungo considerato il miglior guerriero e il miglior
sovrano.
Sigmundr si recò quindi nella terra dei Franchi per prendere
in sposa Hjǫrðís, figlia del re Eylimi, con la
quale concepì un figlio maschio.
Si narra che Sigmundr morì in battaglia da valoroso prima
che la moglie partorisse e che, sul punto di spirare, egli
preannunciò alla consorte che avrebbero avuto un erede; il
grande sovrano e guerriero affidò a Hjǫrdís i frammenti
della sua spada andata in pezzi, perché da essi sarebbe
stata forgiata una nuova lama.
La vedova riparò quindi presso la corte di re Álfr,
che sposò in seconde nozze, e partorì un figlio cui venne
dato il nome di Sigurðr.
| ① |
Gli scaldi riferiscono che questo
era uno dei modi in cui Óðinn era solito
presentarsi ai mortali. |
.
Sigurðr e il drago
 |
| Reginn consegna a Sigurðr la spada Gramr
(✍ 1911) |
|
Arthur Rackham (1867-1939) |
 l
giovane Sigurðr venne adottato dal suo patrigno e crebbe
forte e coraggioso: i suoi occhi acuti ne rivelavano la
profondità d'animo ed egli era superiore ai suoi coetanei in
ogni cosa. Il caso volle che il padrino del giovane rampollo
dei Vǫlsunghi fosse proprio Reginn, figlio di Hreiðmarr, che
ancora si struggeva per riprendere possesso di quell'immenso
tesoro che suo fratello gli aveva sottratto. l
giovane Sigurðr venne adottato dal suo patrigno e crebbe
forte e coraggioso: i suoi occhi acuti ne rivelavano la
profondità d'animo ed egli era superiore ai suoi coetanei in
ogni cosa. Il caso volle che il padrino del giovane rampollo
dei Vǫlsunghi fosse proprio Reginn, figlio di Hreiðmarr, che
ancora si struggeva per riprendere possesso di quell'immenso
tesoro che suo fratello gli aveva sottratto.
Reginn rivelò a Sigurðr il segreto del tesoro custodito da
Fáfnir, che era così posseduto dalla brama dell'oro al punto
da impazzire: mai, infatti, egli si era allontanato dal
tesoro, che continuava a custodire in forma di drago.
Per compiere l'impresa, Reginn forgiò due spade ma Sigurðr
le rifiutò perché esse si erano infrante quando il giovane
guerriero le aveva provate contro la pietra; Sigurðr affidò
allora al fabbro i frammenti dell'arma che era stata di suo
padre: questa volta, Reginn riuscì a trarre dalla fucina una
spada cui venne dato il nome di Gramr; il figlio di
Sigmundr capì che quella lama l'avrebbe aiutato a compiere
grandi imprese quando riuscì a tagliare di netto in due un
ciuffo di lana e quando fendette l'incudine del fabbro sino
al ceppo.
Sigurðr e Reginn si recarono quindi nella piana dei detriti
per uccidere Fáfnir; il valoroso eroe aveva il privilegio di
montare il mitico cavallo Gráni, che si dice
discendesse addirittura da Sleipnir, la cavalcatura
di Óðinn; egli scavò una buca lungo la via percorsa dal
drago mentre usciva dalla tana per raggiungere l'acqua.
Sopraggiunse allora un vecchio da un occhio solo per
chiedergli cosa stesse facendo; questi ascoltò la risposta
di Sigurðr ed esclamò: «Questo è un cattivo consiglio. Scava
diverse buche e lascia che il sangue vi scorra dentro; tu
mettiti in una e colpisci la serpe all'altezza del cuore».
 |
| Sigurðr e Fáfnir
(✍ 1911) |
|
Arthur Rackham (1867-1939) |
Quando Fáfnir venne strisciando verso l'acqua sputando
veleno, egli passò sopra la buca in cui si era nascosto Sigurðr; questi vibrò un colpo micidiale con la spada e gli
inferse una ferita mortale. Il drago si scosse muovendo la
testa e la coda e, prima di spirare, ammonì il suo
assassino: mai avrebbe dovuto prendere possesso del tesoro,
per non essere vittima della maledizione di Andvari.
Seguendo il consiglio dell'uomo con un occhio solo, Sigurðr
si immerse nel sangue del mostro ucciso, diventando così
invulnerabile; a rimanere indifesa, fu solo una parte della
schiena in mezzo alle scapole, che non venne sfiorata dal
liquido vitale del drago perché una foglia si era posata
sulla pelle dell'eroe durante l'abluzione.
Giunse nel frattempo Reginn, che si era tenuto in disparte
durante lo scontro, il quale chiese a Sigurðr di arrostire
sul fuoco il cuore del drago; quindi, il fabbro bevve del
sangue del fratello e si pose a dormire.
Il figlio di Sigmundr estrasse il cuore dal mostro e si mise
a cuocerlo sullo spiedo; quando ritenne che fosse ormai
cotto, egli lo toccò con un dito ma il sangue gli colò sulla
pelle e lo scottò: istintivamente, l'eroe si mise il dito in
bocca ma, quando il liquido vitale del drago toccò la lingua
di Sigurðr, questi divenne capace di comprendere il
linguaggio degli uccelli e intese cosa stavano dicendo i
volatili appollaiati sugli alberi:
«Là siede Sigurðr
macchiato di sangue,
il cuore di Fáfnir
sulla fiamma arrostisce;
saggio mi parrebbe
donatore di anello
se il muscolo della vita
splendente mangiasse.»
«Là sta Reginn
e rimugina fra sé,
vuole ingannare il giovane
che ha fiducia in lui;
medita nell'ira
false parole,
vuole, quel fabbro di mali,
vendicare il fratello.»
Il giovane, avendo ascoltato ciò che avevano detto gli
uccelli, riuscì a voltarsi appena in tempo per scorgere
Reginn che tentava di ucciderlo; in un attimo, Sigurðr
brandì la spada e mozzò il capo del subdolo fabbro.
Il figlio di Sigmundr si recò quindi nella tana di Fáfnir e
afferrò a piene mani l'oro di Andvari; quindi, egli saltò in
groppa a Gráni e si allontanò.
.
Sigurðr e i Burgundi
 |
| Sigurðr e Brynhildr
(✍ 1911) |
|
Arthur Rackham (1867-1939) |
 igurðr
giunse nel paese dei Franchi e lì vide un bastione di scudi,
circondato da un cerchio di fuoco; il giovane guerriero,
incuriosito, spronò il suo cavallo e balzò sopra le folgori.
Qui egli notò un guerriero che giaceva «in un sonno di
morte» , vestito con un elmo ed una cotta di maglia e con
una spada accanto. igurðr
giunse nel paese dei Franchi e lì vide un bastione di scudi,
circondato da un cerchio di fuoco; il giovane guerriero,
incuriosito, spronò il suo cavallo e balzò sopra le folgori.
Qui egli notò un guerriero che giaceva «in un sonno di
morte» , vestito con un elmo ed una cotta di maglia e con
una spada accanto.
Sigurðr sollevò l'elmo e scoprì una lucente chioma bionda:
il fantomatico guerriero altri non era che Brynhildr,
una donna guerriera al seguito del grande Óðinn, condannata
dal nume a cessare di combattere e a trovare marito: questa
era la punizione per aver aiutato un guerriero in battaglia
contro il volere degli dei.
La valchiria aveva accettato il suo destino ma chiese di
poter essere sposata solo dal guerriero più valoroso di
tutti; Óðinn l'aveva così fatta addormentare dentro un
cerchio di scudi circondato dalle fiamme, in modo che solo
il più valente degli uomini potesse spezzare l'incantesimo.
Sigurðr lacerò la cotta di maglia della donna guerriera ed
in questo modo restituì Brynhildr al mondo: tra i due nacque
immediatamente una passione amorosa, per cui essi si
giurarono eterna fedeltà.
Il figlio di Sigmundr donò alla sua amata il fatale anello
di Andvari, le raccontò delle sue imprese e del suo
desiderio di compiere altre gesta eroiche, rivelando anche
il segreto della sua invulnerabilità. Brynhildr, a questo
punto, disse a Sigurðr di ritornare da lei solo quando si
fosse procurato una corona ed un regno.
Sigurðr proseguì il suo viaggio ed arrivò nella terra dei
Burgundi, dove regnavano Gjúki e sua moglie
Grímhildr, una esperta conoscitrice di magia. Essi
avevano tre figli maschi, di nome Gunnarr, Hǫgni
e Gotthormr, nonché una figlia femmina che si chiamava
Guðrún.
Poiché i sovrani dei Burgundi ritenevano che sarebbe stata
una fortuna se l'uccisore del drago avesse sposato la loro
principessa, la regina preparò un filtro magico che dava
l'oblio a chiunque ne bevesse.
Sigurðr sorseggiò la bevanda e, in un attimo, dimenticò
Brynhildr e le sue promesse di amore eterno: egli sposò
quindi Guðrún e si legò con giuramenti ai suoi fratelli, con
i quali egli compì grandi imprese.
Non passò molto tempo che Gunnarr concepì l'idea di prendere
in sposa proprio la valchiria circondata dal bastione di
scudi; per quanti sforzi egli facesse, tuttavia, egli non
riusciva a spronare il suo cavallo oltre il muro di fuoco.
Venne allora in suo soccorso Sigurðr che, prese le sembianze
del cognato, spinse Gráni al di là del cerchio di scudi e si
presentò a Brynhildr come Gunnarr, chiedendola in sposa. Il
figlio di Sigmundr dormì per tre notti con la valchiria, ma
come atto di estrema correttezza nei confronti del figlio
del re dei Burgundi collocò sempre nel letto la sua spada,
in modo che i corpi di lui e di Brynhildr rimanessero
separati. Egli non poté fare a meno, tuttavia, di sottrarre
alla bella guerriera il prezioso anello di Andvari (che, in
precedenza, lui stesso le aveva donato) sostituendolo con un
altro monile del tesoro di Fáfnir.
 |
| Brynhildr e Guðrún
(✍ 1911) |
|
Arthur Rackham (1867-1939) |
Brynhildr, pur rimanendo assai perplessa per la piega degli
eventi (ella non aveva dimenticato la promessa d'amore fatta
a Sigurðr), acconsentì alle nozze con Gunnarr che vennero
celebrate con grande letizia del popolo dei Burgundi.
Avvenne tuttavia in seguito che tra Guðrún e Brynhildr
scoppiasse una lite su chi fosse il più nobile e il più
coraggioso tra gli uomini. La valchiria sosteneva con
veemenza che nessuno, all'infuori di Gunnarr, sarebbe stato
in grado di attraversare il bastione di fuoco; allora,
Guðrún la schernì e rivelò che era stato suo marito Sigurðr
a compiere l'impresa: prova ne era l'anello di Andvari, che
il figlio di Sigmundr aveva donato alla moglie dopo averlo
sfilato dalla mano di Brynhildr.
A seguito di quella notizia, la valchiria divenne triste e
taciturna; nel profondo, ella cercava vendetta nei confronti
di Sigurðr per quello che considerava un vero e proprio
tradimento.
La tristezza mutò ben presto in furore, ragion per cui
Brynhildr spinse il marito ad uccidere il cognato Sigurðr
calunniandolo presso di lui; la valchiria arrivò anche a
rivelare a Gunnarr l'unico punto debole dove colpire il
figlio di Sigmundr.
Alla fine fu Gothorm ad uccidere lo sterminatore del drago,
sorprendendolo nel sonno (anche se, prima di spirare, lo
sposo di Guðrún riuscì a prendersi la sua vendetta
decapitando il suo assassino con un fendente). Altre fonti
riportano invece che fu Hǫgni ad uccidere il cognato in un
vile agguato, colpendolo alle spalle durante una battuta di
caccia.
Una cerimonia funebre senza pari venne allestita per
celebrare il grande eroe: attorno alla pira vi erano arazzi
e scudi, la spada Gramr e due falchi; quando il fuoco venne
acceso, la bella Brynhildr non poté sopportare il rimorso
per aver causato la morte di chi gli aveva giurato amore
eterno: ella indossò la corazza e si trapassò con la spada
(ovvero, secondo alcuni, si gettò tra le fiamme).
Poi le fiamme
divampano
con turbinio di fumo,
alto ruggisce il fuoco,
circondato da pianti.
Trapassò così Sigurðr
discendente di Volsung,
anche Brynhild fu arsa:
e ogni gioia ebbe fine.
J.R.R. Tolkien,
Il nuovo lai dei Volsunghi [76] ①
Sigurðr e Brynhildr vennero accolti nel
Valhǫll, dove banchettarono alla destra del padre
Óðinn, in attesa della guerra finale che opporrà un giorno
le forze del bene a quelle del male.
Quando il corno di
Heimdall
tutti udranno squillare
e il ponte dell'Iride
piegheranno i cavalli,
sarà Brynhild a cingergli
la cintura e la spada.
J.R.R. Tolkien,
Il nuovo lai dei Volsunghi [79] ①
Dopo la morte di Sigurðr, i Burgundi si
impossessarono del tesoro di Fáfnir e, da allora, presero il
nome di Nibelunghi; un triste destino, tuttavia, attendeva
gli assassini.
| ① |
J.R.R. Tolkien, La leggenda
di Sigurd e Gudrún (Tolkien
2009). |
.
La strage dei Nibelunghi
 |
| Hǫgni e Guðrún
(✍ 1911) |
|
Arthur Rackham (1867-1939) |
 irca
tredici anni dopo la morte dell'amato Sigurðr, l'infelice
Guðrún venne data in sposa, contro la sua volontà, al re
degli Unni Atli (Attila). irca
tredici anni dopo la morte dell'amato Sigurðr, l'infelice
Guðrún venne data in sposa, contro la sua volontà, al re
degli Unni Atli (Attila).
L'avido sovrano voleva a tutti i costi impadronirsi del
tesoro dei Nibelunghi, per cui egli invitò Hǫgni e Gunnarr
nelle sue terre, pensando poi di tradirli.
Guðrún comprese che si ordiva un inganno contro i suoi
fratelli, per cui incise delle rune, prese un anello d'oro,
vi legò un pelo di lupo e lo consegnò a dei messaggeri
affinché lo consegnassero direttamente ai Nibelunghi; uno
dei messi, tuttavia, lesse il messaggio e lo alterò in modo
tale che apparisse che Guðrún invitava i suoi familiari a
recarsi alla corte di Atli.
I Nibelunghi ricevettero l'invito e si consultarono tra di
loro per decidere se fosse opportuno accettarlo; a
persuaderli furono proprio le rune alterate, che i Burgundi
attribuirono a Guðrún.
Mentre i Nibelunghi attraversavano il Danubio, le Ondine
profetizzarono a Hǫgni che, di tutta la compagnia, solo un
monaco sarebbe tornato vivo in patria.
Hǫgni, con fare sprezzante, per impedire l'avverarsi della
profezia tentò di uccidere l'unico monaco al seguito della
spedizione, gettandolo nel Danubio: questi, però, riuscì a
guadagnare l'altra sponda del fiume e a tornare indietro. A
quel punto, alcuni dei Nibelunghi cominciarono a dare
credito alla profezia.
Giunti alla corte di Atli, i Burgundi si mostrarono sin da
subito sospettosi e si rifiutarono di consegnare le proprie
armi.
Atli li circondò con il proprio esercito e dichiarò che era
sua ferma intenzione ucciderli ed impadronirsi del famoso
tesoro conquistato da Sigurðr uccidendo il drago. In breve
tempo le due fazioni diedero inizio ad un'aspra battaglia.
Giunti alle nere porte
gridarono e colpirono;
delle spade il clangore,
delle scuri lo schianto.
I fabbri da battaglia
martellano le incudini;
scintillano e si spaccano
elmi e lance degli Unni.
J.R.R.
Tolkien, Il nuovo lai di Gudrun [100]
①
Il combattimento durò a lungo e con gravi
perdite da una parte e dall'altra; gli uomini di Atli
circondarono Hǫgni e riuscirono a catturarlo: il re degli
Unni ordinò che gli fosse strappato il cuore (si dice
addirittura che il cuore del Nibelungo rimase saldo anche
dopo il supplizio).
Anche Gunnarr venne catturato e rivelò al re degli Unni che
il tesoro dei Nibelunghi era stato nascosto nelle profondità
del fiume Reno e che pertanto nessuno al mondo sarebbe stato
in grado recuperarlo. Atli allora fece gettare il cognato in
una fosse di serpenti, dove il guerriero trovò la morte ②.
Ma la turpe saga dei Nibelunghi non finisce qui: Guðrún,
infatti, meditò di vendicarsi nei confronti del marito che
gli aveva ucciso i fratelli.
Secondo taluni, ella giunse al punto di uccidere i figli che
aveva avuto da Atli, rivelando al re quel che aveva fatto e
rivolgendogli parole ingiuriose.
Altri sostengono invece che Guðrún si alleò con Hniflungr,
figlio di Hǫgni, per uccidere il sovrano degli Unni; essi
sorpresero Atli nel sonno e lo trafissero con la spada: il
re degli Unni, prima di spirare, rivolse alla moglie parole
di odio.
Guðrún promise un degno funerale per il marito: ella appiccò
il fuoco alla corte e tutti gli uomini che si trovavano lì
ne morirono.
Con le fiamme della reggia di Atli, che giunsero a lambire
il firmamento, termina una delle leggende più turpi e
gloriose della storia del mondo. Essa influenzò autori
antichi e moderni e proprio con i versi di uno degli ultimi
scrittori ispirati da questa saga intendiamo congedarci
dall'atmosfera delle saghe nordiche, che sa di clangore di
spade, di magia e di gesta valorose.
Così ha fine la
gloria,
e sbiadisce anche l'oro,
su rumori e clamori
scende sempre la notte.
Sollevate ora i cuori
guerrieri e fanciulle
per il lai di dolore
che un tempo si cantò.
J.R.R.
Tolkien, Il nuovo lai di Gudrun [166]
①
| ① |
J.R.R. Tolkien, La leggenda
di Sigurd e Gudrún (Tolkien
2009). |
| ② |
Va evidenziato che, nella
versione germanica del poema, è Guðrún (che l'anonimo
autore del Canto dei Nibelunghi
chiama Kriemhilt) ad organizzare la sua vendetta nei
confronti dei fratelli Hagen (Hǫgni) e Gunther
(Gunnarr) e a pretendere che le venga reso il tesoro dei
Nibelunghi. Nella disputa che ne seguì, i Burgundi
vennero accerchiati in un salone e vennero attaccati
dagli Unni in diverse ondate.
Il poema indugia sul conflitto interiore di personaggi
come Rüdiger e Dietrich von Bern
(Teodorico di Verona), che sono legati da vincoli di
amicizia con i Burgundi ma sono anche vassalli di
Attila. Rüdiger decise di affrontare i Burgundi ma
acconsentì a donare armi ai Nibelunghi affinché potessero difendersi.
Dopo una serie lunghissima e tragica di duelli e
combattimenti, tutti i Burgundi vennero uccisi, eccetto
Hagen e Gunther. Kriemhilt uccise Gunther in prigione e
mostrò la sua testa a Hagen, intimandogli di rivelare
dove aveva nascosto il tesoro; il rifiuto di Hagen venne
ripagato con la morte.
A quel punto Hildebrand, maestro d'armi di Dietrich,
preso dall'ira per la morte di tanti valorosi causata
dalla sete di vendetta di Kriemhilt, impazzì e uccise la
moglie di Attila, mettendo così fine alla stirpe dei
Nibelunghi.
Non è inutile evidenziare che la strage raccontata nelle
saghe nibelungiche ha un fondamento storico; nel 437 d.C.,
infatti, i Burgundi stanziati dentro i confini
dell'impero romano vennero dapprima attaccati dalle
truppe legionarie del comandante Ezio e poi annientati
dagli Unni. L'eco di questo massacro influenzò la poesia
epica medievale al punto da farne l'argomento di molte
saghe, anche se il luogo del massacro venne «trasferito»
nella terra degli Unni. |
|
|
VI
RE ARTÙ
I cavalieri della Tavola Rotonda
Re Artù, figlio di re Uther Pendragon, è
una delle figure più importanti dell'immaginario medievale:
egli appare spesso, nelle leggende e nei poemi di cui egli è
protagonista, come l'emblema del monarca ideale sia in pace
sia in guerra. È il personaggio principale della cosiddetta
«materia di Britannia» (si parla anche di «Ciclo bretone» o
di «Ciclo arturiano»), che ispirò molti poeti dell'Età di
Mezzo e delle epoche successive, mantenendo intatto il suo
fascino sino ai giorni nostri... ①
.
La spada nella roccia
 i
fu un tempo, in Inghilterra, in cui secoli bui si
succedettero perché i sudditi di quella terra non riuscivano
ad avere un re che li proteggesse dai barbari che
provenivano dal nord (i Pitti e gli Scoti) e dal mare (gli
Angli, gli Juti e i Sassoni). i
fu un tempo, in Inghilterra, in cui secoli bui si
succedettero perché i sudditi di quella terra non riuscivano
ad avere un re che li proteggesse dai barbari che
provenivano dal nord (i Pitti e gli Scoti) e dal mare (gli
Angli, gli Juti e i Sassoni).
Le fonti riportano che, quando i Romani abbandonarono la
Britannia per difendere le frontiere del Reno e del Danubio,
tutta l'isola cadde in un periodo di anarchia; si racconta
che fu il crudele Vortigern, un signore locale, a
chiedere l'intervento dei Sassoni pur di garantirsi il
dominio assoluto sull'Inghilterra. Quando tuttavia egli
volle sbarazzarsi di quegli alleati che stavano cominciando
a diventare troppo scomodi, era ormai troppo tardi: i nuovi
venuti avevano cominciato a chiedere rinforzi dalla madre
patria e organizzavano scorrerie in tutte le isole
Britanniche.
Per un certo periodo, le incursioni dei Sassoni vennero
contrastate da alcuni coraggiosi condottieri, tra cui
Aurelio Ambrosio (di stirpe romana) e Uther Pendragon,
che giunse a fregiarsi del titolo di re.
Al tempo in cui Uther governava su tutta l'Inghilterra, vi
era in Cornovaglia un potente duca, signore di Tintagel, che
gli faceva guerra da molti anni. Un giorno il re lo convocò
a corte ma, quando il nobile giunse alla presenza del
sovrano, questi si innamorò follemente della moglie del
duca, la bella Igraine. Poiché Uther Pendragon palesò
in modo sfacciato la sua passione per la donna, il signore
della Cornovaglia si allontanò sdegnato dalla corte del re
inglese: tale oltraggio scatenò una guerra tra i due signori
che sembrava non avere mai fine.
Poiché il desiderio di Uther non si sopiva, questi chiese
aiuto al suo consigliere Merlino ②, famoso per le sue
conoscenze delle arti magiche. Il mago si adoperò per
soddisfare il suo sovrano, in cambio di una grazia: «Ecco
cosa voglio, sire. La prima notte che trascorrerete con
Igraine concepirete in lei un figlio che mi farete
consegnare appena sarà venuto alla luce. Io lo alleverò dove
più mi piacerà, affinché a voi derivi onore e al bambino i
vantaggi che gli spettano». Il re accondiscese alla
richiesta.
 |
| Re Artù
(✍1903) |
| Charles Ernest Butler (1864-1933), dipinto. |
Merlino fece in modo che Uther riuscisse a prendere le
sembianze del duca di Cornovaglia per una notte intera; così
egli poté giungere al castello di Tintagel e giacere con la
bella Igraine; quella notte, venne concepito un figlio cui
venne poi dato il nome di Arthur Pendragon, ma che
noi conosciamo come Artù.
Allo spuntar del giorno, venne data la notizia che il duca
di Cornovaglia era morto in battaglia: Igraine pianse la
morte del marito e si chiese con grande stupore chi mai
poteva essere l'uomo che si era coricato con lei con le
sembianze del suo signore.
In seguito, venne conclusa la pace tra i nobili di
Cornovaglia e il re d'Inghilterra, che venne sugellata con
il matrimonio tra Uther e Igraine. Quando la nuova regina di
Britannia mise alla luce un figlio, Uther la rassicurò
raccontandole dell'inganno di Merlino e rivelandole così che
era lui il vero padre di quel rampollo.
Come promesso, il bambino venne affidato alle cure di
Merlino, il quale lo fece crescere presso il castello di un
gentiluomo leale e fedele: sir Ector.
Due anni dopo re Uther si ammalò gravemente; i loro nemici
ne usurparono i diritti, sferrarono battaglia ai suoi uomini
e uccisero numerosi sudditi. Il re d'Inghilterra affrontò i
suoi avversari sul campo di battaglia e li sgominò, ma la
sua malattia si aggravò per cui egli ben presto ne morì.
Dopo la morte di Uther Pendragon, il regno restò a lungo in
pericolo perché ogni signore di potenti armate si rafforzava
e in molti ambivano a diventare re.
Alla fine Merlino consigliò all'arcivescovo di Canterbury di
convocare tutti i nobili ed i gentiluomini d'arme a Londra
per il giorno di Natale; tutti i baroni dell'Inghilterra
accolsero l'invito e si riunirono nella più grande chiesa
della città per pregare.
Nel camposanto dietro l'altare maggiore fu vista una grande
roccia quadrangolare simile ad un blocco di marmo, che
sorreggeva nel mezzo un'incudine su cui era infitta una
spada. Attorno all'arma era scritto: «Colui che estrarrà
questa spada dalla roccia e dall'incudine è il legittimo re
di tutta l'Inghilterra».
Tutti i nobili tentarono di estrarre la spada nella speranza
di diventare re; ma nessuno riuscì nemmeno a smuoverla.
Venne pertanto indetta una giostra ed un torneo per il primo
giorno dell'anno, cui furono invitati tutti i cavalieri del
regno: erano tutti convinti che il trionfatore sarebbe stato
il degno vincitore della spada.
Il giorno di Capodanno, tutti i coraggiosi e valenti uomini
dell'Inghilterra giunsero a Londra per torneare: tra di loro
anche sir Ector accompagnato dal figlio sir Kay e dal
giovane Artù.
Sir Kay era stato da poco ordinato cavaliere ed era quindi
intenzionato a partecipare alla giostra; accortosi quando
era in cammino di avere dimenticato la spada nei suoi
alloggi, prego Artù di andargliela a prendere.
Artù si diresse verso la locanda nella quale dimoravano, per
scoprire che era chiusa: tutti si erano infatti recati ad
assistere al torneo. Addolorato, egli si recò nel cimitero
della chiesa londinese; scese di sella, legò il cavallo e si
avvicinò alla tenda che riparava la spada nella roccia:
quindi, afferrò l'impugnatura e la estrasse con uno strappo
deciso, ma senza sforzo; poi riprese il cavallo e raggiunse
il fratello Kay per consegnargliela.
Quando sir Kay vide la spada, la riconobbe subito; allora,
si avvicinò al padre e disse: — Signore, ecco la spada della
roccia. Dunque devo essere io il re di questa terra.
Sir Ector osservò l'arma; quindi tornò indietro con i due
giovani, entrò nella chiesa e ordinò a Kay di ripetere,
davanti al Libro Sacro, come era entrato in possesso di
quella spada, al che il figlio rispose: — Me l'ha portata
mio fratello Artù, padre.
Ector capì allora che il rampollo che Merlino gli aveva
affidato era destinato a diventare il legittimo re del paese
ed esclamò: — Ora fammi vedere se sei capace di riporre la
spada dov'era e di tirarla fuori di nuovo.
Artù non ebbe difficoltà a rinfilare la spada nella roccia;
più tardi, alla presenza di tutti i baroni, il giovane
figlio di Uther Pendragon estrasse nuovamente la spada dalla
roccia, mentre tutti gli altri uomini d'arme che provano a
cimentarsi nella stessa impresa fallirono miseramente.
Arthur Pendragon venne così acclamato sovrano di tutta
l'Inghilterra e divenne famoso tra tutti i suoi sudditi e
baroni come re Artù.
| ① |
La letteratura dedicata alle
gesta di re Artù è immensa; per i primi approfondimenti,
si consiglia la lettura della Storia di re Artù e
dei suoi cavalieri di Thomas Malory
(Agrati ~ Magini 1985); dei
Romanzi della Tavola Rotonda
(Boulenger 1922); dei
Romanzi cortesi di
Chrétien de Troyes (Agrati ~
Magini 1979). |
| ② |
Una delle figure più
affascinanti ed enigmatiche di tutto il ciclo arturiano,
Merlino è stato di volta in volta identificato con un
erudito di lingua latina dei primi secoli dell'era
cristiana ovvero con uno degli ultimi seguaci della
cultura druidica. Negli Annales
Cambriae viene citato un Myrddin Wyllt,
un bardo che divenne folle a seguito dell'eccidio della
battaglia di Arderydd e si ritirò in eremitaggio nella
foresta di Calidonia. Come spesso avviene nel mondo
mitologico, è verosimile che la tradizione orale abbia
fuso in un'unica figura più personaggi appartenenti a
cicli diversi. |
.
La Tavola Rotonda
 rtù
dovette, in primo luogo, consolidare il suo potere su tutta
l'isola; per questo, egli si affidò ai nobili, ai baroni, ai
cavalieri e ai valentuomini che gli avevano giurato subito
fedeltà (tra i quali c'era suo fratello di latte sir Kay,
destinato a diventare il suo siniscalco) e, con l'aiuto di
Merlino, radunò un esercito per combattere i suoi
oppositori. rtù
dovette, in primo luogo, consolidare il suo potere su tutta
l'isola; per questo, egli si affidò ai nobili, ai baroni, ai
cavalieri e ai valentuomini che gli avevano giurato subito
fedeltà (tra i quali c'era suo fratello di latte sir Kay,
destinato a diventare il suo siniscalco) e, con l'aiuto di
Merlino, radunò un esercito per combattere i suoi
oppositori.
Il re d'Inghilterra si procurò anche l'alleanza di re Ban
di Benwick e di re Bors di Gallia; insieme a loro
egli sconfisse duramente quanti non lo avevano riconosciuto
come legittimo sovrano e consolidò il potere su tutta
l'isola.
La guerra, risolta soprattutto grazie al valore di Artù e
all'intervento delle magie di Merlino, raggiunse il suo
culmine durante l'assedio del castello di re Leodegrance
di Camelerd, che si era subito schierato a favore del
Pendragon ed era stato per questo attaccato dai ribelli; il
giovane sovrano aveva rotto l'accerchiamento di soldati che
si era formato attorno alle mura del suo alleato e aveva
così salvato il re di Camelerd e la sua bellissima figlia
Ginevra.
Dopo aver rinsaldato il suo potere, Artù prese in moglie
proprio la figlia di Leodegrance, che gli portò in dote la
famosa Tavola Rotonda, destinata a diventare celebre nei
secoli a venire.
Attorno a quella tavola sedevano i migliori cavalieri del
regno: la forma circolare stava a significare l'assenza di
gerarchia tra i membri ammessi a quella congregazione;
stretti da un patto di fedeltà con il sovrano, essi
garantivano il rispetto dei valori della giustizia, della
lealtà e della cortesia, ispirati anche da un forte
attaccamento alla religione cristiana.
Con l'aiuto dei Cavalieri della Tavola Rotonda, re Artù
riuscì a mantenere stabile e duraturo il suo regno,
sconfiggendo a più riprese i Sassoni invasori.
Il figlio di Uther si rifiutò inoltre di versare il consueto
tributo all'imperatore romano Lucio, che venne
sconfitto in battaglia e costretto a prestargli omaggio
nonché a dichiararsi suo vassallo.
Nel corso delle tante battaglie affrontate da Artù, la spada
nella roccia andò in frantumi; per questo motivo, Merlino
gli procurò una nuova arma dal nome leggendario: la famosa
Excalibur ①. Il mago riuscì a persuadere la Dama
del Lago ② a consegnargli una lama in grado di tagliare
qualunque materiale; il suo fodero era in grado di rendere
invincibile chiunque lo indossasse (nell'iconografia del
mito, Artù ottiene la spada prendendola dalla mano della
Dama, che uscì fuori da un lago per porgergli l'Excalibur).
Quando venne consolidata la pace in tutto il regno, Artù ed
i suoi Cavalieri si adoperarono per mantenere giustizia ed
armonia. Essi si esercitavano in giostre e tornei e,
periodicamente, giungevano al cospetto del sovrano, la cui
corte si riuniva normalmente nella mitica reggia di
Camelot; Artù ed i suoi vassalli erano soliti piantare
le tende anche in mezzo alla brughiera, dove assi di legno
venivano unite per ricreare la Tavola Rotonda.
Era costume, da parte del sovrano, ascoltare i propri
cavalieri e udire da loro quali avventure avessero
incontrato durante la loro assenza; anche alla corte di Artù
si sviluppò l'arte di raccontare le gesta e le imprese degne
di essere ricordate, creando un materiale che venne poi
rielaborato nei secoli a venire.
Nacque così la figura del cavaliere errante, che andava per
lande solitarie alla ricerca dell'ignoto e del misterioso,
per riparare torti ed assicurarsi gloria imperitura. Tale
spirito viene rappresentato in modo emblematico nell'opera
di Chrétien de Troyes, che mette in bocca queste parole al
cavaliere Ivano e al suo interlocutore:
— Come vedi, sono un cavaliere che cerca ciò che non può
trovare: la mia ricerca è stata lunga, ma vana.
— E cosa vorresti trovare?
— L'avventura, per misurare il mio valore e il mio coraggio.
Ti prego dunque, e ti domando vivamente, di indicarmi, se
sai, un'avventura o una meraviglia. ③
I cavalieri della Tavola Rotonda erano famosi anche per i
loro sentimenti; le ardenti passioni per una spesso
irraggiungibile donna amata divennero materia per i più
grandi poemi del Medioevo; anche in questo caso lasciamo la
parola a Chrétien de Troyes, che così descrive il sentimento
nei confronti di una dama: «Ormai conviene che io sia per
sempre in suo potere, poiché tale è il comando di Amore.
Colui che non accoglie Amore di buon grado quando questi
l'attira a sé, commette tradimento e fellonia. Dico, e
l'intenda chi vuole, che costui non ha diritto ad alcuna
gioia» ③.
In un epoca in cui gli sposalizi venivano decisi per
interesse o per stringere alleanze tra famiglie potenti,
l'amore vero sbocciava spesso tra due persone non unite in
matrimonio; si trattava, nella maggior parte dei casi, di
amori impossibili, di grandi passioni che nascevano già
nella consapevolezza della loro tragica ed inevitabile fine.
I due amanti anelavano di stare vicini, consapevoli che i
momenti di gioia sarebbero stati brevi e inframmezzati da
lunghi periodi di infelicità; si trattava, quindi, di storie
malinconiche che parlavano di lacrime, di sospiri e di
struggente lontananza e che i posteri ci hanno tramandato
coniando la felice formula di «amore cortese» ④.
Tra i cavalieri della Tavola Rotonda vanno citati almeno i
nomi più celebri: innanzi tutto i già noti sir Ector e Sir
Kay, re Leodegrance, sir Ivano; e poi sir Sagramor, Sir Tor,
sir Pellinor, re Lot, re Uriens, sir Erec, sir Lionel, sir
Bors, sir Moroldo, sir Pelleas, sir Lamorak il gallese, sir
Palamede il Saraceno, sir La Cotta Maltagliata, sir
Alessandro l'Orfano, Sir Agravano, sir Gareth, sir Gaheris,
sir Bedivere, sir Lucano il Maggiordomo, sir Dinadan, sir
Galahad, sir Percival e tanti altri ancora.
 |
| La partenza dei cavalieri
(✍1890) |
| Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) William Morris (1834-1896) John Henry
Dearle (1849-1917), arazzo. |
Il primo tra tutti i cavalieri, tuttavia, fu senz'altro sir
Lancillotto del Lago, la cui fama era destinata ad
eclissare quella dello stesso Artù.
Figlio di re Ban e rimasto orfano in tenera età, egli venne
allevato dalla Dama del Lago e diventò cavaliere all'età di
diciotto anni. Ben presto divenne il più coraggioso,
valoroso e fedele di tutti quanti i componenti della Tavola
Rotonda.
In seguito, Lancillotto si innamorò della regina Ginevra ed
iniziò con lei una relazione destinata a portare la rovina
di Camelot e di tutta la sua corte.
Fra le sue molte imprese, si ricorda il salvataggio della
regina, prigioniera nel castello di Méléagant; si
racconta anche che egli venne sedotto dalla figlia del Re
Pescatore, che alcune fonti chiamano Elaine: con
lei concepì Galahad, destinato ad avere un ruolo da
protagonista nella ricerca del Graal.
Notevole anche la figura di Galvano (Gawain), nipote
di re Artù; considerato uno dei cavalieri più prodi e
valorosi, egli era leale al sovrano, difensore dei poveri e
delle dame. Secondo la leggenda, Galvano prendeva la sua
forza direttamente dal sole: infatti, durante il giorno era
pressoché impossibile sconfiggerlo, mentre la notte le
energie lo abbandonavano.
Inizialmente estraneo alla materia di Bretagna, ma poi
incorporato nel ciclo arturiano, era il personaggio di sir
Tristano di Liones. Nipote di re Marco di
Cornovaglia, egli si innamorò (complice un filtro d'amore)
della bella Isotta, destinata tuttavia a diventare la
sposa di suo zio. I due vissero insieme una tormentata
storia d'amore; quando vennero scoperti, Tristano e Isotta
vennero condannati a morte, ma riuscirono a fuggire.
 |
| Imprigionamento di Merlino da parte di Nimue
(✍1874) |
| Sir Edward Burne-Jones (1833-1898), olio su tela. |
Dopo tantissime vicissitudini, nel corso delle quali i due
amanti furono costretti a separarsi, essi cercarono di
ritrovarsi. A causa di un inganno ordito ai suoi danni,
Tristano credette di essere stato abbandonato dalla donna
che amava e si lasciò morire. Isotta, a sua volta, spirò per
il dolore.
I cavalieri della Tavola Rotonda assicurarono per un lungo
periodo pace e stabilità ma ben presto dovettero rinunciare
ad un prezioso alleato.
Accadde infatti che Merlino si innamorò perdutamente di
Nimue, una delle damigelle della Dama del Lago. Il mago
la seguiva dappertutto, tentando più volte di sedurla con le
sue arti sottili, ma la fanciulla si fece giurare che mai
Merlino avrebbe fatto uso di incantesimi con lei, altrimenti
non si sarebbe mai concessa. Il mago e Nimue partirono
assieme per la Cornovaglia e, nel corso del viaggio, egli le
insegnò molte meraviglie. Avvenne quindi che un giorno
Merlino mostrasse alla damigella una caverna che si
sprofondava sotto una grande pietra.
Nimue, mettendo in opera le arti che aveva apprese, indusse
il mago ad entrarvi per mostrarle i prodigi che nascondeva;
poi, fece in modo che egli non ne uscisse mai più e si
allontanò lasciandolo prigioniero.
| ① |
La parola Excalibur ha
origini molto controverse, che possono farsi risalire a
due ceppi linguistici ben differenti: quello latino e
quello sassone. Dal latino abbiamo diversi significati,
ma quello più plausibile deriva da un'antica popolazione
di fabbri chiamati Calibi; Excalibur si può
quindi scindere in due parole ex Calibis, quindi
tradotto letteralmente il significato diventerebbe
«forgiata dai Calibi». Altre sfumature latine riportano
alla capacità della spada e al suo aspetto come, per
esempio, ex calibro che tradotto significa «in
perfetto equilibrio». Il nome celtico della leggendaria
spada, consegnato da Geoffrey di Monmouth, è Caliburn,
che in antichità significava «acciaio lucente» o
«acciaio indistruttibile». Essa era probabilmente una
lontana parente della Caladbolg della mitologia
irlandese. |
| ② |
Figura enigmatica del ciclo
arturiano, viene di volta in volta chiamata Viviana,
Nimue, Niniane, Nyneve o Coventina e viene a volte
identificata con la fata Morgana, sorella di Artù (tanto
da far ritenere ad alcuni studiosi che le dame del lago
fossero più di una, forse legate tra di loro da un
rapporto di discendenza di tipo iniziatico); a questo
personaggio vengono attribuite numerose gesta, dalla
consegna della spada Excalibur sino all'adozione
del cavaliere Lancillotto. Essa rappresenta l'eco
di antiche culture celtiche o pre-celtiche,
probabilmente contaminate con elementi greco-romani. |
| ③ |
Chrétien de Troyes,
Ivano
(Agrati ~ Magini 1979). |
| ④ |
La Chiesa Cattolica, inorridita
da un tale concetto del sentimento, cercò di ricondurre
l'amore cortese nell'ambito del sacro vincolo del
matrimonio; il poeta Chrétien de Troyes, nelle sue opere
Érec ed Énide e
Cligès
(Agrati ~ Magini 1979) si fece
promotore di questo fine moraleggiante, ma il destino
volle che gli amori più famosi del Medioevo (Lancillotto
e Ginevra; Tristano e Isotta) fossero adulterini. La
passione terrena prevalse infine sulla morale cristiana… |
.
La ricerca del Santo Graal
 l
primo riferimento alla leggenda del Graal è contenuta
nell'opera «Percival» di Chrétien de Troyes. l
primo riferimento alla leggenda del Graal è contenuta
nell'opera «Percival» di Chrétien de Troyes.
Percival era uno dei cavalieri della Tavola Rotonda,
destinato ad un grande destino; egli è forte e coraggioso,
ma molto ingenuo in quanto è vissuto a lungo presso la
madre, che per anni lo ha tenuto lontano dal mondo cercando
di proteggerlo dagli orrori della vita. Per questo motivo,
l'eroe tendeva spesso a seguire i consigli che gli venivano
resi, senza fare uso di prudenza e buon senso.
Durante le sue peregrinazioni come cavaliere errante, egli
giunse in un castello in cui venne accolto come ospite e
dove assistette ad una insolita rappresentazione:
«Da una camera apparve un valletto, che impugnava a metà una
lancia splendente di biancore. Una goccia di sangue usciva
dalla punta del ferro della lancia e colava fino alla mano
del valletto, questa goccia vermiglia. […] Vennero allora
due altri valletti, due bellissimi uomini, che tenevano in
mano due candelabri d'oro fino lavorato […] Un Graal teneva
una damigella tra le mani e seguiva i valletti: bella,
gentile e nobilmente adornata. E quand'essa fu entrata, da
tutto il Graal che essa teneva s'irradiò per tutta la sala
un chiarore sì grande che le candele impallidirono come le
stelle o la luna quando si leva il sole. Dopo questa
damigella ne veniva un'altra che portava un piatto
d'argento. Il Graal che veniva avanti era fatto dell'oro più
puro; vi erano inserite pietre preziose delle più ricche e
delle più varie che esistano per mare e per terra; nessuna
gemma potrebbe paragonarsi a quelle del Graal.» ①
Dal racconto di Chrétien apprendiamo che il padrone del
castello è il «Re Pescatore» ②; egli è infermo a causa di
una ferita che lo ha reso inabile alla guerra e alla caccia
(per questo motivo, la pesca è per lui l'unico sistema per
procurarsi il cibo) ③. Secondo uno schema caro a tutta la
mitologia del Medioevo, che ha probabilmente origini più
antiche, l'impotenza del re si trasmette a tutto il suo
regno, che è diventato una «Terra Desolata» (Wasteland).
L'incantesimo può essere spezzato unicamente dal più nobile
e dal più puro dei cavalieri, qualora questi abbia il
coraggio di formulare la fatidica domanda: — In onore di chi
si fa il servizio del Graal?
Nell'opera di Chrétien lo sprovveduto Percival, a causa
della sua timidezza, non ha il coraggio di proferire parola,
ragion per cui il mistero del Graal è destinato a rimanere
tale; né siamo in grado di sapere come andrà a finire,
atteso che il Percival
di Chrétien è rimasto incompiuto.
Gli autori di epoca successiva, tuttavia, ci vengono in
aiuto nel decifrare questo «mistero»; secondo il poeta
tedesco Wolfram von Eschenbach, infatti, si tratterebbe di
un lapsit exillas (rectius: lapis exillis),
ovvero di una pietra caduta dal cielo; uno smeraldo caduto
dalla fronte dell'arcangelo Lucifero durante la sua
ribellione a Dio e portato sulla terra dagli angeli
neutrali. Robert de Boron, invece, identifica il Graal con
il calice utilizzato da Gesù di Nazareth durante l'Ultima
Cena, con il quale Giuseppe d'Arimatea aveva raccolto il
sangue del Messia crocifisso ③. La lancia viene identificata
con l'arma con cui Longino colpì il costato di Gesù di
Nazareth, per verificarne il decesso.
In questa maniera viene «sancita» la cristianizzazione del
mito del Graal, che però ha evidenti ascendenze risalenti a
culture anteriori, legate a rituali connessi al ciclo della
morte e della rinascita; taluni rintracciano le origini
della leggenda in alcuni archetipi della cultura classica
(Adone, Osiride), mentre altri ritengono che l'origine del
mito sia celtica, rinvenendo la sua genesi nel calderone del
Dagda (uno delle Túatha Dé Danann) delle
leggende irlandesi ovvero nel paiolo magico in grado di far
rivivere i morti, citato nei
Mabinogion.
Secondo quanto ci tramandano gli autori del Medioevo, il
Graal apparve un giorno di fronte a tutti i cavalieri della
Tavola Rotonda: la sensazione di beatitudine che promanò
dalla semplice contemplazione di quell'oggetto sacro spinse
tutti ad abbandonare ogni occupazione per andare alla
ricerca di quell'oggetto.
 |
| Sir Lancelot alla cappella del Santo Graal
(✍1888) |
| Sir Edward Burne-Jones (1833-1898), dipinto. |
La quest ④ per il santo Graal è una delle imprese più
importanti di tutto il ciclo arturiano: alcuni dei cavalieri
persero la vita nella ricerca, mentre per i più la missione
ebbe un esito comunque infruttuoso: il Calice, infatti, era
interdetto a quanti erano troppo sedotti dai piaceri
terreni; per questo motivo, anche valorosi come Galvano e
Lancillotto fallirono nel loro compito, in quanto a lungo
coinvolti da passioni lussuriose ⑤.
Secondo una prima versione del mito, a raggiungere il
castello del Graal fu nuovamente Percival, il quale pose
finalmente la fatidica domanda riuscendo a spezzare
l'incantesimo che opprimeva il Re Pescatore (che si scoprì
essere discendente di Giuseppe di Arimatea e parente di
Percival stesso) e la sua Wasteland. Il cavaliere venne
nominato nuovo custode del Graal e trasmise un giorno questo
importante incarico al figlio Lohengrin.
Altre versioni più ortodosse della leggenda, invece, che non
perdonavano evidentemente alla storia di Percival le sue
origini troppo «pagane», attribuivano il successo nella
impresa del Graal a Galahad, figlio di Lancillotto,
il più puro e il più casto di tutti i cavalieri. Egli, sin
dalla più tenera età, fu protagonista di eventi miracolosi e
riuscì a prendere possesso del «Seggio periglioso»,
destinato al migliore tra tutti i cavalieri.
Dopo avere trascorso anni in meditazione e a seguito di un
itinerario fatto di privazioni e di penitenze, Galahad
giunse infine al Castello del Re Pescatore, al cospetto del
Graal (la visione del Calice venne comunque consentita anche
a Percival e Bors, in quanto casti ma non vergini).
Anche a distanza di secoli, scrittori e letterati si sono
avventurati nella materia del Graal, non solo per studiarne
la leggenda, le sue origini o le possibili interpretazioni,
ma anche per fornire ipotesi alternative (non sempre su basi
scientifiche) sulla reale natura e sulla reale ubicazione
del Graal, tanto da suggerire a più di uno studioso
l'ipotesi che gli oggetti sacri descritti nelle leggende
arturiane fossero più di uno.
A questi letterati dallo spessore alquanto tenue ci
permettiamo di rispondere usando le parole di uno scrittore
americano contemporaneo: «Voi siete i draconiani paladini
del risultato finale che rifiutano di credere che la gioia
stia nel viaggio e non nella destinazione (e poco vi importa
quante volte abbiate avuto riprova del contrario)» ⑥.
La mitologia del Graal, infatti, per essere veramente
compresa, non può e non deve essere esaminata solo tenendo
presente il risultato finale, come certa pseudo-cultura
dell'occidente contemporaneo vorrebbe imporci.
La ricerca di un oggetto sacro, prezioso ed allo stesso
tempo irraggiungibile, costituisce la metafora di un viaggio
verso la perfezione, nella consapevolezza che un tale
percorso è sempre un «tendere all'ulteriore» (Streben)
destinato a non avere mai una fine.
Ed è in questa continua ricerca dell'inarrivabile, nella
consapevolezza che l'obiettivo da raggiungere è quasi
impossibile e nella coscienza che ciò contribuisce a
renderci migliori, che si manifesta la metafora del vero
cavaliere arturiano e – forse – dell'intero vivere umano.
⑦
 |
| La visione del Santo Graal
(✍1890) |
| Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) William Morris (1834-1896) John Henry
Dearle (1849-1917), arazzo. |
① |
Chrétien de Troyes,
Perceval il Gallese o il
racconto del Graal.
(Bianchini 1981). |
| ② |
La tradizione lo chiama in modi
diversi: Pelles, Pellehan, Parlan, Hebron (Bron) o
Amfortas (quest'ultimo nome viene da enfertè, che
vuol dire il «ferito»). |
| ③ |
Secondo Malory, il «colpo
doloroso» venne inferto al Re Pescatore da Balin
il Selvaggio, uno dei cavalieri della Tavola Rotonda,
con la stessa lancia mostrata nella processione del
Graal. |
| ④ |
Termine tipico della letteratura
mitologica e del fantasy, per indicare una
ricerca. |
| ⑤ |
Galvano era solito indulgere
alla passione amorosa, mentre Lancillotto era noto per
la sua storia adulterina con la regina Ginevra. |
| ⑥ |
Stephen King, La torre nera
(King,
2004). |
| ⑦ |
Sulla leggenda del Graal, oltre
alla bibliografia citata nella nota VI 1 ①, si
consiglia La leggenda del Santo Graal
(Agrati ~ Magini 1995). |
.
La morte di Artù
 a
cavalleria di re Artù, già indebolita dopo la quest
del Graal (alcuni dei suoi componenti avevano trovato la
morte nella loro ricerca), venne ulteriormente funestata da
una faida interna. a
cavalleria di re Artù, già indebolita dopo la quest
del Graal (alcuni dei suoi componenti avevano trovato la
morte nella loro ricerca), venne ulteriormente funestata da
una faida interna.
La fedifraga storia d'amore tra Lancillotto e Ginevra,
infatti, venne scoperta, gettando la corte nello sconforto:
il figlio di re Ban fu costretto a fuggire, mentre la moglie
del re fu processata per tradimento e condannata al rogo.
Fu lo stesso Lancillotto, con l'aiuto di alcuni cavalieri a
lui fedeli, a liberare Ginevra con un colpo di mano e a
condurla con sé nel castello della Gioiosa Guardia.
Artù ed il suo seguito non poterono accettare lo smacco e si
mobilitarono per mettere sotto assedio il rifugio dei due
amanti. Fu una guerra fratricida, che oppose tra loro
cavalieri che sino a poco tempo prima erano stati fedeli al
loro sovrano; durante il più cruento di questi scontri,
Lancillotto ferì a morte Galvano; il nipote del re, prima di
spirare pregò lo zio di riconciliarsi con la moglie e con il
migliore dei suoi cavalieri.
Gli eventi, però, non consentirono ad Artù di riportare
l'armonia nella sua corte, tra quanti gli avevano giurato
fedeltà. Il re venne a sapere, infatti, che durante la sua
assenza aveva usurpato il trono il figliastro che egli aveva
avuto da una relazione incestuosa con la sorella Morgawse
(ovvero, secondo taluni, con l'altra sorella: Morgana
la fata); il traditore, che aveva osato calpestare la
fiducia del proprio padre e del proprio sovrano, era
Mordred, un nome destinato nei secoli ad essere sinonimo
di infedeltà e di brama di potere.
Artù levò l'assedio e si recò nel Kent con i suoi cavalieri.
Ginevra decise di trascorrere il resto dei suoi giorni in
convento, mentre Lancillotto divenne eremita.
Lo scontro decisivo tra le due fazioni avvenne a Camlann
(ovvero, secondo altre versioni, a Barham Down) e fu la
battaglia più funesta mai vista in terra cristiana. Il fior
fiore della cavalleria trovò la morte; Artù e Mordred si
affrontarono in un duello cruento: il figliastro del re si
scagliò addosso al padre con la spada, mentre il re affondò
la sua lancia sotto lo scudo di Mordred, trapassandolo da
parte a parte; poco prima di spirare, però, l'usurpatore
riuscì a ferire gravemente Artù alla testa.
Sir Lucano e Sir Bedivere, unici sopravvissuti alla strage,
cercarono di sollevare il re, che con un filo di voce disse:
— Prendete la mia spada Excalibur e portatela sulla riva del
mare; vi ordino di gettarla in acqua e di tornare poi a
dirmi cosa avete visto.
Sir Bedivere prese in mano la spada ma non ebbe il coraggio
di obbedire agli ordini, per cui nascose l'arma sotto un
albero e poi si affrettò a tornare dal re.
— Che cosa hai visto? — gli domandò Artù.
— Nient'altro che onde e venti.
— Non è vero — replicò il re. — Ora affrettati ad ubbidire
e, se ti sono caro, non esitare a fare quanto ti ho detto.
Allora sir Bedivere tornò a prendere la spada, ma pensando
che fosse un peccato ed una vergogna gettare via un'arma
tanto nobile, la nascose di nuovo.
— Che cosa hai visto? — domandò per la seconda volta il re.
— Nient'altro che flutti e ondate nere.
— Ahimè, mi hai ingannato ancora. Sbrigati a compiere la tua
missione; non capisci cosa potrebbe succedere se la spada
cadesse in mani sbagliate?
Sir Bedivere tornò dove aveva nascosto la spada e si
avvicinò alla riva; poi avvolse la cintura attorno all'elsa
e la scagliò più lontano che poté. Allora vide un braccio ed
una mano sorgere dall'acqua, afferrarla stretta, brandirla
tre volte e poi inabissarsi con l'arma.
Quando sir Bedivere tornò vicino al re e gli raccontò quello
che aveva visto, il sovrano si limitò ad annuire.
Nel mentre, una piccola chiatta proveniente da un lago
attraccò; scesero a terra tre belle dame, che condussero
Artù all'interno dell'imbarcazione per portarlo nell'isola
di Avalon ①.
Nessuno seppe più nulla di Arthur Pendragon, ma i più
sostengono che a condurlo via furono la Dama del Lago ed il
suo seguito e che tra le donne giunte sulla chiatta vi fosse
sua sorella, Morgana la fata ②. Secondo taluni, egli non è
morto ma riposa in attesa di tornare a nuova vita, assieme a
Merlino, quando la sua terra avrà ancora bisogno di lui.
 |
| L'ultimo sonno di Artù ad Avalon
(✍1898) |
| Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) |
① |
Questa mitica isola viene
da alcuni collocata all'interno della piana di Glastonbury, nel cui terreno paludoso sorgeva una
collina come un'isola nel mare di acquitrini. |
| ② |
Il ruolo e la figura di Morgana
nella leggenda di Artù appare ambiguo e, per certi
versi, affascinante; le versioni moderne e
cinematografiche tendono a descriverla come una donna
malvagia e come perfida alleata di Mordred. Nei testi
più antichi, da un lato ella appare a più riprese come
avversaria di Artù, contro il quale ordisce una congiura
con la complicità di Accolon; dall'altro, la fata
conduce il sovrano nell'isola di Avalon, dove Artù potrà
godere del giusto riposo dopo le sue imprese.
Verosimilmente, il mito originario (la cui origine
risale ad un passato assai remoto) presentava un legame
molto forte tra Artù, Morgana e la Dama del Lago, che un
misogino cristianesimo medievale ha cercato di
«occultare», gettando un'aura di malvagità sulle
presenze femminili della leggenda, ritenute
evidentemente troppo ingombranti. |
.
Dalla storia al mito
 a
storia della leggenda di Artù attraverso i secoli è quasi
altrettanto affascinante delle vicende legate alla Tavola
Rotonda, ragion per cui si è deciso di dedicare un capitolo
a parte alla genesi di questo corpus letterario ①. a
storia della leggenda di Artù attraverso i secoli è quasi
altrettanto affascinante delle vicende legate alla Tavola
Rotonda, ragion per cui si è deciso di dedicare un capitolo
a parte alla genesi di questo corpus letterario ①.
Il nome di Artù appare per la prima volta nella letteratura
gallese: nel Gododdin,
un antico poema risalente al VI secolo, infatti, il poeta
Aneirin scrisse di uno dei suoi sudditi che lui «nutriva
i corvi neri sui baluardi, pur non essendo Artù» (il poema è
tuttavia ricco di inserimenti posteriori e non è possibile
sapere se questo passaggio sia parte della versione
originale o meno).
Alcune composizioni del bardo e poeta Taliesin, appartenenti
presumibilmente allo stesso periodo, citano Artù: il poema
Viaggio a Deganwy
contiene un interessante passaggio: »come alla battaglia di
Badon con Artù, il capo che organizza banchetti, con le sue
grandi lame rosse dalla battaglia che tutti gli uomini
possono ricordare».
Altre importanti citazioni sono contenute nelle Vite dei
santi o negli Annali di Pasqua, conservati al
British Museum come «Historical Miscellany», che risalgono
all'XI-XII secolo ma che verosimilmente trascrivono
annotazioni di epoche precedenti.
Ma il riferimento più importante tra gli scritti dell'Alto
Medioevo è contenuto nella Historia
Brittonum, attribuita al monaco gallese Nennio,
che scrisse questo compendio dell'antica storia del suo
paese nel IX sec.; quest'opera ci descrive Artù come un
dux bellorum, cui vengono attribuiti almeno dodici
scontri contro gli invasori; in particolare, nella battaglia
del Monte Badon egli avrebbe ucciso da solo
novecentosessanta nemici. È importante sottolineare che
Nennio consideri a tutti gli effetti Artù come un
personaggio storico realmente esistito. ②
Secondo gli Annales Cambriae,
una cronaca del X sec. relativa agli eventi più
significativi del Galles nell'Alto Medioevo, Artù sarebbe
stato poi ucciso durante la battaglia di Camlann nel 537.
Un altro storico medievale del XII sec., Guglielmo di
Malmesbury, autore dell'opera Deeds
of the Kings of England, trattò dalla esistenza
storica del personaggio di Artù.
Nel frattempo, la figura di Artù cominciò ad essere oggetto
di un processo di mitizzazione letteraria, iniziato
probabilmente in Galles. Nei racconti gallesi dei
Mabinogion, una delle
testimonianze più importanti della letteratura celtica
(giunti a noi in una redazione del XIV sec. ma risalenti ad
una tradizione molto più antica), egli compare a più
riprese.
Nella storia di Culhwch e Olwen,
il protagonista visita la corte di Artù e cerca il suo aiuto
per conquistare la mano della bella Olwen. Anche nel
racconto Peredur
(l'equivalente gallese di Percival) ci sono numerosi
riferimenti al ruolo del sovrano inglese e dei suoi
cavalieri ③.
La prima grande popolarizzazione della leggenda di re Artù
fu però il romanzo di Geoffrey di Monmouth (Historia
Regum Britanniae), che sviluppò la novella di
Artù soprattutto su elementi fantastici ed avventurosi.
Le leggende di re Artù varcarono poi la Manica per diventare
popolari in Francia (soprattutto in Bretagna, dove
confluirono le migrazioni della comunità gallese),
assimilando anche tradizioni letterarie locali ④. La materia
arturiana si diffuse poi nel resto d'Europa; in particolare,
si deve al poeta Chrétien de Troyes (vissuto a lungo presso
la corte di Aquitania e considerato dai molti il più grande
poeta medievale dopo Dante Alighieri) l'elaborazione di
molti dei tópoi letterari del ciclo bretone, come
l'amore cortese e la ricerca del santo Graal.
Tali tematiche saranno poi rielaborate da più autori nel
corso del Medioevo (tra cui Marie de France, Robert de Boron,
Wolfram von Eschenbach, l'anonimo autore della
Vulgata nonché
l'altrettanto anonimo artefice di
Sir Gawain e il Cavaliere Verde, per citare solo
i più noti), incorporando anche il ciclo di Tristano,
inizialmente autonomo (Thomas, Béroul, Goffredo di
Strasburgo).
Nel XV sec. la saga arturiana culmina nella mirabile sintesi
di Thomas Malory, un nobile caduto in disgrazia durante la
Guerra delle Due Rose, il quale durante la sua prigionia
scrisse una summa delle leggende arturiane che divenne poi
la versione «ufficiale» dell'epopea, cui attinsero molti
degli autori successivi.
La materia arturiana avrebbe poi fornito ispirazione ai
poemi cavallereschi del Rinascimento e sarebbe stata
utilizzata come strumento di propaganda dalla dinastia
inglese dei Tudor, che vantavano una discendenza diretta da
re Artù.
Dopo un breve periodo di appannamento, la sensibilità del
Romanticismo si riavvicinò alla poesia e all'epica
medievale; la corrente pittorica dei Pre-Raffaeliti si
ispira spesso alle leggende arturiane. Il XX secolo, da
ultimo, grazie alla nascita e alla grande popolarità del
genere fantasy inaugurato da Tolkien e da altri
autori di lingua inglese (Lewis, Howard, Ashton Smith,
ecc.), conosce un vero e proprio revival del ciclo bretone,
con numerose rielaborazioni e reinterpretazioni sia nel
campo letterario che cinematografico, senza dimenticare il
mondo del fumetto e dell'animazione ⑤.
 |
| La dama di Shalott (✍1888) |
| John William Waterhouse (1849-1917), dipinto. |
| Elaine di Astolat, innamorata ma non corrisposta da
Lancillotto, morì di dolore. L'episodio, narrato da Thomas Malory, divenne
oggetto di un poemetto romantico di Alfred Tennyson, The Lady of Shalott
(✍ 1833), che fu di
grande ispirazione per i preraffaelliti. |
Una delle questioni che ha affascinato maggiormente gli
storici contemporanei consiste nello stabilire se re Artù
sia stato un personaggio storico realmente esistito ovvero
se si tratti di una mera invenzione letteraria. Se negli
anni precedenti si era raggiunto un consenso generalizzato
nel ritenere leggendaria la figura del sovrano, ultimamente
alcune scuole di pensiero avanzano con convinzione l'ipotesi
opposta.
Le tesi proposte sono state molteplici e le andiamo qui a
riportare in estrema sintesi:
-
Artù sarebbe stato un condottiero
romano-britannico vissuto nel V-VI secolo d.C., che
combattè a lungo contro i Sassoni (è la versione di
Nennio); i suoi ipotetici quartieri generali sono stati
di volta in volta collocati in Galles, in Cornovaglia o
nella parte occidentale dell'Inghilterra ⑥.
-
Il re di Camelot sarebbe stato un
sovrano di origine celtica, identificato di volta in
volta con personaggi storici più o meno famosi, tra cui
citiamo: Riotamo, re dei Bretoni in Armorica;
Áedán mac Gabráin ovvero suo figlio Artuir mac
Áedáin, signori della guerra scozzesi; Owain
Ddantgwin, che sembrerebbe essere stato un re di
Rhôs (nel Galles).
-
Il leggendario sovrano coinciderebbe
con un condottiero romano, identificato ora con
l'usurpatore Magno Massimo ora con il dux
Lucio Artorio Casto, che nel II secolo d.C. riportò
numerosi successi militari guidando un'unità di
guerrieri sarmati (provenienti dall'Ucraina
meridionale); questi ultimi avrebbero importato in
Britannia le loro usanze militari, come l'uso costante
delle cavalcature durante le battaglie: i Sarmati
sarebbero così gli antenati degli antichi cavalieri.
-
Secondo un'altra teoria Artù sarebbe
stato in realtà un re dell'età del bronzo (III millennio
a.C.); la leggenda della spada nella roccia
costituirebbe una metafora della fusione del metallo e
della successiva «estrazione» dell'arma.
Un'interessante ipotesi è stata
recentemente prospettata da alcuni storici britannici
consulenti dell'ente televisivo statale BBC circa l'origine
del nome Arthur. Esso, a loro dire, potrebbe infatti
derivare dall'unione del termine bretone arth (che
significa «orso»), con l'analogo termine latino ursus:
dal vocabolo ancestrale Arth-Ursus sarebbe derivato
Arthur.
Anche sulla base del suo nome, una scuola
di pensiero ritiene che la figura di Artù non abbia nessuna
consistenza autentica e che si tratterebbe di una divinità
celtica (Artaios ⑦) dimenticata e poi trasformata
dalla tradizione orale in un personaggio storico.
Volendo sintetizzare in poche righe i contributi dei tanti
studiosi che si sono occupati della materia, bisogna tornare
al clima storico della Britannia del V sec.; le legioni
romane, non potendo sostenere le pressioni dei barbari dal
Reno e dal Danubio, decisero di abbandonare l'isola, che si
ritrovò quindi a gestirsi in un vero e proprio autogoverno.
L'aristocrazia romana e quella celtica si
allearono, facendo fronte comune contro gli invasori che
provenivano dal nord (Pitti e Scoti) e dal mare (Angli, Juti,
ma soprattutto Sassoni).
In questa fase, evidentemente uno o più
condottieri particolarmente valorosi riuscirono ad arginare
l'avanzata dei Sassoni e a dare alla Britannia un periodo di
stabilità. È molto probabile che tali figure avessero
un'ascendenza romana ⑧ e che si avvalessero anche di quei
legionari che avevano preferito rimanere nell'isola (ivi
compresi quei guerrieri a cavallo che tanto dovettero
influenzare il modo di combattere nei secoli successivi: i
Sarmati, cavalieri ante litteram).
Ad ogni modo, tale periodo rimase
particolarmente impresso nelle generazioni successive,
spesso afflitte dalle invasioni di Sassoni e Vichinghi. Si
può pensare che, nelle epoche successive, il riferimento ad
un periodo in cui i Britanni fecero fronte contro il nemico
occupante avesse un certo ascendente sul pubblico.
È quindi probabile che il personaggio del
dux bellorum che fronteggiò gli invasori sia stato
mitizzato e che, con il passare dei secoli, più figure siano
state poi riunite dalle credenze popolari e tramandate come
se fossero un'unica entità.
Secondo un meccanismo tipico del
Medioevo, che non conosceva la prospettiva storica, il
sovrano ha incarnato i valori delle epoche in cui sono
vissuti, di volta in volta, i poeti che lo cantavano,
diventando così il campione della cortesia e dei valori
cavallereschi, tutte qualità probabilmente ignorate dall'Artù
storico.
Questa singolare mescolanza di storia e
mito, in cui trovano posto fatti realmente accaduti,
l'immaginario celtico e la fantasia medievale, ci hanno
donato una delle leggende più longeve che la mitologia e la
letteratura ricordino.
| ① |
Per approfondimenti, v.
Elizabeth Jenkins, Il mistero di
re Artù (Jenkins 1975); Howard Reid, La
storia segreta di re Artù
(Reid 2001); Marc Rolland, Re Artù
(Rolland 2004). |
| ② |
Va tuttavia evidenziato che
alcune opere storiche antecedenti a Nennio, il
De excidio Britanniae
del monaco Gildas (VI sec.) e la
Historica ecclesiastica
gentis Anglorum di Beda (VIII sec)
attribuiscono le vittorie sui Sassoni ad Ambrosio
Aureliano (successivamente mutato in Aurelio
Ambrosio), un condottiero di origine romana.
Tutta la letteratura arturiana successiva, pertanto,
sarebbe frutto di una «svista» degli storici
dell'Alto Medioevo (a meno di non considerare, come
certuni sostengono, Ambrosio ed Artù come un'unica
figura). |
| ③ |
Sul filone gallese delle
leggende arturiane, v. I racconti gallesi del
Mabinogion (Agrati ~
Magini 1982¹), e Viaggio irreale nella
Britannia di Merlino e Artù
(Giansanti ~ Maschio 2010). |
| ④ |
Non a caso, alcuni studiosi
sostennero che, dopo alcuni secoli, quando i
Normanni conquistatori «riportarono» in Gran
Bretagna la materia arturiana, l'Artù gallese e
quello bretone avevano sviluppato cicli narrativi il
cui contenuto si era totalmente diversificato. |
| ⑤ |
L'Autore è particolarmente
affezionato alla versione letteraria di Marion
Zimmer Bradley, Le nebbie
di Avalon (Bradley 1982). |
| ⑥ |
Alcuni studi portano ad
identificare l'Artù letterario con Ambrosio
Aureliano il condottiero che vinse alcune
battaglie contro i Sassoni. Si rammenta che Nennio
attribuisce ad Artù quella gesta che Gildas e Beda
ascrivono ad Ambrosio (Giansanti
~ Maschio 2010). |
| ⑦ |
Saggi: [Mercurius
>
Epiteti del Mercurius gallico:
Artaios] ► |
| ⑧ |
Non è inutile evidenziare
che Sir Ector e Sir Kay, rispettivamente padre
adottivo e fratello di latte di Artù, hanno dei nomi
di evidente origine greco-romana. |
|
|
EPILOGO
Giunge così al termine, dopo due anni di duro lavoro,
il compito che l’Autore si era prefissato agli inizi del
2010: quello di far rivivere in un linguaggio adatto ai
lettori del XXI secolo le storie che, ricoperte da una
coltre di molti secoli, hanno acceso la fantasia e
l’immaginario di molte generazioni.
Non so se, al di là di queste fatiche, vi sia uno
scopo, un ammaestramento o una morale; so per certo che i
nostri antenati amavano raccontarsi storie sin da quando il
fuoco scaldava le notti primeve.
Molti grandi personaggi storici del passato (Socrate,
Seneca) hanno addirittura preferito trascorrere le loro
ultime ore di vita discorrendo con gli amici.
Il filosofo Severino Boezio, poco prima di essere
condannato a morte per un presunto tradimento ai danni
dell’imperatore Teodorico, immaginò che la filosofia si
manifestasse a lui per consolarlo discettando della
predestinazione e del libero arbitrio.
Abelardo ed Eloisa, i due amanti del Medioevo
costretti a rifugiarsi in convento perché non era loro
possibile proseguire una relazione carnale (Abelardo era
stato infatti orribilmente evirato dai suoi avversari),
continuarono a scriversi lettere d’amore dal chiostro; mi
piace pensare, anche se le fonti ufficiali non mi sono di
conforto, che anche loro amassero raccontarsi una storia,
ogni tanto.
Questi esempi letterari servono solo a documentare e a
farci rendere conto che, dall’alba dei tempi, l’umanità ama
raccontare e raccontarsi.
E questo ci spinga, nei millenni a seguire, a
continuare a leggere storie e a trasmetterle alle
generazioni che ci seguiranno.
Con un abbraccio ideale a tutti i lettori che mi hanno
seguito con grande affetto, mi congedo da questi
Racconti senza tempo che, al pari dei miei figli, mi
hanno sottratto tutte le forze residue della mia faticosa
giornata, anche se mai per un istante ho dubitato che ne
valesse la pena.
Daniele Bello |
Bibliografia
- AA.VV., Dictionary of the Irish Language.
Compact Edition. Royal Irish Academy, Dublin, 1990.
- AGRATI Gabriella ~ MAGINI Maria Letizia [cura]: CHRÉTIEN de Troyes, I
romanzi cortesi (5 voll.). Guanda, Milano 1979.
- AGRATI Gabriella ~ MAGINI Maria Letizia [cura], I racconti
gallesi del Mabinogion. In «Saghe e leggende celtiche» (2 voll.). Mondadori, Milano 1982¹.
- AGRATI Gabriella ~ MAGINI Maria Letizia [cura], La saga
irlandese di Cu Chulainn, In «Saghe e leggende celtiche» (2 voll.). Mondadori, Milano 1982².
- AGRATI Gabriella ~ MAGINI Maria Letizia [cura]: MALORY Thomas,
Storia di re Artù e dei suoi cavalieri (2
voll.). Mondadori, Milano 1985.
- AGRATI Gabriella ~ MAGINI Maria Letizia [cura], Saghe e
racconti dell'antica Irlanda, Mondadori, Milano 1993.
- AGRATI Gabriella ~ MAGINI Maria Letizia [cura], La
leggenda del Satno Graal, Mondadori, Milano 1995.
- AMORETTI Giovanni Vittorio [cura], I Nibelunghi.
UTET, Torino 1962. Tea, Milano 1988.
- BIANCHINI Angela [cura], Romanzi medievali d’amore
e d’avventura. Garzanti, Milano 1981.
- BOULENGER Jacques, Les romans de la Table ronde.
Plon, Paris 1922. → ID., I romanzi della tavola
rotonda (3 voll.), Mondadori, Milano 1988.
- BRADLEY Marion Zimmer, The Mists of Avalon.
Balantine Books, New York 1982. → ID., Le nebbie
di Avalon. Tea, Milano 2005
- ISNARDI Gianna Chiesa [cura]: SNORRI Sturluson,
Edda di Snorri. Rusconi, Milano 1975.
- ISNARDI Gianna Chiesa, I miti nordici.
Longanesi, Milano 1991.
- GIANSANTI Dario ~ MASCHIO Claudia, Agenzia
Senzatempo. Viaggio irreale nell'Irlanda celtica. QuiEdit, Verona
2010.
- JENKINS Elizabeth, The Mystery of King Arthur.
Michael O'Mara Books, London 1975. → ID., Il mistero di
re Artù. Armenia, Milano 1997.
- KING Stephen, The Dark Tower. Grant,
Hampton Falls 2004. → ID., La torre nera.
Sperling & Kupfer, Milano 2006.
- KOCH Ludovica [cura], Bēowulf. Einaudi,
Torino 1987.
- LLYWELYN Morgan, Red Branch. Morrow, New
York 1989. → ID., I guerrieri del Ramo Rosso.
Tea, Milano 1986.
- MELI Marcello [cura], La saga dei Volsunghi.
In: «Antiche saghe nordiche». Mondadori, Milano 1997.
- MORPURGO Giuseppe, Le favole antiche. Petrini,
Torino 1953.
- O'GRADY Standish James, History of Ireland:
Critical and Philosophical. London 1881.
- REID Howard, Arthur, the dragon king : the barbaric
roots of Britain's greatest legend. Headline, London 2001. → ID.,
La storia segreta di re Artù. Le radici barbariche
della più grande leggenda britannica. Newton Compton, Roma 2003.
- ROLLAND Marc, Le roi Arthur. Un mythe heroïque au
XX siècle. Presses universitaires de Rennes, Rennes 2004. → ID.,
Re Artù. Il Mulino, Bologna 2011.
- ROLLESTON Thomas William, Myths and Legends of the Celtic
Race. 1911. → ID.
I miti celtici. Longanesi, Milano 1994.
- TOLKIEN John Ronald Reuel, The Legend of Sigurd and
Gudrún. Houghton Mifflin Harcourt,
Boston / HarperCollins, New York 2009. → ID.
La leggenda di Sigurd e Gudrún. Bompiani,
Milano 2009.
|
 Download Download
Scarica gratuitamente Racconti senza Tempo V,
in formato PDF.
© Daniele Bello. Tutti i diritti riservati
Peso: 4173 KB. |
|